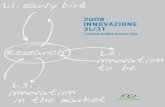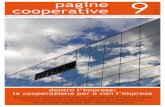Premio Nobile - AREA Science Park
Click here to load reader
-
Upload
area-science-park -
Category
Technology
-
view
6.064 -
download
23
description
Transcript of Premio Nobile - AREA Science Park

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Facoltà di Ingegneria
Corso di laurea specialistica in Architettura
Dipartimento di Ingegneria Civile
ARCHITETTURA IN MOVIMENTO:PROGETTO DI UNA UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO (U.M.S.S.)
RelatoreProf. Lodovico Tramontin
CorrelatriceDott.sa Anna Poggi
Anno Accademico 2007/2008
LaureandaChiara Pasut


ARCHITETTURA IN MOVIMENTO:
PROGETTO DI UNA UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO (U.M.S.S.)
Laureanda: Chiara Pasut _ Relatore: Prof. Lodovico Tramontin _Correlatrice: Dott.sa Anna Poggi
Università degli Studi di Udine _ Facoltà di Ingegneria _ Corso di laurea specialistica in Architettura _ Dipartimento di Ingegneria Civile _ A.A. 2007/08


I N D I C E


EMERGENZA E PROGETTAZIONE
UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO_UMMS_
ARCHITETTURA IN MOVIMENTO
L’ARCHITETTURA MOBILE PER ECCELLENZA: LA TENDA, LE SUE DECLINAZIONI MODERNE E L E I N N O V A Z I O N I T E C N O L O G I C H E
LE MAXI EMERGENZE, IL PMA ELE ALTRE T IPOLOGIE DI UNITÀMOBILE DI SOCCORSO SANITARIO
PROGETTO DI UNA UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO (UMMS)


013 INTRODUZIONE
021 CAP.1_ EMERGENZA E PROGETTAZIONE 023 Il ruolo dell’architetto nel progetto per le situazioni di emergenza 029 I primi progetti per l’emergenza 034 L’architettura contemporanea in risposta alle situazioni di emergenza 055 Shigeru Ban | paper tube 063 Emergenza tra architettura ed arte: Lucy Orta
069 CAP.2_ ARCHITETTURA IN MOVIMENTO 076 Richard Buckminster Fuller | Living in motion 086 Lo scenario contemporaneo 093 Architettura trasportabile 095 Architettura trasformabile 099 Architettura fl essibile 101 Architettura adattabile 103 Il fattore movimento: tra necessità e possibilità
107 CAP.3_ L’ARCHITETTURA MOBILE PER ECCELLENZA: la tenda, le sue declinazioni moderne e le innovazioni tecnologiche 109 La tenda come architettura mobile: dalle origini alle recenti innovazioni tecnologiche
116 Le declinazioni moderne della tenda: tensostruttura e pressostruttura come campi di ricerca per i materiali 125 Il controllo climatico: l’aerogel, le sue proprietà e il suo utilizzo nelle membrane 133 Tensotherm™ Nanogel® 137 Possibili nuovi scenari
141 Il reperimento delle informazioni e il ruolo di internet
143 Normative
147 CAP.4_ LE MAXI EMERGENZE,IL PMA E LE ALTRE TIPOLOGIE DI UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO 149 Linee guida per le maxi emergenze 156 Il triage 159 Il PMA (posto medico avanzato): defi nizione di Unità Mobile di Soccorso Sanitario piu’ vincolante 165 Tipologie delle unità mobili di soccorso sanitario 177 Esperienze sul campo
185 CAP.5_ PROGETTO DI UNA UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO (UMMS) 188 Concept progettuale
190 Organizzazione funzionale 191 Sviluppo della forma 194 Layer organizzativi

197 Organizzazione interna
206 Supporto logistico 209 Soluzioni progettuali 209 Pavimentazione livellante 214 Struttura principale 223 Membrane 234 Struttura secondaria 248 Impianto di illuminazione 255 Carrello medico 258 Lettino pieghevole per le prime cure e brandine degenza 262 Porte e collegamenti con altre U.M.S.S. 265 _Calcolo dei probabili pesi dell’U.M.S.S. 267 _Modellino
271 CONCLUSIONE
275 BIBLIOGRAFIA



I N T R O D U Z I O N E

14

15
Il tema della mobilità è sempre stato un concetto che ha affascinato numerosi architetti.
Il sogno di poter svincolare l’architettura dal concetto di staticità che è insito nella sua defi nizione ha prodotto innumerevoli
progetti e visioni. La mobilità può essere interpretata in diverse maniere nell’ambito edilizio, può essere vista come edifi cio
che si muove da un luogo ad un altro, o come singolo componente mobile facente parte di un’architettura tradizionale, ecc.
Molti pensano che l’essere mobile sia una caratteristica dell’architettura contemporanea, in cui i sistemi trasportabili e
facilmente trasformabili vengano richiesti come spazi temporanei ospitanti manifestazioni itineranti, mostre o attività che
hanno una durata limitata nel tempo. Questo è in parte vero, ma esiste anche un ambito architettonico che si basa sulla
temporaneità dell’architettura e del costruito, che è quello dei ripari temporanei, comunemente chiamati shelter.
Gli shelter in genere sono dei sistemi assemblati a secco che devono provvedere a fornire un riparo alle persone, possono
essere abitazioni, luoghi di lavoro, spazi per la collettività, comunque tutti temporanei.
Questa tesi vuole affrontare il concetto di shelter come unità mobile di soccorso sanitario in caso di maxi emergenza.
Quindi garantire un riparo al personale sanitario in una situazione di crisi in cui sono coinvolte un numero medio alto di
persone, le quali devono necessariamente ricevere le prime cure sul luogo del sinistro prima di venir smistate ai vari ospedali.
Dal punto di vista medico questo genere di situazioni, nelle nazioni più evolute, è strettamente regolamentato e vi sono dei
protocolli comuni che dovrebbero garantire la corretta catena dei soccorsi. In questa, è precisamente defi nito il tipo di shelter
da utilizzare e le funzioni che tale struttura deve assolvere.
Proprio perché le situazioni di crisi non sono strettamente prevedibili e gli scenari possono essere innumerevoli, gli shelter
devono essere facilmente trasportabili, trasformabili, fl essibili ed adattabili.
È stato dunque necessario approfondire la tematica della progettazione a supporto delle situazioni d’emergenza, della mobilità
nell’ambito architettonico e le relative tecnologie, ed infi ne i protocolli che regolano le varie attività mediche.
Il risultato è il progetto di una unità mobile di soccorso sanitario (UMMS) che è concepita come luogo funzionale al
corretto svolgimento delle operazioni mediche e come architettura mobile, facilmente trasportabile (facendo attenzione quindi
anche al fattore peso), fl essibile a possibili cambiamenti dello scenario della crisi e adattabile ai possibili ambienti.
Il primo capitolo della tesi affronta il tema del rapporto tra progettista e situazione di emergenza, in cui il professionista viene
chiamato per defi nire delle soluzioni a supporto della crisi. La maggior parte delle richieste da parte delle organizzazioni
umanitarie e degli enti governativi ai progettisti è quella di pensare e rendere fattibile un riparo che riesca a garantire, in
brevissimo tempo, la sicurezza delle persone coinvolte.
Le considerazioni di Cameron Sinclair, a capo dello studio di architettura Architecture for Humanity, vengono intrecciate con
quelle di Enzo Mari relative al percorso progettuale di un industrial designer.
In entrambi i casi, per quei campi progettuali che hanno un grado di complessità elevato, viene segnalata la necessita di
collaborare con persone che per professione si occupano costantemente della tematica per poter individuare in maniera
rapida i problemi.
Vengono poi individuati in generale i vari momenti di intervento in situazioni di crisi (emergenza, riabilitazione, ricostruzione)
e i requisiti caratterizzanti il progetto per l’emergenza attraverso le linee guida dell’International Conference on Disaster Area
Housing . Per concludere tali considerazioni si sottolinea come i quattro punti che propone Enzo Mari per poter ottenere un
buon progetto (componente etica, qualità culturale, strumenti di produzione e attinenza tra prodotto e possibile produzione)
siano fondamentali quando si parla di progetto per l’emergenza.
Il capitolo prosegue con una veloce presentazione dei primi progetti che fi no alla prima metà del XX secolo hanno cercato di
garantire un riparo alle persone sfollate sia a causa di disastri naturali, ma soprattutto della Seconda Guerra Mondiale. Dopo
questo drammatico evento si è cominciato a trattare sistematicamente il problema della fornitura di shelter alla popolazione,
dapprima come forma temporanea di abitazione e successivamente come struttura di supporto anche per le altre attività,
comprese quelle mediche.
I progetti che vengono presentati sono relativi a soluzioni studiate per le crisi umanitarie in quanto questo campo è da sempre
il settore in cui, purtroppo, vi è la maggiore richiesta di shelter. Inoltre l’UNHCR, l’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’ONU,
fornisce dei manuali e dei documenti dove vengono fornite dettagliate informazioni circa l’allestimento e l’utilizzo degli shelter.
Queste sono rivolte principalmente agli operatori UNHCR ma sono utili anche ai progettisti che intendono cimentarsi con il
progetto per l’emergenza in quanto defi niscono in modo chiaro e preciso le problematiche, le necessità e le caratteristiche di
uno shelter. Per questo, sebbene tali progetti non siano legati strettamente al campo medico, è stato utile studiare le soluzioni
adottate per affrontare la fase progettuale. Si è potuto così constatare che non sempre la soluzione ottimale è defi nita attra-
verso un progetto contenete dell’alta tecnologia, ma che anche piccoli accorgimenti possono risolvere problematiche che
possono rivelarsi drammatiche sul lungo periodo.
Un esempio è senza dubbio l’utilizzo dei paper-tube introdotto da Shigeru Ban per le strutture delle tende dei campi profughi
in Ruanda e il successivo utilizzo degli stessi nelle città colpite da terremoti in Giappone, Turchia ed India.
Con i tubi di cartone nel primo caso si è evitato il disboscamento delle aree limitrofe ai campi profughi che avrebbe potuto
portare a smottamenti e successive ulteriori situazioni di pericolo.

16
La presentazione dei progetti per l’emergenza umanitaria è introdotta da quelle soluzioni che hanno riconsiderato la
tradizionale tenda, composta da un singolo telo di plastica sostenuto da pali, utilizzata dalle organizzazioni umanitarie come
primo supporto alla popolazione; si è proseguito con l’illustrazione di strutture più stabili e protettive e si è fi nito con due
esempio di prodotti industriali atti a migliorare le condizioni di vita degli utilizzatori.
A fi ne capitolo si è voluto analizzare l’opera di Lucy Orta per dimostrare come l’arte permetta, citando le parole di Sigfried
Giedion, “di scorgere ciò che per nostro conto non siamo stati capaci di afferrare” .1
Il secondo capitolo è dedicato all’approfondimento dell’architettura in movimento, del suo maggior esponente, Richard
Buckminster Fuller, e all’analisi dello scenario contemporaneo.
Colui che probabilmente per primo ha sperimentato le possibilità della mobilità in architettura e soprattutto ha ridefi nito
lo standard degli shelter è Richard Buckminster Fuller. Figura quasi leggendaria, inventore ed esploratore delle possibilità
costruttive è stato il primo a intravedere nella riconversione dell’industria bellica e nel transfert tecnologico tra industria
aerospaziale ed architettura, la strada verso il rinnovamento del campo edilizio. Con la sua Dymaxion Development Unit, poi
diventata House, ha rivoluzionato il concetto di abitazione, ancor prima di quella di shelter, con una grado di fl essibilità e
adattabilità raggiunto da pochi.
Ancora più importanti i suoi studi relativi alle cupole geodetiche, strutture capaci di avere un equilibrio interno grazie
all’interazione tra forze di trazione e compressione. Queste strutture trovarono largo impiego nel settore militare, come riparo
per i radar e varie attrezzature militari, ma riuscirono ad imporsi anche come elemento architettonico, sottoforma di abitazioni
e padiglioni.
Il lascito di Fuller che più ha condizionato ed infl uenzato le generazioni successive è probabilmente l’idea di contaminare il
progetto con i saperi dei settori a più alto grado di innovazione per migliorare le condizioni abitative.
Nello scenario contemporaneo possono essere individuati tre livelli di “portabilità”, individuati da Robert Kronenburg2,
dell’architettura mobile: i portable buildings, i relocateble buildings e i demontable building.
Nel primo caso sono sistemi che vengono trasportati intatti e possono essere identifi cati con il termine di “semovente”
proposto da Alessandra Zanelli3; nel secondo caso hanno parti preassemblate e sono parzialmente integrati al sistema
di trasporto, possono essere detti anche “semi-autonomi”; infi ne quei sistemi che sono pensati per essere assemblati e
dissassemblati, detti anche “portatili”.
Trasportabilità, trasformabilità, fl essibilità, adattabilità sono le parole chiave per un progetto generalmente detto di architettura
portatile.
La trasportabilità è a sua volta correlata con la leggerezza o la pesantezza del sistema; la trasformabilità permette un
diverso utilizzo del sistema grazie al suo cambiamento di forma, colore, apparenza; la fl essibilità permette all’elemento di
poter rispondere in maniera ottimale ai cambiamenti d’uso e di localizzazione; infi ne un edifi cio adattabile è concepito per
poter rispondere in maniera rapida alle differenti funzioni, confi gurazioni e richieste degli utenti.
Nel quarto paragrafo viene affrontata la mobilità dal punto di vista del sistema mobile per eccellenza: la tenda.
Questa infatti, grazie alla sua storia millenaria, è riuscita a rimanere una dei sistemi di shelter più utilizzati, soprattutto dalle
popolazioni nomadi. Il suo punto di forza è senza dubbio la facilità di trasporto, la leggerezza, la fl essibilità d’uso.
Già le popolazioni nomadi hanno imparato a ripararsi dalle avverse condizioni ambientali attraverso alcuni accorgimenti
apportati ai tessuti, ma è attualmente nelle tende per spedizioni alpinistiche che la ricerca ha permesso di avere un
avanzamento tecnologico.
Parallelamente in ambito architettonico si sono sviluppati i sistemi tensostrutturali e presso strutturali.
I primi vengono oggigiorno visti con estremo interesse per perseguire la strada della leggerezza, la quale non signifi ca
solamente chiara idea progettuale ma anche risparmio di materiali durante la costruzione di un edifi cio.
Nel campo delle tensostrutture si può trovare uno dei settori di innovazione dell’edilizia. Le aziende produttrici di membrane
infatti stanno cercando di attuare dei transfert tecnologici dal settore aerospaziale per migliorare i loro prodotti.
Uno di questi casi è quello del prodotto Tensotherm della ditta Birdair che ha applicato alla tradizionale membrana in PTFE
uno strato intermedio di aerogel di silice. L’aerogel è un materiale molto leggero che però garantisce un elevato isolamento
termico su spessori limitati. Inoltre assolve anche alla funzione di isolante acustico.
Nell’approfondimento sull’aerogel si può vedere come questo materiale, dapprima utilizzato dalla Nasa come materiale per
raccogliere la polvere stellare, negli ultimi anni ha destato l’attenzione anche dei progettisti edili per le sue eccellenti proprietà
isolanti.
Vi è poi anche una rifl essione su un possibile ulteriore miglioramento delle prestazioni della membrana se venisse utilizzato
l’aerogel addizionato con i materiali a cambiamento di fase (brevetto WO/2007/014284) e sulla questione della mancanza di
1 Sigfried Giedion, Spazio, Tempo, Architettura, Ulrico Hoepli editore, 1965, Milano
2 Robert Kronenburg, Portable Architecture. Design and Technology, Birkhauser Verlag AG, 2008, Basel- Boston - Berlin
Robert Kronenburg, Flexible,architecture that responds to change, Laurence King Publishing, 2007, Londra
3 Alessandra Zanelli, Trasportabile/Trasformabile. Idee e tecniche per architetture in movimento, Libreria Clup, 2003, Milano.

17
uno standard comune alle aziende del settore edile per la diffusione delle principali caratteristiche.
Nel campo delle tensostruttre non tutti i produttori ad esempio inseriscono nelle loro schede tecniche il peso del materiale,
altri non indicano i valori di rifrazione delle radiazioni, ecc.
Un confronto prestazionale preciso risulta essere diffi coltoso per il progettista soprattutto se deve confrontarsi con quei termini
che sono il fi lo conduttore della ricerca di questa tesi: trasportabilità, trasformabiltà, fl essibilità ed adattabilità.
Quindi con questioni come quelle del peso, quelle climatiche e di adattabilità ambientale.
Con il quinto capitolo si sono identifi cati i requisiti principali prescritti dalle varie normative, direttive e protocolli che una unità
mobile di soccorso sanitario deve avere.
Necessario è risultato introdurre il concetto di maxi-emergenza, cioè quella situazione che prevarica il normale funzionamento
dei soccorsi ospedalieri e in cui i sistemi medici mobili devono operare; una situazione eccezionale, che vede il
coinvolgimento di un numero signifi cativo di persone e che richiede un fi ltraggio dei feriti prima che questi vengano trasportati
nei vari ospedali.
Per far fronte a queste situazioni gli ospedali sono attrezza con strutture chiamate PMA, posti medici avanzati, che a
seconda delle loro tipologie possono essere direttamente ricondotte alla classifi cazione proposta da Kronenburg.
Esistono infatti PMA che possono essere considerati dei portable buildings (PMA furgonati), relocateble buildings
(PMA conteinerizzati ), demontable building (PMA sottoforma di tende), ognuno ha i propri vantaggi e svantaggi che sono stati
analizzati e comparati.
I PMA sono le unità mobili di soccorso sanitario che comportano più limitazioni progettuali in quanto sono sistemi che devono
essere disponibili e assemblabili in un breve lasso di tempo (in genere 1 ora dall’arrivo sul luogo del sinistro).
La funzione di PMA è infatti quella di essere il fi ltro tra l’area del sinistro (cantiere in termine medico) e gli ospedali.
Tale operazione è necessaria in quanto non è possibile trasportare tutti i feriti in un unico ospedale, magari in quello più vicino.
Ogni ospedale è predisposto ad accogliere un numero limitato di feriti gravi contemporaneamente, non è possibile per i medici
seguire contemporaneamente più di un numero prestabilito di casi in cui le funzioni vitali del sinistrato siano seriamente a
rischio.
Per questo l’unità mobile è predisposta per eseguire il cosiddetto triage, cioè quella procedura che stabilisce il grado di
criticità della situazione del paziente, la stabilizzazione di quest’ultimo e il successivo smistamento verso l’ospedale più
attrezzato ad affrontare la patologia.
Essendo una struttura mobile, come per altro indica il nome, che deve essere a disposizione in un breve lasso di tempo,
l’unità mobile di soccorso sanitario è un dispositivo che deve rispondere appieno ai quattro termini caratterizzanti
l’architettura mobile, cioè trasportabilità, trasformabiltà, fl essibilità ed adattabilità.
Per prima cosa la struttura deve essere facilmente trasportabile in qualunque luogo; per questo nel progetto si è deciso di non
integrarla con il sistema di trasporto; si è optato per un sistema “demontable”/disassemblato, da montare direttamente sul
luogo, facendo particolarmente attenzione alla questione “peso” in modo da poterne garantire il trasporto anche con un
elicottero civile tramite gancio baricentrico. La scelta è quindi ricaduta su una struttura riconducibile alla tipologia della
tenda.
Questo ha reso necessaria una rifl essione: se nelle altre tipologie il container o il mezzo furgonato vengono attentamente
allestiti per le immaginabili problematiche relative al limitato spazio a disposizione, nei sistemi a tenda la cura nell’introduzione
di facilitazioni per le operazioni di soccorso è sempre molto scarsa. La tenda ha sì una grande fl essibilità di utilizzo, ma questo
alle volte diventa l’alibi per il non-progetto di questa caratteristica.
Le foto del PMA allestito in occasione di una manifestazione sportiva in provincia di Udine mostrano chiaramente come la non
predisposizione di una integrazione tra shelter e impiantistica porti a notevoli diffi coltà operative.
Compito del progettista è quindi defi nire il limite tra le esigenze legate all’emergenza, quindi velocità di assemblaggio, e la
funzionalità dello spazio interno.
Non si può dimenticare comunque che le diffi coltà create da una scarsa organizzazione interna ricadono drammaticamente
sull’operatività dei soccorritori, sia da un punto di vista strettamente materiale che emozionale.
Da ricordare che l’emergenza è una situazione di alto stress anche per coloro che la scelgono come scenario lavorativo; il
progettista dovrebbe considerare che altre fonti di stress, quali impedimenti riconducibili alla struttura, provocano scarsa
effi cienza nei soccorsi.
Utilizzando le parole di Wright si potrebbe dire che questa tesi cerca di creare un’unità medica di soccorso sanitario
organicamente organizzata.
Lo scopo del progetto quindi è quello di garantire una struttura mobile con agevolazioni che facilitino le operazioni di soccorso,
evitando la confusione e rendendo autonoma la struttura per un certo periodo qualora la situazione lo imponesse (ad esempio
il prolungamento delle operazioni anche durante la notte in una zona diffi cilmente raggiungibile dai mezzi di terra).
Il sesto capitolo cerca quindi di essere la sintesi progettuale delle precedenti ricerche, seppur condotte in ambiti alle volte
molto distanti. L’approfondimento delle tematiche dell’architettura in movimento e dell’evoluzione della tenda ha permesso

18
di poter predisporre accorgimenti utili a limitare effetti di disagio e aumentare alcune prestazioni, come l’isolamento termico;
la ricerca nel campo degli shelter per l’emergenza ha permesso di avere una visione più ampia delle problematiche delle
persone in diffi coltà, degli scenari con limitate agevolazioni e delle prescrizioni dettate da decenni di esperienza come quelli
accumulati dell’UNHCR; gli approfondimenti sulle tecnologie e sulle innovazioni nel campo dei materiali ha garantito l’utilizzo
di prodotti che garantiscono prestazioni di alto livello del sistema; infi ne la fi gura di Richard Buckminster Fuller ha aumentato
la curiosità per tutti quei settori che non sono strettamente architettonici ma che possono comunque essere d’ispirazione per
il progettista.



E M E R G E N Z A E P R O G E T T A Z I O N E
01


23
Numerosi architetti negli ultimi decenni si sono imbattuti in progetti che dovevano essere sviluppati in modo da poter far fronte
a vari tipi di emergenze. La maggior considerazione nella programmazione delle emergenze delle varie organizzazioni ha
fatto in modo che il fermento attorno a progetti di architettura mobile, temporanea e di emergenza riprendesse vigore dopo
le sperimentazioni del secolo scorso.
Ma cos’è una emergenza? E soprattutto quali sono i diversi approcci per l’emergenza nell’ambito architettonico?
Dal vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli:
Emergenza: circostanza o eventualità imprevista, specialmente pericolosa.
Quindi un’emergenza è un evento in genere imprevisto e pericoloso.
Nello specifi co possiamo rifarci al Manuale per le Emergenze dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che,
sebbene sia stato redatto specifi camente per le emergenze umanitarie, può essere d’aiuto nell’approfondimento.
Il manuale dice che nella defi nizione di un’emergenza “la distinzione si basa sulla gravità del fenomeno” che in questo caso
è “qualunque situazione in cui, in mancanza di un’azione immediata e appropriata, la vita o il benessere dei rifugiati possano
essere in pericolo, e che richiede una risposta straordinaria e misure eccezionali.”
Quindi si può dire che in generale l’emergenza è una circostanza straordinaria che necessita di una risposta eccezionale che
prevarica le capacità dei singoli, ma richiede la collaborazione di più persone e/o organizzazioni per risolverla nel più breve
tempo possibile.
Le emergenze che richiedono l’ausilio dell’architettura e che in parte verranno analizzate in questa tesi riguardano in genere
la possibilità di dare, entro un breve l’asso di tempo, riparo e assistenza a coloro che si trovano nello stato di emergenza.
Fortunatamente questa situazione è eccezionale, almeno nei Paesi industrializzati e che in genere tende a risolversi e a
lasciare il posto ad una condizione di normalità entro tempi brevi. Invece nei Paesi meno avvantaggiati lo stato di emergenza è
purtroppo molte volte la normalità. Basti pensare alle epidemie, alle carestie, allo spostamento di un gran numero di persone
che scappano da confl itti, agli eventi naturali non previsti e che colpiscono territori non attrezzati per affrontare tali situazioni,
ecc.
Negli ultimi anni, si sta cercando di prevedere e formulare protocolli sempre più precisi per affrontare queste situazioni,
soprattutto nei Paesi sviluppati e all’interno di tutte quelle organizzazioni che operano a stretto contatto con territori e
popolazioni svantaggiate. Purtroppo gli effetti di tali provvedimenti ha un riscontro diverso a seconda che vengano posti in
atto in territori dotati di infrastrutture o meno. Si pensi ad esempio ad un terremoto; nel caso questo colpisca una metropoli
l’obiettivo è cercare di porre in atto, nel minor tempo possibile, le attività di ricerca, soccorso e ricostruzione.
Questo è possibile perché da tempo si cerca di prevenire possibili cause di emergenza, si provvede a pianifi care un iter di
operatività durante l’emergenza e soprattutto vi è un controllo e un’accessibilità al territorio e alle sue parti in genere buona.
In territori svantaggiati, di diffi cile accesso, l’obiettivo primario sarà invece quello di riuscire a raggiungere il luogo
dell’emergenza sempre nel minor tempo possibile, che però può signifi care giungere sul posto quando le attività di ricerca di
persone sopravvissute hanno minime possibilità di riuscita, in quanto, in genere, gli aiuti signifi cativi provengono da nazioni
straniere. Per questo le attività saranno concentrate sul dare conforto ai sopravvissuti.
Se nel primo caso l’architettura ha avuto un ruolo nell’emergenza precedente all’evento stesso, con l’attuazione ad esempio
dei dispositivi quali il corretto dimensionamento antisismico degli edifi ci, nel secondo caso l’architettura ha un ruolo postumo,
cioè si occupa dell’assistenza attraverso shelter e della ricostruzione.
Ma come fare a mettere a fuoco realmente le esigenze a cui un progettista deve far fronte in una situazione di generale
emergenza?
Cameron Sinclair dello studio Architecture for Humanity rispondendo ad una intervista dice:
“In generale il primo accorgimento consiste nel coinvolgere il maggior numero di persone estranee al mondo dell’architettura:
medici, scienziati, professionisti, persone comuni. In questo modo si evita di appiattirsi sulle questioni di stile. I criteri variano
a seconda delle situazioni, ma oltre alle valutazioni tecnico-scientifi che assumono grande rilievo gli aspetti economici, e non
è detto che si debba a ogni costo risparmiare, perché può essere più interessante - per esempio - una soluzione che apra la
possibilità di generare profi tti per la comunità.
Un singolo problema, come la scarsità d’acqua, può essere affrontato dal punto di vista del trasporto minuto, del fi ltraggio,
della raccolta, del riciclo, della questione igienica a seconda della convenienza rispetto al luogo: per ognuno di questi problemi
il design ha elaborato soluzioni ingegnose.”1
IL RUOLO DELL’ARCHITETTO NEL PROGETTO PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA
1 http://www.architectureforhumanityitaly.org/download/Il%20manifesto%2007.04.2007.pdf

24
Citando Enzo Mari possiamo infatti dire che il progettista si deve porre proprio in quella situazione tipica del design, cioè:
“il designer (qualunque sia la specifi ca tipologia d’intervento) deve necessariamente svolgere il proprio lavoro con la
consapevolezza dei due mondi: quello dell’utopia e quello del reale” 2,
defi nizione che funziona anche per il progetto per l’emergenza. Il progettista deve far in modo che tutto il suo bagaglio
culturale e architettonico (anche utopico) si metta in relazione con tutte le contingenze del reale, e specifi camente con le
condizioni dettate da una situazione d’emergenza.
Sempre Mari :
“Questo gli consente, molto più che ad altri, di avvicinarsi alla comprensione di ciò che concretamente condiziona la nostra
modernità (per chi vuole anche «post»). Trasmettere in modo comprensibile la conoscenza di tali contraddizioni è oggi forse
il primo obiettivo del buon progetto.” 3
Similmente a Sinclair, anche Mari descrive come in quei progetti che prevedono una qualche complessità, devono essere
coinvolte, direttamente o indirettamente, più persone con ruoli e specializzazioni diverse.
Secondo il loro modo di porsi e interagire nella complessità del progetto ci possono essere due esiti: il primo favorevole, nel
momento in cui le diversità riescono a procedere le proprie ricerche e confrontarsi con gli altri inducendo momenti di dialogo;
il secondo sfavorevole, nel momento in cui ognuno procede separatamente riducendo lo scambio di informazioni al minimo.
Questa seconda situazione porta alla realizzazione di un progetto improprio 4.
Enzo Mari. Schemi delle due modalità di interazione tra i partecipanti ad un progetto, il primo con esito favorevole, il secondo con esito sfavorevole.
A sostegno di questo vi è anche una caratteristica fondamentale che viene sottolineata dall’UNHCR che, anche se si
riferisce alla fase acuta della emergenza, può ritenersi valida anche per il progetto architettonico a sostegno dell’emergenza;
questa caratteristica è l’approccio multisettoriale. Inoltre è necessario un continuo riesame dell’effi cacia della risposta e un
adeguamento nel momento in cui si riscontrino delle esigenze differenti.
La necessita della progettazione di shelter per far fronte alle emergenze è ribadita da Sinclar:
“Nessuno vuole investire nella prevenzione. Sono le grandi ondate emotive che seguono le catastrofi a mobilitare le energie,
il denaro, il potere necessario a fare partire le idee, e spesso neanche quelle sono suffi cienti. Prendiamo il caso di New
Orleans: il rischio di inondazione era noto, e nonostante questo non si è voluto prevenirla. Il tasso di povertà degli abitanti era
inammissibile per una città degli Stati Uniti, nessuno si era reso conto di quanta gente potesse essere esposta alla rovina
totale dall’uragano Katrina.
Il risultato è noto: nessuno ha capito bene come reagire ed è stato uno sfacelo, uno spreco di risorse e vite umane.” 5
2-3 Enzo Mari, Progetto e passione, Bollati Boringhieri Editore, 2001, Torino
4 Enzo Mari, Progetto e passione, Bollati Boringhieri Editore, 2001, Torino
5 www.architectureforhumanityitaly.org/download/Il%20manifesto%2007.04.2007.pdf

25
La seconda guerra mondiale fu l’avvenimento che segnò un grande cambiamento all’interno della gestione delle emergenze:
la nascita delle NGO, nongovernmental organization, le organizzazioni non governative.
Con l’eccezione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che fu fondata negli anni 60 dell’’800 da Henri Dunant, la
gran parte delle organizzazioni e delle agenzie che sono attive tutt’oggi sono state fondate sulla base dell’esperienza dalla
seconda guerra mondiale.
Queste includono non solo le Nazioni Unite, ma anche altre agenzie governative come l’agenzia degli Stati Uniti per lo
Sviluppo Internazionale (USAID), organizzazioni di aiuto umanitario come l’International Rescue Committee, CARE, e l’Oxfam,
e organizzazioni religiose come Catholic Relief Services.
Da questo momento in poi, le organizzazioni non governative hanno giocato un ruolo fondamentale nel provvedere ai rifugi di
emergenza per i rifugiati o a sostegni dopo i disastri naturali.
Dopo la fi ne della guerra e la fi ne della colonizzazione, il problema delle emergenze, come già detto, si è spostato dall’Europa
e dall’America ai Paesi in via di sviluppo.
La Croce Rossa ha stimato che nelle passate due decadi, più di 75˙000 persone sono state uccise annualmente da disastri
naturali o prodotti dall’uomo, altri 211 milioni sono state interessate dai disastri ogni anno, 98% delle quali risiedevano in
Paesi in via di sviluppo. Inoltre si è visto come nell’ultimo decennio il numero di eventi calamitosi, e di conseguenza il numero
di persone coinvolte, sono in costante aumento.
Con l’aumento del numero delle NGO, queste hanno migliorato molto la parte dello sviluppo e della creazione di sistemi
sanitari e di approvvigionamento di acqua, e nella costruzione di abitazioni.
Solo negli ultimi anni però si è sottolineata l’importanza di associare all’intervento umanitario il rispetto per le realtà in cui si
interviene.
Questo aspetto va tenuto presente soprattutto dopo la fase della primissima emergenza, in cui bisogna ricostruire, dove
possibile, nel territorio colpito.
Ian Davis, consulente per i rifugi temporanei per le Nazioni Unite e che ha collaborato con Fred Cuny, uno dei primi ad
interessarsi negli anni ’70 alla pianifi cazione dei campi profughi e alle tematiche relative all’emergenza, misteriosamente
scomparso in Cecenia nel 1995 con due medici russi, sottolinea come
“When you told them (ai rifugiati) that you can build a permanent house in Bangladesh in three days for the same amount of
money they were proposing to spend on temporary housing, they igored you.”
La distruzione dell’uragano Katrina a New Orleans nell’agosto del 2005

26
Fred Cuny in Somalia nel 1992 accanto al veicolo dell’ONU danneggiato da un attacco armato a Mogadiscio. Tre anni dopo, all’età di 50 anni, Cuny
sarebbe sparito in Cecenia durante una missione di pace.
Il progettista quindi deve sempre relazionarsi con i parametri del luogo in cui andrà ad intervenire e non con quelli del suo
Paese d’origine. Il rischio è quello di creare una struttura totalmente inutile ed ineffi cace per affrontare l’emergenza. Tanto che
le tende – la soluzione scelta dalla gran parte delle agenzie – possono essere spedite a grande distanza a un costo accessibile
ma magari non vengono utilizzate perché arrivano troppo tardi o vengono montate in campi lontani dalle case e dai luoghi di
attività economica.
Nel 1977 si tentò di decodifi care una linea di intervento comune a tutte le organizzazioni attraverso l’“International Conference
on Disaster Area Housing” a Istambul.
Si individuarono tre momenti per l’intervento del soccorso:
-emergenza: come immediato impatto con gli effetti del disastro e i relativi problemi abitativi in termini di riparo, di ricovero;
-riabilitazione: intermedia tra l’emergenza e la risistemazione defi nitiva, che viene individuata con la durata variabile da molte
settimane a mesi e anche anni, durante il quale “il massimo sforzo è rivolto a procurare un minimo di condizioni ambientali
per le attività umane e alla costruzione di abitazioni temporanee che devono durare fi no a quando non siano terminate le
costruzioni a carattere permanente”;
-ricostruzione: il complesso dei provvedimenti legislativi, economico-fi nanziari e dei processi produttivi e costruttivi tesi ad
approntare le condizioni generali e a realizzare le operazioni per tornare alla normalizzazione della vita.
Da tutto ciò vengono dedotti alcuni fattori e requisiti caratterizzanti:
- adattabilità a qualsiasi tipo e condizione di terreno;
- accettabilità del comfort idro-termico ed acustico;
- compatibilità dimensionale dei componenti ai vincoli imposti dai mezzi di trasporti;
- massima leggerezza degli elementi e dell’insieme sia per ragioni economiche, sia per facilitare il trasporto, l’assemblaggio
e garantire la massima sicurezza;
- massima riduzione di mano d’opera specializzata e minimo ricorso ad attrezzature speciali nell’assemblaggio dei
componenti;
-potenzialità allo smontaggio e ri-montaggio in altro sito e per altre, analoghe, ricorrenza.
Alla conferenza di Istambul segue quella di Oxford organizzata da Ian Davis, “International Conference on Disasters and Small
Dwelling”, promossa dall’University College locale.
Il tema centrale è stato quello dello Shelter After Disaster, inteso nel senso di ricovero di primo soccorso e defi nito come
“accettabile protezione dagli elementi (freddo, caldo, vento, pioggia, ecc) dal momento del disastro fi no alla disponibilità di un
ricovero temporaneo o permanente”.

27
Bisognerebbe tener comunque sempre conto di quelli che Enzo Mari indica come le qualità di un progetto6:
- la componente etica;
- la qualità culturale;
- il possesso degli strumenti di produzione;
- i tipi di coincidenza tra progetto e produzione.
Se solo dalla seconda metà dello scorso secolo si è cominciato a sottolineare la problematica progettuale di quelli che
vengono chiamati shelter, cioè rifugi, già da molto tempo prima, i progettisti hanno affrontato il tema dell’emergenza,
soprattutto sotto il profi lo abitativo.
Facendo un salto nel tempo possiamo risalire forse al primo progetto che cercò di far fronte ad una emergenza tentando un
approccio di post-riscostruzione. Fu il caso di Lisbona, che nel 1755 venne colpita da un terremoto e successivo tsunami.
Con il progetto denominato gaiola (gabbia), si creò una struttura fl essibile di legno formata da puntoni diagonali rinforzati e da
un reticolo di elementi sempre di legno verticali ed orizzontali, in modo da rendere in qualche modo “antisismici” i nuovi edifi ci
in previsione di un successivo terremoto.
Ma l’evento che forse decretò l’inizio delle strategie di intervento fu il terremoto del 18 aprile 1906 che devastò San Francisco.
Fu infatti l’evento catastrofi co più imponente dell’epoca di prima industrializzazione.
In un primo momento la Croce Rossa, fondata solo 25 anni prima, quindi senza una signifi cativa esperienza, e i volontari
fornirono prima delle tende ai sopravvissuti e successivamente alcune baracche che si rivelarono ben presto costose e
ineffi caci. Si resero quindi conto che l’obiettivo doveva essere quello di ricostruire nel più breve tempo possibile la città per
riportare tutti alla normalità.
Per questo una combinazione di concessioni e prestiti ai più abbienti per l’edifi cazione di nuove case e la costruzione tra il
settembre 1906 e marzo 1907 di più di 5610 cottage progettati dagli ingegneri dell’esercito (tra i 13 e i 37 m2 e per un costo
variabile tra i 100 e i 741 dollari) di facile successiva dismissione, portò alla rapida normalizzazione.
Purtroppo a più di 100 anni di distanza, quello che oggi è una prassi della veloce ricostruzione nei Paesi industrializzati, per
6 Enzo Mari, Progetto e passione, Bollati Boringhieri Editore, 2001, Torino
Fasi di riabilitazione e ricostruzione di territori colpiti da calamità

28
la gran parte del mondo è un traguardo ancora molto lontano.
Per decenni gli architetti hanno discusso sull’opportunità e la necessità di provvedere alla defi nizione di nuovi rifugi per far
fronte alle situazioni di crisi. Da quando i progettisti hanno confi dato nell’idealismo dell’era delle macchine, nella crescente
ascesa del progresso tecnologico e nello sviluppo di idee a prima vista spesso utopiche, c’è stato uno sviluppo di soluzioni
e progetti per il supporto sia alla popolazione che agli operatori che devono far fronte alle problematiche delle situazioni di
crisi, come il provvedere a un riparo temporaneo, alla garanzia di acqua potabile, all’assistenza sanitaria alle famiglie che
necessitano.
Col tempo però, il mondo del soccorso e sviluppo post evento catastrofi co si è separato dal mondo dell’architettura e del
design. Quello che i progettisti da sempre hanno considerato una sfi da, i soccorritori invece lo considerano come un problema
di pianifi cazione e politica.
Questa disconnessione ha portato ad alcuni interrogativi, espressi anche da Kate Stohr nel saggio sui 100 anni di design
umanitario per il libro edito dallo studio newyorkese Architecture for Humanity7, quali: che ruolo deve avere la
progettazione nella defi nizione e soddisfazione delle esigenze di un primo riparo? Come possono gli architetti indirizzare al
meglio la progettazione per soddisfare i bisogni della cittadinanza colpita? E, andando al cuore della questione, il design
deve essere considerato un bene di lusso o una necessità, un mezzo per il semplice godimento estetico o in prima istanza,
la soddisfazione primaria dei bisogni?
Questo problema ha da sempre interrogato non solo gli architetti ma anche i pianifi catori, i politici e le organizzazioni di
soccorso , dibattendo per bilanciare il bisogno logistico di provvedere ad un riparo con il bisogno/desiderio dell’uomo di avere
un luogo da poter chiamare casa.
7 Architecture for Humanity, Design Like You Give a Damn, Architectural Responses to Humanitarian Crisis, Published by Metropolis Books, 2006, New York

29
La storia del design, inteso come progetto, umanitario/sociale ha le sue radici nei primi movimenti dei cittadini che tra il 1800
e il 1900 cominciarono a rivendicare e promuovere la riforma delle condizioni sociali e abitative delle fasce povere della
società. Parallelamente a progetti di architettura “convenzionale”, cominciavano a farsi largo anche tipologie di architettura
mobile.
Nel 1917 in varie località della Francia vennero erette delle case di legno completamente assemblabili a secco per dare un
primo rifugio stabile ai rifugiati della Prima Guerra Mondiale.
Le abitazioni, donate dall’ American Friends Service Committee, erano composte da due stanze.
Demontable Wooden House, 1917, Francia
Nel 1936 Wally Byam costruì la prima roulotte aerodinamica, la Durham Portable House, che costava tra i 1˙500 e i 3˙000
dollari, che non solo imitava la casa convenzionale, ma fu anche precursore del “double-wide”, cioè poteva essere trasportata
in due parti e assemblata in loco come singola abitazione (in genere hanno dimensioni che possono raggiungere i 9 metri di
larghezza e i 27 di lunghezza).
La casa mobile non fu il solo successo delle abitazioni prodotte per la grande massa in America prima della Seconda Guerra
Mondiale. Tra il 1908 e il 1940 il venditore americano Sears, Roebuck and Co. Vendette più di 100˙000 case dal proprio
catalogo. Le case venivano vendute in più di 30˙000 parti, complete di istruzioni di assemblaggio e due alberi per il giardino
e per un breve periodo queste case offrirono una valida alternativa alle costruzioni tradizionali. Le case potevano essere
acquistate a un prezzo che andava da 650 per le più piccole, da fi no a 1˙000 dollari per le medie. In più la società garantiva
che “un uomo di medie capacità” poteva costruire con il kit a disposizione, la casa in soli 90 giorni” 8.
“The Winona”, Sears Modern Homes, Akron, Ohio, USA
I PRIMI PROGETTI PER L’EMERGENZA
8 www.searsarchives.com/homes/index.htm

30
In merito al MOMA di New York da luglio a ottobre (2008) vi è la mostra “Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling” che
ripercorre la prefabbricazione in ambito edilizio in America, nella quale vi sono alcuni esempi di case self-made per gli strati
della popolazione meno abbienti (www.momahomedelivery.org).
Nel continente africano, uno degli esempi più signifi cativi di sperimentazione dello stile self-help housing, cioè dell’auto
costruzione, fu il lavoro di Hassan Fathy in Egitto. Nel 1930 Fathy iniziò a sperimentare le costruzioni fatte in mattoni di
fango.Dopo aver costruito alcune case di campagna con i tradizionali tetti a volta e i mattoni di fango, inclusa una sede
dimostrativa per la Mezza Luna Rossa in un villaggio distrutto da un’inondazione, fu chiamato dal Dipartimento delle Antichità
del suo paese per progettare e ricostruire un villaggio, il villaggio di Gourna.
Per Fathy la costruzione della nuova città, vicino ad un sito archeologico, fu l’opportunità per testare le sue idee di
un’architettura basata su sistemi a basso costo di costruzione e con tecniche sostenibili per il territorio, prese direttamente
dalle tecniche costruttive dei suoi avi. Anche perché i nuovi abitanti di Gourna non avrebbero potuto nemmeno permettersi le
tanto pubblicizzate case prefabbricate.
La costruzione si protrasse tra il 1946 e il 1953 ma non si ottenne il risultato sperato per l’incomprensione con gli abitanti che
si aspettavano di avere subito una casa completamente terminata, come fosse l’ennesimo prodotto.
Il problema del self-help housing è che si viene a negare il ruolo stesso dell’architetto, che è relegato al semplice ruolo di
insegnante delle tecniche costruttive.
Hassan Fathy, piano per il villaggio di New Gourna, Egitto, 1946
Allo stesso tempo un altro progetto più fortunato di quello di Fathy fu iniziato dal governo di Puerto Rico per ricostruire e
ridistribuire la terra. A 67˙000 lavoratori agricoli fu dato un piccolo appezzamento che comprendeva 3 acri. La costruzione
delle case iniziò nel 1949, e le famiglie furono organizzate, per tali lavori, in gruppi di 30 persone. Inoltre le famiglie erano
libere di decidere come progettare e costruire le proprie abitazioni utilizzando ogni metodo che potesse avere un senso, che
comprendesse un metodo costruttivo tradizionale o meno. Agli inizi degli anni ’60 erano già state costruite tra le 30˙000 e le
40˙000 piccole abitazioni.

31
Con la Seconda Guerra Mondiale per la prima volta nella storia il numero dei civili morti superò quello dei soldati, la distruzione
delle città e dei paesi non aveva precedenti e praticamente tutta l’Europa doveva essere ricostruita.
Da questo momento in poi l’attenzione dei progettisti si spostò sui rifugi di emergenza, i quali divennero la priorità per dare
un tetto ai milioni di sfollati.
L’architetto fi nlandese Alvar Aalto sviluppò un rifugio di emergenza temporaneo che poteva essere trasportato e utilizzato da
quattro famiglie con un sistema di riscaldamento centralizzato.
Transportable Primitive Shelter, Alvar Aalto, Helsinki, Finlandia, 1939-40 circa
Nell’ottica della ricerca di sistemi e processi idonei a soddisfare le esigenze dell’utenza sfollata ad avere spazi ridotti (quindi
poco costosi) ma sempre più dinamici e fl essibili, in Francia Jean Prouvè propone soluzioni l’impiego di semilavorati industriali
per la produzione di costruzioni per l’emergenza. Tra queste le écoles volantes, scuole per bambini rifugiati, e il Pavillon 6x6.
Quest’ultima unità abitativa fu concepita per rispondere alle richieste di 450 abitazioni provvisorie avanzata dal Ministero
della Ricostruzione francese. La possibilità dell’assemblaggio da parte di pochi uomini e a secco permetteva che questi rifugi
fossero disponibili in breve tempo e senza aggiunta di altri materiali oltre quelli che uscivano dalla fabbrica produttrice.
La copertura si poggiava su puntoni in lamiera che costituivano la struttura principale e veniva successivamente
controsoffi ttata. Il pavimento era in legno, sollevato da terra e sostenuto da una intelaiatura metallica. Gli elementi di chiusura
verticale erano pannelli di legno con anima di alluminio.

32
Interessante, anche sotto l’ottica della diversità culturale tra Europa ed America, è notare come nel continente americano tra
il 1940 e il 1945 circa otto milioni di persone hanno trovato un nuovo alloggio con il programma edilizio nazionale della
National Housing Agency che comprendeva varie tipologie quali: trailers, mobile houses, demountables, dormitories,
temporary houses, ecc.
E sono proprio gli Stati Uniti d’America i pionieri nella progettazione e creazioni di case o semplici “shelter” montabili in poco
tempo e trasportabili.
Le linee di ricerca principali erano due: quella di Richard Buckminster Fuller che utilizzava le industrie che si stavano via
via convertendo dalla produzione bellica e quella dalle varie agenzie per la casa che proponevano delle case facilmente
trasportabili generalmente di legno.
Nel secondo caso, identifi cato dall’alloggio unifamiliare in legno come la portable unit cottage della TVA, Tennessee
Valley Authority, la sperimentazione avveniva tutta in fabbrica e le fasi di montaggio che potevano essere più complicate per
l’acquirente venivano eseguite già in fase di produzione.
Airstream Clipper, Wally Byam, Los Angeles, California, USA, 1936, New Demountable Cottage,T.V.A. Tennessee Valley Authority, 1940
Walter Gropius, durante la sua esperienza ad Harvard intraprese una prestigiosa collaborazione con la General Panel
Corporation.
Insieme a Wachsmann condussero una formulazione più matura ed esaustiva del sistema strutturale prefabbricato.
La loro interpretazione delle strategie connesse con la prefabbricazione intendeva rispondere all’assemblaggio della struttura
tramite la connessione di parti a loro volta assemblate in fabbrica.
La ricerca svolgeva verso il superamento delle rigide schematizzazioni determinate dalla produzione industriale con la volontà
di giungere a combinazioni fl essibili dei vari elementi costituenti l’alloggio garantendo fl essibilità e modifi cabilità.
Scriveva Wachsmann: «Lo sviluppo del modulo degli elementi delle superfi ci universali viene determinato in sostanza da due
condizioni opposte. Mentre un elemento di costruzione dovrebbe venire dimensionato il più grande possibile, per avere un
minor numero di giunzioni, che sono pur sempre i punti più deboli, è necessario nello stesso tempo che esso sia il più
La costruzione del Pavillon 6x6, Jean Prouvè, France, 1944

33
piccolo possibile, perché la sua maggiore o minore utilità dipende dalla sua capacità di adattamento in relazione ad infi nite
combinazioni, sia al momento della progettazione che dell’applicazione».
Konrad Wachsmann e Walter Gropius in cantiere per il montaggio del Package House System. Sullo sfondo le pareti del sistema in fase di allestimento.
Nel 1945 negli Stati Uniti la US Federal Public Housing Autority preparò circa 30˙000 abitazioni temporanee prefabbricate
di prima emergenza da spedire in Gran Bretagna. Le piombature e i fi ssaggi venivano spediti assieme alla struttura, ma non
venivano forniti gli arredi interni.
Houses for Britain, 1945

34
L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA IN RISPOSTA ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
Precedentemente è stata defi nita l’emergenza come una situazione eccezionale, con un livello di gravità che pregiudica il
normale funzionamento delle strutture come possono essere gli ospedali.
Se ci si trova in Paesi industrializzati sarà più semplice che l’emergenza duri un lasso di tempo inferiore rispetto a Paesi in via
di sviluppo e che abbia effetti meno signifi cativi.
Ciò nonostante, nella ricerca condotta per questa tesi, si è visto come ad oggi, la maggior sperimentazione in ambito
architettonico riguardante situazioni di emergenza sia stata fatta attraverso concorsi che vedono come scenario principale
Paesi con un grado di infrastrutture e supporto logistico insuffi ciente, come i Paesi africani o del sud est asiatico.
Vi sono alcuni tentativi di inserire nell’ambito delle città occidentali l’architettura “d’emergenza”, cioè che risponde in maniera
rapida a situazioni precarie, ma i tentativi in genere si risolvono in installazioni temporanee.
Il concetto che lega l’architettura alle emergenze è quello di shelter, cioè di rifugio, che viene defi nito in “Tents, A Guide to
the use of family tents in humanitarian relief” edito dall’ Offi ce for the Coordination of Humanitarian Affair delle Nazioni Unite
come “an habitable, covered living space”, ma viene anche specifi cato che non deve essere solo un tetto, un riparo, ma deve
contenere una serie di comfort, accessori e la possibilità di accedere facilmente ad alcuni servizi. Nel caso dei rifugiati questi
saranno ad esempio dei vestiti, delle coperte, delle stufe, cioè tutte quelle cose che una persona in fuga non può portare con
se.
Per uno shelter ad uso sanitario si dovranno predisporre tutte quelle facilitazioni che permettono un agile lavoro al personale
medico. Al progettista non spetta tanto la defi nizione esatta delle quantità degli accessori, bensì il pensare a tutte le possibili
attività che potrebbero svolgersi all’interno dello shelter, progettando delle soluzioni che permettano l’utilizzo dello spazio in
modo ottimale.
La guida delle Nazioni Unite dà poi delle indicazioni che possono sembrare banali ma che meritano di essere citate per iniziare
a comprendere le primarie necessità di cui bisogna tener presente nella progettazione di uno shelter.
Nel precedente paragrafo “Il ruolo dell’architetto nel progetto per le situazioni di emergenza” venivano specifi cate le
caratteristiche che deve garantire un rifugio, cioè mantenere in un buono stato di salute gli occupanti, garantirne una minima
sicurezza e un grado, anche se minimo, di dignità.
Campo profughi, Macedonia, maggio 1999

35
Nelle emergenze le tende, principale tipo di rifugio, utilizzato dalla maggior parte delle organizzazioni, soprattutto per la facilità
con cui possono essere spedite in tutto il mondo, avendo un facile stoccaggio, assicurano i precedenti fattori nel seguente
modo:
- salute: le tende proteggono dagli agenti climatici esterni (pioggia, neve, vento, polvere, sole);
- privacy e dignità: garantiscono un grado di privacy e un riparo dignitoso alle persone che hanno appena perso tutto;
- sicurezza: provvede a una sicurezza fi sica, riducendo ad esempio il rischio di furti, e da una sensazione di protezione alle
persone che vivono all’interno. I campi devono comunque avere altri sistemi di sicurezza.
- mezzo di sicurezza di supporto: la tenda permette alle persone di allontanarsi per prendere cibo e combustibile,
mantenedo sotto controllo i fi gli e potendo così condurre altre attività essenziali.1
Campo profughi in Etiopia, febbraio 1985
In genere la costruzione di rifugi d’emergenza è strettamente dipendente dalle condizioni locali; ripari possono essere costruiti
con materiali provenenti da edifi ci danneggiati, o reperiti direttamente in loco, come teli di plastica, legno, corde,ecc.
La costruzione di rifugi con questi materiali può coinvolgere attivamente la popolazione, divenendo inoltre disponibili più
velocemente e ad un costo inferiore rispetto alle tende spedite dai Paesi soccorritori.
Teli di plastica, pali, corde in genere sono le prime cose ad essere distribuite dalle organizzazioni umanitarie, in modo tale da
evitare il disboscamento delle aree limitrofe all’accampamento e garantendo la costruzione di tali rifugi in tempi brevissimi.
Deve esserci però la capacità costruttiva delle persone coinvolte; bisogna tener presente che se ci si trova in climi estremi
queste soluzioni non sono però suffi cientemente adeguate. Per questo a volte è preferibile costruire rifugi utilizzando le
tecnologie del luogo, in che modo possano essere costruiti in breve tempo e garantire un riparo più stabile e dignitoso.
Prime due foto: campo profughi di Mokindo, Rwanda, novembre1993; ultima foto: Campo profughi in Congo, dicembre 1995
1 Offi ce for the Coordination of Humanitarian Affair, Tents, A Guide to the use of family tents in humanitarian relief, 2004, United Nations Publication

36
La costruzione di questo tipo di rifugi in alcuni casi può rivelarsi meno costosa del trasporto delle tende; sono inoltre più
appropriati culturalmente e migliori per quella che potrebbe essere una futura riconversione.
Per far fronte a emergenze umanitarie vengono anche fornite delle strutture a tunnel, che per disposizione dell’UNHCR sono
costituiti , per una struttura standard di 7x4m, da:
- 3x6m x tubi per l’acqua in Polietilene a media densità con diametro esterno di 63mm;
- 3x3,6m x 12mm di barre di metallo per l’irrigidimento orizzontale,
- 6x0,5m x 12mm di barre di metallo per il fi ssaggio,
- 1x7m x 4 m di telo di plastica per la copertura,
- 2x2m x 2m di telo di plastica per le porte,
- 32 m di corda.
Il vantaggio di queste strutture è che garantiscono un immediato supporto per i programmi sanitari e per
l’approvvigionamento dell’acqua, quindi in genere vengono utilizzate come supporto logistico.
Tende con struttura a tunnel, prescrizioni UNHCR
Tenda con struttura a tunnel della Croce Rossa

37
Nella progettazione degli shelter per le popolazioni in situazioni di crisi vi sono più approcci. In genere vi sono
progetti che con un livello di tecnologia minimo garantiscono le prestazioni basilari e quelli che, aumentando via via l’apporto
tecnologico, cercano di creare un ambiente più stabile e duraturo nel tempo. Normalmente infatti le soluzioni di base, tipo le
tende, dovrebbero essere utilizzate per un tempo limitato, cioè solo nella prima fase dell’emergenza per poi lasciare posto a
soluzioni sempre più durature fi no al ristabilimento della normalità, anche in ambito architettonico.
Purtroppo però i dati che ci provengono dalle organizzazioni umanitarie non sempre confermano questa evoluzione degli
eventi. Dati UNHCR riportano come la media della permanenza di un rifugiato in un campo profughi è passata dai 9 anni del
1993 ai 17 del 2003, e considerando che il 47% dei rifugiati ha età inferiore ai 18 anni si può facilmente capire l’effetto di
tali dati sulla società del paese colpito: mancanza di scolarizzazione, delle minime garanzie sanitarie, ecc.
Di seguito si presentano alcuni progetti che, con diversi gradi di complessità e tecnologia, possono far comprendere i diversi
approcci progettuali e come vengono risolte le varie problematiche relative agli shelter.
LIGHTWEIGHT EMERGENCY TENT
Location.................................................Varie
Data........................................................dal 2002
Organizzazione......................................UNHCR (Alto Commissariato per I Rifugiati delle Nazioni Unite)
Cliente finale..........................................Rifugiati
Consulente progettuale......................Ghassem Fardanesh
Produttore.............................................H. Sheikh Noor-ud-Din & Sons (Pvt.) Limited, Lahore, Pakistan
Costo per unità....................................≈ 100$
Area........................................................16,5 m2
Occupazione..........................................4-5 persone
Dimensione............................................5,5 x 3 x 2,1m
Peso........................................................41,5 kg
Nei Paesi colpiti dalla guerra o da disastri naturali la presenza delle tende dell’UNHCR è uno dei primi segnali di aiuto alla
popolazione. L’incarico dato ai progettisti era quello di ripensare la tenda base in dotazione all’organizzazione.
Nel tempo sono stati pensate e testate varie soluzioni, dalle strutture prefabbricate, ai container, alle tende di poliuretano, ma
nessuno di questi presidi ha dato un signifi cativo sviluppo all’assistenza ai rifugiati.
Molte soluzioni hanno fallito perché semplicemente altri sistemi di riparo erano già disponibili al momento dell’emergenza e
il tempo per sviluppare soluzioni alternative non era suffi ciente. Altre volte i progetti proposti non sembravano delle soluzioni
temporanee ma avevano carattere “permanente” rendendo da un lato di diffi cile accettazione il loro posizionamento in loco e
dall’altro più diffi cile il ritorno dei rifugiati alle loro case. In altri casi si sono rivelati troppo costosi o di diffi cile produzione in
serie.
Come già visto in genere la distribuzione dei teli di plastica può essere, a seconda della gravità della crisi, la prima soluzione
o l’unica perché è la più semplice per far fronte all’emergenza.
Comunque, nel caso in cui non potesse essere possibile reperire in loco materiali per costruire strutture più permanenti,

38
dove le famiglie non hanno possibilità di trovare accoglienza negli edifi ci comunitari, l’UNHCR provvede a fornire soluzioni più
durature, tipicamente una tenda rigida o una formata da doppio tessuto in tela. Però queste tende non sono resistenti, sono
ingombranti da trasportare e costose da spedire, si deteriorano facilmente e non possono essere stoccate per lungo tempo.
L’usura e gli strappi riducono ancora drasticamente la vita di queste tende.
Nel 2002 l’agenzia ha cominciato a testare nuove tende per le famiglie.
Le tende dovevano essere ben illuminate ed avere una vita più lunga di quelle precedenti.
La prima considerazione che è stata fatta fu quella di ridurne il volume, il peso e le dimensioni in quanto è più costoso spedirle
che produrle; parlando di quantità che vanno dalle 50˙000 alle 100˙000 tende il dato non è trascurabile.
Il risultato progettuale è stato un tunnel per la massimilizzazione degli spazi e la più ampia versatilità.
La produzione attuale prevede che il telo di copertura sia di materiale sintetico, di minor peso (da 110 kg a 41,4 kg) e con la
possibilità di stoccarle in grandi quantità,.
Un telo interno provvede all’isolamento del piano di calpestio e l’aria circola attraverso dei fori e fi nestre riparate con
zanzariere per non permettere la trasmissione della malaria.
Le corde esterne permettono sia l’ancoraggio che il corretto distanziamneto dalle altre tende.
Per garantire la privacy, cosa molto importante per la sicurezza di un campo profughi, soprattutto per evitare violenze su donne
e bambini o attriti tra gruppi, i progettisti hanno dotato ogni tenda di un tessuto che può ripartire lo spazio interno della tenda,
dove le donne possono cambiarsi e i genitori dormire separati dai fi gli.
La partizione può essere utilizzata anche per creare degli spazi semi- pubblici.
L’agenzia inizialmente ha prodotto 10˙000 unità e il nuovo prodotto è stato testato in Ciad (in risposta alla crisi del Darfur) e
nelle aree dell’Indonesia colpite dallo tsunami del dicembre 2004.
Trasporto e montaggio Lightweight Emergency Tent
“In our business it’s really diffi cult to say,
- I have something new, and let’s replace (the old version).-
The tent we have now has been under surveillance for 20 years.
This is a newborn baby.”
Ghassem Fardanesh, senior physical planner, UNHCR

39
In questo progetto è da notare come piccoli accorgimenti possono garantire un grado di comfort più elevato
anche se il rifugio è una struttura di per sé precaria. Far pronte alle più elementari esigenze dell’essere umano e
garantirne un senso di sicurezza in situazioni d’emergenza, fa si che i piccoli progetti possano avere successo.
È già stato citato il libro “Tents, A Guide to the use of family tents in humanitarian relief” dell’ Offi ce for the Coordination
of Humanitarian Affair. Il libro deriva dall’esperienza di numerose organizzazioni quail OXFAM GB, CARE, CHF, UNHCR rac-
colte da Tom Corsellis del Martin Center for Architectural and Urban Studies dell’Università di Oxford, che insieme ad altri
collaboratori ha dato origine al progetto Shelterproject.
SHELTERPROJECT
Data........................................................dal 1997
Progettista............................................Martin Center for Architectural and Urban Studies, University of Cambridge
Team di progetto.................................Joseph Ashmore, Dr. Tom Corsellis, Peter Manfi eld, Antonella Vitale
Partner di progetto.............................Oxfam, Gran Bretagna
Consulenti..............................................Consulenze da numerose organizzazioni umanitarie
Clienti finali.............................................Sfollati
Website.................................................www.shelterproject.org
Nel 1997 il Dr. Tom Corsellis, che aveva già lavorato con organizzazioni umanitarie quali CARE e UNHCR, insieme a un gruppo
di progettisti, cercò di ripensare il rifugio d’emergenza. Per anni il progetto delle tende per le emergenze si è focalizzato su
due problemi: il costo e la facilità di montaggio.
Molte tende venivano costruite con tessuto, che però è pesante e costoso da trasportare, facilmente deteriorabile e non può
essere lasciato in magazzini per lunghi periodi.
Inoltre le tende dovrebbero essere utilizzabili sia in climi rigidi che caldi. Altre volte vengono montate senza pensare a problemi
come il drenaggio dell’acqua, la resistenza al fuoco e altri fattori critici. Conseguentemente le tende sono state utilizzate con
vari gradi di successo a seconda degli scenari e dell’organizzazione dei campi.
Iniziata nel 1995 la collaborazione con OXFAM GB e grazie all’apporto dell’esperienza di altre organizzazioni, è stato possibile
per il team di progetto lo sviluppo di linee guida per le tende che sono state pubblicate nel libro “TENTS”, edito nel 2004.
Più recentemente il progetto di ricerca ha approfondito la tematica dell’organizzazione e pianifi cazione tra lavoro di primo
soccorso e la successiva programmazione dello sviluppo futuro della zona colpita.
Nel 2005 vennero pubblicate le linee guida per un miglior intervento “Transitional Settlements: Displaced Populations”.

40
Studio per la suddivisione in settori di un campo profughi
test delle tende a Bamyan, Afghanistan, febbraio 2003
test delle tende a Panjwai, Kandahar, febbraio 2003

41
SHELTER FRAME KIT _ Q-SHELTER
Location.................................................Varie
Data........................................................dal 1983
Organizzazione......................................World Shelter
Consulente progettuale......................Steven Elias, Bruce LaBel
Partner di progetto.............................Buckminster Fuller Institute
Clienti finali.............................................Popolazione sfollata, campi per operazioni d’emergenza
Costo per unità....................................365$
Superficie...............................................25 m2
Dimensione...........................................7,4 x 3,4 x 2,6m
Dimensione imballaggio......................38 x 38 x152cm
Peso........................................................30 kg
Il progettista Bruce LaBel ha avuto il primo approccio con la progettazione in situazioni d’emergenza dopo il terremoto che nel
1976 ha colpito il Guatemala, poi nel 1977 ebbe modo di lavorare con Buckminster Fuller.
Poi lavorò per la The North Face, che fu la prima ditta ad utilizzare il concetto di Fuller sulla tensegrity nelle sue tende e
dove Bob Gillis con Bruce Hamilton svilupparono la prima tenda impacchettabile con asticelle fl essibili che è la medesima
tecnologia che è stata utilizzate per il progetto del Shelter frame Kit.
Il progetto prevede la costruzione di una tenda attraverso l’utilizzo dei teli di plastica in dotazione all’organizzazione USAID
(United States Agency for International Development) e dei semplici tubi di PVC.
La struttura è derivata chiaramente dai progetti di Fuller e l’aggancio tra il telo di plastica e i tubi è garantito attraverso delle
clip inventate dal designer Robert Gillis chiamate GripCLips.
IL Q-shelter ha tutti i vantaggi relativi alla leggerezza, alla trasportabilità e al facile montaggio delle tende, ma ne eredita anche
gli svantaggi. La ventilazione è relegata alle aperture usate come ingresso, l’isolamento viene effettuato attraverso l’utilizzo di
un secondo telo, soluzioni che accoppiate aumentano la possibilità di avere la formazione di condensa interna.
Tenda medica allestita in Uganda, consegna di un Shelter Frame Kit a dei medici dello Sri Lanka colpiti dallo tsunami del 2004

42
GRIDCLIPS
Location.................................................Varie
Progettista............................................Robert Gillis
Produttore.............................................Shelter System
Costo......................................................8-10$ per il set da 4 elementi
Il progetto è una semplicissima soluzione per il fi ssaggio dei teli alle strutture delle tende. La clip è adatta per tutti i tipi di teli
e per i più utilizzati sistemi di fi ssaggio, quali fascette di plastica e metallo ma anche semplici cordini.
È composta da due elementi: il primo viene fi ssato alla struttura, mentre il secondo viene incastrato al primo dopo aver
posizionato il telo di plastica. La semplice rotazione del secondo elemento sul primo crea un incastro grazie al particolare
disegno delle due parti.
Una tenda fi ssata alla struttura con i GridClips

43
Ci sono invece dei progetti che mirano a garantire una più dignitosa vita alle popolazioni disagiate e che vogliono superare
le problematiche sia tecnologiche, come la ventilazione, ma anche sociali, come il fatto di vivere in un ambiente diverso dal
proprio abituale luogo domestico.
Ma questo spesso si scontra con la proibizione dei governi a costruire degli alloggi permanenti agli sfollati, sia perché essi si
trovano in territorio straniero, sia per la preoccupazione di una edilizia selvaggia.
Quindi il progettista si trova a dover mediare tra le esigenze delle vittime e le restrizioni burocratiche.
A questo proposito una soluzione interessante è il progetto Bold (Building Opportunities and Livelihoods in Darfur).
BOLD
Location.................................................Darfur , Sudan
Data........................................................2004-05
Organizzazione.....................................CHF International
Progettista............................................Scott Mulrooney, Isacc Boyd
Consulente progettuale......................Richard Hill
Maggior finanziatore...........................USAID
Clienti finali............................................Popolazione sfollata
Costo per unità....................................90$
Superficie...............................................6,5m2
Il progetto prevede la creazione di shelter che usino le tecniche costruttive tradizionali e dalla forma tipica delle rakubas, cioè
le tipiche costruzioni in bamboo del Sudan.
Le costruzioni hanno infatti una struttura di bamboo che è tenuta insieme attraverso pneumatici e corde di materiale riciclato
ed è ricoperta dai tipici tessuti in fi bra vegetale.
Le abitazioni “Bold” montate e utilizzate dai rifugiati

44
GLOBAL VILLAGE SHELTER
Location.................................................Grenada
Data.......................................................1995 - 2005
Progettista............................................Ferrara Design Inc.
Team di progetto.................................Daniel A. Ferrara, Jr., Mya Y. Ferrara
Consulente per i materiali..................Ferrara Design Inc., Weyerhaeuser, Inc.
Produttore.............................................Weyerhaeuser, Inc.
Maggior finanziatore...........................Architecture for Humanity, Weyerhaeuser, Inc., Ed Plant, e altre donazioni private
Clienti finali............................................Popolazione sfollata
Costo per unità....................................400$
Durata del prodotto............................8-12 mesi
Il team di progetto formato da padre e fi glia e arrivata al progetto dell’elegante, semplice, relativamente a basso costo, rifugo
dopo aver sperimentato più di 100 differenti confi gurazioni.
Fatto con cartone laminato corrugato, il rifugio può essere montato in meno di un’ora da due persone usando solamente un
set di informazioni per il montaggio.
Il cartone ha la funzione di irrobustire, dare privacy e permettere un facile trasporto del rifugio.
Solamente tre ditte che trattavano il cartone erano disponibili per la realizzazione, ma solo la Weyerhaeuser, Inc. era in grado
di trattare lastre di cartone corrugato così grandi da permettere la realizzazione completa del rifugio.
Lavorando con la stessa ditta la prima idea venne perfezionata riuscendo a fornire un miglior isolamento e una resistenza
maggiore all’acqua. Si decise di impregnare il cartone con un prodotto ritardante la combustione e dotando la porta d’accesso
di una chiusura meccanica per garantire la sicurezza degli occupanti.
Purtroppo, come ogni struttura trasportabile e temporanea i costi per le spedizioni sono molto maggiori rispetto ai costi della
produzione. La Weyerhaeuser, Inc. ha stimato che 88 unità possono essere stivate in un container standard da spedizione, in
rapporto a 500-1000 tende.
Un campo di prova fu l’isola Grenada, in cui un uragano aveva pressoché distrutto l’85% delle abitazioni.
Furono montati 70 rifugi distribuiti nelle aree rurali per essere utilizzate come abitazioni transitorie e cliniche ambulatorie.
I rifugi sono stati appositamente studiati per durare poco tempo, anche su suggerimento delle Nazioni Unite, in quanto
strutture troppo resistenti possono successivamente ritardare il rientro della popolazione nelle loro case e creare situazioni di
nuova povertà.
Montaggio e moduli assemblati

45
Global Village Shelter, istruzioni di montaggio
Lo studio Ferrara Design Inc., come tutti i progettisti che si trovano a lavorare sull’architettura per l’emergenza, sono
consapevoli del fatto che progettare un nuovo rifugio che possa competere con la tenda è un’operazione quasi impossibile.
Le persone che si trovano in situazioni critiche diffi cilmente accettano drastici cambiamenti. Per loro è diffi cile anche pensare
ad una spesa maggiore per un riparo quando ogni centesimo è fondamentale per la sopravvivenza.
È per questo che molte soluzioni rimangono solo dei progetti, come il caso di 139 Shelter e Concrete Canvas.
139 SHELTER
Location.................................................Etiopia
Data.......................................................1989, ma mai costruito
Progettista............................................Future System
Team di progetto.................................Jan Kaplicky, David Nixon
Consulente strutturale.......................Atelier 1
Ingegneria meccanica.........................ARUP (Ove Arup & Partners)
Maggior finanziatore...........................Architecture for Humanity, Weyerhaeuser, Inc., Ed Plant, e altre donazioni private
Persone coinvolte................................200
Persone per l’assemblaggio..............12 persone in 30 minuti
Dimensioni.............................................500m2
Costo per unità....................................30˙000$
Furono le immagini della popolazione etiope affamata e che assaliva i centri di distribuzione del cibo nel 1985 che spinse Jan
Kaplicky e David Nixon a progettare 139 Shelter. Voleva essere un riparo per la popolazione che dal nord del paese andava
verso sud. Il rifugio può ospitare fi no a 200 persone, può essere facilmente trasportato con un aereo cargo e poi agganciato
a un camion o paracadutato. Una volta in sito necessita di 12 persone per essere assemblato.
La forma è ad ombrello ed ancorata al terreno con sacchi di sabbia. La copertura di Pvc, rifl ettendo più dell’80% del calore
solare, garantisce un’effi cace zona d’ombra durante il giorno ed un effi cace riparo durante le notti più fredde.
La ventilazione è garantita da una ventola centrale.

46
Metodi di trasporto
Meccanismo di apertura
Sistema di ventilazione

47
CONCRETE CANVAS
Data.......................................................2003-2004
Team di progetto................................Peter Brewin, William Crawford
Dimensioni............................................16m2 - 230 kg
Costo per unità...................................2˙000$ (prototipo)
Website.................................................www.concretecanvas.org.uk
Inventato da Peter Brewin, William Crawford, ingegneria al Royal College of Art, “Concrete Canvas” è un “edifi cio in una
sacca”. Gonfi ata la sacca, 12 ore dopo il rifugio è pronto per essere utilizzato.
Entrambe i progettisti hanno avuto precedenti esperienze militari prima di iscriversi al Royal College e sono convinti che
questa soluzione potrebbe essere utilizzata in scenari di crisi, per cliniche mobili in situazioni di emergenza medica o come
luogo per stoccare cibo e materiale.
Il funzionamento è il seguente: si prende la sacca di tessuto impregnato di cemento e la si riempie di acqua (la dimensione
della sacca controlla la giusta quantità che deve essere usata, eliminando quella in eccesso).Si lascia in posa per 15 minuti
in modo che il cemento si reidrati ed una matrice di fi bre tessili insieme ad un agente legante acqua-assorbente, producono
una reazione chimica che miscela il cemento.
Poi, si apre la struttura, che viene gonfi ata come un materassino ad aria attraverso un pacchetto chimico che rilascia un
volume controllato di gas. Una volta gonfi ata la si lascia in posa fi nchè non indurisce e successivamente si tagliano le porte e
i fori per la ventilazione. Infi ne si lascia che la struttura indurisca per tutta notte.
Il risultato è una sottile struttura in calcestruzzo di 16 m2. Una fodera aderente all’interno di plastica provvede a creare un
ambiente sterile impermeabilizzato.
Sebbene l’idea di poter avere un rifugio resistente che può essere riposto in uno zaino è ottima, il peso e la necessità di
avere a disposizione una grande quantità di acqua, fa si che questa idea debba essere maggiormente sviluppata e non sia
immediatamente utilizzabile in scenari di crisi in corso in Paesi non industrializzati.
Montaggio con relativa tempistica; posizionamento, idratazione, gonfi aggio, fi niture
Due elementi montati e interno del Concrete Canvas

48
Uno dei problemi principali nella creazione degli shelter è il reperimento dei materiali che magari si pensa di trovare in
loco. Nel progetto precedente la disponibilità d’acqua veniva data per scontata, senza tener conto che in una situazione di
emergenza questa può scarseggiare, sia perché il luogo può esserne privo (Paesi in via di sviluppo) sia perché le infrastrutture,
quali le tubature o le strade che potrebbero essere utilizzate da mezzi con cisterne, potrebbero essere danneggiate (Paesi
sviluppati). Naturalmente se si dispone di un apparato di tipo militare questi problemi possono essere superati in tempi brevi
grazie allo spiegamento di mezzi, ma ciò non può essere garantito se ci si trova ad agire in campo civile.
Il reperimento del materiale in loco è comunque un problema tenuto in grande considerazione dalle agenzie dell’ONU. Infatti
il ricorso senza controllo a materiale da costruzione locale per far fronte alla prima emergenza può provocare successivi gravi
danni nella gestione della crisi. Il disboscamento di ampie zone per reperire legname per la costruzione provoca la distruzione
della vegetazione e di conseguenza anche la mancanza di zone ombreggiate, l’evaporazione dell’acqua e la sua dispersione.
Da queste considerazioni nacque la collaborazione tra l’architetto Shigeru Ban e l’UNHCR.
PAPER TUBE EMERGENCY SHELTER
Location.................................................Byumba Refugee Camp, Rwanda
Data.......................................................1999
Progettista............................................Shigeru Ban
Progetto e prototipo...........................Primavera 1995 – luglio 1996
Costruzione e montaggio...................Febbraio – Settembre 1999
Committente........................................UNHCR
Cliente finale.........................................Rifugiati ruandesi
Finanziatore..........................................UNHCR
Un tipico campo profughi e un campo attrezzato con gli shelter progettati da Shigeru Ban
Nel 1995 Shigeru Ban fu chiamato dall’ UNHCR per progettare delle dimore temporanee per più di 2 milioni di ruandesi che
scappavano dal genocidio in corso per trovare rifugio in Tanzania e Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo).
Il progetto nella sua forma fi nale arrivò dopo una serie di ipotesi sui possibili materiali utilizzabili (bamboo, alluminio,
plastica e tubi di cartone). Numerosi fattori portarono alla scelta fi nale dei tubi di cartone. In primo luogo il grave problema
della deforestazione per la richiesta di legname da parte dei rifugiati per la stessa costruzione di ripari improvvisati. In secondo
luogo i tubi di cartone sono poco costosi e di facile trasporto. Infi ne era anche possibile produrre gli stessi in loco, riducendo
così le spese di spedizione, il tempo di attesa e gli scarti di lavorazione.
La costruzione di tre prototipi, avvenne nella primavera del 1995. Questi rifugi, che venivano coperti da teli di plastica di 4 x
6 m e garantivano la copertura di 16 m2, furono costruiti in collaborazione con Vitra e testati per garantirne la manutenzione,
i bassi costi di produzione e la resistenza termica.
La prima tipologia venne costruita come una semplice tenda a forma triangolare con un tubo di cartone posto in
corrispondenza della fi ne di ogni timpano e delle corde a garantire la giusta tensione.
La seconda fu costruita come un rifugio assimetrico che permette un utilizzo più funzionale dello spazio interno rispetto al
primo modello. I tubi di catone creano una forma a V in corrispondenza di ogni fi ne timpano e le corde permettono di mettere
in tensione la struttura.
L’ultimo prototipo, più grande e con 3 fogli di plastica (uno grande e due più piccoli) può essere connesso ad altri moduli
dello stesso modello alla fi ne dei timpani. Questo modello permette un’area coperta maggiormente utilizzabile, rendendola
disponibile per piccole cliniche o altri servizi.

49
I tre prototipi proposti
Il terzo fu il prototipo scelto per essere utilizzato dall’UNHCR. Dopo vari test da Vitra, il rifugio fu trasferito nel Luglio 1996 nel
giardino delle nazioni Unite a Ginevra per la presentazione fi nale all’ UNHCR.
Nella seconda fase di progettazione fu esplorata la possibilità della produzione in loco. Nel febbraio 1997, specialisti della
Sonoco, fabbrica di tubi di cartone, sono andati al centro logistico di Medici Senza Frontiere a Bordeaux in Francia portandosi
un macchinario e il materiale per la produzione dei tubi, volendo dimostrare la fl essibilità della produzione anche in larga
quantità nei luoghi delle emergenze. Per Ban la fase finale del progetto, nel 1999, è stata quella del monitoraggio
delle costruzione di 50 rifugi.
L’evento che fece capire la necessità della costruzione di abitazioni più stabili per le persone che improvvisamente non
avevano più la propria casa, fu il terremoto che colpì il Giappone, in special modo la città di Kobe, nel 1995.
Infatti in quel caso Ban potè affrontare e testare in tempo reale i suoi progetti.
La prima soluzione fu quella di spostare le residenze temporanee fuori dal centro cittadino, ma fu subito chiaro che i campi
provvisori allestiti in centro città continuavano a persistere perché vicini ai luoghi di lavoro.
Quindi Ban con i suoi studenti costruirono le prime 21 case in tubi di cartone (Paper Long House) vicino ai maggiori centri di
produzione. Queste case vennero poi migliorate con l’esperienza del terremoto del 1999 in Turchia e del 2001 in India.
Pagine dall’allegato D, procedure di assemblaggio dal manuale edito per i Paper Tube Shelter

50
Pagine dall’allegato D, procedure di assemblaggio dal manuale edito per i Paper Tube Shelter
Allestimento dei Paper Tube Shelter nel campo profughi di Byumba in Ruanda, 1995-1999

51
Il problema ambientale durante le fasi di emergenza è sempre più tenuto in considerazione. Infatti la scarsa attenzione a tale
tema durante la fase pianifi catrice degli interventi e durante gli stessi può provocare, come per altro già detto, delle situazioni
critiche nell’immediato futuro. Così, come Shigeru Ban nelle sue Paper House, sempre più progetti mirano alla salvaguardia
ambientale anche attraverso la corretta progettazione di shelter e costruzioni permanenti.
BAREFOOT COLLEGE
Location................................................Tilona, Rajasthan, India
Data.......................................................1986-89
Progettista capo.................................Bunker Roy
Team di progetto................................Bhanwar Jat, Neehar Rain e Barefoot Architects, strutture geodetiche di Rafeek
Mohammed e Barefoot Architects.
Costruttori...........................................Bhanwar Jat con abitanti del posto
Clienti finali...........................................Abitanti di Tilona
Maggior finanziatore..........................Social Work e Research Center, Governo indiano, Nazioni Unite, German Argo Action,
HIVOS- Humanist Institute for Development Cooperation, Plan Internazional
Costo.....................................................21˙430$
Superficie..............................................2800 m2 (sito 35000 m2)
All’interno della costruzione del Barefoot Colege a Tilona, nella regione del Rajasthan, in India, gli architetti impegnati nella sua
costruzione hanno utilizzato le cupole geodetiche ideate da Buckminster Fuller come elemento integrante di una architettura
sostenibile. Infatti il problema della deforestazione in questa regione dell’India è urgente ed allarmante a causa del taglio
indiscriminato del legname per la costruzione delle tipiche case.
Rafeek Mohammed e sette altri architetti del programma hanno costruito le cupole con materiali di scarto dell’agricoltura,
inclusi i pezzi non più utilizzati dei carri e alcune sezioni delle pompe. Le hanno poi ricoperte con paglia, conferendo così
un aspetto tradizionale a queste nuove costruzioni. Le strutture geodetiche sono tutt’ora utilizzate come laboratori medici,
dispense, uffi cio postale e internet caffè.

52
Ci sono poi progetti che nascono specifi catamente per essere utilizzati nell’ambito delle grandi metropoli, per dar modo alle
persone meno abbienti di aver a disposizione un luogo da chiamare casa, un luogo i cui rifugiarsi, anche se non rispecchia
l’idea tradizionale di “domesticità”. Sono progetti che si confrontano strettamente con il concetto di existens minimum e che
alle volte, come si potrà vedere successivamente, arrivano a confondersi con la performance artistica, con la sola differenza
che il performer, in questo caso, è una persona in evidente stato di emergenza abitativa.
DOMEVILLAGE
Location................................................Los Angeles, California, USA
Data.......................................................dal 1993
Concept................................................Ted Hayes, Craig Chamberlain
Progettista...........................................Craig Chamberlain
Organizzazione....................................Justiceville, Usa
Cliente finale........................................Senzatetto
Maggior finanziatore..........................IARCO Corporation
Costo totale.........................................250˙000$
Costo per unità..................................10˙000$
Area per unità.....................................29 m2
Il Dome Village consiste in 20 sfere ognuna di 6,1m di diametro e alta 3,6m con una superfi cie di 29 m2 .
Ogni sfera è formata da 21 pannelli di fi bra di vetro e poliestere poi uniti con 150 bulloni di Tefl on, rendendo la struttura
impermeabile. In meno di 4 ore, due persone possono assemblare una Omni-Sphere usando una scala, un cacciavite e una
chiave inglese. È stato progettato per offrire un riparo stabile ai senzatetto e cercare così di ridare una prospettiva di vita alle
persone che non posseggono nulla.
L’interno di una Dome

53
Per fi nire questa rassegna di progetti sviluppati per far fronte a situazioni di emergenza si segnalano alcuni progetti che non
riguardano strettamente il campo architettonico, ma sono forse più vicini al mondo del design. Questo per dimostrare come il
processo della progettazione, che si tratti di un rifugio, di una casa o di un semplice recipiente richiede lo stesso iter, cioè una
fase di individuazione delle problematiche, lo stato delle condizioni in cui dovrà inserirsi il progetto, l’utilità e la fattibilità,ecc.
Ancora una volta si può vedere come soluzioni low-tech possono convivere con tecnologie hig-tech e che le une non
escludono le altre. Si tratta solamente di vedere in che modo si può dare risposta nel modo ottimale alle richieste che vengono
fatte al progettista.
paraSITE
Location................................................New York, Baltimora, Boston, Cambridge
Data.......................................................dal 1998
Progettista...........................................Michael Rakowitz
Consulenti............................................vari senzatetto
Cliente finale........................................senzatetto
Finanziatore.........................................autofi nanziato
Costo totale.........................................5$
Website................................................www.michaelrakowitz.com
paraSITE è un rifugio temporaneo per persone che vivono in strada. Il riparo è un elemento gonfi abile costruito da due fogli di
plastica e un nastro (materiali facilmente reperibili dai senzatetto).
Una serie di tubi vuoti interconnessi creano una struttura che ha come parte fi nale un singolo tubo.
Per gonfi are la struttura bisogna connettere la parte fi nale agli sfi atatoi degli impianti di ventilazione degli edifi ci. Il calore
attraversa i tubi e gonfi a la doppia membrana strutturale, creando istantaneamente un riparo caldo. Al mattino il riparo può
essere semplicemente ripiegato e riposto in una borsa facilmente trasportabile.
Rakowitz ha costruito il primo prototipo nel 1997 a Cambridge, nel Massachussetts, per un senzatetto di nome Bill Stone. Da
quel giorno ha costruito 30 prototipi di paraSITE, ognuno personalizzato per ogni utilizzatore fi nale.
Un altro lato di questo progetto è il fatto che, dovendosi attaccare ai sistemi di ventilazione degli edifi ci, paraSITE diventa un
elemento visibile e che denuncia agli abitanti più benestanti il dilagare del problema delle persone che non hanno più una
casa, problema in aumento negli Stati Uniti d’America.
paraSiITE può essere trasportato dai senzatetto in una borsa e all’occorrenza posizionato alle prese d’aria, fatto che attira l’attenzione dei passanti

54
HIPPO WATER ROLLER
Location................................................Sud Africa
Data.......................................................dal 1993
Progettista...........................................Grant Gibbs
Team di progetto................................Pettie Petzer, Johan Jonker
Produttore...........................................Imvubu Projects
Consulenti esterni..............................Robin Drake, Piet Hickley
Maggior finanziatore..........................Africa Foundation
Costo per unità...................................circa 75$
Website................................................www.hipporoller.org
Il progetto Hippo Water Roller ha permesso a migliaia di donne e bambini di poter trasportare l’acqua necessaria al
sostentamento giornaliero delle famiglie senza doversi caricare sulle spalle innumerevoli quantità d’acqua in recipienti in
genere contenenti 20 litri.
L’idea principale del progetto è stata quella di non dover per forza caricare l’acqua sulle spalle, ma semplicemente farla
rotolare all’interno di un contenitore in polietilene cilindrico di 90 litri. Il sistema permette alle persone di trasportare molta più
acqua e un notevole risparmio di tempo; inoltre il peso percepito facendo rotolare il contenitore è di 10 kg contro i 90 kg che
si avrebbero se l’acqua venisse trasportata con i tradizionali metodi, con un notevole vantaggio per la salute delle persone che
trasportano i contenitori e della famiglia che può avere a disposizione più acqua per cucinare e per la propria igiene.
L’Hippo roller in una foto da catalogo

REPORT
55
SHIGERU BAN | I PAPER TUBE
Shigeru Ban ha costruito la sua prima struttura in paper-tube nel 1989, chiamata Paper Arbor (un padiglione per il
World Design Expo a Nagoya in Giappone) ed ha continuato la ricerca raggiungendo espressioni formali di alto livello, come
dimostrano le esperienze del Japan Pavilion per l’Expo di Hannover del 2000 e il Paper Arch del museo di arte moderna di
New York.
Nell’analisi di questi edifi ci si potrà facilmente capire come l’innovazione all’interno dell’architettura può percorrere due
strade, come per altro già anticipato precedentemente: quella che vede un apporto di innovazione relativamente basso,
low technologies, cioè tecnologie desunte dall’esperienza e in genere a basso costo; e quella della high technologies, cioè
tecnologie ad alto contenuto di innovazione, in genere derivati da settori in cui gli investimenti nella ricerca sono signifi cativi,
come quello aerospaziale o dei trasporti.
Nel capitolo riguardante le soluzioni tecnologiche utilizzate nelle architetture mobili si avrà modo di approfondire tale tema, ma
è necessario, per comprendere il lavoro di Ban con i paper-tube, “dire che i termini e i concetti «avanguardia» e «tradizione»,
applicati alla civiltà orientale, non hanno signifi cato, o meglio, hanno signifi cato solo se li si intende come concetti e termini
opposti: in tale civiltà, infatti, essi vanno intesi come sinonimi di «innovazione» e di «stabilità» in una relazione reciproca di
dipendenza.” 1
“In campo architettonico tale approccio trova esempi signifi cativi nelle esperienze di Toyo Ito, Kazuyo Sejima e Shigeru Ban,
le cui opere danno continuità alla cultura giapponese pur impiegando un linguaggio architettonico e tecniche costruttive tese
alla ricerca del nuovo.” 2
Ban è un esempio di progettista che sa muoversi tra soluzioni progettuali che percorrono la strada dell’ high-tech, come nel
caso della Neked House, e soluzioni che invece privilegiano il low-tech, come le abitazioni Paper Log House.
In un’intervista della rivista Detail, Ban ha detto “Cerco sempre di lanciare nuove idee, ma non ho «inventato» nulla; utilizzo
materiali standard, solo in modo nuovo”.
Dai dati tecnici reperibili sulle strutture in paper-tube, per le Paper House si nota come c’è stata una grossa fase di verifi ca
delle proprietà meccaniche della nuova struttura che si è svolta tra il 14 ottobre e il 20 novembre 1991, nel dipartimento di
Scienze e Ingegneria della Scuola di Architettura a Tokyo.
Nel caso in esame i tubi di cartone sono utilizzati come delle vere colonne. Lo scopo di una parte degli esperimenti era quello
di indagare la risposta, entro tempi brevi, del papaer-tube attraverso un test a piegatura (bendino test), a compressione e a
taglio. I tubi utilizzati avevano diametro esterno di 280mm e quello interno di 250mm.
1 G. Pasqualotto, Yohaku, Forme di ascesi nell’esperienza estetica orientale, Esedra, 2001, Padova in Nicola Sinopoli, Valeria Tatano, a cura di, Sulle tracce dell’innovazione.
Tra tecniche e architettura, Angeli, 2002, Milano.
2 Nicola Sinopoli, Valeria Tatano, a cura di, Sulle tracce dell’innovazione. Tra tecniche e architettura, Angeli, 2002, Milano.

REPORT
56
“The average compressive strenght of paper tube was 113.9 kgf/cm2”
“The bending strenght is more than 1.42 times the compressive strength”
“The single shear strength was 581 kgf per lag screw”3
Paper Log Houses
A Kobe, a Kaynasli e a Bhuj le Paper Log House vennero costruite per dare un riparo alle
migliaia di persone sfollate dopo i violenti terremoti che avevano colpito tali città.
Le Log House, di 4m2, erano costruite con travi di cartone e con muri fatti di tubi dal
diametro di 108mm e spessi 4mm.
La base fu costruita con casse di birra collegate con sacchi di sabbia. Il soffi tto e il tetto,
ognuno dei quali rivestito con una membrana di PVC, furono separati per permettere la
circolazione dell’aria, mantenendo fresco l’interno d’estate con l’apertura del timpano e
invece lasciandolo caldo in inverno attraverso la sua chiusura.
Quando le famiglie numerose necessitavano di avere due unità collegate si creava
un’area comune tra le due parti in cui i tetti venivano collegati.
Per ogni casa era necessario disporre di 10 operai, incluso il capomastro.
Le prime 6 case si poterono costruire in sole otto ore e, di seguito, ne vennero costruite
21 nel giro di un mese al costo di 250˙000 yen l’una (1˙500 euro circa). Queste case
erano meno costose e più facili da montare rispetto alle tradizionali case prefabbricate e
il fatto di essere facilmente riciclabili contribuì al successo del progetto.
In Turchia le case vennero costruite invece con una dimensione di 18m2, fatto dovuto
alla dimensione di produzione del compensato nel Paese. Inoltre le case vennero meglio
isolate attraverso l’inserimento di carta da scarto all’interno dei tubi lungo le pareti e
l’utilizzo di fi bra di vetro nel soffi tto.
Nel caso indiano invece, vi furono problemi nel reperimento di alcuni materiali come
le casse di birra da utilizzare per la base. Per questo si decise di utilizzare il pietrisco
ricavato dalle macerie degli edifi ci distrutti per poi costruirci sopra un pavimento in fan-
go, tipico della tradizione costruttiva locale come la stuoia tessuta con canne la quale,
accoppiata con un mantello di plastica chiara cerato proteggeva l’interno dalla pioggia.
La ventilazione veniva garantita attraverso dei fori nella stuoia del frontone caratteristica
che diede la possibilità alle donne di cucinare all’interno della casa, evitando il fastidioso
problema delle zanzare.
Quindi si può notare come la tecnologia dei peper-tube e del loro assemblaggio è stata
mutuata a seconda delle esigenze e delle caratteristiche costruttive del luogo.
Location: Nagata, Kobe, Giappone
Data: settembre 1995
Ing. strutturali: Minoru Tezuka, TSP
Taiyo
Location: Kaynasli, Turchia
Data: Gennaio 2000
Arch. associati: Mine Hashas, Hayim
Beraha, Okan Bayikk
Location: Bhuj, India
Data: Settembre 2001
Ing. strutturali: Kartikeya Shodhan
Associates
Kobe, shelter allestiti prima dell’arrivo
delle Paper Log House; Paper Log House
e montaggio.
3 Matilda McQuaid, Shigeru Ban, Phaidon Press, 2003, Londra

REPORT
57
Paper Log House, Bhuj, India, 2001: esploso assonometrico; interno di una Log House usata come scuola; interno.
Paper Log House, Kaynasli, Turchia, 1999: fasi della costruzione.
Paper Log House, Kobe, Giappone, 1995: esploso assonometrico; interno.

REPORT
58
Paper Church
La costruzione della Paper Church fu fatta accanto alle macerie della chiesa di Takatori a
Kobe. La comunità era per la maggior parte composta da rifugiati vietnamiti le cui case
furono a loro volta rase al suolo dal terremoto che ha colpito la città nel 1995. la pianta
rettangolare di 10x15m ha una pelle di rivestimento in pannelli di policarbonato. La parte
frontale e metà di ogni lato laterale può essere aperto, facilitando la ventilazione interna
e permettendo, in caso di necessità, la partecipazione ai riti anche a numerose persone
che altrimenti non avrebbero potuto entrare nella chiesa.
Lo spazio interno è reso dinamico dalla disposizione ovale dei 58 paper-tube di 5m di
altezza, con diametro di 33cm e 15cm di spessore, e può contenere 80 persone.
Location: Nagata e Kobe, Giappone
Data: settembre 1995
Ing. strutturali: Minoru Tezuka, TSP
Taiyo
Paper Church: montaggio
Paper Church: interni; esploso assonometrico; particolare del l’interfaccia paper-tube - tetto; estremo.

REPORT
59
Paper Dome
La Paper Dome è uno shelter permanente progettato da una specifi ca richiesta di un
contractor di case in legno.
Le richieste del cliente furono chiare fi n dall’inizio. Il riparo di 28x25m doveva essere
progettato considerando che doveva essere agevole per i lavori esterni di movimentazione
del materiale della ditta, particolarmente resistente alla neve e il sistema di assemblaggio
doveva essere così facile da poter essere fatto dai carpentieri del cliente stesso.
Il progetto di Ban prevedeva la costruzione di un arco di 27.7m, con un altezza massima
di 8m, realizzato con tre materiali accoppiati. Siccome non potevano essere prodotti
dei paper-tube così grandi e curvi senza una perdita delle caratteristiche meccaniche
tipiche, si dovettero creare 18 segmenti per ogni arcata, ognuno di 1.8m e di diametro
esterno di 29cm, connessi tra loro con giunti in legno laminato.
Trasversalmente, un sistema di 28 segmenti lunghi 0.9m e 14cm di diametro, si
connettono alle arcate in modo da garantire la rigidezza strutturale.
I paper-tube vennero resi impermeabili attraverso del poliuretano trasparente spalmato
prima dell’assemblaggio, in modo da minimizzare l’espansione e la contrazione degli
elementi dovute all’umidità e ai cambiamenti estremi delle temperature tipici della
zona.
La rigidezza laterale venne ottenuta mediante uno strato di compensato posato
esternamente al reticolo strutturale dei paper-tube; inoltre tali pannelli vennero ricoperti
con fogli di policarbonato corrugato.
Cavi in acciaio in tensione e rinforzi sempre in acciaio, vennero aggiunti per garantire
la sicurezza della struttura anche sotto carichi eccezionali come quelli dovuti al grande
accumulo di neve.
Paper Dome: interno ed esploso assonometrico della copertura
Location: Masuda, Giappone
Data: gennaio 1998
Ing. strutturali: Minoru Tezuka, VAN
structural design
Paper Dome: esterno e particolare
copertura

REPORT
60
Japan Pavilion
Il padiglione fu progettato per l’Expo di Hannover del 2000 dal titolo
“Humankind-Nature-Technology: A New World Arising”, sulla scia dell’idea dello sviluppo
sostenibile e dell’Earth Summit tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992.
Shigeru Ban ha collaborato per la realizzazione dell’opera con Frei Otto, architetto e
ingegnere strutturale conosciuto per le costruzioni con tensostrutture, proponendogli la
realizzazione di un tunnel di 74x25x16m.
Partendo dalla considerazione che i paper-tube possono essere fabbricati con qualsiasi
lunghezza, l’idea era quella di costruire una struttura a griglia tridimensionale senza
alcun tipo di giunto tra i cilindri di carta.
Questo avrebbe anche permesso di abbattere i costi per l’acquisto dei giunti.
L’accortezza fu quella di richiedere tubi lunghi 20 metri per poterli facilmente trasportare
e l’utilizzo di collegamenti di legno per evitare quelli classici e costosi metallici.
Il team di progetto decise di adottare infatti un sistema di unioni fl essibili per collegare le
varie parti della griglia tridimensionale che doveva essere sollevata da terra per prendere
poi la caratteristica forma una volta elevata. Inoltre sia Ban che Otto vollero che questi
sistemi derivassero da un materiale low-tech, come il tessuto o del nastro metallico, in
accordo con il tema dell’Expo. Il nastro avrebbe permesso il collegamento dell’angolo tra
i tubi e il successivo sollevamento per creare la curvatura tridimensionale. Otto propose
anche una cornice rigida esterna formata da archi accoppiati a due a due, con dei pioli
a collegamento, e dei puntoni a unione degli stessi archi accoppiati. Questa soluzione
avrebbe permesso una maggiore rigidezza alla struttura, l’aggancio della membrana che
avrebbe fatto da copertura e la futura manutenzione della struttura.
Japan Pavilion: esploso assonometrico della copertura; vista interna ed esterna
Location: Hannover, Germania
Data: maggio 2000
Consulente: Frei Otto
Ing. strutturali: Buro Happold
Japan Pavilion: particolare

REPORT
61
Paper Arch_ The Museum of Modern Art
Per le celebrazioni del nuovo millennio il Museo di Arte Moderna di New York ha fatto
costruire a Ban un arco alto 9.1m, con una apertura di 26.5m all’interno del giardino
dello Sculpture Garden all’Abby Aldrich Rockefeller, trasformando questo spazio in una
monumentale sala esterna.
Il museo aveva già commissionato, nella sua storia, delle architetture temporanee; iniziò
nel 1949 con il tema “House in the Garden” proposto a Marcel Breuer, per fi nire 10 anni
dopo con le “Tre strutture” di Richard Buckminster Fuller.
La produzione e costruzione dell’arco avvenne in una ditta di impalcature a Maspeth,
poco fuori New York.
La struttura venne divisa in otto segmenti e trasportata al museo, dove venne sollevata
mediante una gru e poi unita nuovamente. La curvatura dell’arco è il risultato dell’azione
del peso proprio della struttura stessa.
I collegamenti tra i vari peper-tube avvenne sia tramite fascette di plastica che tramite
tiranti d’acciaio.
Paper Arch: particolari e vista dall’alto
Location: New York, Usa
Data: aprile 2000
Arch. associati: Dean Maltz, Kamonsin
Chathurattaphol
Ing. strutturali: Takenaka Corp.
Progetto esecutivo: Buro Happold
Consultino Engineers
Paper Arch: particolare

REPORT
62
Boathouse, Centre d’interpretation du Canal de Bourgogne
A Bah venne commissionata prima la costruzione di una boathouse e poi dell’istitu-
to dedicato alla storia del Canale de Bourgogne per la comunità di piccoli villaggi nel
Burgundy.
La boathouse è una struttura in paper-tube che fa da riparo ad una caratteristica barca
del canale.
Il tunnel, di 20m, è composto da una griglia formata da un reticolo a base triangolare
di paper-tubes. Il diametro esterno del tunnel, 11 metri, riprende quello delle gallerie
che si trovano lungo il canale. Per la prima volta Ban ha utilizzato dei giunti in alluminio
pressofusi in modo da poter utilizzare la stessa dimensione dei paper-tube utilizzati per il
Japan Papillon e di conseguenza utilizzare gli stessi test meccanici per poter certifi care
la sicurezza della struttura.
La struttura è stata poi ricoperta da pannelli di policarbonato corrugato semitrasparente
ma è completamente aperta sui fronti.
Boathouse: viste esterne ed interne
Location: Pouilly-en-Auxois, Francia
Data: settembre 1998-agosto 2002,
fi ne lavori 2005
Arch. associati: Jean de Gastines
Architecte DPLG
Ing. strutturali: Buro Happold, Terrel
Rooke and Associates
Boathouse: particolari di studio dei
collegamenti strutturali

63
“L’artista in realtà rappresenta spesso la parte dell’inventore o dello scopritore scientifi co: tutti e tre cercano nuovi rapporti
fra l’uomo e il suo mondo. I rapporti scoperti dall’artista sono emotivi invece di pratici o conoscitivi. L’artista creativo non vuol,
per un verso, copiare quanto lo circonda, e neppure, dall’altro, mostrarcelo attraverso i suoi occhi. Egli è uno specialista che
ci permette di scorgere nella sua opera, come in uno specchio, ciò che per nostro conto non siamo stati capaci di afferrare: la
condizione della nostra anima. Egli trova i simboli esteriori per i sentimenti che in realtà ci dominano, ma che in realtà restano
per noi soltanto stimoli caotici, e quindi inquietanti ed ossessivi. Questo è il motivo per cui gli artisti ci sono tuttora necessari;
nonostante le diffi coltà che mettono in pericolo il loro posto nel mondo moderno.”1
Lucy Orta con il marito Jorge dal 1991 stabiliscono il loro studio a Parigi. La loro ricerca artistica si basa sull’investigazione
della realtà, per sottolineare alcune contraddizioni insite nella nostra società, analizzandone i problemi e le convinzioni, alle
volte stereotipizzanti.
Nel loro lavoro cercano di trovare un punto di giunzione tra il senso etico e il senso estetico; non mancano però le
contaminazioni della moda, del design, dell’architettura, del teatro, della pianifi cazione urbana e delle arti visive.
In ogni opera degli artisti si può ritrovare una mistura di aspetti che attingono da tutte queste discipline e un uso dei singoli
linguaggi che viene di volta in volta contaminato.
Grazie agli studi nel campo della moda di Lucy e quelli in architettura di Jorge, i primi lavori si sono basati sul signifi cato che
ricoprono i vestiti nell’immaginario moderno. Nell’opera Refuge Wear – City Interventions l’abito è come un fi lm a protezione di
una superfi cie, un “biglietto da visita” della nostra personalità, elemento con cui comunicare, ma allo stesso tempo portatore
dell’istanza di protezione, stabilità e sicurezza.
Lucy + Jorge Orta: Refuge Wear - City Interventions, 2001
Naturalmente la ricerca non si è basata solo sulla defi nizione e progettazione di un abito, ma bensì di un “rifugio”, usato per
far sorgere domande e dubbi allo spettatore. Le loro creazioni possono essere considerate delle architetture portatili, oggetti
indossabili, tra l’impegno sociale e l’immaginario futuribile. Fanno in modo che lo spettatore non venga solo attratto dall’abito
in sé, ma anche dalle relazioni interne ed esterne che si vengono a creare durante le installazioni. Esprimono la mancanza di
comunicazione sociale, un senso di solitudine, ma anche la volontà di uscire da questo isolamento. Le grandi città, secondo
gli artisti stanno diventando grandi concentratori di solitudine e soprattutto emarginano coloro che sono impossibilitati a
comprare i beni di consumo tanto cari alle società occidentali. Per questo lo studio Orta propone le propri opere nell’intento di
ridare visibilità a queste persone e a tutte quelle che non hanno un’immagine affascinante agli occhi della società: senzatetto,
rifugiati politici o, come negli ultimi lavori, la grande quantità di cibo sprecata.
Quello che propongono è una ri-socializzazione della comunità che va fatta su vari livelli.
E M E R G E N Z A T R A A R C H I T E T T U R A E D A R T E : L U C Y O R T A
1 Sigfried Giedion, Spazio, Tempo, Architettura, Ulrico Hoepli editore, 1965, Milano

64
Nel lavoro Refuge Wear – City Interventions dichiarano: “Living without a shelter for prolonged periods rapidly destroys phy-
sical and moral health. The lack of adequate sleep increase stress, weakens the immune system and accelerates the loss of
identity and desocialization” 2
Lucy + Jorge Orta: Refuge Wear - City Interventions, 2001
In questo lavoro, che in realtà si snoda attraverso vari modelli dal 1992, le fi bre tessili vengono trasformate in un’architettura
portatile, il primo layer sta a contatto con la pelle, il secondo, più resistente, è l’interfaccia con l’esterno ma funge anche da
rifugio inespugnabile.
L’abito e l’architettura in questo caso sono il limite, sia psicologico che fi sico, tra l’individuo e la società.
Lucy + Jorge Orta: Refuge Wear - Habitent, 1992-93; Refuge Wear - City Interventions, 1993-96
2 Roberto Pinto, Nicolas Bourriaud, Maia Damianovic, Lucy Orta, Phaidon Press, 2003, Londra

65
Con il lavoro Vehiconnectro, M.I.U. hanno trasformato un vecchio veicolo militare utilizzato come ambulanza in una unità per
civili, decorate con immagini inerenti la sopravvivenza. Da un lato di un veicolo immagini di mucche e riciclo di
materiali, dall’altra le immagini dei rifugiati ruandesi e la fortuna di bere latte. Un’altra via per porre questioni etiche alla
società occidentale.
Lucy + Jorge Orta: M.I.U. I+II, G8 Environmente Summit Trieste, 2001
Con il lavoro denominato Antartica lo studio Orta esplora il tema dello shelter associandolo a quello della migrazione e dei
rifugiati. Gli shelters, concepiti come le tradizionali tende, sono composte da parti di bandiere delle nazioni da cui le persone
fuggono per guerre o carestie. Nel numero 5003 si vuole invece sottolinea come il nome Antartic derivi dal Trattato Antartico
del 1959 in cui veniva stabilita la libertà scientifi ca e di ricerca nel continente ghiacciato, la protezione ambientale e la
proibizione di qualsiasi attività militare. Nel numero 5002, ricoperto di stracci, il messaggio è quello della drammatica
situazione di milioni di persone costrette all’esilio dai loro paesi nativi a causa delle disastrose condizioni economiche, delle
guerre e del terrore politico.
Lucy + Jorge Orta: Antarctic Village - No Borders, ephemeral installation in Antarctica, 2007

66
Lucy e Jorge Orta fanno loro le parole di Poul Hartling, Commissario Onu per i Rifugiati: “There are many challenges facing
the international community today but few, in my mind, are more pressing than those of fi nding humanitarian solutions to
refugee problems. We talk of regional confl icts, of economic and social crises, of political instability, of abuses of human rights,
of racism, religious intolerance, inequalities between rich and poor, hunger, over-population, under-development and I could
go on and on. Each and every one of these impediments to humanity’s pursuit of well-being are also among the root causes
of refugee problems.”
Lucy + Jorge Orta, Antarctic Village - Dome Dwelling, 2007



A R C H I T E T T U R A I N M O V I M E N T O
02


71
L’approfondimento delle questioni che riguardano quell’ambito dell’architettura che si pone come obiettivo quello di
intervenire e proporre soluzioni per le situazioni di emergenza non può prescindere dalla cultura architettonica in generale.
Nella ricerca condotta per questa tesi infatti non si è solo voluto conoscere e comprendere qual è lo stato dell’arte nel
particolare ambito di progetto, ma si è volto lo sguardo anche a tutto quel retaggio di architettura mobile che da sempre
si contrappone ma anche dialoga con la convenzionale staticità che generalmente si accompagna all’idea di manufatto
edilizio.
Parole quali trasportabilità, trasformabilità, fl essibilità, adattabilità saranno il fi lo conduttore di questo capitolo che
analizzerà esempi progettuali e tecniche dell’architettura mobile.
Questo tema è sempre stato di grande fascino per i progettisti perché si può concepire e declinare in diversi modi; architettura
mobile può essere un padiglione che deve essere esposto in varie località ma può essere anche la singola componente di un
tradizionale manufatto edilizio, basti pensare alle strutture retrattili di molti stadi.
Probabilmente il grande avanzamento teorico e tecnologico per introdurre il movimento all’interno dell’architettura
tradizionalmente intesa è l’eredità lasciataci dalla grande sperimentazione, sia teorica che pratica, dello scorso secolo; si
pensi alla ricerca di Richard Buckminster Fuller, degli Archigram, di Cedric Price, solo per citarne alcuni.
Come già detto nel primo capitolo, durante il secondo confl itto mondiale si registra una cospicua richiesta di spazi a uso
temporaneo, per far fronte a situazioni legate alle contingenze belliche e alle emergenze umanitarie. È per rispondere a queste
richieste che si avviano, in ambito militare, studi fi nalizzati alla messa a punto di sistemi costruttivi temporanei, caratterizzati
da leggerezza, reversibilità, adattabilità.
È con la riconversione post bellica che vi è la necessità di trovare nuovi campi d’impiego per i sistemi portatili, in modo da
valorizzarne le potenzialità. Inoltre si assiste al primo utilizzo delle plastiche, materiale che permette la diminuzione radicale
del peso degli oggetti, e alla rinnovata disponibilità dell’alluminio.
È in questo scenario che si colloca il lavoro di Richard Buckminster Fuller, le ricerche di Jean Prouvè e Frei Otto.
In contesti e tempi differenti tutti questi protagonisti hanno contribuito allo sviluppo dei sistemi costruttivi a carattere
temporaneo, sperimentando sistemi di assemblaggio, materiali e tecnologie che ancor oggi possono ritenersi attuali nel loro
percorso di ricerca. A testimonianza del grande fermento di questo periodo vi sono i progetti teorici non realizzati, come quelli
dei già citati Archigram e Cedric Price, che alla luce delle attuali possibilità tecniche, sono di grande attualità, sia per il loro
bagaglio culturale, sia per la visionaria componente tecnologica.
È per queste motivazioni che si è deciso di inserire un approfondimento sulla fi gura di Richard Backminster Fuller in questo
capitolo che tratta l’architettura mobile contemporanea.
L’eredità di Fuller, diretta o indiretta, è imprescindibile per la comprensione dei progetti contemporanei.
Archigram, Plug in City, 1964; Frank Lloyd Wright, Airhouse for the US Rubber Company all’ International Home Exposition, New York, 1959
Oggi il pericolo è quello di porre l’attenzione più sui singoli termini che descrivono questo tipo di architettura che
sull’architettura stessa.
Negli anni ’60 l’introduzione in maniera quasi violenta dei termini e delle teorie sull’architettura mobile non era mirata a un
puro esercizio stilistico ma alla sovversione ideologica e architettonica delle accademie. I progetti, anche se utopici, parlavano
comunque di architettura, abbracciando tutti gli ambiti progettuali.
Nel libro “Philosophy of Fine Arts” Hegel, il quale viene anche ripreso da Bernard Tschumi in “Architettura e disgiunzione”,
ARCHITETTURA IN MOVIMENTO

72
distinse convenzionalmente cinque arti, dando loro un ordine: architettura, scultura, pittura, musica e poesia.
Al primo posto mise l’architettura perché pensava precedesse le altre per ragioni sia storiche che concettuali, ma non senza
diffi coltà. Infatti anche lui si trovò di fronte alla questione che da sempre perseguita gli architetti: le caratteristiche funzionali
e tecniche di una casa o di un tempio erano i mezzi per un fi ne che escludeva proprio quelle caratteristiche? Dove fi nisce la
capanna e comincia l’architettura? Il discorso sull’architettura riguardava solamente ciò che non era in relazione al “costruire”
stesso? Hegel ha dato risposta a questo quesito dicendo che l’architettura è tutto quello che in una costruzione non mira
all’utilità. L’architettura è una sorta di “supplemento artistico” aggiunto alla semplice costruzione. Ma la diffi coltà di un simile
argomento appare evidente quando si prova a concepire una costruzione che sfugga l’utilità dello spazio, una costruzione che
non voglia avere nessun altro scopo che ‘”architettura”.
Tschumi aggiunge che “dopo più di mezzo secolo di pretese scientifi che, di teorie sistematiche che la defi nivano come
l’intersezione tra industrializzazione, sociologia, politica ed ecologia, l’architettura si domanda se può esistere senza dover
cercare i propri signifi cati o le proprie giustifi cazioni in qualche fi nalizzata necessità esterna.”1
Steven Hall, edifi cio per appartamenti con pareti mobili a Fukuoka, Giappone, 1992
Jean Nouvel, Insitute du Monde Arabe, Parigi, Francia, 1987; facciata e particolare del maccanismo che permette la regolazione del a luce entrante
L’essere “mobile” dà all’architettura un valore aggiunto quando esprime una funzione, una fi nalità dell’architettura stessa che
colma un’impossibilità di quella tradizionale.
Si potrebbe pensare che la mobilità sia un argomento di interesse in questi ultimi anni solo per la diffusione delle teorie sul
nomadismo dell’uomo moderno. Questo è vero in parte ma non vi è un reale legame di causa ed effetto, infatti, come vedremo
in seguito, l’architettura mobile ha radici ben più lontane, legate alle culture delle popolazioni nomadi che in genere vivevano
e in alcuni casi ancora vivono in ambienti estremi.

73
Durante gli anni 60, l’indagine condotta sulla mobilità da parte del mondo architettonico diede il via a numerose
sperimentazioni che si inserirono nell’ambito della generale contestazione, ma come dice Tschumi “Se l’organizzazione dello
spazio può temporaneamente modifi care il comportamento dell’individuo o del gruppo, non signifi ca che cambierà la struttura
socio-economica di una società reazionaria.” 2
Molto spesso il fi ne di quell’architettura era quello dell’uso e del signifi cato che gli veniva attribuito, non tanto quello della
ricerca formale.
Ad esempio, in Francia, le case-guerriglia erano, dal punto di vista architettonico, semplici rifugi, baracche di cantieri, ma
quando vennero chiamate “Case del popolo” acquisirono tutti quei signifi cati legati al movimento di contestazione politica:
libertà, uguaglianza e potere. Lo spazio in sé era neutrale e per comprovarne il signifi cato politico erano necessari due
simboli specifi ci: o assegnandogli un particolare nome o attuando azioni politiche che coinvolgessero l’edifi cio stesso (come
la costruzione di una casa per il popolo su una proprietà privata o statale).
La seconda tipologia di sperimentazione del periodo era più strettamente collegata alla prassi architettonica, nell’ impiego dei
mezzi espressivi a disposizione degli architetti (piante, planimetrie, prospettive, collage ecc.) per denunciare le
disastrose conseguenze di una pianifi cazione imposta da amministrazioni e governi conservatori. “No-Stop City” di
Archizoom o “Monumento continuo” di Superstudio costituivano due possibili modelli.
Archizoom, No-Stop City, 1969
Uno degli aspetti più importanti di queste ricerche era la volontà di creare delle interferenze tra architettura e gli ambiti della
cultura, dell’economia e della politica, diventando consapevoli della possibilità di poter contaminare i vari ambiti della vita
dell’uomo moderno.
Per Archigram il futuro era delle strutture spaziali modifi cabili, spostabili e fl essibili. Anticipatori delle tecnologie digitali ed
i sistemi di informazione globale del nostro tempo, incentrarono la loro ricerca nell’interazione tra comunicazione, mobilità e
sviluppo urbano.
Gli alloggi e le strutture ideate dal gruppo di Peter Cook erano progetti che già all’epoca anticiparono le tematiche del
nomadismo moderno, in cui si permetteva una libertà nuova che l’architettura convenzionale non aveva mai consentito
prima.
“Oggi ci sono molte cose da dire a proposito dell’idea del plug-in. Anche gli architetti più mainstream difendono il progetto di
alloggi modifi cabili. E fi nalmente possiamo usare la televisione e altri sistemi in quadricromia per descrivere il nostro futuro.
Alcuni nostri studenti (e anche noi, speriamo) dovranno realizzare capsule usa e getta. I nostri lavori possono essere citati e
copiati, ma non dovranno mai diventare i giocattoli di una cultura povera ma sofi sticata.
Non ci siamo organizzati politicamente come un gruppo, ma un desiderio di emancipazione sta alla base dei nostri progetti.
L’uomo è a un passo dal baratro: svilupperà tutte le proprie potenzialità oppure rinuncerà alla propria esistenza per sempre.
In Inghilterra, in questo momento, siamo pronti a sfruttare la nostra genialità: l’uomo deve reinventare se stesso, al di là delle
scelte terribili che lo aspettano in questo momento, e deve inventarsi una vita che gli conceda la possibilità di scegliere e
dirigere i propri consumi. Noi pensiamo ai nostri progetti come oggetti di consumo.
La casa capsula è un oggetto da negozio: le parti che la compongono possono essere cambiate e scambiate, possono essere
giustapposte all’infi nito. La natura del “luogo” sarà transeunte nella defi nizione delle proprie parti, ma la vera personalità del
proprietario verrà rivelata molto più facilmente. Leggete “casa”, ma pensate “uomo”.”
“Allo stesso modo i nostri alloggi a capsule riproducono la stessa domanda e la stessa risposta tecnologica. La scala e il
1-2 Bernard Tschumi, Architettura e disgiunzione, Edizioni Pendragon, 1996, Bologna
3 Peter Cook in un articolo della rivista Perspecta di Yale nel 1967

74
grado di complessità sono superiori, ma la base fi losofi ca è la stessa. E se il preconfezionato diventasse l’oggetto preferito?
Si tratterebbe di una semplice rigenerazione della tradizione della simbologia dell’architettura. La colonna ionica era l’oggetto
preferito di una certa epoca. La pellicola d’alluminio potrebbe diventare il nostro simbolo preferito. Nei nostri lavori più recenti
ci siamo accorti che dobbiamo aggiornare e futurizzare alcune parti (almeno dal punto di vista dell’immagine) non appena
appaiono obsolete. Solo allora staremo interpretando i valori e i simboli di un’architettura spendibile.” 3
Analogamente ai Futuristi, gli Archigram erano affascinati dal potenziale estetico della tecnologia.
E ciò è principalmente rappresentato dal culto che essi avevano per la mobilità e la dinamicità. Ma questo, nelle loro intenzioni,
non fece della tecnologia un mito, essa fu sempre considerata come un mezzo.
Citando Giovanni Corbellini nel suo Ex-Libris nel gruppo britannico si possono riconoscere le attente ricerche relative alla
velocità nell’immaginario del gruppo britannico.
“ll confronto con gli spazi della mobilità, e con le condizioni percettive che li contraddistinguono, comporta infatti la riduzione
alla superfi cie delle partizioni architettoniche e il loro ibridarsi con la grafi ca, la pubblicità e il cinema.
La necessità di apertura verso forme partecipate e indipen¬denti trasforma la solidità dello spazio architettonico in
un’organizzazione fl uida di elementi infrastrutturali e di parti mobili, esplorata da Cedric Price nei progetti per la Potteries
Thinkbelt (1964) e per il Fun Palace (1961-72). Entrambi rinunciano all’idea di durata, introducendo l’obsolescenza program-
mata e differenziata dei loro componenti con l’obiettivo di cogliere occasioni non ancora all’orizzonte.” 4
Cedric Price, Fun Place, 1961-72
La sperimentazione nel campo dei materiali può essere considerata l’altra faccia della medaglia delle sperimentazioni teoriche
degli Archigram.
Coop Himmelblau ad esempio esplorò il potenziale dell’architettura pneumatica, una nuova tecnologia che nel momento in
cui nacque parve offrire un’architettura immediata, fl essibile ed organica, costruzioni leggere, ambienti non fi sici.
Le opere di Haus-Rucker-Co oscillano tra l’arte e l’architettura, ed aspirano ad essere autentici esempi stupefacenti, un
mezzo e non un fi ne, per stimolare il processo di ricerca e di esperienza personale di ciascuno di noi.
Coop Himmelblau, Villa Rosa, 1968; Hans-Rucker-Co, Cuore Giallo in esposizione alla collezione permanente del Centre George Pompidou, Parigi
Nel momenti in cui tutta la società moderna ha visto aumentare la propria mobilità, quest’ultima ha cominciato a divenire una
tematica ricorrente anche nel di architetti e progettisti che in genere si sono occupati del costruito più tradizionale.
4 Giovanni Corbellini, Ex Libris, 16 parole chiave dell’architettura contemporanea, 22 Publishing, 2007, Milano
5-6 Aldo Rossi, Autobiografi a scientifi ca, Nuova Pratiche Editrice, 1999, Milano

75
Negli anni 80 si è avuto forse l’esempio più poetico di architettura mobile:
“Stando il teatro sull’acqua si vedeva dalla fi nestra il passaggio dei vaporetti e delle navi entravano nell’immagine del teatro
costituendo la vera scena fi ssa e mobile.” 5
Il Teatro del Mondo di Aldo Rossi venne costruito su una chiatta in un bacino di Fusina, un piccolo porto della laguna di
Venezia in occasione della Biennale del 1979/80. Fu rimorchiato a Venezia ed ormeggiato alla Punta della Dogana, sul Canal
Grande, di fronte a Piazza San Marco e alla fi ne della manifestazione raggiunse, attraversando l’Adriatico, Dubrovnik. L’edifi cio
era costituito da una struttura portante in tubi di acciaio rivestita da un tavolato di legno e raggiungeva una altezza di 25 metri.
Il corpo principale era costituito da un parallelepipedo a base quadrata di circa 9,5 metri di lato per una altezza di 11 metri.
Sulla sua sommità un tamburo ottagonale sosteneva una copertura a falde in zinco. Il palcoscenico era centrale ed il pubblico
prendeva posto ai lati o nelle gallerie al piano superiore raggiungibili tramite scale poste ai lati del parallelepipedo. Il Teatro
poteva accogliere fi no a 400 spettatori di cui 250 seduti.
“Perché questo mi piaceva soprattutto: l’essere una nave e come una nave subire quei movimenti della laguna, leggere
oscillazioni, il salire e il scendere, così come nelle ultime gallerie alcune potevano provare una leggera nausea che disturbava
dall’interesse ed era aumentata dalla linea dell’acqua che si vedeva oltre le fi nestre.” 6
Aldo Rossi, Teatro del Mondo, 1979/80; schizzo e fotografi a con il Teatro in laguna
Attualmente un rinnovato interesse per i sistemi trasportabili e trasformabili è motivato dalla continua e sempre più diffusa
richiesta di spazi temporanei pronti all’uso e di componenti dell’edifi cio ad alto grado di adattabilità e trasformabilità. Le carat-
teristiche quindi dell’architettura che cerca di dare risposta a queste richieste sono la leggerezza e la reversibilità costruttiva,
la facilità di assemblaggio e disassemblaggio, la possibilità di riconfi gurazione spaziale in base alle mutevoli condizioni o al
variare delle esigenze e infi ne la temporaneità dell’assetto in un dato contesto.
La temporaneità di queste costruzioni ha due possibili declinazioni: temporaneità come breve permanenza in un luogo per poi
spostarsi in un altro e temporaneità di esistenza della stessa architettura.
Nel secondo caso molte volte non è concepita la trasportabilità, ma l’architettura, in genere padiglioni, è trasformabilie,
fl essibile e adattabile. Trasformabile perché dopo la fi ne del suo utilizzo può essere smontata e i materiali possono essere riu-
tilizzati, fl essibile per poter assolvere a più funzioni contemporaneamente, adattabile per poter far fronte ai parametri mutevoli
come i cambiamenti climatici, di luce, ecc.
Un esempio di questo interesse è l’iniziativa della Serpentin Gallery che ogni anno, grazie ai fi nanziamenti di alcune istitu-
zioni inglesi e a proventi pubblici del gioco del Lotto, fa realizzare ai più quotati architetti dei padiglioni temporanei da allestire
nei Kensington Gardens. Dal 2000 ad oggi, Zaha Hadid, Daniel Liebeskind con Ove Arup, Oscar Niemeyer, Toyo Ito, Alvaro
Siza con Eduardo Souto de Moura, Rem Koolhaas, Olafur Eliasson con Kjetil Thorsen e per il 2008 Frank Gehry hanno ideato
dei piccoli saggi di architettura, ipotesi progettuali e prototipi strutturali. Il tema della tenda, architettura mobile primordiale, è
risultato essere il modello più effi cace per creare delle forme e delle strutture archetipe.

REPORT
76
RICHARD BUCKMINSTER FULLER | L IVING IN MOTION
Richard Buckminster Fuller (1895 Milton, Massachusetts-Los Angeles 1983) non era un architetto, ricevette un diploma
che lo abilitava a praticare la professione quando aveva 79 anni, a titolo onorifi co, e forse proprio non essendo un architetto
vedeva il problema dell’edilizia come questione della distribuzione e dell’organizzazione sociale, oltre che della scelta dei
materiali e dei procedimenti costruttivi più opportuni.
“Non è possibile migliorare il mondo limitandosi a parlargli. Per essere effi cace la fi losofi a deve avere un’applicazione
meccanica” diceva per questo le sue teorie si traducevano in performance, dimostrazioni pubbliche delle leggi strutturali da
lui enunciate, in strutture prima immaginate e poi realizzate, dalle automobili a tre ruote Dymaxion alla cupola geodetica e alle
città fl uttuanti Cloud Nine.
Gli edifi ci di Fuller erano progettati per essere mobili, per essere aerotrasportati in un qualsiasi terreno dove potesvano essere
ancorati. Per questo sono poche le realizzazioni originarie ancora visibili, come lo scheletro carbonizzato della cupola dell’Expò
’67 di Montreal (nota come La Biosphere), oppure la cupola di Baton Rouge in Louisiana, la cupola Carbondale nell’Illinois,
dove Fuller ha abitato, e la Wichita Dymaxion House, trasferita dal sito originario del Kansas per trovare oggi, restaurata, una
nuova sede in Michigan, nel Ford Dearborn Museum.
Legate alla collaborazione tra Fuller e l’esercito americano sono le Radome, che all’epoca della guerra fredda servivano per
alloggiare e proteggere le delicate apparecchiature radar nelle condizioni climatiche proibitive dei territori (Canada e Alaska)
dove correva la linea DEW ( Distant Early Warning = allarme precoce a distanza).
Una Radome elitrasportata e posizionata in vetta al monte Fuji in Giappone
Alcune strutture ispirate alle idee di Fuller che si possono ancora vedere sono: la Spaceship Earth nell’Epcot Center di Disney,
l’Eden Project di Nicholas Grimshaw, in Cornovaglia e la cupola geodetica sovrastante il teatro della memoria progettato da
Salvador Dalì a Figueres, concepito dall’artista come dimostrazione paradossale dell’idea secondo cui un progetto votato al
fallimento è come una costruzione edile che porta al tetto.
Spaceship Earth ed Eden Project

REPORT
77
Molti altri progetti possono essere ricondotti all’esperienza fulleriana, benché il risultato progettuale non si esprima chiara-
mente attraverso cupole geodetiche.
Fuller infatti aggiunge una caratteristica che è alla base di molte architetture contemporanee: la quarta dimensione, ovvero
l’architettura basata sul tempo (edifi ci pensati come entità temporali e non solo spaziali) associata all’uso dei materiali più
leggeri, alla tensione come principio normativo dell’edilizia, all’esperienza diretta della cantieristica navale aeronautica e la
consegna dei manufatti edili per via aerea.
La straordinarietà dell’opera di Fuller sta nel lascito teorico. Non a caso ha ispirato tutta una generazione di progettisti e
aziende che attraverso le sue teorie geodetiche e della tensegrity hanno intrapreso una via alternativa alle consolidate teorie
statiche.
Proprio perché mirava a produrre edifi ci più leggeri Fuller si dedicò all’analisi delle strutture basate sulla tensione anziché
sulla compressione.
Nell’estate del 1948, quando Fuller arrivò al Black Mountain College, gli fu assegnato uno studente d’arte che doveva aiutarlo
a preparare i modellini per il seminario. Nell’inverno del 1948 Snelson, questo il nome dell’assistente, fece vari esperimenti
con strutture mobili modulari, somiglianti ai mobile di Alexander Calder: sostituì tutti gli elementi di sostegno, costituiti da cavi
metallici, con spago, e per rendere stabili le sue strutture provò varie soluzioni aggiungendo altri cavi in tensione.
Alla fi ne arrivò a un progetto in cui un pezzo di legno a X era sospeso, sfi dando all’apparenza la forza di gravità, al di sopra
di un altro pezzo di legno a X. I due pezzi non si toccavano, e le loro punte, sospese nello spazio, costituivano i vertici di un
ottaedro invisibile.
Come riferisce Snelson, “benché non vi fosse più nessun movimento, la struttura statica era la cosa più strana che potessi
immaginare: parti rigide fi ssate nello spazio l’una all’altra solo per mezzo di fi li” .
Kennet Snelson, Wooden X-piece, 1948
La scommessa fu poi quella di dimostrare che simili strutture potevano essere estese in forma modulare in tutte le direzioni,
in modo da creare pilastri di sostegno e altre strutture di grandi dimensioni.
Fuller defi niva questi sistemi strutturali “tensegrity” (tensegrali), una parola che combinava tension (tensione, trazione) e
integrity (integrità) e secondo lui la tensegrity era il modo più economico di realizzare grandi strutture stabili con le componenti
più leggere.
Nei capitoli successivi si vedrà come anche le aziende produttrici di tende per spedizioni alpinistiche estreme, come la The
North Face®, hanno sviluppato dei prodotti ispirati al lavoro di Fuller o creati proprio dall’esperienza dei suoi allievi.
Buckminster Fuller amava spiegare che lui lavorava nel futuro, con un anticipo di cinquant’anni, e che le sue idee sarebbero
state accettate soltanto allora.
Nel ventesimo secolo è stato uno dei pochissimi a brevettare un sistema di proiezione cartografi ca, e anche a brevettare una

REPORT
78
forma geometrica: la travatura a ottaedro – tetraedro. Ai suoi studenti faceva fi rmare moduli con cui li autorizzava a usare
la sua nuova geometria “sinergica”, ma a condizione che tutte le loro eventuali scoperte diventassero una sua proprietà
intellettuale.
Sebbene il suo obiettivo fosse quello di trasformare il concetto di abitazione, il quale a sua volta avrebbe potuto modifi care
il comportamento di chi abitava, le sue strutture ebbero un successo enorme per usi extradomestici, come padiglioni per le
fi ere commerciali e alloggiamenti dei radar. Per un breve periodo negli anni Settanta le cupole geodetiche si diffusero presso
le comunità hippie, ma quell’esperimento fu poi in gran parte abbandonato.
Il suo modo di affrontare e risolvere le tematiche della residenza e in particolare di quella temporanea - come la Wichita
House - utilizzando componenti per la fabbricazione di aeroplani della Beech Aircraft, offre uno dei più importanti esempi
di trasferimento tecnologico. Non era più necessario adeguare il progetto ai materiali disponibili, l’ingegneria navale ed
aeronautica dimostravano la possibilità di essere applicate alla vita quotidiana di tutti, riducendo il distacco tra scienza ed
architettura.
Secondo Fuller, la casa unifamiliare era un microcosmo della Terra e gli strumenti necessari per comprendere i principi della
struttura architettonica potevano essere trovati in Natura, nella dimensione minima dei cristalli e dei microrganismi. Fuller
è morto prima del 1985, quando fu scoperto il Buckminsterfullerene ovvero la “Buckyball”, la molecola di carbonio 60 dalla
forma di un pallone da calcio, per la quale nel 1996 sir Harold W. Kroto, Richard E. Smalley e Robert F. Curl junior hanno rice-
vuto il premio Nobel per la Chimica; se avesse assistito a questa scoperta l’avrebbe senza dubbio considerata una conferma
indipendente delle sue teorie strutturali.
La defi nizione che più volentieri dava di se stesso era quella di “scienziato del design totale e anticipatore”.
“Totale” perché trattava i problemi del design in modo sistematico, “anticipatore” perché era come un marinaio che scrutava
con ansia le correnti della storia per individuare le tendenze a lungo termine, “scienziato del design” perché Fuller vedeva il
design come una scienza radicata nelle leggi rigorose dell’economia e dell’effi cienza.
Nel 1928, anno del volo inaugurale del Graf Zeppelin di Hugo Eckener, pareva che i dirigibili dovessero avere un avvenire di
successo. L’esplosione dello Hindenburg, nel 1937, pose però fi ne all’età d’oro dei dirigibili e sembrava avesse reso impos-
sibile da realizzare il sogno di Fuller di produrre e muovere edifi ci aerotrasportati. Nel 1954 però si dimostrò che l’obiettivo
di Fuller era realizzabile: un elicottero Sikorski del corpo dei marines degli Stati Uniti sollevò una cupola geodetica. Sul retro
della fotografi a che ricordava l’evento, Fuller scrisse: “Primo trasporto aereo della storia di un alloggio (shelter) utilizzabile
dall’uomo.(…)”
Fuller assiste al primo trasporto aereo di uno shelter grazie ad un elicottero Sikorsky, Raleigh, North Carolina, USA, 1954

REPORT
79
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale crebbe la domanda di alloggi di pronto impiego per le famiglie sfollate.
Prevedendo i bombardamenti sulle città britanniche, nel 1940 la War Relief Organization (Organizzazione per gli aiuti ai
civili in tempo di guerra) invitò Fuller a progettarne uno. Mentre viaggiava in auto nel Midwest insieme all’amico, lo scrittore
Christopher Morley, Fuller notò i depositi per granaglie in accaio, prodotti in serie dalla società Butler, e si rese conto che
trasformare un silo come quelli in casa abitabile non avrebbe richiesto una spesa esagerata.
Nacque così la Dymaxion Deployment Unit (DDU). La struttura del primo prototipo era composta da fogli di lamiera
ondulata; la forma cilindrica racchiudeva maggior spazio di un cubo della medesima superfi cie, si presentava più rigida e
non richiedeva supporti interni. In una fase successiva, l’unità-alloggio fu perfezionata nell’isolamento delle pareti metalliche,
realizzate in pannelli di due fogli ondulati e fi bra di vetro.
Il pavimento era composto di tre strati metallici incrociati, con rivestimento di pannelli di masonite (pannelli costituiti da un
conglomerato di fi bre di legno di poco pregio) pressata ed isolante. Lo spazio interno era diviso da tende con meccanismo
automatico e prevedeva un fornello ed un frigorifero al kerosene. Il bagno era sistemato in un’altra unità anch’essa cilindrica
e dalle stesse caratteristiche strutturali, che poteva essere collegata tangenzialmente in corrispondenza di un’apertura di
passaggio.
La copertura conica lavorava come una cupola, scaricando tutti gli sforzi sul perimetro del cilindro di bordo, rendendo inutile
un appoggio centrale verticale. Essa veniva assemblata a terra, ricoperta da una doppia membrana di tessuto
impermeabilizzante e da uno strato intermedio di fi bra di vetro per migliorane l’isolamento termico ed acustico.
Ogni settore di membrana veniva poi infi lato in guide radiali di alluminio, curvate in modo tale da disegnare la curvatura della
copertura che veniva poi sollevata per potervi assemblare i pannelli perimetrali costituenti le pareti.
Le unità potevano essere parzialmente interrate con l’impiego di vari materiali isolanti. Tutta la struttura, completa di aperture
schermate, arredamento ed impianti poteva essere prodotta in serie con un costo minimo.
Alla fi ne il governo britannico si ritirò dal progetto (l’acciaio serviva per fabbricare armi), ma la Dymaxion Deployment Unit fu
usata da meccanici e avieri russi ed americani durante la Seconda guerra mondiale, soprattutto nel Golfo Persico. La Butler
Manufacturing Company infatti si attrezzò per una produzione giornaliera di 1.000 unità destinata a scopi militari.
R.B. Fuller, Due Dymaxion Development Unit; planimetria con il collegamento modulare; interni, 1940

REPORT
80
Come per molti suoi progetti, anche per la Dymaxion Deployment Unit Fuller trovò una disponibilità di gran lunga maggiore
nei militari che nell’edilizia civile.
Fuller continuò a considerare il mondo militare adatto a sperimentare materiali, tecnologie e principi nuovi da cui solo in
seguito e molto lentamente sarebbero scaturiti vantaggi per la popolazione civile.
La Dymaxion Dwelling Machine, ovvero la Wichita House (l’unico prototipo prodotto), era un esempio immediato del
tentativo di convertire l’industria dell’armamento in quella che Fuller chiamava “industria dell’alloggiamento”.
Con questa espressione si riferiva all’uso delle più moderne innovazioni tecniche non ai fi ni militari, come avveniva di solito,
ma per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo.
Fuller aveva mostrato ai militari i disegni di una casa in alluminio modifi cata, costruita intorno ad un albero centrale e rialzata
rispetto al terreno chiamata “Airbarac” (aerocaserma) Dymaxion Dwelling Machine poteva trovare impiego come alloggio
uffi ciali, caserma e perfi no ospedale a più piani.
Il sistema era concepito come integrazione tra elementi che lavorano a compressione e a trazione ed una volta posto il primo
anello-solaio metallico, un altro poteva essere posto superiormente, centro su centro, fi no ad assemblare un edifi cio a più
piani, come dimostra la soluzione della 4D-Tower del 1928.
R.B.Fuller, uno dei primi progetti per la 4D Tower, 1928
Nel 1944 la Beech Aircraft, principale industria di bombardieri, decise di usare la propria attrezzatura d’avanguardia e lo staff
di ingegneri aeronautici per realizzare il progetto di Fuller.
Tra il 1944 e 1946 furono prodotti due prototipi, entrambe presentavano superiormente un foro orientabile per la ventilazione
munito di un timone. La struttura, che pesava tre tonnellate e poteva essere spedita in un container cilindrico predisposto per
il trasporto negli aerei merci, era progettata per resistere ai tornado.
Oltre alla leggerezza, grazie ai principi tensostrutturali, la struttura permetteva di avere un ampio spazio fl essibile in quanto era
necessario l’utilizzo di un solo elemento portante verticale, liberando così lo spazio dalle altre colonne portanti dei tradizionali
sistemi strutturali a compressione. Tutte le parti della struttura collaborano sinergicamente per migliorare la resa funzionale
dell’insieme.
Nella distribuzione funzionale interna vi è una completa integrazione degli spazi e l’insieme non è un mero contenitore, ma
diventa un “micro organismo attrezzato”, in grado di soddisfare le esigenze abitative di ogni abitante.
Fuller aveva provveduto a dotare le Dymaxion Dwelling Machines diventate Dymaxion Houses di sistemi per il

REPORT
81
raggiungimento di un’autosuffi cienza e l’eliminazione delle produzione di inquinanti. Infatti le abitazioni potevano essere
dotate di impianti per la produzione e l’impiego dell’energia eolica, per lo smaltimento dei rifiuti, serbatoi d’acqua e
combustibili localizzati nella fondazione, schermi solari di facciata per il controllo dell’apporto di calore dell’energia solare.
La possibilità della modulazione degli ambienti interni fa si che ogni Dymaxion House potesse adattarsi alle diverse esigenze
di chi l’avrebbe abitata.
R.B.F., plastico della Dymaxion House, 1929
È ora chiaro perché i concetti di trasportabilità, trasformabilità, fl essibilità, adattabilità siano da attribuire in prima istanza alla
fi gura e alle idee di Richard Buckminster Fuller.
La Beech Aircraft era intenzionata ad arredare l’interno delle Dymaxion Houses con mobili tradizionali per far apparire la
nuova costruzione più familiare ai futuri acquirenti, ma Fuller ne fu sempre contrariato, come immaginabile, tanto che l’aveva
progettata, nella defi nizione base, già corredata da.
- una Dymaxion Bahroom, composta principalmente dell’assemblaggio di quattro elementi in rame. Ne furono prodotti
solamente dodici blocchi dalla Phelps-Dodge, all’epoca la terza compagnia per la lavorazione del rame nel mondo; dopo la
seconda guerra mondiale furono realizzati in fi bra di vetro da una industria tedesca e, dopo circa venti anni dalla sua proget-
tazione, ebbe un buon successo.
- dagli scaffali O-volving, progettati tra il 1928 e il 1929, che si facevano ruotare azionando un interruttore.
R.B.F., scaffali O-volving, 1946

REPORT
82
La pubblicità data dai media a questo prodotto provocò 3˙500 ordinazioni ma alcuni elementi della casa risultarono
problematici. Ad esempio le correnti di convezione “rinfrescanti” avevano l’effetto di risucchiare l’aria dal tetto della casa
e la espellevano attraverso i fori di aerazione nel pavimento, praticamente con l’effetto contrario di quello che Fuller aveva
immaginato.
Si sarebbero dovute realizzare industrialmente, secondo i calcoli di Fuller, 60.000 unità abitative all’anno, con dimensioni
diverse a secondo delle necessità. Il costo medio era di circa 6˙500 dollari (circa 33˙000 dollari attuali) quando una casa della
medesima superfi cie all’epoca poteva costare all’incirca 12˙000 dollari.
Alla fi ne ne fu venduta solo una, la Witchita House, per un dollaro ad un uomo d’affari del posto che la costruì sul proprio
giardino attuando numerose modifi che.
R.B.F., Wichita House, Wichita, Kansas, 1944
Le strutture ideate da Fuller, fi no alla Wichita House del 1946 compresa, erano in sostanza costituite da piani orizzontali
sospesi centralmente ad un asse verticale. Una parziale eccezione fu la Dymaxion Deployment Unit, anche se per essere
installata, richiedeva necessariamente un congegno per la sospensione centrale e la sua simmetria si riferiva a un asse
privilegiato, quello verticale.
Nei primi anni Quaranta, Fuller intraprese un percorso di sperimentazione che lo avrebbe portato a progettare strutture con
assi di simmetria multipli e non ortogonali, un’apparente sfi da alla gravità.
È in questo modo che nasce l’avventura dello studio delle strutture geodetiche.
Secondo Fuller, la trasformazione, il passaggio, dai poliedri alle cupole geodetiche poteva avvenire attraverso tre metodi.
- Il primo metodo opera direttamente sulla faccia piana del poliedro d’origine. Esso consiste nel suddividere ogni faccia del
poliedro generatore in tanti triangoli e poi proiettare i vertici così ottenuti sulla superfi cie della sfera circoscritta.
- Il secondo metodo opera sulla faccia del poliedro sferico, ossia gli spigoli del poliedro di origine vengono proiettati sulla
sfera e poi suddivisi in parti uguali; per questi punti si fanno passare le geodetiche ottenendo cosi il reticolo per realizzare la
cupola.
- Il terzo metodo consiste nel suddividere in parti uguali l’angolo al centro sotteso allo spigolo del poliedro generatore. Questo
terzo metodo coincide nei risultati con il secondo, differenziandosene solo nella procedura di calcolo della lunghezza delle
aste.

REPORT
83
Appare probabile che Fuller sia arrivato alla cupola geodetica seguendo un percorso che cominciava con la sovrapposizione
alla sfera di solidi regolari, costruendo plastici delle circonferenze massime che gli permettevano di testare direttamente
la stabilita delle strutture geodetiche triangolate, e infi ne concependo strutture architettoniche basate sulle circonferenze
massime. La cupola geodetica emerse nella sua forma defi nitiva grazie all’elaborazione del concetto di frequenza (numero
di parti in cui viene diviso lo spigolo del poliedro), a sua volta derivato dallo studio che gli aveva permesso di arrivare alla
Dymaxion Map suddividendo le facce dei solidi sferici.
Ma iI cubottaedro della Dymaxion Map ideata da Fuller nel 1943 avrebbe potuto essere una forma appropriata per uno spazio
abitativo?
Purtroppo la sua eccezionale robustezza strutturale entra in gioco soltanto quando il solido e sospeso dal nodo centrale, ossia
dividendo lo spazio in scomode cellule a forma di tetraedri e di mezzi ottaedri.
Fuller si accorse che facendo pressione su una delle facce triangolari il corpo centrale del cubottaedro si torceva.
La forma attraversava alcune fasi distinte: in primo luogo i vertici defi nivano un icosaedro regolare, poi, se si continuava
a far pressione, si appiattiva diventando un ottaedro regolare. Quando poi si torceva il triangolo superiore, l’intero sistema
collassava, formando un triangolo in piano.
Ripiegando su se stessi i triangoli si può ottenere un tetraedro, che Fuller chiamò “sistema minimo dell’Universo”.
Smettendo di esercitare pressione sul tetraedro, il solido tornava alla forma originale di cubottaedro. A questo movimento di
torsione, una sorta di danza geometrica, Fuller dette il nome di Jitterburg Trasformation.
R.B.F., Dymaxion Map, 1943
Tutti questi progressi si verifi carono, sembra, molto rapidamente fra il 1948 e il 1950, l’anno in cui presso Montreal fu
innalzata la prima cupola geodetica di Fuller pienamente riuscita, costruita su un reticolo a icosaedro sferico.
Fuller disegnò la cupola per poterla poi installare nelle terre artiche. La struttura era formata da puntoni di alluminio, ognuno
dal peso di circa mezzo chilo. La struttura era così leggera che non fu necessario nessuna gru o albero centrale per erigerla.
R.B.F., prima cupola geodetica eretta a Montreal nel 1950

REPORT
84
Prima della cupola di Montreal ci fu una importante realizzazione che diede il via alla vera e propria sperimentazione
geodetica. Nell’autunno del ’49 Fuller insegnò all’Institute of Design di Chicago dove diede il compito ai suoi studenti di pro-
gettare l’arredo di una roulotte per 6 persone. Lo Standard of Living Package era un progetto complementare allo studio
delle cupole, in quanto doveva fornire un ambiente abitativo portatile. Infatti la ricerca di soluzioni ottimali portò Fuller a trovare
un nuovo collegamento dei puntoni delle cupole geodetiche attraverso tubi metallici rigidi, infi lati su una fune.
Da questa soluzione prese origine il nome della cupola che poi venne costruita con la collaborazione degli studenti di Chicago:
Necklace Dome (cupola a collana).
R.B.F., Standard of Living Package; Nacklace Dome, 1949
Da queste prime cupole scaturì un grande interesse per le cupole geodetiche tanto che sia Fuller che altre persone
cominciarono a sperimentare nuovi materiali, connessioni, destinazioni d’uso.
Si è gia accennato all’inizio come negli anni Settanta la comunità hippie vide nelle cupole geodetiche un sistema per costruire
autonomamente e a basso costo una abitazione.
Vennero pubblicati libri su come auto-costruirsi una cupola geodetica, con diversi materiale e diversi sistemi di
assemblaggio.
Vi erano cupole costruite con struttura in legno e copertura in plastica, come la Sun Dome, con la descrizione delle possibili
alternative di fi ssaggio dei vari pezzi di struttura; la Alluminum Triacon Dome, tutta composta di alluminio con spalmatura
interna di schiuma isolante; la Sheet Metal Dome, composta da una struttura lignea e ricoperta con pannelli di alluminio
sovrapposti in modo da garantire una maggior tenuta d’acqua, ecc.7
Senza dubbi la cupola geodetica più bella di Richard Buckminster Fuller fu quella costruita per il padiglione degli Stati Uniti
all’Expo di Montreal 1967.
La cupola era alta 76 metri con struttura in acciaio e rivestimento trasparente acrilico composto da una serie di lenti esa-
gonali che, mediante opportuni fi ltri azionati elettronicamente, controllavano l’ingresso della luce e del calore all’interno del
padiglione.
La cupola, costruita in collaborazione con Sadao, la Geometrics Inc. e Associated Architects, geometricamente era tre quarti
di una sfera. I visitatori vi entravano trasportati da una futuristica monorotaia sopraelevata e all’interno potevano trovare
attività accumunate dal tema “America creativa”, come la mostra di pittura “American Painting Now”, con opere di Warhol e
Lichtenstein, la Dymaxion Air-Ocean Map a icosaedro ideata sempre da Fuller e un modulo spaziale Apollo.
La cupola era resa impermeabile da un rivestimento trasparente di pannelli di vetro acrilico, oscurati in caso con un sistema
di tende da sole mobili, di forma triangolare che si muovevano a seconda della posizione del sole.
“ Dentro la cupola sembra che le chiusure tendano ad uscire; questo è uno straordinario effetto psicologico in quanto si ha
la sensazione che non esistano chiusure... la gente al suo interno sembra felice. E ciò non è stato realizzato secondo i canoni
dell’estetica dell’architettura come si fa solitamente. E stata fatta sem¬plicemente con lo scopo di realizzare il massimo con
il minimo.” 8
Nel 1976, durante i lavori di manutenzione, a causa di un saldatore poco attento, il rivestimento di acrilico prese fuoco e
6 AA.VV, Domebook 2, Pacifi c Domes, 1971, Bolinas , California, USA
7 Note del regista Robert Snyder, riportato da Martin Pawley, Design Heroes: Buckminster Fuller, Grafton, 1990 e da Laura Angeletti, Innovazione tecnologica ed architettura,
Gangemi Editore, Roma

REPORT
85
trasformò la cupola in una palla di fuoco.
R.B.F., Cupola per l’Expo ‘67 di Montreal, 1967
Più o meno nello stesso periodo Fuller abbozzò una possibile applicazione architettonica, denominata Your Private Sky.
Un congegno simile a un planetario personale, consistente in una cupola basata sulla circonferenza massima.
Le circonferenze massime, arricchite dagli elementi di un planisfero stellare, permettevano all’abitante di eseguire
osservazioni esatte del cielo e di “vedere in modo corretto la sua geografi a”, osservando la posizione della Stella polare e cosi
via. Fuller arrivo a proporre una piscina semisferica che poteva essere decorata con le costellazioni del cielo corrispondente
all’emisfero opposto, permettendo all’abitante di contemplare l’ordine del cosmo mentre galleggiava nell’acqua.
Fuller con alcuni modellini di cupole geodetiche

86
Trasportabile e trasformabile identifi cano e qualifi cano due differenti modi di essere dei manufatti edilizi, molto lontani dai
caratteri di solidità, massività, pesantezza, staticità e permanenza generalmente attributi all’architettura: trasportabilità, come
possibilità di insediamento in luoghi di volta in volta differenti; trasformabilità, come attitudine a cambiare confi gurazione
rispetto alle diverse condizioni ambientali; trasportabilità e trasformabilità insieme, come risposta a modalità d’uso in continua
evoluzione.
In generale si può dire che l’architettura trasportabile, ha come oggetto l’architettura progettata per essere spostata;
l’architettura trasformabile, riguarda l’architettura in grado di modifi care il proprio assetto.
Nella prefazione al libro di Alessandra Zanelli, “Trasportabile/Trasformabile. Idee e tecniche per architetture in movimento”,
Andrea Campioli dice: “leggerezza, molteplicità, fl essibilità, mobilità, reversibilità appaiono come assunti paradigmatici:
leggerezza, implicando la ricerca di nuovi rapporti dimensionali, di nuovi modelli di trasparenza, di nuovi materiali, o di
interpretazioni inedite di materiali della tradizione costruttiva; molteplicità e fl essibilità, delineando una prospettiva progettuale
all’interno della quale una soluzione non e data una volta per tutte ma è sottoposta a continue trasformazioni, a continui
mutamenti, a un continuo alternarsi delle confi gurazioni possibili; reversibilità, proponendo l’adozione di soluzioni in grado di
assecondare i processi trasformativi dell’architettura, consentendo facili adattamenti rispetto a diverse situazioni di contesto,
verifi cando la compatibilità tra i singoli componenti e tra i componenti e l’intero edifi cio a partire da una attenta analisi dei
rispettivi cicli di vita.”
Robert Kronenburg, scrittore di numerosi libri riguardo la mobilità in architettura e la sua conseguente infl uenza tecnologica,
distingue tre livelli di portabilità:
- i portable buildings, ossia i sistemi che sono trasportabili intatti, autosuffi cienti, adattabili a qualsiasi contesto, ma
caratterizzati da un grado minimo di flessibilità di utilizzo e dalla limitatezza delle dimensioni in relazione al mezzo di
trasporto;
- i relocatable buildings, ossia i sistemi in parte preassemblati e in parte assemblabili in sito, spesso parzialmente
integrati al sistema di trasporto, così da conciliare i vantaggi di facilità e velocità di assemblaggio con una maggiore
disponibilità di spazio rispetto alle dimensioni di trasporto;
- i demontable buildings, sistemi progettati per essere smontabili e riassemblabili, costituiti da un numero fi nito di
componenti in grado di confi gurare spazi, anche di notevoli dimensioni, del tutto o quasi svincolati dai limiti imposti dal mezzo
di trasporto.
A completamento di questa distinzione è utile aggiungere anche quella proposta da Alessandra Zanelli 9, in grado di
evidenziare soprattutto le interrelazioni risultanti tra gli elementi del kit di montaggio e il sistema di trasporto.
Da sempre sono il criterio di assemblaggio e le modalità di trasporto a dettare i limiti dimensionali e il peso dell’unità
trasportata e, proprio dall’analisi di tali parametri, emergono signifi cative differenze tra i sistemi attuali e quelli a cui sono
ispirati.
- Sistemi portatili: il sistema di trasporto è completamente indipendente dall’unità trasportata. In fase di progetto il
parametro della portabilità detta il vincolo dimensionale del volume trasportabile. Ma ciò che non è trasportabile su
un autoarticolato lo è su due o più, e in questo senso il vincolo maggiore diventa il costo.
Dal punto di vista dell’assemblabilità, le unita di questa categoria sono progettate come insieme di componenti da montarsi
sul luogo, oppure possono essere parzialmente o completamente preassemblate in offi cina. Nessuna integrazione è prevista
tra il sistema di assemblaggio e quello di trasporto.
- Sistemi semi-autonomi: unita caratterizzate da una parziale integrazione tra il sistema di trasporto e quello di
assemblaggio, con una notevole riduzione delle operazioni da svolgersi manualmente e del tempo complessivo di messa in
opera. Può essere posta in atto in due maniere: o i mezzi di trasporto sono dotati di strumenti elettrifi cati cooperanti alla fase
di assemblaggio dell’unità, o il mezzo di trasporto può essere standard mentre l’unità stessa, spesso già preassemblata, è
dotata di sistemi automatizzati che cooperano al raggiungimento dell’assetto di esercizio. Gli automatismi di assemblaggio in
genere sfruttano i cinematismi dei sistemi pieghevoli azionabili manualmente, oppure la spinta dell’aria pressurizzata, oppure
ancora la potenza dei sistemi oleodinamici.
- Sistemi semoventi: mezzo di trasporto e le parti trasportate costituiscono una unita inscindibile e preassemblata.
LO SCENARIO CONTEMPORANEO
9 Alessandra Zanelli, Trasportabile/Trasformabile. Idee e tecniche per architetture in movimento, Libreria Clup, 2003, Milano.

87
La peculiarità di questa categoria e di rendere libero l’utente fi nale nell’interazione diretta con la mobilita della cellula,
per spostarla oppure per modifi carne l’assetto spaziale, senza il ricorso ad alcuno sforzo fi sico. In questo caso si tratta di
progettare un mezzo di trasporto vero e proprio e insieme defi nirne i gradi di trasformabilità. La fase di esercizio può infatti,
in alcuni casi, comportare il movimento di alcuni elementi semoventi per il raggiungimento di un assetto spaziale più ampio e
confortevole rispetto al volume trasportabile. È possibile distinguere, all’interno di questa categoria, da un lato le unità
trasportabili, confi gurate in modo univoco e in cui solo il sistema integrato di trasporto ne determina la semovenza, dall’altro
le unita ampliabili, in cui la semovenza non si traduce soltanto in autonomia di spostamento, ma riguarda anche la possibilità
di movimento di alcune componenti della cellula trasportabile, come la copertura o le pareti verticali, allo scopo di rendere
disponibile in fase di utilizzo una confi gurazione più ampia e variabile rispetto all’assetto di trasporto.
Kronenburg Zanelli
Trasporto intatto Portable building Sistemi semoventi Integrazione totale tra struttura e unità mobile
Preassemblaggio Relocateble building Sistemi semi-autonomi Integrazione parziale tra struttura e unità mobile
Assemblaggio totale Demontable building Sistemi portatili Indipendenza tra struttura e unità mobile
P O R T A B L E B U I L D I N G S
FLOATING PAVILION: Fumihiko Maki
Il Floating Pavilion è una struttura multifunzionale che viene trasportata lungo i canali grazia a un rimorchiatore. Lo scopo,
oltre a ospitare attività culturali, è quello di capire come l’architettura, in questo caso mobile, cambiando localizzazione evoca
nello spettatore scenari nuovi e a sua volta infl uenza il paesaggio stesso che attraversa. Infatti la struttura a doppia spirale e
ricoperta da una leggera membrana in poliestere bianco traslucido, scivolando nei canali di Groningen (Olanda), si fondeva
con la nebbia del mattino, diventando un elemento fantastico.

88
MOBILE HIV AIDS CLINIC: Jeff Alan Gard
Il Floating Pavilion è una struttura multifunzionale che viene trasportata lungo i canali grazia a un rimorchiatore.
Lo scopo, oltre a ospitare attività culturali, è quello di capire come l’architettura, in questo caso mobile, cambiando
localizzazione evoca nello spettatore scenari nuovi e a sua volta infl uenza il paesaggio stesso che attraversa.
Infatti la struttura a doppia spirale e ricoperta da una leggera membrana in poliestere bianco traslucido, scivolando nei canali
di Groningen (Olanda), si fondeva con la nebbia del mattino, diventando un elemento fantastico.
R E L O C A T A B L E B U I L D I N G S
MARKIES: Eduard Bohtlingk
Concepita come una casa mobile per le vacanze, Markies durante la circolazione misura 2,2 x 4,4m. Una volta collocata
sul luogo prescelto la sua superfi ci e triplica in pochi attimi. Le due pareti laterali possono infatti essere aperte grazie ad un
meccanismo elettronico e l’area risultante può essere ricoperta con delle tende a fi sarmonica. Al centro si trovano la cucina
con la zona pranzo ed il bagno, da un lato il soggiorno e dall’altro la camera da letto. La tenda del soggiorno è semitrasparente
e aprendola totalmente crea uno spazio-terrazza; quella della zona notte è invece opaca. Lo spazio interno è stato pensato
seguendo l’idea di una distribuzione fl essibile, pur integrando tutti gli elementi necessari ad un comodo soggiorno: armadi ad
incasso, sedili, letti (fi no a quattro), un frigorifero, la cucina, la doccia e il bagno.

89
LanMAS: FTL Studio
Progettata come ricovero di grandi dimensioni per l’esercito Americano, in genere per gli elicotteri, la tenda LanMASS (Light
Area Night Maintenance Shelter) è un sistema che si distingueva per un’alta autonomia di installazione, grazie all’impiego di
archi pres¬surizzati. Le tende LanMAS sono molto leggere in fase di trasporto, grazie all’uso della fi bra di klevlar in sostituzio-
ne della più diffusa membrana in poliestere. Ogni arco portante, di circa 7 metri con cavità di soli 300mm, pesa intorno ai 34
kg e, sopporta un carico di oltre 317 kg con una infl essione di soli 100 mm. Una tenda di 800-1000 mq può essere montata
in meno di 24 ore da dieci uomini ed e trasportabile in due soli container.
D EMO N T A B L E B U I L D I N G S
MUSEUM OF MOVING IMAGE (MOMI TENT): Eduard Bohtlingk
Il MOMi fu progettato e costruito per il National Film Theatre a Londra. London’s South Bank.
È stato immaginato come una struttura leggera che poteva essere riutillizata per altri eventi.
Sei persone possono montare e smontare la struttura nell’arco di due giorni. La struttura ha un pavimento rialzato assemblato
con pannelli di alluminio, in cui trovano alloggio gli impianti. La copertura è in membrana Tenara® prodotta dalla ditta Gore
tesa sugli archi in vetroresina.
IBM TRAVELLING PAVILION: Renzo Piano Building Workshop
Nel 1983 l’IBM decise di promuovere la propria innovazione attraverso un padiglione itinerante che avrebbe dovuto
posizionarsi nei parchi urbani delle maggiori città europee, a stretto contatto con la natura.
La progettazione è stata affi data a Renzo Piano che, mutuando la tradizione del Cristal Palace, ne richiamò i principi di
modularità e trasparenza ma utilizzando materiali molto diversi dal ferro e dal vetro. Piano utilizzò il policarbonato, il legno
lamellare e l’alluminio. Il padiglione era composto da 34 archi autoportanti assemblati in sequenza; la struttura primaria di
ogni arco venne realizzata in legno lamellare con giunti in fusione di alluminio, cui si annettevano gli elementi piramidali (6
piramidi per ogni semiarco) in policarbonato, leggeri e resitenti, che costituivano la pelle trasparente dell’edifi cio. Guarnizioni
di neoprene e tiranti di acciaio furono utilizzati per creare le giunzioni tra i diversi materiali. Il padiglione complessivamente
misurava 48 metri in lunghezza, 12 di larghezza e 6 di altezza.
Per lo spostamento dell’edifi cio furono necessari 23 camion, 21 contenenti la struttura vera e propria e 2 per le tecnologie
informatiche e il sistema di condizionamento.
Alcune delle tecnologie esposte all’interno del padiglione erano sensibili al calore per cui si rese necessaria la creazione di
pannelli isolanti in Perspex con una lastra separata di alluminio da applicare ad alcune parti del policarbonato e l’aggiunta di
membrane per ridurre i rifl essi sugli schermi dei computer.

90
La struttura poteva essere assemblata in tre settimane; per permettere la contemporaneità dell’evento in più città, ne venne
realizzata una seconda.
Kronenburg sottolinea come il termine “architettura” è stato sdoganato anche per gli edifi ci mobili contemporanei, i quali
sono visti alla pari delle strutture statiche, come ad esempio i padiglioni. Dall’altra parte vì è ancora un certo preconcetto a
considerare alcune tipologie dell’architettura mobile, ad esempio le case mobili, come un elemento standardizzato, come un
prodotto industriale. (Robert Kronenburg, Portable Architecture. Design and Technology).
Lo sviluppo dell’architettura mobile è un campo di ricerca che potrebbe portare a un incremento
dell’innovazione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda I sistemi “a secco”. In molti casi vi è
infatti la contaminazione con altri saperi, come l’industria dei veicoli, il product design e lo sviluppo di
nuovi materiali.
È da notare inoltre che i buoni progetti di architettura mobile in genere producono un sentimento di iden-
tificazione, un senso di luogo, allo stesso modo delle architetture permanenti.
Questo perché nel loro insieme, le funzioni sono chiare, le facilitazioni e i comfort non sono sacrificati,
ma sono i medesimi richiesti dalle architetture tradizionali.
Gli approcci nella progettazione di un edifi cio permanente o di uno mobile sono i medesimi; la portabilità è solamente un
ulteriore fattore da tenere in considerazione, come può esserlo la progettazione luminosa, la sicurezza,ecc.
È per questo che il progetto d’architettura mobile dovrebbe essere giudicato secondo i parametri classici di: appropriatezza
allo scopo, al contesto, esteticamente bello, economico nell’uso.
In genere, in questo tipo di costruzioni, vi è un’onestà intrinseca nell’utilizzo dei materiali, cioè i materiali strutturali in genere
non vengono ricoperti, bensì espressi, perché nel caso contrario si avrebbe un ulteriore complessità non necessaria e un
aumento del peso.
È anche per questo fatto che vengono visti come territori di sperimentazione: esprimendo chiaramente i materiali, le loro
connessioni, i componenti, questi devono essere progettati in modo tale da essere inseriti organicamente nell’insieme,

91
di conseguenza il metodo di costruzione e le tecniche di assemblaggio, se innovative, possono poi essere trasferite ai si-
stemi costruttivi tradizionali. L’utilizzo infatti di materiali sempre più leggeri, prefabbricati, riduce nettamente il lavoro della
manodopera in cantiere, il tempo di costruzione e i costi di trasporto.
I progetti sperimentali che nascono con l’obiettivo dichiarato di aprire nuove strade all’innovazione
sono una parte riconosciuta di quelle industrie che basano la loro competitività sul mercato mondiale
sulla ricerca e lo sviluppo, come ad esempio le industrie aerospaziali, quelle impegnate nei campionati
di automobilismo o motociclismo e quelle information di technology.
Essendo gli investimenti nell’industria edilizia molto scarsi, questo transfert tecnologico può avvenire solo attraverso pic-
coli componenti, ma la costituzione di un’intera e nuova visione della costruzione nel suo complesso è un’impresa che non
può essere affrontata. In alcuni casi, la competenza di alcuni progettisti ha portato a piccole innovazioni componentistiche
all’interno dell’industria edile, come le competenze ingegneristiche dello studio Buro Happold in Inghilterra e dell’ FTL Design
Engineering Studio in America (www.burohappold.com e www.ftlstudio.com).
Buro Happold con Norman Foster, British Museum, Londra; Buro Happold con DLA Architecture , Health and Safety Laboratory, Buxton, Gran Bretagna
La diffi coltà maggiore che si riscontra nel trasfert tecnologico sta nel fatto che molti progetti che hanno avuto un notevole
successo dal punto di vista della prototipizzazione, sono falliti in vista della commercializzazione su larga scala.
È però da sottolineare, analizzando alcuni casi progettuali, che, comparando la richiesta del cliente, la disponibilità economica
e il progetto fi nito, quest’ultimo ha molto spesso caratteristiche tecniche superiori a quelle inizialmente patuite. Il costo fi nale
è inferiore a quello previsto, la velocità di assemblaggio è maggiore e si riscontra una vita più lunga rispetto alle previsioni.
Un esempio è l’utilizzo delle membrane, siano esse utilizzate per tensostrutture o per strutture pneumatiche. Prestazioni sem-
pre migliori dovute all’innovazione nei materiali e soprattutto la relativa facilità della loro lavorazione, ha permesso ai progettisti
di ottimizzare l’utilizzo del materiale.
L’alluminio e l’acciaio rimangono poi i materiali strutturali per eccellenza, ma quando i budget lo permettono vengono utilizzati
materiali più performanti come le fi bre di carbonio o il Kevlar. Questi spin-offs inevitabilmente affi orano in prima istanza in quei
progetti in cui le richieste prestazionali e la leggerezza sono caratteristiche fondamentali.
L’innovazione nel campo dei materiali crea innumerevoli possibilità, ad esempio il LiTraCon, un calcestruzzo trasparente che
incorpora delle fi bre ottiche. Questo permette di avere dei muri di 20 cm ma con un grado di trasparenza che che permette
di distinguere le sagome delle persone e degli oggetti posti dall’altra parte.
Esempi di LiTraCon

92
Lo SmallWrapp, creato dallo studio Timberlake Associates e dalla DuPont per sostituire la tradizionale e voluminosa parete, è
un fi lm di poliestere spesso 1 millimetro che protegge le superfi ci dagli agenti atmosferici ma permette di essere associato
ad altri layer che possono essere composti con materiali a cambiamento di fase, o con tecnologia OLED (light-emitting diode
display), quindi che possono avere la funzione di isolamento, di fonte luminosa, ecc. I vari tipi di layer possono essere trasferiti
sul fi lm SmallWrapp usando un sistema di stampaggio chiamato ‘Deposition Printing’, simile alla stampa inkjet printing.
SmartWrap Building, New York, USA, 2003
Trasportabilità, trasformabilità, fl essibilità, adattabilità sono le parole chiave per un progetto generalmente detto di architettura
portatile. Come si sarà già notato infatti i termini molte volte sono intercambiabili e non è detto che uno ne escluda l’altro nella
descrizione di un progetto.
Per questo fare delle catalogazioni nette rispetto a questi termini dei progetti presi in esame durante le ricerche per questa tesi
è impensabile, ma è possibile invece leggerne alcune peculiarità. Per questo di seguito gli esempi progettuali presi in esame
per ogni parola chiave saranno catalogati in maniera puramente simbolica, solo per sottolinearne un aspetto signifi cativo, non
per escludere in modo netto gli altri termini.

93
Architettura trasportabile
Molte volte si tende ad associare l’architettura mobile esclusivamente con le soluzioni progettuali prefabbricate. Questo non è
corretto, e non è corretto nemmeno pensare che tutte le costruzioni prefabbricate possano essere facilmente trasportate.
Per essere mobile una architettura deve avere alcuni parametri base che possono essere riassunti in:
1. leggerezza dei materiali impiegati;
2. reversibilità delle tecniche costruttive, in grado di garantire rapidità di assemblaggio e
disassemblaggio (trasportabile) e ripetibilità degli atti legati al cambiamento di assetto
(trasformabile);
3. temporaneità, in termini di permanenza limitata in un dato contesto (trasportabile) o in un
medesimo assetto (trasformabile).
Sin dall’antichità infatti, il successo di un sistema costruttivo mobile era direttamente collegato al fattore peso. Tutti i sistemi
costruttivi per architetture provvisorie o temporanee del passato, le tende nomadi e i tendoni dei circhi, ma anche i ponti
smontabili da guerra, le baracche e le strutture provvisorie dei cantieri possono defi nirsi sistemi leggeri, in quanto in tali
sistemi si presuppone che le operazioni di assemblaggio possano essere totalmente a carico di pochi uomini e che i singoli
elementi del sistema siano facilmente maneggiabili.
La strategia più vincente per la movimentazione di un edifi co è il trasporto come singolo elemento (portable building).
Questo metodo ha il vantaggio che, una volta raggiunta la location desiderata, il sistema può essere subito a disposizione
dell’utente. Bisogna comunque tener presente che questa soluzione può far sorgere delle problematiche relative
all’inserimento dell’impiantistica e soprattutto nella defi nizione spaziale, in quanto prima di tutto deve sottostare ai limiti
dimensionali dettati dal metodo di trasporto.
Nel caso di relocateble o demontable buildings, cioè edifi ci che implicano una qual forma di assemblaggio, quest’ultimo deve
essere il più possibile facile e veloce, ma soprattutto ogni parte assemblata deve essere altrettanto facilmente disassemblata
e immagazzinata, per affrontare un nuovo trasporto. Nel caso dei sistemi trasformabili, le fasi della costruzione possono
essere paragonate a quelle di un edifi cio a carattere permanente. Senza dubbio, anche in questo caso, le parti trasformabili
dell’edifi cio devono essere progettate secondo una sequenza di movimento reversibile e ripetibile, in relazione ai cambiamenti
climatici e/o alla possibile modifi cazione delle esigenze d’uso.
A fi anco di una reversibilità che coinvolge le fasi di assemblaggio e le fasi d’uso, si può individuare una reversibilità che
si potrebbe defi nire di processo, cioè la possibilità che un componente o materiale una volta disassemblato possa essere
riutilizzato o reimmesso nella fi liera produttiva . Ad esempio, nel campo delle membrane, nuovi materiali a base vinilica, quali
per esempio l’etfe e il thv, vengono oggi prodotti mediante processi di stampaggio e di estrusione che permettono la realiz-
zazione di fi lm altamente performanti e competitivi con altri tessuti tecnici ma, al tempo stesso, possono essere riciclati per
circa il 95%, per ottener un nuovo fi lm con le medesime prestazioni.
The Screen Machine è il nome dato a un cinema mobile che doveva portare il cinema nelle remote e isolate località della
Scozia. Il cinema, progettato nel 1999 per l’Higlands and Islands Arts Ltd, è uno speciale camion rimorchio che una volta
giunto sul posto si espande lateralmente in modo da poter contenere un numero maggiore di spettatori, circa 100, e con la
possibilità di accesso anche alle persone in carrozzina. Inoltre all’interno vi sono tutti comfort di un cinema tradizionale: aria
condizionata, schermo widescreen e suono sourround, particolari che hanno decretato il vero successo dell’operazione.
Screen Machine 2, Gran Bretagna, 2002

94
Una prioritaria caratteristica dei portable buildings e del loro effettivo successo è avere un alto grado di competitività
rispetto agli edifi ci statici. Infatti, per considerare questi edifi ci vera architettura, bisogna fare in modo che le caratteristiche
di trasportabilità, trasformabilità, fl essibilità e adattabilità siano un di più rispetto a quelle che normalmente si richiedono agli
edifi ci, e non le uniche.
In alcuni casi addirittura si richiedono prestazioni superiori e per questo anche sperimentali, come per il caso dei Motorhome
della F1. I motorhome sono quelle strutture mobili che seguono la squadra nei vari Gran premi per dare supporto logistico e
servizi ai lavoratori e collaboratori delle varie squadre. Ma queste strutture sono soprattutto l’espressione della squadra, sono
uno dei modi di comunicare la propria superiorità tecnologica agli spettatori, alla stampa e soprattutto agli investitori.
I motorhome sono anche il luogo in cui generalmente le squadre diramano i comunicati stampa, tengono incontri, conferenze
per la stampa, sono quindi lo sfondo alle attività di comunicazione e della massima esposizione mediatica.
Un caso emblematico di sviluppo progettuale di un motorhome è stato quello della West McLaren Mercedes nel 2002
chiamato “Communications Centre”. La struttura veniva trasportata scomposta in 11 componenti distinti utilizzando 6
camion, dotati di tutte le dotazioni necessarie per l’assemblaggio.
La strategia utilizzata per poter montare una struttura del genere in uno spazio ristretto come quello dei parcheggi dei box
fu quella di creare 8 capsule ognuna con dei piedi idraulici che avrebbero abbassato la struttura dal livello dei cassoni dei
camion adibiti al loro trasporto fi no a terra.
Successivamente questi elementi venivano posizionati in modo corretto a terra e uniti sempre con giunti idraulici.
Due elementi erano provvisti anche di un piano superiore che veniva anch’esso rialzato tramite pistoni idraulici e la cui
copertura era una piramide trasparente prefabbricata che serviva per creare un atrio coperto ma al contempo luminoso.
Per il montaggio erano necessarie 8 persone e il tempo previsto era di 12 ore.
Negli anni si è poi acuita la rivalità dei team anche nella progettazione dei paddok e motorhome. Per esempio, la stessa
McLaren in concorrenza con il team della RedBull, che nel 2007 ha proposto l’ “Energy Station” progettato dallo studio
austriaco Kitz exklusiv specializzato in strutture e attrezzature mobili, ha ritenuto necessario richiedere un nuovo motorhome
per le gare di F1, il nuovo “Brand Center”. In effetti l’Energy Station aveva messo in ombra tutti gli altri motorhome in quanto
oltre alle classiche funzioni che in genere si svolgono all’interno dello stesso, ne aveva proposte alcune anche esterne, come
lo spazio privè con piscina allestito per il Gran Premio di Montecarlo.
Inaugurato per il British Grand Prix del 2007 il nuovo motorhome della McLaren è alto ben 3 piani, ha una facciata rivestita di
pannelli rifl ettenti. Il piano terra è a pianta libera, al secondo piano alloggiano gli uffi ci e al terzo vi è la galleria per gli ospiti.
Sono previste inoltre delle speciali stanze per i piloti con tutti i comfort possibili, docce, console per i giochi, stazioni MP3,
ecc.
La struttura necessita di 48 ore per essere montata e altrettante per lo smontaggio; per il trasporto sono necessari 12 tir.
McLaren Comunication Center, Red Bull Energi Station, Motorhome Bmv, Motorhome Ferrari

95
Architettura trasformabile
Un edificio trasformabile è un edificio che cambia forma, colore, apparenza, attraverso
l’alterazione della sua struttura, del rivestimento o della superficie interna, permettendo un
significativo cambiamento del modo in cui viene utilizzato o percepito.
È un’architettura che si apre, si chiude, si espande e si contrae.
Non è facile introdurre quesa caratteristica in quanto vi sono almeno tre caratteristiche fondamentali dell’architettura trasfor-
mabile che possono essere causa di numerosi problemi: i meccanismi che provocano il movimento di qualche componente,
la perfetta adesione di partizioni interne ed esterne e il corretto funzionamento dei vari servizi in condizioni diverse. I mecca-
nismi utilizzati per permettere il movimento di parti architettoniche devono essere robusti, non devono richiedere frequenti
manutenzioni, devono essere facili nell’utilizzo e affi dabili. Questo signifi ca, in particolari situazioni domestiche, che l’energia
utilizzata per il loro funzionamento deriva solamente dalla forza umana, fatto che comporta la stretta reazione tra utente ed
edifi cio. Nuovi materiali hanno reso queste operazioni più facili, come ad esempio l’uso del neoprene per le guarnizioni tra
le parti mobili, sistemi di movimentazione elettrica, idraulica e pneumatica che però devono garantire un utilizzo in estrema
sicurezza. Un importante parte del successo di questi elementi nell’architettura è il loro perfetto funzionamento e soprattutto
la loro competitività rispetto ai tradizionali sistemi statici.
La sperimentazione nella trasformabilità in architettura è stata fatta anche con il particolare scopo di poter adattare
climaticamente edifi ci tradizionali.
Infatti poter aprire o chiudere in brevi tempi una copertura permette di usufruire in modo dinamico dello spazio architettonico,
una molteplicità di utilizzo dello spazio stesso e una modulazione delle condizioni acustiche in relazione a specifi che esigenze.
Questi sistemi derivano tutti dal velarium romano che, grazie agli sviluppi dell’industria chimica, ha potuto trovare il proprio
erede moderno nella tecnologia delle tensostrutture a membrane, le cui prime realizzazioni risalgono al 1955 con il progetto
del Bandstand di Frei Otto.
Tra il 1965 e il 1975 si costruirono diverse coperture trasformabili, caratterizzate da superfi ci tensostrutturali, retrattili
lungo direzioni libere di movimento e da un sistema fi sso di cavi, con la duplice funzione di sostegno della membrana e di
scorrimento della stessa. Le strutture sportive e ricreative appaiono come gli ambiti più adatti a questi tipi di soluzioni perché
devono essere utilizzate in qualsiasi condizione climatica.
Negli edifi ci tradizionali le coperture trasformabili possono essere:
- retrattili a forma libera: caratterizzate da una superfi cie tensostrutturale in membrana tessile, retrattile lungo direzioni libere
di movimento, e da un sistema fi sso di cavi con funzione si sostegno tensostrutturale e di scorrimento della tela;
- retrattili ad ombrello: nelle forme più semplici, un’asta centrale sorregge delle bacchette radiali che a loro volta sostengono
la membrana di rivestimento in tensione. La connessione tra l’asta centrale e le bacchette può essere rigida o dotata di gradi
di libertà, in modo da permettere l’apertura e la chiusura dello stesso ombrello.;
- scorrevoli a elementi rigidi: sono strutture costituite da parti mobili lungo un perimetro di forma geometrica defi nita e
invariabile durante le fasi di trasformazione.
Roger Taillibert, copertura retrattile in Kevlar sospesa con 26 cavi d’acciaio per lo stadio di Montreal, 1987[

96
SL Rasch, ombrello 10x10m con sistema a braccio pieghevole, 1988; ombrelli per ombreggiamento ripiegabili, Il Cairo, Egitto; Lisbona, Portogallo
Pino Zoppini, Piscina alla Sciorba, Genova, 1993
Le tipologie strutturali con le quali oggi è possibile realizzare coperture convertibili sono tre:
- sistema strutturale a membrana, che può avere:
a) movimento secondo direzioni libere,
b) movimento a scorrimento parallelo,
c) movimento radiale;
- sistema pneumatico, che a livello di trasformabilità sono competitivi per:
a) il sistema costruttivo è composto da un numero più limitato di elementi e la sua
stabilizzazione non comporta il pensionamento di cavi e funi anche a distanze
considerevoli rispetto all’area da coprire,
b) possono essere installate coperture pneumatiche in contesti di limitate dimensioni o
in situazioni critiche per diffi coltà di manovra nelle fasi di assemblaggio,
c) le fasi di apertura e chiusura della superfi cie trasformabile sono in gran parte regolate
unicamente dal sistema pneumatico e pertanto sono ridotti al minimo i problemi
ricorrenti nelle tensostrutture, relativi alla sincronizzazione del movimento dei trattori e
dei carrelli scorrevoli su complessi sistemi di cavi.
- sistema a elementi rigidi, che possono essere:
a) sistemi scorrevoli e telescopici,
b) sistemi “up and down” e pivotanti,
c) sistemi estensibili
Dr. Kamal Ismail, Architekturbiiro Dr. Bodo Rasch, copertura per i cortili della Moschea, Medina, Arabia Saudita, 1991; Nicolas Michelin, Fin Geipel,
copertura pneumatica dell’arena di Nimes, 1988; SIAT, Hangar per dirigibili , Brand, Germania, 2000

97
Chuck Hoberman è un progettista e inventore il cui lavoro esplora le possibilità delle geometrie cinetiche che defi niscono lo
spazio e la struttura attraverso sistemi ripiegabili ed estensibili.
Il suo lavoro più famoso è la Hoberman Sphere, una sfera pieghevole che si espande in una grande formagrazie a un
movimento continuo dei suoi componenti interconnessi.
I progetti di Hoberman sono concepiti sulla base di elementi cinetici, collegati tra loro per il trasferimento delle forze che
vengono poi convertite in movimento.
Hoberman ha costruito un gran numero di strutture a grande scala, inclusa la Retractable Dome per l’Expo 2000 ad
Hanover, in Germania, e l’Expanding Hypar per il Science Center a Los Angeles nel 1995. Il suo più grande progetto fu
realizzato per i Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City in America nel 2002.
Hoberman creò una “tenda” meccanica di 22 metri chiamata Hoberman Arch per il palco che avrebbe dovuto ospitare tutte
le cerimonie di assegnazione delle medaglie, chiudendo e aprendo l’arco, l’utilizzo della struttura sarebbe stata così garantita
in qualsiasi condizione climatica. Una volta chiusa, la struttura cinetica avrebbe occupato solo una fascia di 1.8 metri.
L’arco fu costruito con alluminio strutturale e 96 pannelli traslucidi fi bro rinforzati. Il meccanismo per il movimento era azionato
da un motore elettrico di 30 Hp.
Più di 500 luci controllate da un computer furono integrate nella struttura in modo da creare degli spettacolari giochi luminosi
durante l’apertura e la chiusura del sistema.
Gli elementi mobili producevano un duplice effetto: creavano un evento all’interno dell’evento stesso della manifestazione e
stupivano gli spettatori nel vedere il movimento all’interno dell’elemento architettonico da sempre considerato statico.
Chuck Hoberman, Hoberman Arc, Salt Lake City, USA, 2002
Chuck Hoberman, Expanding Geodesic Dome, Liberty Science Center, Jersey City, NJ, USA, 1991

98
Il Beng Sjostrom/Starlight Theatre è stato progettato dallo studio Gang O’Donnel, ora Gang Architects, per il Rock Valley
College dell’Illinois. Doveva rimpiazzare la sede all’aperto del teatro preesistente ma i clienti volevano che allo stesso tempo si
facesse fronte alla necessità di avere un luogo riparato dalla pioggia ma poter anche godere del sole o del cielo stellato.
I progettisti quindi idearono un edifi cio che potesse essere costruito con un programma della durata di tre anni che avrebbe
permesso al College di continuare ad organizzare le normali performance ed eventi estivi. L’elemento fondamentale del
progetto è il tetto trasformabile, che è concepito come una piramide composta da sei pannelli triangolari identici fi ssati sul
bordo inferiore alla restante parte della copertura.
Il meccanismo di apertura e chiusura è reso possibile da un sistema idraulico.
Gang Architect, Beng Sjostrom/Starlight Theatre, Rockford, Illinois, USA, 2003

99
Architettura f lessibi le
In generale gli edifici flessibili sono concepiti in modo da rispondere in maniera ottimale ai cambiamenti
d’uso e di localizzazione. È una architettura concepita per adattarsi, trasformarsi, muoversi, interagire
con l’utente.
Molto spesso viene contaminata da altri ambiti e per questo è legata alle tematiche dell’innovazione e dell’espressività
artistica. Comunque la fl essibilità non deve essere vista come un fenomeno, ma come una caratteristica dell’edifi cio che
si è evoluta assieme alle abilità costruttive dell’essere umano; quando in genere vi sono problemi rispetto alla funzionalità
dell’edifi cio, la fl essibilità dello stesso permette di trovare soluzioni ottimali.
Le strategie per creare la fl essibilità all’interno degli edifi ci sono molteplici e diffi cilmente categorizzabili, possono essere però
identifi cati dei fattori comuni.
Ci sono quattro modi in cui la progettazione può creare delle istanze di fl essibilità nell’architettura che possono avere
applicazione generale in qualsiasi edifi cio:
- elementi trasformabili: spazi che in genere vengono concepiti come ospitanti solamente una sola funzione possono essere
progettati in modo da supportare o incoraggiare altre modalità di utilizzo;
- spazi adattabili: utilizzo dello spazio in prospettiva multifunzionale;
- funzionamento interattivo: l’attenta pianifi cazione e organizzazione dello spazio con la progettazione dello stesso edifi cio
dovrebbe incoraggiare la libertà di movimento del visitatore e aumentare l’interazione con l’utente;
- elementi mobili: l’edifi cio dovrebbe permettere l’allestimento di componenti mobili che possono essere localizzati nello spazio
in molteplici modi.
La visione dell’architettura di Cedric Price, come disciplina che vede i suoi prodotti materiali con una vita limitata, fl essibile
piuttosto che forma fi ssa, lo condusse ad esplorare il concetto di edifi cio come oggetto che defi nisce uno spazio pubblico
piuttosto che spazio defi nito da confi ni netti. Price ha sfi dato costantemente la credenza che gli edifi ci debbano essere una
risposta univoca al problema della statica. Nel 1964 con il progetto Potteries Thinkbelt utilizzò miglia di binari per la creazione
di un’università fl essibile per 20˙000 studenti. Un nuovo luogo si sarebbe creato su terreni industriali non utilizzati con servizi
prefabbricati e mobili, non solo ridefi nendo e riqualifi cando i terreni industriali, ma defi ndendo l’idea di quello che è probabilmente
l’università dovrebbe essere.
Centrale nel pensiero di Price fu l’idea che attraverso l’uso corretto delle nuove tecnologie i cittadini avrebbero potuto avere un
controllo senza precedenti sull’ambiente in cui vivono, avrebbero potuto soddisfare pienamente i loro bisogni e decidere quali
attività avrebbero dovuto insediarsi specifi catamente in quel luogo.
Dal 1971 Price progettò per Londra il Kentish Town Inter-Action Centre, basato sulla sua prima idea per il Fun Palace
(1960-1), incluse una cornice di acciaio aperta nella quale, attraverso una gru che sollevava i componenti, si potevano inserire
muri prefabbricati, gradini e moduli di servizio come preferito dall’utente. Erano inclusi anche studi, uffi ci, un club ed un asilo
nido. Price aveva già pensato che la struttura avrebbe dovuto avere una vita limitata di 20 anni,sebbene in questo lasso di tempo
avrebbe continuamente cambiato conformazione. Le idee di Price avranno importanti infl uenze sulla successiva generazione di
architetti, come Peter Cook degli Archigram e Richard Rogers.
Cedric Price, disegni per Potteries Thinkbelt, Staffordshire, Inghilterra,1965

100
Un edifi cio che è stato progettato specifi catamente attorno al concetto di “meeting place” è l’AT&T Global Olimpic Village
dello studio FTL Design Engineering, creato nel 1996 per i Giochi Olimpici ad Atlanta, Stati Uniti. Sebbene la maggior parte
delle installazioni costruite per i Giochi Olimpici fossero parte di un più generale programma di riqualifi cazione urbana per il
miglioramento futuro dei servizi per i cittadini di Atlanta, ci sono delle funzioni che non possono essere riassegnate facilmente
ad un nuovo uso. È per questo che è necessario concepire anche edifi ci provvisori. La funzione primaria dell’AT&T Global
Olimpic Village doveva essere un luogo per facilitare la comunicazione sia per i turisti che per gli atleti con le loro famiglie nei
paesi natali attraverso postazioni telefoniche, fax e internet point.
A questa funzione era poi associata anche quella di favorire gli incontri tra le delegazioni, attraverso luoghi informali in cui
rilassarsi, ristoranti e sale per conferenze.
L’architettura stessa fu concepita come strumento di comunicazione. Consisteva in due padiglioni con copertura a membrana,
sostenuta da un portale in acciaio, fi ssato su una struttura a due piani. La membrana fu usata come un schermo, con proiettori
controllati da computer in modo da poter far vedere al pubblico gli eventi sportivi in corso senza dover subire la deformazione
del supporto tensostrutturale. L’edifi cio diventò così il fondale del palcoscenico del principale spettacolo che ogni sera veniva
proiettato.
AT&T Global Olimpic Village, FTL Design Engineering Studio, Atlanta, USA, 1996
Un edifi cio fl essibile dovrebbe rappresentare l’architettura che offre innumerevoli opportunità all’utente, un luogo pieno di
opzioni e sfi de che dovrebbero migliorare la vita quotidiana delle persone.
Un’architettura che non esprime la visione di edifi cio chiavi in mano e pronto all’uso, ma una visione proiettata nel futuro, in
cui l’utente modifi ca lo spazio a seconda delle mutate esigenze funzionali.
Pensiamo ad esempio a quanti palazzi, prima dimore signorili, sono ora edifi ci per uffi ci. Questo scenario non è quasi mai
tenuto in considerazione dai progettisti che si accingono a ideare un nuovo elemento architettonico.

101
Architettura adattabile
Gli edifici adattabili sono concepiti per poter rispondere in maniera rapida a differenti funzioni, varie
configurazioni d’uso e specifiche richieste degli utenti; tali edifici sono frequenti nei progetti di edilizia
che prevedono la vendita degli spazi con funzione di uffici o spazi vendita.
Sono edifi ci con spazi poco defi niti, che possono essere facilmente adattabili alle richieste degli appaltatori e dei progettisti.
Questo tipo di edifi ci signifi cano anche un più cospicuo e sicuro ritorno economico per l’investitore, al cambiamento delle
esigenze del mercato, l’edifi cio può essere facilmente modifi cato.
Il ricorso ad una progettazione adattabile sottolinea come il processo di sviluppo dell’idea progettuale non è sempre
qualcosa che può essere intrapreso da un singolo soggetto o un team per creare un progetto fi sso, statico, ma è un processo
di collaborazione tra un numero maggiore di individui.
Comunque la principale caratteristica dell’architettura adattabile è che questa permette all’utilizzatore fi nale dell’edifi cio di
infl uenzare le decisioni progettuali.
Un esempio di architettura adattabile è il caso dell’aggiunta denominata INO all’Insel University Hospital Campus a Berna,
in Svizzera (Suter + Partner Architekten).
Dopo anni di attesa per decidere un programma per creare nuovi servizi, continuamente contrastata dai cambiamenti di staff,
di spazio e di richieste operative, fu adottato un nuovo concetto di pianifi cazione che ponesse in primo piano la possibilità di
adattare il nuovo edifi cio. Il progetto INO fu diviso in tre sistemi: un primo sistema mirato a 100 anni, un secondo a 20 anni,
ed un terzo a 10 anni. Il primo sistema, detto anche “base building”, fu assegnato a Peter Kamme Kundig Architects, ed è
basato su una griglia di 8.4metri con il compito di provvedere alla progettazione dei collegamenti verticali e di alcuni servizi.
Il progetto del sistema secondario è basato sull’uso attuale dell’ospedale già esistente ma tenendo in considerazione
possibili e differenti scenari futuri, con possibilità di riadattamento delle stanze, di cambiamento delle attrezzature e sistemi.
I livelli superiori dell’edifi cio utilizzati per i macchinari hanno permesso il facile aggiornamento di questi per permettere un
miglioramento di tutto l’edifi cio, soprattutto in previsione del futuro utilizzo plurifunzionale previsto come tematica del terzo
sistema. Sistema fondamentale per l’adattabilità di un edifi co, in quanto questa caratteristica è in più stretta relazione con
l’impiantistica (condizionamento, illuminazione, sistemi di sicurezza) rispetto alla semplice riqualifi cazione spaziale.
Sutern + Patner Architekten, INO Hospital, Berna, Svizzera, 2001 -

102
Un altro esempio di adattabilità è il progetto del Ferry Terminal di Yokoama, in Giappone, progettato da Farshid
Moussavi e Alejandro Zaera Polo dello studio Foreing Offi ce Architects di Londra. Il progetto è risultato il
vincitore del concorso di riqualifi cazione del terminal portuale per le navi da crociera bandito nel 1994.
L’idea vincente è stata quella di considerare la possibilità che lo stesso molo diventasse un sistema a più liveli, in cui
il fl usso dei veicoli fosse separato da quello dei pedoni. L’ultimo lembo della propaggine del terminal è diventata una
struttura che ha ridefi nito il landscape del luogo, divenuto un’estensione della città di Yokoama, e un luogo simbolo
della stessa città, anche grazie alla pavimentazione in assi di legno, in netto contrasto con le classiche lastre di
cemento caratterizzanti i moli. Il terminal oltre a mantenere il tale ruolo è diventato un luogo di relazione dei cittadini
della città con numerosi servizi per la collettività.
Foreign Offi ce Architects, Yokohama Ferry Terminal, Giappone, 2002
Infi ne si prende ad esempio la Millennium Dome di Richard Rogers e Buro Happold eretta nel 1999 per i festeggiamenti
per il nuovo millennio.
L’idea progettuale sfi dò la volontà del governo di creare più padiglioni indipendenti; i progettisti decisero di proporre una
grande struttura che dopo le celebrazioni potesse essere riutilizzata. Oggi la Millenium Dome, dopo aver ospitato diverse
manifestazioni, è considerato un successo ingegneristico, tanto che è già stato pensato di adattarla a palestra e centro per la
pallacanestro nelle Olimpiadi che vedranno protagonista Londra nel 2012 e come futuro complesso sportivo per i residenti.
Richard Rogers, Buro Happold, Millennium Dome, Londra, Gran Bretagna, 1999

103
L’architettura mobile è una forma intelligente di abitare un ambiente in un determinato luogo ed in un determinato tempo,
capace di reagire e di interagire con i sempre crescenti cambiamenti sociali e culturali, con le città complesse ed i territori
incerti, i limiti imprecisi, le strutture cangianti.
Il fattore movimento in architettura può essere sia necessità che possibilità. La necessità può essere quella di dover far
fronte a successivi e numerosi cambi di localizzazione, dettati da spostamenti lavorativi delle persone occupanti (camper,
case trasportabili), necessita di presidiare logisticamente un territorio (container attrezzati, moduli prefabbricati), necessita
di dover allestire un evento in un luogo caratterizzante ma mobile, sia per la promozione che per costi di locazione (tendoni,
tensostrutture mobili),ecc.
La possibilità è quella di poter utilizzare il movimento come idea, concept progettuale.
La necessità di inserire il movimento come caratteristica fondamentale è stato il problema principale nell’ideazione di una
struttura per gli scienziati impegnati nella ricerca antartica.
La base di ricerca Halley British Antarctic doveva localizzarsi su una piattaforma ghiacciata nell’Antartide. Il problema
non era lo spessore del ghiaccio (150m) ma il fatto che questo non era statico, infatti si muove di 400 metri l’anno verso il
mare fi no a rompersi in numerosi iceberg. Di conseguenza il bando di concorso redatto nel 2004 prevedeva che nei progetti
fosse tenuto conto di questo evento naturale, oltre naturalmente delle rigide temperature (fi no a -30°C) e ad avere un minimo
impatto sull’ecosistema del polo. Quindi la mobilità come caratteristica necessaria per poter spostare in caso di necessità la
struttura in un luogo più sicuro nel momento in cui le condizioni del ghiaccio fossero diventate proibitive.
I vincitori del concorso sono stati gli ingegneri dello studio Faber Maunsell Ltd, che già in passato avevano intrapreso porgetti
antartici, coadiuvati dallo studio di architettura Hugh Broughton Architects. L’idea è quella di considerare l’edifi cio come
una serie di moduli separati, appoggiati su degli sci che permettono la facilità di spostamento sulla superfi cie ghiacciata. Il
modulo principale sarebbe stato quello più grande e in cui avrebbero trovato luogo tutti i servizi comuni alla comunità dei
ricercatori. Gli altri moduli sarebbero stati attrezzati per avere postazioni di lavoro, aree per il riposo e risorse per la produzione
facilitata di energia. Il progetto prevedeva l’utilizzo di materiali leggeri per la costruzione dei moduli e un alto grado di isola-
mento, in modo da garantire il comfort degli utenti e la facilità di movimentazione.
I moduli sarebbero stati tarsportati in Antartide via mare e poi trasportati sino al luogo della postazione di ricerca grazie agli
sci.
Hugh Broughton Architects, Halley British Antarctic, 2005
Il movimento può essere anche una possibilità progettuale, per poter diventare l’elemento riconoscibile in luoghi diversi e
permettere l’interattività tra la struttura architettonica e l’utente.
Questi sono i casi del Nomadic Museum di Shigeru Ban, della Tower of Winds di Toyo Ito e la Son-O-House del gruppo
Nox.
Nel primo caso il movimento è inteso sia come fattore che porta l’esposizione fotografi ca di Gregory Colbert in mostra nelle
principali città del mondo, sia come elemento di concept progettuali allorché il progettista ha deciso di utilizzare come ele-
mento strutturale proprio uno degli strumenti tipici del trasporto merci, cioè il container.
Nella Tower of Winds il movimento è invece considerato come fattore produttivo dell’illuminamento dell’architettura stessa. Il
mutare di fl ussi della viabilità vicina alla torre stessa provoca il cambiamento e la diversa illuminazione a seconda dell’affol-
lamento e del movimento delle autovetture transitanti.
I L F A T T O R E M O V I M E N T O : T R A N E C E S S I T À E P O S S I B I L I T À

104
Infi ne la Son-O-House, un’installazione artistica permanente sita a Son in Breugel, in Olanda, nella quale il movimento dei vi-
sitatori genera una sequenza di suoni. A seconda dell’approccio dell’utente all’architettura, il suono (programmato dall’artista
Edwin Van der Heide) cambia rendendo la visita un’esperienza unica
(udibili in www.revver.com/video/482781/i-was-in-the-son-o-house/ e http://www.youtube.com/watch?v=NRyfQmlenrI ).
Shigeru Ban, Nomadic Museum; Toyo Ito, Tower of Winds, Yokohama, Giappone, 1986; NOX, Son-O-House, Son in Breugel,Olanda, 2004



L’ARCHITETTURA MOBILE PER ECCELLENZA: LA TENDA, LE SUE DECLINAZIONI MODERNE E L E I NNOVAZ ION I T ECNOLOG ICHE
03

108

109
Giancarlo Cataldi, dice che “in genere un riparo (dal latino reparare = proteggere) può essere considerato un qualsiasi orga-
nismo ligneo monostrutturale e monofunzionale a impianto prevalentemente circolare, rispondente ai bisogni di protezione
occasionale. [...]. Suo archetipo naturale e l’albero, i cui rami, opportunamente curvati e intrecciati, possono aver dato lo
spunto per le prime esperienze costruttive umane” 1.
La tenda, in tutte le forme e tipologie costruttive messe a punto dai diversi popoli nomadi in relazione alle specifi che esigenze,
rappresenta la forma più evoluta del riparo e con il più alto grado di adattamento ambientale.
La tipologia costruttiva attuale più vicina a quella esperienza sono i circhi. Essi conservano infatti ancora oggi la semplice
impostazione strutturale delle antiche tende nomadi; in entrambi i casi gli elementi portanti puntiformi (pali) sopportano i
carichi della soprastante copertura in materiale fl essibile (tessuto). Sia i circhi che le più semplici tende possiedono inoltre un
sistema di funi destinate a mettere in tensione la copertura e a garantire l’equilibrio dell’intero sistema tendostrutturale.
La principale caratteristiche delle tende utilizzate dalle popolazioni nomadi sono quelle di avere una grande versatilità e
fl essibilità per il fatto di poter cambiare confi gurazione seconda delle esigenze, sia abitative che ambientali.
Questi ripari in genere sono uno spazio unico costruito con materiali come le fi bre tessili, pelle e legno, materiali poveri ma
che in genere riescono a garantire un buon riparo dagli agenti esterni.
Inizialmente lo sviluppo di abitazioni mobili era dovuta all’esigenza di spostarsi per cacciare, successivamente per proteggere
anche gli animali domestici che accompagnavano il nomade lungo i suoi percorsi ed ora per dare un alloggio a tutte quelle
persone che devono viaggiare per lavoro o per turismo.
In prima istanza il riparo delle popolazioni nomadi doveva garantire la facilità di trasporto, ma in seguito, soprattutto in
quelle popolazione divenute più stanziali, l’abitazione doveva garantire anche una certa fl essibilità e rispondere alle necessità
determinate dal luogo. È proprio la diversifi cazione dei luoghi in cui le popolazioni nomadi si sono sviluppate che ha prodotto
le varie tipologie di tende oggi ancora esistenti.
L A T E N D A C O M E A R C H I T E T T U R A M O B I L E : D A L L E O R I G I N I A L L E R E C E N T I I N N O V A Z I O N I T E C N O L O G I C H E
1 Giancarlo Cataldi, a cura di, Attualità del primitivo e del tradizionale in architettura, Alinea, 1989, Firenze

110
Tralasciando le molte variazioni sul tema, in genere si possono classifi care tre principali tipi di tende nomadi: il tipi, la tenda
nera e la yurta dell’Asia Centrale.
Il tipi è la tradizionale abitazione degli Indiani delle pianure del Nord America e in lingua Sioux signifi ca “da usare per
riposarsi”. I primi tipi erano piccoli, con copertura semicircolare composta dalle cinque alle sette pelli di bufalo cucite assieme.
I pali venivano prima sbucciati e lisciati in modo da rimuovere tutti i nodi e le imperfezioni che potevano causare infi ltrazioni
d’acqua.
Con l’introduzione della copertura in tela la struttura del tipi veniva eretta attorno a tre, quattro pali, più inclinati per resistere
ai venti dell’est. La struttura a terra non aveva più una forma circolare, ma a forma d’uovo.
Vari Tipi delle popolazioni del Nord America
La tenda nera è la dimora delle popolazioni nomadi più diffusa e può essere direttamente ricondotta alle attuali tensostrutture
tanto che i beduini la chiamano “la casa d’aria”.
Le possibilità di adattamento delle tende dei nomadi sono principalmente due. La prima è la possibilità di adattare la copertura
a seconda della situazione climatica esterna, la seconda è la possibilità di variare le dimensioni dello spazio interno, in genere
con l’eliminazione o l’aggiunta di pali.
La tenda nera, man mano che veniva eretta in nuove zone, veniva adattata all’ambiente particolare. Sulle montagne, dove
talvolta pioveva, il tetto si alzava ripido perché l’acqua scivolasse via, nel deserto era appiattito ed abbassato per proteggere
dal sole e dalle tempeste di sabbia.
Tenda beduina nel deserto del Sahara, Marocco; accampamento in Tunisia; tenda nomade in Giordania
La yurta è la tipica tenda delle popolazioni dell’Asia Centrale (per stragrande maggioranza mongoli), utilizzata da più di 2˙000
anni dalla Mongolia alla Turchia, dai Monti Altai fi no alla Siberia meridionale, all’Afghanistan.
Il termine è di origine turca e signifi ca “luogo/spazio sopra il quale è posta la tenda”.
La struttura generalmente è composta da una parete circolare fatta di legni intrecciati e da pali che, partendo dal reticolo di
base, culminano al centro a formare la copertura. Il tutto è ricoperto da coperte di feltro che, nei casi dei climi più rigidi, può

111
consistere in numerosi strati.
Yurte della Mongolia e relativo montaggio
I principali tipi di tende nomadi possono quindi distinguersi in base alle caratteristiche strutturali, alle confi gurazioni
geometriche della pianta, ai materiali di copertura e anche alle peculiarità d’uso.
In relazione alle caratteristiche strutturali, le tende nomadi si possono distinguere in:
- tende autoportanti, come la yurta della popolazione della Mongolia;
- tende in trazione, come la tenda nera.
I materiali che costituiscono la copertura si differenziano in relazione alle aree climatiche e alla loro stessa reperibilità in
natura: tessuti di pelo di cammello a trama rada (tenda nera), pellami di animali e stuoie pesanti realizzate con arbusti
intrecciati e strati di feltro (yurta).

112
Le tipologie delle tende tradizionali vengono utilizzate come base per lo sviluppo di più tipologie formali utilizzate ad esempio
nel campo dell’assistenza umanitaria, dove vi è la necessità di garantire un certo comfort e una quantità di spazio suffi ciente
per ospitare, in genere, una famiglia sfollata.
Nel manuale “Tents” delle Nazioni Unite vengono riportate le più comuni tende con i relativi vantaggi e svantaggi per fare in
modo che chi si appresta ad organizzare una missione di soccorso possa rendersi conto della soluzione migliore a seconda
del luogo di utilizzo e delle condizioni ambientali. Esse sono:
- ridge tent: è la tradizionale tenda per il primo soccorso, necessità di 2-3 pali verticali e uno di irrigidimento orizzontale,
l’area coperta risulta essere di 12-16m2; ormai è un dispositivo testato ma vi è la limitazione dell’altezza nelle
parti laterali a causa della pendenza della copertura; il peso varia dai 75 ai 120kg;
- center pole tent (tall wall): è la tenda che necessita di un palo centrale per sorreggere la copertura e permette di avere
una altezza laterale maggiore; le pareti laterali sono sostenute da pali; l’area coperta risulta
essere di 16-24m2; l’altezza laterale è un vantaggio ma può risultare negativa in presenza di
forti venti; il peso è in genere di 120kg;
- center pole tent (lower wall): tenda con un palo centrale ma basse pareti laterali; l’area coperta risulta essere di 16-
24m2; il vantaggio è di essere relativamente leggera (50-100kg) ma la limitazione
dell’altezza laterale può essere un problema per gli occupanti;
- hoop tent: è una tenda a forma di tunnel, copre un’area di 12-18m2, ha una altezza suffi ciente ma richiede numerosi
pali ed è ancora in fase di sperimentazione; il peso si aggira tra i 40-80kg;
- frame tent: è una tenda composta da componenti semirigidi, di 16m2, ha un’altezza che ne permette l’utilizzo agevole in
ogni sua parte, richiede però numerosi pali e a volte può essere molto costosa, pesa in genere 100-120 kg;
- nomadic tent (traditional): comprende tutte le tipologie utilizzate dai popoli nomadi, può avere una superfi ci che varia dai
10 ai 30 m2; si adatta molto bene ai climi di varie zone ma una produzione su larga scala in
tempi brevi non è pensabile; il peso si aggira tra i 200 e i 300kg.

113
Attualmente la maggior sperimentazione tecnologica nel campo delle tende è fatta da due tipologie di aziende:
- le aziende del campo sportivo, le cui innovazioni, soprattutto nel campo dei materiali, vengono prima applicate sui prodotti
per le spedizioni (soprattutto alpinistiche) e successivamente trasferite sui prodotti per campeggio; ad esempio: The North
Face®, Salewa, Mountain Hardwear;
- le aziende del campo militare, della protezione civile, della sicurezza, del soccorso medico; ad esempio Aerosekur,
Eurovinil
Non mancano i casi in cui la stessa azienda lavora sia nel campo sportivo che in quello della protezione civile, delle
attrezzature per i soccorsi medici, della sicurezza sul lavoro: ad esempio Ferrino (attrezzature alpinistiche e per primo
soccorso medico o di protezione civile), Camp (attrezzature alpinistiche e di sicurezza sul lavoro), Bertoni® (attrezzature per
sport outdoor e per comunità civili e militari).
Spesso si assiste all’introduzioni di una tecnologia nel campo edilizio dopo che questa è stata sperimentata in settori più
piccoli e specifi ci.
In genere il campo del design, in ogni sua declinazione, può essere un incubatore di innovazioni
tecnologiche estremamente efficiente per tutto l’ambito architettonico. In genere il design è sempre
stato sia più ricettivo ad assorbire le novità e a pensare nuove soluzioni, dando un significativo ap-
porto alla ricerca tecnologica.
Un motivo è che, essendo in genere oggetti di piccole dimensioni, il costo della prototipizzazione può essere minore rispetto
a quello che sarebbe se la tecnologia fosse immediatamente applicata in ambito architettonico. Ma probabilmente vi è anche
una ragione relativa agli investimenti e ai ritorni economici; in genere, come già accennato, il campo edilizio non ha una
signifi cativa immissioni di fondi per la ricerca che è ad appannaggio quasi totalmente delle grandi aziende che in genere ap-
plicano il transfert tecnologico da altri campi in cui sono impegnati (es: industria chimica). Non si dimentichi poi la diffi denza
del consumatore verso le innovazioni, queste devono presentarsi con test che certifi chino le reali prestazioni e non presunte.
In genere è diffi cile che una novità introdotta nell’ambito architettonico sia immediatamente recepita da un considerevole
numero persone, solitamente si tende a fi darsi solamente quando la si vede già applicata in un manufatto.
All’interno di uno sviluppo tecnologico possiamo così distinguere quattro fasi:
- fase iniziale, quando l’innovazione viene introdotta,
- fase di reazione da parte degli operatori e del mercato,
- fase di assimilazione parziale della nuova tecnologia da parte della società,
- fase di diffusione all’interno della totalità del sistema tecnologico.
È proprio per la diffi coltà di diffusione nell’intero sistema che molte aziende creano dei concorsi appositi per far sperimentare
ai progettisti nuovi materiali, staccando quest’ultimi dalle responsabilità di un progetto “privato” con la conseguente scia di
garanzie da dare al cliente.
Molte volte gli stessi concorsi vengono creati per testare le stesse possibilità della nuova tecnologia proposta, proprio
perché i produttori non sempre sanno quali applicazioni può avere il nuovo prodotto o perché vogliono cercarne nuovi settori
di utilizzo.
Nel campo delle tende per spedizioni alpinistiche e nella componentistica per l’attrezzatura di supporto, la ricerca di
soluzioni funzionali e di grande affi dabilità è fondamentale. Si pensi alla necessità di garantire un’impermeabilizzazione
ottimale, anche attraverso speciali saldature dei tessuti nei punti di giunzione, o strutture sempre più leggere ma al contempo
resistenti ai forti venti. La Ferrino® si avvale per le sue tende Highlab del tessuto Texit®, prodotto dal gruppo Frizza, in quanto
devono resistere a condizioni climatiche ed ambientali estreme,.
La tecnologia si basa su nuovo fi nissaggio ad alta traspirabilità, su base poliuretanica, che consente il mantenimento della
temperatura corporea ottimale , in modo che, conseguentemente allo stato di attività, sarebbe destinata a salire nelle zone
di contatto con indumenti esterni o accessori. La mancata eliminazione di questo effetto genererebbe la formazione di
condensa fra il corpo e l’indumento o l’accessorio, nel caso della Ferrino® la tenda, con relativa sensazione di fastidio e
conseguente situazione non confortevole.
L’attivazione di questo automatismo, nel caso di tessuti TEXIT, è immediata “al contrario delle membrane attualmente sul
mercato che invece necessitano, per attivarsi, di tempi di reazione molto più lunghi e intensità signifi cative, con conseguente
creazione di situazioni di disagio per l’individuo”. (wwww.frezzagroup.it)

114
I tessuti così trattati possono garantire prestazioni anche oltre a 10˙000mm di colonna d’acqua (valore di misura
dell’impermeabilità dei tessuti) ed alta resistenza all’abrasione, con qualsiasi tipo di armatura, anche dal lato interno del
tessuto senza particolari necessità di protezione o creazione di tessuti multistrati.
Possiamo affermare che i tessuti TEXIT riescono a combinare, in maniera ottimale, le esigenze di protezione dai fattori esterni
e le necessità di comfort del nostro corpo.
“TEXIT “ è applicabile a tutte le costruzioni tessili, anche elastiche, e alle principali fi bre utilizzate nella realizzazioni di
soluzioni tessili.
Tende Higlab Ferrino, modello Expè, Snowbound 2, Colle Sud e Portaledge utilizzato dagli scalatori.
Nel campo delle tende, soprattutto quelle per gli utilizzi più estremi, si è assistito (e questo è uno dei pochi esempi) ad un
tranfert da conoscenze architettoniche. Infatti per prima la The North Face® nel 1975 presenta Oval Intention, disegnata da
Robert Gillis, studente di Fuller, la prima tenda a cupola geodetica, di peso leggero, caratterizzata dall’impiego di paleria in
alluminio fl essibile. Il design di questa tenda ha stabilito lo standard per tutte le tende d’alta quota e per spedizioni estreme.
Nel 1978 viene presentata la VE-24, la tenda che applica perfettamente la teoria di Buckminster Fuller che prevede “massima
effi cienza con un impiego minimo di materiale”, 4 kg al prezzo di 550$.
Robert Gillis, Oval Intention; VE-24

115
La lezione di Buckminster Fuller quindi è stata fondamentale anche per lo sviluppo del design nelle tende per le spedizioni
estreme; oggi infatti praticamente tutti i produttori di questo genere di attrezzature hanno nel loro catalogo almeno una tenda
di tipo geodetico:
_ Ferrino:
Campo Base : 15kg, circa 700euro
Colle Sud: 15 kg, 1900 euro
-The North Face:
Dome 5 :15.88kg, 1800$
The North Face, Dome 5

116
Oltre al campo delle tende per alte prestazioni ve ne è un altro che può essere da spunto al progettista di shelter. Esso ha avuto
sviluppo sempre dalla tipologia della tenda ma ha trovato larga applicazione nel campo architettonico.
Le tensostrutture infatti derivano direttamente dai principi costruttivi delle tende. Frei Otto, uno dei maggiori esponenti
nel campo delle tensostrutture infatti dice: “I nostri tempi richiedono maggior leggerezza, maggiore risparmio di energie,
maggiore mobilità e adattabilità; in breve esigono costruzioni più sintonia con la natura, capaci al tempo stesso di non
disattendere le domande di sicurezza e protezione. Queste rinnovate richieste rendono necessario un ulteriore sviluppo delle
costruzioni leggere, quali tende, gusci, tendoni e coperture pneumatiche, e promuovono anche l’applicazione di nuovi criteri
di mobilità, fl essibilità e variabilità nelle costruzioni.” 2
Quindi una ricerca di quelle caratteristiche di trasportabilità, trasformabilità, fl essibilità, adattabilità che già si sono prese in
esame per descrivere l’architettura in movimento ma che possono descrivere anche un progetto di architettura statica.
La ricerca progettuale attorno alle membrane è sintomo di una volontà di perseguire quei principi di chiarezza, funzionalità,
stabilità e leggerezza che già molte volte nel corso della storia l’architettura ha cercato di esprimere, sebbene con risultati a
volte molto diversi.
Frei Otto, complesso dello stadio Olimpico di Monaco, 1972
L’architettura a membrana moderna strutturalmente è costituita da una superfi cie tessile che grazie alla forma datale e alla
sua fl essibilità è in grado di sostenere i carichi. Lo sviluppo di questa nuova modalità costruttiva è stata resa possibile dallo
sviluppo di tecniche di tessitura e fi latura attraverso macchine nel 19°secolo, con una diffusione commerciale avvenuta a
cavallo tra Ottocento e Novecento.
Le tensostrutture vengono oggi viste con estremo interesse per perseguire la strada della leggerezza, la quale non signifi ca
solamente chiara idea progettuale ma anche risparmio di materiali durante la costruzione di un edifi cio. Tale ricerca può però
essere agevolata solamente se vi è una continua sperimentazione di tecniche produttive, di nuovi materiali,con una corretta
scelta dei materiali più performanti e il loro corretto utilizzo.
LE DECLINAZIONI MODERNE DELLA TENDA:TENSOSTRUTTURA E PRESSOSTRUTTURA COME CAMPI DI RICERCA PER I MATERIALI
2 Frei Otto, Verso un’architettura minimale, in Brian Foster, Marijke Mollaert, Associazione Tensinet, Progettare con le membrane, tensostrutture e presso strutture, materiali
e tecnologie, ed. italiana a cura di Alessandra Zanelli, Maggioli Editore, 2007, Santarcangelo di Romagna, Rimini.

117
Se la leggerezza sembra essere il punto forte di questo tipo di materiali, la trasportabilità, la trasformabilità, la fl essibilità e
l’adattabilità possono rivelarsi delle opportunità progettuali notevoli.
Infatti “le novità introdotte nel settore chimico e il rinnovamento dei processi di produzione dei tessuti contribuiscono ad
ampliare continuamente la gamma dei materiali tessili disponibili per il progettista. Tessuti fl essibili e pieghevoli, fi lm sottili
trasparenti e ultraleggeri, ma anche elementi di rinforzo per i materiali compositi o per pennellature a più strati, le membrane,
non solo offrono una molteplicità di applicazioni possibili, ma si fanno portavoce in tutti i casi di un’architettura minimale la cui
diminuzione di peso proprio va pari passo con un incremento delle prestazioni dell’effi cienza complessiva.” 3
Ad oggi il settore delle tensostrutture è probabilmente il comparto nel settore edile in cui vi è il più alto grado di innovazione e
avanzamento tecnologico. Tipologie costruttive e soprattutto materiali vedono un notevole sviluppo, ad esempio si sviluppano
strutture a reti di cavi, pneumatiche. I materiali impiegati perseguono la strada della leggerezza associata alle alte prestazioni,
come gli acciai speciali, le leghe, i materiali compositi, tessuti tecnici e fi lm.
Per poter applicare l’innovazione, il progettista deve reperire tutti i dati disponibili sul materiale o
sulla tecnologia che intende applicare. Deve saper analizzare, confrontare e valutare questi dati per
costruire ipotesi di possibili soluzioni.
Queste considerazioni, che sono strettamente correlate con la metodologia e le teorie dell’industrial
design, porteranno alla definizione della risposta progettuale più conforme.
Le tecnologie non ancora esplorate in campo edilizio, ma che derivano da settori produttivi diversi o che rappresentano
soluzioni diverse da quelle per cui sono state pensate, possono essere la risposta ad alcuni problemi o tematiche
progettuali.
Parole chiave, quando si parla di tecnologia, sono ricerca, sviluppo e trasferimento che nell’ambito edilizio possono
essere defi nite come:
_ Ricerca di base e applicata;
_ Sviluppo;
_ Applicazione e divulgazione;
_ Trasferimento;
_ Obsolescenza.
La procedura usualmente legata allo sviluppo della tecnologia è chiamato problem solving process e si compone in:
- Identifi cazione del problema. Informazioni preliminari e defi nizione dei vincoli e dei limiti.
- Sviluppo delle soluzioni del problema. Alcune possibili soluzioni del problema sono sviluppate e rifi nite attraverso
l’ideazione e la procedura brain-storming (pensiero creativo).
- Isolamento e dettaglio della soluzione migliore. La soluzione migliore è selezionata e dettagliata.
- Progettazione e valutazione della soluzione. Modelli fi sici e/o grafi ci della soluzione selezionata sono prodotti e testati.
- La soluzione fi nale è selezionata e preparata per la produzione e l’uso.
Si può affermare che molta della ricerca di base all’interno del sistema tecnologico in generale si attua attraverso lo studio
di nuovi materiali. Le ricerche sono svolte principalmente nelle università e nei centri di ricerca di particolari industrie, per
esempio automobilistiche, chimiche e aeronautiche e generalmente non riguardano direttamente il settore edile.
L’applicazione all’edilizia si attua così, come già accennato, attraverso il trasferimento tecnologico, specie per quanto
riguarda l’applicazione dei cosiddetti materiali innovativi, quali le leghe metalliche, le plastiche, i materiali compositi, ecc.
Nel trasferimento delle tecnologie al campo edilizio, le ricerche si basano principalmente sullo studio di comportamenti e
prestazioni, chimiche, fi siche, meccaniche e termiche, al fi ne di accentuarne le possibilità per l’applicazione.
Lo sviluppo delle membrane è sia legato alla ricerca di materiali che possano assolvere alla necessità di leggerezza intesa
come tematica progettuale, sia come ricerca di metodologie costruttive volte al risparmio energetico e costruttivo.
Una struttura tessile infatti non è affascinante solo per la sua forma, ma offre anche una serie di vantaggi concreti e pratici:
_ tempi brevi di costruzione e montaggio veloce;
_ possibilità di coprire grandi spazi senza l’ausilio di sostegni;
3 Alessandra Zanelli, Progettare con le membrane nel contesto italiano, in in Brian Foster, Marijke Mollaert, Associazione Tensinet, Progettare con le membrane,
tensostrutture e presso strutture, materiali e tecnologie, ed. italiana a cura di Alessandra Zanelli, Maggioli Editore, 2007, Santarcangelo di Romagna, Rimini.

118
_ connubio tra economicità e bellezza;
_ buon isolamento termico in estate grazie all’alta capacità riflettente;
_ buona resistenza ai sismi grazie alla sua massa leggera.
PRINCIPALI MATERIALI PER L’ARCHITETTURA TESSILE: LE PRESTAZIONI3
TIPO DI TESSUTO Poliestere/PVC Poliestere/PVC Vetro/PTFE Vetro/silicone PTFE/PTFE
Tipo di fi nitura
superfi ciale
acrilico PVDF _ _ _
Durata garantita
(anni)
10 15 30 20 30
Resistenza
all’invecchiamento,
max •••••
•• ••• ••••• •••• •••••
Resistenza allo
sporco, max •••••
• •• ••••• •• •••
Traslucenza 12% 12% 14% 20-40% 20-40%
Resistenza al fuoco,
max •••••
••• ••• •••• ••••• •••••
Resistenza alla piega-
tura, max •••••
•••• ••• • •• •••••
Metodo di saldatura ad alta frequenza ad alta frequenza a caldo a caldo con nastro
adesivo
a caldo o ad alta
frequenza
Costo molto basso basso alto medio medio alto
Applicazione
consigliata
trasportabili
industriali
temporanee permanenti permanenti trasformabili
retrattili
Massimiliano Fuksas, Dorina Fuksas, Zenith, Strasburgo, Francia, 2008, membrana tessile in vetro/silicone
3 Heindrum Bögner-Balz, Alessandra Zanelli, a cura di, Ephemerl Architecture. Time and texiles, Proceedings of Tensinet Symposium 2007, 16-18 Aprile 2007, Politecnico
di Milano, Clup, 2007, p.43

119
Le membrane possono essere costituite da diversi materiali, ognuno dei quali con proprie specifi che possibilità e propri
limiti:
1. tessuto spalmato;
2. tessuto non spalmato;
3. fi lm.
Tessuti spalmati
I tessuti spalmati sono il materiale più usato per le membrane. Il tessuto di base è prodotto con fi bre ad altissima resistenza e
spalmato da entrambi i lati. In tal modo è protetto dai raggi UV (in caso di tessuto in poliestere), dall’umidità (in caso di tessuto
in fi bra di vetro), dallo smog, dagli agenti inquinanti e diventa impermeabile.
Il tessuto in poliestere, spalmato con PVC, è normalmente utilizzato per piccole e grandi luci, ma ha una durata limitata nel
tempo rispetto ai materiali convenzionali.
Attraverso un’ulteriore spalmatura sulla superfi cie, il tessuto in poliestere, spalmato con PVC, può essere protetto dallo smog
e dagli agenti inquinanti, rendendo più duratura sia l’immagine esteriore sia l’utilizzabilità.
Le spalmature possono essere effettuate con lacca acrilica, con polivinilidenfl uoruro (PVDF) e con rivestimenti Tediar®.
Il tessuto in fi bra di vetro, spalmato di Tefl on® (PTFE), è il tessuto standard per le strutture che necessitano di un’alta
resistenza e una durata nel tempo paragonabile a quella dei materiali edilizi convenzionali.
Le fi bre utilizzate sono rivestite con un tessuto protettivo e nella maggior parte dei casi sono le seguenti:
- fi bra di poliestere (Trevira, Terylene, Dacron);
- fi bra di composti vinilici (Vinylon);
- fi bra di vetro (Fiberglass);
- fi bre di composti poliammidici (Nylon).
I tipi di spalmatura (rivestimento) più utilizzati sono:
- spalmatura in PVC (polivinilcloruro);
- spalmatura in composti della famiglia delle gomme sintetiche: cloroprene (Neoprene), cloruro di polivinile (PVC), polietilene
e clorosulfanato, politetrafl uoruroetiliene PTFE, polifl uoro-carbonio (Tefl on).
I tessuti esistenti ad oggi maggiormente utilizzati sono:
- tessuti in fi bra poliestere PET rivestiti con PVC;
- tessuti in fi bra poliestere rivestite con PVC e Tediar® (fl uoro di polivinile) più laccatura di polivinile e fl uoruro PVF;
- tessuti in fi bra poliestere PET.
Tessuti non spalmati
Sono molto fl essibili, ma poco impermeabili, così come limitati nella durata nel tempo e nella resistenza; sono soprattutto di
cotone e di PTFE.
I Film
I fi lm si distinguono per la grande rigidezza. La loro alta trasparenza, unita alla traslucidità, non è raggiunta da nessun altro
materiale di membrana. La durata dei fi lm in PVC è limitata, mentre per quelli in etilentetrafl uoroetilene (ETFE) è molto alta.
CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLE MEMBRANE
Tessuto Rivestimento N° fi bre/cm Tens. di Rott. (N/cm) All. a Rott. (%) Modulo E (N/cm)
vinilico gomma sintetica 6/16 1330/1370 28/27 4750/4900
vinilico PVC 18/14 580/530 25/19 2350/2800
vinilico PVC 18/13 530/460 33/25 1440/-
poliestere gomma sintetica 8/9 1330/1330 30/30 4440/4440
fi bra di vetro PTFE 7/11 1300/1000 4.7/8.9 35000/25000
poliestere PVC 9.5/9.5 660/620 14/20 -/-
poliestere PVC 14/15 1000/1000 15/23 -/-
Kevlar PVC _/_ 6000/5500 2,4/2,4 160000/150000

120
La scelta delle membrane da utilizzare dipende dalla tipologia dell’edifi cio che si sta progettando; per un edifi cio temporaneo
o stagionale, il quale deve essere assemblato e dissassemblato con regolarità, bisogna orientarsi verso la scelta di membrane
tessili e supporti di dimensioni e peso contenuti.
Da tenere presente che in genere i tessuti vengono prodotti in larghezze che variano tra i 2 e i 5 metri e quindi nella
progettazione bisogna tener presente che ci dovrà essere la fase in cui la membrana verrà decomposta e sagomata in modo
da assecondare le caratteristiche produttive dell’azienda che fornirà il materiale e i metodi di saldatura.
Le tecniche di giunzione variano a seconda dei materiali è possono essere fatta attraverso:
- cucitura;
- saldatura: termica o ad alta frequenza;
- incollaggio-impiego di adesivi;
- sistemi misti (cucitura-saldatura, usate soprattutto nelle presso strutture).
Se il progetto prevede una grande metratura di membrana dovrà essere presa in considerazione la possibilità di unire varie
parti di membrana direttamente in loco.
In genere poi bisogna pensare che è utile prevedere un rinforzo per il bordo delle membrane, attraverso l’utilizzo di
materiale anche fatto della stessa fi bra del tessuto della membrana stessa, in modo da mantenere una omogeneità nel
comportamento meccanico.
Utilizzare le membrane per la copertura offre, ad esempio, accanto ai “vantaggi della membrana”, anche la possibilità di
risparmio energetico, per l’illuminazione e per la climatizzazione, secondo il luogo e la necessità: le membrane, lasciando
trasparire la luce, di solito non richiedono l’illuminazione artifi ciale durante il giorno, e così non occorre neppure condizionare
l’ambiente. La climatizzazione non è d’altra parte necessaria nemmeno in zone climatiche calde, poiché possono essere
facilmente inserite delle aperture per l’aerazione e, utilizzando un tessuto in fi bra di vetro e politetrafl uoroetilene (PTFE), gran
parte dell’irraggiamento viene rifl esso dal tetto.

REPORT
121
OMBRELLONI PER LA MOSCHEA DEL PROFETA | CONTROLLO CLIMATICO
Location...............................................Medina, Arabia Saudita
Data......................................................1992
Committenti........................................SBG Saudi Binladin Group, Jeddah
Architetti............................................. progetto generale: Dr. Kamal Ismail Membrana: Architekturbiiro Dr. Bodo Rasch
Ingegneri strutturisti.........................SL Sonderkonstruktionen und Leichtbau GmbH Statica: Buro Happold
Consulenti specializzati.....................climatizzazione: Fa. Krantz, Dr.-ing.Haaf Supervistone tempi e costi: Buro Happold
+ SL Sondakonstruktionen und Leichtbau GmbH
Appaltatore.........................................Saudi Binladin Group
Subappaltatore...................................SL Sonderkonstruktionen und Leichtbau GmbH
Membrana..........................................KOIT High-tex GmbH
Meccanica e acciaio:.........................Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Per la realizzazione di una copertura per le corti della moschea del Profeta a Medina, dove si radunano ogni giorno
decine di migliaia di fedeli, era necessario sviluppare un progetto che migliorasse le condizioni climatiche, senza far perdere
all’ambiente che le circonda la propria identità. La soluzione ha previsto l’installazione di 12 grandi ombrelloni mobili di 17m
x 18me alti 14m, che si inseriscono perfettamente nella corte interna rispettandone le proporzioni. Sei parasoli che si aprono
tra i pilastri e il porticato che circonda la corte, riproducono l’effetto delle volte traslucide grazie alla membrana a forma di
imbuto. La climatizzazione avviene regolando la chiusura e l’apertura idraulica degli ombrelloni evitando in tal modo forti sbalzi
termici che incidono sul clima di tutto l’edifi cio.
In estate, gli ombrelloni aperti durante il giorno, creano nella corte la penombra e, grazie al bianco tessuto di PTFE della
membrana, rifl ettono la maggior parte dell’irradiazione solare incidente; durante la notte, gli ombrelloni chiusi permetto alle
superfi ci calde dell’edifi cio di rilasciare l’energia accumulata. In inverno, quando la temperatura media è relativamente bassa,
gli ombrelloni aperti durante la notte evitano che l’edifi cio disperda troppo calore, mentre, chiusi durante il giorno, permettono
ai raggi del sole invernale di raggiungere l’interno della corte e di riscaldarla.
L’apertura e la chiusura degli ombrelloni è regolata elettronicamente attraverso un computer in funzione della posizione del
sole, della stagione, della temperatura esterna, del vento e della nuvolosità. Durante la stagione estiva, quando la temperatura
dell’aria può superare i 45°C all’ombra, il sistema di ombrelloni è affi ancato da un impianto di condizionamento che rende
più confortevole l’ambiente all’interno della corte. Quando piove poi, l’acqua corre lungo la forma a imbuto della membrana
ed è incanalata a terra tramite la colonna.
In ogni parasole sono installate 4 luci che illuminano la corte durante la notte.
Nella fase di progettazione è stata posta particolare attenzione alla forma della struttura del parasole chiuso e alle pieghe
della membrana. Lungo i bracci a sbalzo sono stati posti lembi di protezione particolarmente leggeri, di laminato di resina
sintetica rinforzato con fi bre di carbonio che si muovono grazie ad un meccanismo di aste e cerniere azionato dai bracci stessi.
Quando l’ombrellone è chiuso i lembi formano, insieme al rivestimento metallico dei bracci superiori, un involucro rigido per
la membrana.

122
Oltre alle applicazioni tensostrutturali, cioè membrane tensionate e stabilizzate mediante l’azione di pretensione meccanica,
le membrane tessili trovano utilizzo anche nelle pressostrutture, strutture curvate a forma di sfera e stabilizzate mediante
pressurizzazione dell’acqua o dell’aria.
La differenza di pressione è generata da compressori che immettono l’aria in una membrana chiusa ermeticamente. In genere
non c’è bisogno di elementi di supporto, ma, se sottoposte a condizioni di carico non uniformi e dissimetriche dovute al vento
o alla neve, si destabilizzano.
Questo tipo di strutture hanno trovato impiego anche nelle applicazioni a supporto dell’emergenza. Molte ditte produttrici
di tende campali per uso civile o militare, hanno progettato strutture pressurizzate che fungono da sostegno strutturale alla
membrana di copertura.
Tenda pneumatica
Un esempio di applicazioni degli elementi pressurizzati in architettura è il rivestimento a membrana variabile Texlon, in ETFE
(etilene-tetra-fl uore-etilene), costituito da un insieme di cuscini pneumatici bloccati da estrusi in alluminio.
La particolarità di questo prodotto sta nel fatto che mediante l’impressione di particolari motivi grafi ci sulle membrane
dei diversi strati i materiale e grazie a sistemi pneumatici, è possibili variare la sovrapposizione dei grafi smi modifi cando
l’irraggiamento e la luminosità degli spazi. I sensori solari e della temperatura determinano la pressurizzazione delle camere
d’aria superiori consentendo alla luce di penetrare; con l’aumento della temperatura e dell’irraggiamento le camere d’aria
inferiori vengono pressurizzate in modo da ridurre il livello di irraggiamento.
PTW, The Water Cube National Aquatics Center; Beijing, Cina

REPORT
123
FESTO KG | AIR ARCHITECTURE
Location...............................................Esslingen, Germania
Data........................................................1996-2000
Committenti........................................Festo KG
Architetti............................................. Festo Corporate Design Rasch
Festo è azienda leader nella produzione di membrane pressostrutturali che per dimostrarne le possibilità dei nuovi materiali,
nel 1996 fece realizzare dagli architetti consulenti della ditta un padiglione dimostrativo. Lo scopo era quello di pubblicizzare
la air-tecture, cioè l’architettura che ha come elemento strutturale l’aria.
Per questo anche il design del padiglione non doveva avere precedenti. Con un area di 375m2, 6 metri di altezza, è una delle
prime pressostrutture in cui tutti gli elementi (330) sono ben distinti e pressurizzati separatamente. Spiccano le particolari
colonne a forma di Y derivanti dalla forma delle ali della libellula, le quali, ancorate a terra, sorreggono la copertura. Grazie alla
particolare geometria, in cui zone di pressione e depressione creano una piastra rigida, e alla pressione di esercizio di circa
1bar, la stessa copertura può sorreggere carichi di circa 50kg/m2.
Le pareti sono realizzate con due membrane in poliammide con camera d’aria interposta di 200mm e ad una pressione di
0,5 bar.
La luminosità interna è garantita da fasce verticali e orizzontali in copertura, poste a intervalli regolari, in fi lm Velaglas
trasparente, una nuova membrana derivata dall’alterazione chimica della gomma naturale.
Cavi in acciaio sono necessari per mantenere distanziate le colonne esterne di sostegno e per garantire la stabilità del
manufatto.

124
Riassumendo, le membrane hanno quindi delle qualità che ben si adattano ai concetti guida di questa tesi (trasportabilità,
trasformabilità, fl essibilità, adattabilità):
- leggerezza del materiale;
- traslucenza: in questo modo si può garantire l’apporto necessario di luce solare;
- flessibilità: possibilità di deformazione sotto carico senza comportare danneggiamenti;
- funzionalità: nell’utilizzo e nella manutenzione;
- protezione dagli agenti atmosferici;- mobilità e temporaneità: la leggerezza e la flessibilità del materiale permettono a strutture con
membrane di essere facilmente trasportate e montate;
- adattabilità e trasformabilità: nella sistemazione spaziale e nelle variazioni climatiche.

125
Passi avanti sono stati fatti anche nel controllo del comportamento termico delle membrane, in genere per fare ciò si
aumentano gli strati tessili che costituiscono la pelle dell’involucro; questo però riduce le proprietà di trasparenza. Tale perdita
può essere motivata dai fattori positivi come: la riduzione del trasferimento di calore, la riduzione del rischio di condensa sullo
strato più interno, il miglioramento delle prestazioni acustiche e il potenziamento della resistenza al fuoco.
In genere negli involucri multistrato viene lasciata una lama d’aria di circa 100-500mm e, per evitare la formazione di
condensa, quando una tensostruttura è composta da una membrana multistrato, è possibile ventilare la camera d’aria
interposta, indipendentemente dalle condizioni di comfort interno richiesto; questo permette anche di rimuovere l’eccessivo
calore solare che durante le stagioni calde surriscalda la parte esterna della membrana.
Ora però l’intercapedine può essere riempita con altri materiale che offrono prestazioni nettamente superiori.
Uno di questi materiali è l’Aerogel.
L’aerogel, come i materiali a cambiamento di fase, è un nanomateriale, cioè creato dalla manipolazione su scala nanometrica
dei propri componenti: molecole, atomi.
A seconda delle dimensioni spaziali d’ordine nanometrico avremo: fi lm, lamelle (una dimensione nanometrica), nanotubi,
nanofi li (due dimensioni nanometriche), nanoparticelle con tre dimensioni nanometriche.
L’aerogel, conosciuto anche con il nome di “frozen smoke”, cioè fumo ghiacciato, è la sostanza solida meno densa, cioè più
leggera al metro cubo esistente al mondo. Per un paragone si pensi che l’aerogel ha una densità dell’ordine di 1 mg/cm3,
mentre quella dell’aria è di 1,2 mg/cm3 (si veda il fi lmato su: http://w1.cabot-corp.com/controller.jsp?entry=product&N=23
+4294967252+1000)
L’aerogel di silice riesce a sopportare grandi carichi; campione di aerogel di silice
Le prime molecole di Aerogel,
definito come la struttura rimanente di un alcolgel nel quale la parte liquida viene rimossa senza
intaccare appunto la struttura primaria,
furono create nel 1931 da Steven Kistel. La ricerca era basata sull’idea di poter creare un gel in cui era stata tolta tutta la
componente liquida lasciandone inalterata la struttura molecolare. I primi tentativi prevedevano che la parte liquida del gel
venisse fatta semplicemente asciugare, ma in questo modo la struttura collassava.
Kistel intuì che la parte solida del gel dovesse essere microporosa e che nel momento dell’evaporazione della parte solida
quest’ultima dovesse esercitare delle forze di tensione superfi ciale che distruggessero la struttura dei pori; bisognava
quindi sostituire il liquido con aria.
Per la produzione di aerogel possono essere utilizzati materiali diversi ma il più comune è il gel di silice. In questo gel le
particelle componenti la struttura sono di anidride silicica, lo stesso materiale che costituisce la sabbia e il vetro, che ha la
caratteristica di avere moltissimi e soprattutto piccoli pori.
I l c o n t r o l l o c l i m a t i c o : L ’ a e r o g e l , l e s u e p r o p r i e t à e i l s u o u t i l i z z o n e l l e m em b r a n e

126
L’aerogel di silice consiste, a livello microscopico, in atomi di ossigeno e silicio vincolati in lunghe serie
che poi vengono collegate casualmente lasciando delle sacche d’aria tra esse di circa 100nm (ma che
possono variare a seconda del metodo di produzione).
L’aerogel visto al microscopio elettronico
Specifi catamente il processo inizia mescolando un alcol liquido come l’etanolo un precursore Si(OR)4 (alcossido di silicio) che
porta alla formazione di gel di silice (sol-gel).
Il processo infatti definito “sol-gel” implica il passaggio da una fase liquida di sol a una fase solida di
gel.
Dal gel di silice, attraverso un processo defi nito essiccamento supercritico, l’alcol viene rimosso dallo stesso gel. Ciò viene
tipicamente realizzato utilizzando acetone, che solubilizza l’etanolo per poi venire entrambe rimossi dalla CO2 supercritica.
Il risultato fi nale consiste nella rimozione di tutta la fase liquida dal gel che viene rimpiazzata da gas, senza permettere all’in-
tera struttura del gel un collasso o una diminuzione del proprio volume.
Supercritical Process, fonte Cabot Corporation

127
Il gel può anche essere addizionato di sostanze dopanti con lo scopo di conferire particolari proprietà al solido vetroso
ottenuto. Può essere sfruttato in diversi ambiti produttivi, tra i quali la produzione di ceramiche, la fabbricazione di pezzi per
colatura del fuso, per la produzione di aerogel e rivestimenti molto sottili di ossidi metallici.
A seconda dei diversi tipi di precursore che portano alla formazione del gel di silice, l’aerogel fi nale avrà diverse
caratteristiche:
- Diversa conducibilità termica: precursore conducibilità termica [ W/mK ]
TEOS tetraethylorthosilicate 0.060
TMOS polyethoxydisiloxane 0.020
PEDS tetramethoxyorthosilicate 0.015
- Diversa trasmissione ottica:
Fotografi a dei campioni di aerogel di silice utilizzando i diversi precursori: (a) TEOS, (b) TMOS and (c) PEDS, fonte: P.B. Wagh, R. Begag, G.M. Pajonk, A.
Venkateswara Rao, D. Haranath, Comparison of some physical properties of silica aerogel monoliths synthesized by different precursors, Material Chemi-
stry and Physics, n° 57,1999, pagg. 214-218
Le principali proprietà dell’aerogel, che al tatto si presenta come una schiuma leggera ma rigida, sono strettamente
collegate con la sua struttura molecolare. Esse sono:
- elevata superfi cie, elevata porosità, bassa densità: per la sua stessa struttura molecolare;
- resistenza alla compressione: riesce a sopportare una forza di compressione di 400 volte il suo peso;
- isolamento termico: gli aerogel sono ottimi isolanti termici sia per la struttura interna, sia, per il caso degli aerogel di silice,
per la scarsa conduttività del silice stesso, quelli di carbonio, invece per la capacità di assorbire la radiazione infrarossa;
- isolamento acustico: gli aerogel hanno la capacità di controllo del suono dovuta alla bassa velocità di propagazione delle
onde sonore aerotrasportate attraverso il mezzo poroso e la bassa trasmissione di vibrazione solida a causa della
struttura tenue;
- friabilità: cercando di piegare una lastra di aerogel, questo si spezza facilmente;
- forte essicante: a causa della sua natura igroscopica;
- idrofobo: se trattati attraverso processi chimici, in quanto inizialmente sono idrofi li. I trattamenti idrofobi possono
riguardare solo la parte superfi ciale o anche quella interna; è facile immaginare che quelli trattati anche nella
parte interna sono meno suscettibili al degrado. Questi tipi di trattamenti favoriscono le lavorazioni successive,
come il taglio ad acqua;
- colorazione: essendo costituito per gran parte da aria, l’aerogel è semitrasparente. Il colore azzurrognolo è dovuto al feno
meno chiamato scattering Rayleigh, cioè la diffusione di un’onda luminosa provocata da particelle più piccole
della lunghezza d’onda dell’onda stessa.
I principali tipi di aerogel sono:
- Aerogel di silice: è il tipo più comune, e quello trattato in questa tesi, e anche quello che ha più applicazioni.
Grazie alla caratteristica di assorbire fortemente la radiazione infrarossa, l’ottimo isolamento termico e la sempre maggior
trasparenza, negli ultimi anni nell’ambito architettonico viene sperimentato e prodotto all’interno di elementi quali le fi nestre,
i lucernai, ecc.
La conducibilità termica è estremamente bassa (da 0,03 W/mK a 0,004 W/mK), la densità è di 1 mg/cm3.
Lastre di aerogel sono usate nello spazio come raccoglitori di polvere di comete.
- Aerogel di carbonio: la densità è compresa tra 0,25 e 0,8 g/cm3. L’areogel di carbonio viene prodotto anche in fogli come
conduttore elettrico. Assorbendo la radiazione infrarossa compresa tra 250 e 14,3 μm, viene utilizzato per immaganizzare
l’energia solare.
- Aerogel di allumina: composti da ossido di alluminio, questi aerogel trovano applicazione come catalizzatori e nel caso di
quelli di nichel-allumina sono utilizzati dalla NASA per catturare le particelle spaziali iperveloci.

128
- Calcogel: sono ottenuti dalle sostanze calcogene come il platino; hanno la caratteristica di assorbire i metalli pesanti e le
loro future applicazioni guardano verso la possibilità di utilizzarli nella depurazione delle acque inquinate da mercurio, piombo
e cadmio.
- SEAgel: Il SEAgel (Safe Emulsion Agar gel, ovvero “emulsione sicura di gel di agar”) è stato creato da Robert Morrison del
Lawrence Lawrence Livermore National Laboratory (un laboratorio di ricerca dell’United States Department of Energy
gestito dall’University of California) nel 1992 . È un eccellente isolante termico con densità di 1-500 mg/cm3. Viene prodotto
utilizzando l’agar, un carboidrato ottenuto dall’alga bruna kelp (Laminaria Japonica) e dalle alghe rosse, e per questo motivo
è completamente biodegradabile.
L’AEROGEL DI SILICE
Una delle proprietà più interessanti a livello architettonico degli aerogel è quella di essere buoni isolanti termici.
In realtà negli anni ’30, all’epoca della loro scoperta, questa proprietà non era vista come quella fondamentale, ma dagli
anni ’80, con il crescente interesse verso le questioni ambientali, il risparmio energetico e l’abbattimento delle emissioni di
clorofl uorocarburi, ha riscosso nuovamente l’interesse degli scienziati. Infatti si profi lava l’idea di sostituire i vecchi sistemi di
isolamento garantendo maggior effi cienza e un maggior rispetto ambientale.
L’aerogel su cui si è rivolta la ricerca scientifi ca e di cui oggi possiamo avere i primi prodotti fi niti anche nell’ambito
architettonico è l’aerogel di silice.
Le proprietà dell’aerogel di silice sono soggette a variazione a seconda del metodo di produzione dell’aerogel e dei trattamenti
di post-produzione.
Oltre alle proprietà precedentemente citate se ne aggiungono di seguito altre che possono essere interessanti per
considerazioni architettoniche:
Proprietà Valore Note
Densità 0.003-0.35 g/cm3 La più comune è di ~0.1 g/cm3
Superfi cie interna 600-1000 m2/g
Percentuale solida 0.13-15% Generalmente 5% (95% di spazio libero)
Diametro dei pori ~20 nm
Diametro delle particelle primarie 2-5 nm
Indice di rifrazione 1.0-1.05 Molto bassa per un materiale solido
Coeffi ciente di espansione termica 2.0-4.0 x 10-6 Determinata usando metodi ultrasonici
Modulo di Young 106-107 N/m2
Resistenza alla trazione 16 KPa Con densità di 0.1 g/cm3.
Alla conducibilità di un materiale isolante contribuiscono:
- la conducibilità solida;
- la conducibilità gassosa;
- la radiazione termica.
La somma di questi tre meccanismi dà la conduttività termica totale di un materiale.
Nel caso degli aerogel di silice, contenendo una percentuale solida molto bassa, una composizione
delle catene molecolari terminanti molto spesso senza un unione ad altre catene (dead-ends) e con
andamento tortuoso, permette che la conduttività termica venga ridotta di molto rispetto a un ma-
teriale solido.
I pori hanno dimensione minore della lunghezza d’onda della radiazione solare e della lunghezza dei
percorso del movimento libero delle molecole d’aria, cosicché la conduzione termica è inferiore a quel-
la dell’aria immobile.
Tipicamente gli aerogel di silicie hanno una conduttività termica totale di circa 0,017 W/mK, circa
R 10/inc nel sistema di misurazione anglosassone, ma si possono raggiungere anche valori di R 12
(nella scala di valori R, più è alto il valore, più il materiale ha proprietà isolanti).

129
Materiale Conducibilità termica (W/mK)
Acciaio da costruzione 50
Calcestruzzo normale 2,1
Mattoni pieni 0.96
Vetro 0.8
Poliuretano 0,35-0,58
Legname di latifoglie 0.2
Polistirolo 0,13-0,16
Aria 0,024
Anidride carbonica 0,016
Vuoto 0
Un vantaggio degli aerogel di silice per le applicazioni come materiale isolante è la sempre maggiore trasparenza che
permette l’uso nelle vetrocamere delle fi nestre o in pannelli di lucernai. Infatti il caratteristico colore azzurrastro è stato già
eliminato producendo gli aerogel in ambiente microgravitazionale, nel quale si possono ottenere particelle di dimensioni più
uniformi che riducono lo scattering Rayleigh.
La produzione industriale degli aerogel è iniziata attorno al 2000 e solo negli ultimi anni sono iniziate le applicazioni in campo
architettonico.
Le aziende che per prime hanno investito sperimentato nel campo degli aerogel sono la BASF, la Airglass, l’Armstromg,
l’Aerojet e la Cabot Corporation.
_ Proprietà, caratteristiche ed applicazioni dell’areogel, tratto da: Lawrence W. Hrubesh, Aerogel applications, Journal
of Non-Crystalline Solids, n° 225, 1998, pagg. 335-342
Property Features Applications
thermal conductivity • best insulating solid
• transparent
• high temperature
• lightweight
• architectural and appliance insulation,
portable coolers, transport vehicles,
pipes, cryogenic, skylights
• space vehicles and probes, casting
molds
density/porosity • lightest synthetic solid
• homogeneous
• high specifi c surf, area
• multiple compositions
• catalysts, sorbers, sensors, fuel Storage,
ion exchange
• targets for ICF, X-ray lasers
optical • low refractive index solid
• transparent
• multiple compositions
• Cherenkov detectors, lightweight optics,
lightguides, special effect optics
acoustic • lowest sound speed • impedance matchers for transducers,
range fi nders, speakers
mechanical • elastic
• lightweight
• energy absorber, hypervelocity particle
trap
electrical • lowest dielectric constant
• high dielectric strength
• high surface area
• dielectrics for ICs, spacers for vacuum
electrodes, vacuum display spacers.
• capacitors

130
_ Campi di applicazione dei prodotti contenenti aerogel, tratto da: M. Schmidt, F. Schwertfeger, Application for silica
aerogel products, Journal of Non-Crystalline Solids, n° 225,1998, pagg. 364-368
_ Coeffi ciente di assorbimento acustico per differenti dimensioni delle particelle componenti l’aerogel in
relazione alla frequenza del suono, tratto da: M. Schmidt, F. Schwertfeger, Application for silica aerogel products, Journal
of Non-Crystalline Solids, n° 225,1998, pagg. 364-368
_ Coeffi ciente di assorbimento acustico e coeffi ciente della resistenza termica di diversi materiali con uno
spessore di 20mm, tratto da: M. Schmidt, F. Schwertfeger, Application for silica aerogel products, Journal of Non-Crystalline
Solids, n° 225,1998, pagg. 364-368

131
Attualmente l’aerogel Nanogel viene già sperimenatato in architettura per migliorare le prestazioni di alcuni prodotti come:
- pannelli strutturali compositi
- pannelli in policarbonato e sistemi di coperture trasparenti
- sistemi vetrati
e nell’ultimo anno lo si è applicato anche a
- membrane tensostrutturali, con il prodotto Tensotherm™ prodotto dalla Birdair che verrà di seguito analizzato essendo un
materiale utilizzato nel progetto di tesi.
Kalwall, pannelli sandwich traslucidi
Scobatherm, pannelli isolanti traslucidi

132
Documento WIPO (World Intellectual Property Organization ) sul brevetto del Nanogel (aerogel di silice) della Cabot Corporation

REPORT
133
T E N S O T H E RM™ N A NOG E L ®
Attualmente la ditta che produce una membrana con aerogel è la Birdair.
Il nome commerciale della membrana è Tensotherm™ ed è composta da due membrane esterne di PTFE, le quali proteggono
lo stato isolante di aerogel di silicio ( in questo caso è il Nanogel® della Cabot Corporation).
Dalla documentazione ricevuta direttamente dalla ditta Americana (Amherst, NY) si nota come il prodotto venga presentato
come altamente performante: “with the most effi cient insulation material” .
A corredo ti tale informazione vi un è una tabella di comparazione delle proprietà isolanti tra l’aerogel e gli altri materiali
comunemente usati.
Insulation Values of Existing Building Insulation Products
(valus are per 1inch/25mm of material)
Materiale R-value
Aerogel 8
Mineral wood 4
Loose-Fill cellulose 3,5 circa
Fiberglass Blanket 3
Rockwool poco meno di 3
Perlite 2,5
I valori sono espressi tramite i’ R-Value, tipico del sistema anglosassone, il quale viene defi nito tramite h•ft2•F/Btu.
La defi nizione del valore R si basa sull’apparente conducibilità termica, la quale descrive il calore trasmesso da tutti e tre i
meccanismi: conduzione, radiazione e convezione.
Il fattore di conversione per poter comparare i dati americani con quelli europei espressi in resistenza termica è.
1 F•h•ft2/Btu = 0.1761 Km2/W (o 5.67446 F•h•ft2/Btu = 1 Km2/W)
4 http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS240388+09-May-2008+PRN20080509

REPORT
134
Nei depliant informativi mancano delle specifi che precise riguardo il prodotto Tensotherm™, non viene indicato un R-value
preciso, solamente dai comunicati stampa è possibile scoprirlo:
“The composite fabric system is less than two inches thick, yet it has an insulation value of R-12,
meeting Virginia energy codes.”4
Quindi convertendo in unità europee abbiamo che la membrana Tensotherm™ ha una resistenza termica di
2,1 Km2/W.
È interessante paragonare tale risultato con le caratteristiche del materiale più utilizzato attualmente nell’isolamento: il pan-
nello termoisolante in polistirene espanso.
In questo caso si sono prese a riferimento le tabelle della Basf.
I valori di resistenza termica più vicini a quello della membrana della Birdair sono:
- a ribasso: 1,80
- a rialzo: 2, 3
Nel primo caso tale risultato è ottenuto grazie a pannelli di spessore non inferiore ai 60mm; nel secondo caso il valore prevede
un pannello dello spessore non inferiore ad 80mm.
Quindi la membrana Tensotherm™ della Birdair può vantare un’alta resistenza termica su uno
spessore di pochi millimetri, 0,5 pollici pari a 12,7 millimetri, riducendo di un quinto lo spessore di
materiale che sarebbe necessario utilizzando il polistirene espanso.
Disegno illustrativo della membrana Tensotherm e tabella delle caratteristiche dei pannelli di polistirene espanso della BASF
Da non dimenticare poi che la membrana Tensotherm™ ha anche proprietà di leggerezza (dovute anche all’inconsistenza
dell’aerogel), della traslucenza (garantendo l’apporto della luce solare all’interno ma bloccando la radiazione infrarossa), può
essere modellato a seconda della creatività del progettista essendo fl essibile. Resistente agli agenti atmosferici, impermeabi-
le, e garantisce un ottimo isolamento acustico.
Purtroppo, anche dopo solleciti, la Birdair non ha fornito il peso preciso della membrana, ma da un calcolo con il campione di
membrana, si è potuto approssimare il valore di 2kg/mq.
Dalla veloce lettura di questi dati si può capire come tale membrana offra ai progettisti delle prestazioni di alto livello con un
apporto di materiale minimo.

REPORT
135
Per le caratteristiche sopra elencate, si è deciso di impiegare nel progetto di struttura medica mobile per le emergenze questo
materiale, in modo da garantire allo stesso tempo sia la leggerezza della struttura mobile sia un comfort interno elevato,
assolutamente migliore delle attuali soluzioni garantite dalle strutture attendate per l’emergenza.
Attualmente si conosce solo un progetto che dalla data di commercializzazione del prodotto (inizio 2008) utilizza la
membrana Tensoterm™, è quello per il rifacimento della copertura del Dadmon Athletic Center, alla Radford University,
VA,. Tale cantiere è ancora in corso.
“Cabot Aerogel and Birdair, Inc., Announce First New TensothermTM with Nanogel® Aerogel Fabric Membrane Roof Installation
Dedmon Athletic Center in VA Selects New Insulated Fabric Roofi ng System For Energy Effi ciency, Comfort and Design Ae-
sthetics”
Dadmon Athletic Center, Radford University, VA, USA
La Birdair sottolinea come con la membrana Tensotherm™ rispetta i principi della progettazione sostenibile, non solo per il
grande coeffi ciente di isolamento termico, ma anche perchè il materiale con cui è composta è completamente riciclabile.
Schema del funzionamento della membrana
Naturalmente il prodotto è anche idrorepellente e l’azienda da la garanzia che la membrana può resistere a condizioni
climatiche estreme senza danneggiarsi e richiederne la sostituzione.

REPORT
136
DEFINIZIONI
Conducibilità termica: lambda;[ W/mK ]; la conducibilità termica è una caratteristica specifi ca dei materiali. Indica il fl usso di
calore che con una differenza di temperatura di 1 K passa attraverso uno strato di un materiale di area pari a 1m2 e spesso
1m. Tanto minore è la conducibilità, tanto migliore è la capacità isolante. Il valore lambda, in quanto valore di laboratorio, si
riferisce a materiali asciutti.1
Coeffi ciente di trasmissione termica: U; [ W/m2K ]; il valore U defi nisce la quantità di calore che passa attraverso 1m2 di un
materiale quando la differenza di temperatura degli starti di aria confi nanti sui due lati è pari a 1K e vengono considerate
dalle resistenze alla convenzione termica tra strati di aria e materiale dell’elemento di fabbrica. Il valore U è necessario per la
determinazione delle perdite di calore dovute alla trasmissione. 2
Più il valore è basso, migliore è l’isolamento.
Resistenza alla trasmissione termica: R; [ Km2/W ]; la resistenza alla trasmissione termica è composta dalla resistenza alla
conducibilità termica di un elemento di fabbrica e la resistenza alla convezione termica all’interno e all’esterno. È il reciproco
del coeffi ciente di trasmissione termica. 3
Nel sistema metrico anglosassone il valore R ha unità di misura [ ft2°F h/Btu ] e il fattore di conversione è:
1 ft2°F h/Btu ≈ 0.1761 Km2/W
1, 2, 3 Hegger Auch-Schwelk, Fuchs Rosenkranz, Atlante dei materiali, Utet, 2005, Monaco

137
Un ulteriore incremento delle caratteristiche isolanti dell’aerogel potrebbe venire dall’accoppiamento di questo con materiali
a cambiamento di fase. Esiste già un brevetto per questo tipo di applicazione (WO/2007/014284).
I Pcm, “Phase changing material”, sono accumulatori di calore che sfruttano il fenomeno fi sico della transazione di fase
per assorbire il calore latente, immagazzinare un’elevata quantità di energia, mantenendo costante la propria temperatura e
restituendo il calore all’esterno durante un abbassamento successivo di temperatura.
Il calore latente è la quantità di energia che viene assorbita o rilasciata da un materiale quando cambia la sua fase mediante
fusione o cristallizzazione, cioè quando raggiunge quelle temperature alle quali passa da uno stato all’altro.
L’accumulo può essere realizzato attraverso il passaggio tra le fasi solido-solido, solido-liquido, solido-gassoso e
liquido-gassoso. L’unico cambio di fase usato per i PCM è la transizione tra solido-liquido. Cambi di fase di liquido-gassoso
non sono generalmente usati a causa dei grandi volumi o delle alte pressioni necessarie. I cambi di fase solido-solidi sono
tipicamente molto lenti e hanno un calore basso di trasformazione.
Fotografi a al microscopio elettronico di particelle di materiale a cambiamento di fase dal diametro di 10-15micron
Lo studio dei materiali a cambiamento di fase è interessante se si pensa di accoppiarli all’energia solare, cioè ricavare energia
dalla radiazione solare per poi immagazzinarla in questi stessi materiali.
È necessario scegliere il PCM più idoneo affi nché il range di fusione e di cristallizzazione coincida con la banda di esercizio
delle temperature della fonte di calore. In genere è possibile ripetere infi nite volte il processo di cambiamento di fase senza
aver perdite di resa del materiale.
I principali tipi di materiali a cambiamento di fase sono:
- le paraffi ne: hanno un range di temperature ampio, sono integrabili con i materiali da costruzione, sono chimicamente
stabili, sono riciclabili.
- Gli acidi grassi: range di temperature molto simile a quelle delle paraffi ne, ma il costo è circa il doppio.
- I sali idrati: hanno grande capacità di stoccaggio, basso costo, non infi ammabili.
Negli ultimi anni in commercio sono presenti varie forme di PCM: in polvere, incapsulati, in tubi o in pannelli di fi bra..
I materiali che contengono i Pcm possono essere diversi: cartongesso, legno, intonaco, plexiglas, e possono essere applicati
anche in soluzioni impiantistiche, quali riscaldamento, raffrescamento, collettori solari e scambiatori di calore.
La qualità di questi materiali è di essere termoregolanti, ottimizzano cioè le fl uttuazioni giornaliere della temperatura attraverso
la riduzione dei picchi di calore interni, consentendo un effettivo risparmio energetico e di climatizzazione dell’ambiente.
La BASF produce Micronal® PCM microcapsule applicate sia a intonaci che a pannelli (SmartBoard™) che combinano
un’elevata inerzia termica e una bassa conduttività, pur avendo uno spessore molto ridotto, di 15 mm, Conducibilità termica,
U: 0,18 W/m2K, sia capsule.
“All’interno delle capsule è immagazzinata della cera il cui punto di fusione è tra i 22 e i 26°C, quindi temperature
confortevoli. Quando la cera si fonde, l’energia, ossia il calore solare, viene consumata e fa sì che la temperatura nella stanza
non aumenti.
…
Analogamente, quando fa freddo, grazie alla cera contenuta nell’intonaco, la temperatura interna rimane costante: quando la
temperatura diminuisce la cera si solidifi ca e rilascia calore.
…
Al fi ne di poter realmente mescolare gli accumulatori di calore latente nell’intonaco, gli stessi devono essere protetti.
Affi nchè la cera liquida non sgoccioli dall’intonaco, essa viene inserita in capsule con un involucro di plastica, le cosiddette
P o s s i b i l i n u o v i s c e n a r i

138
microcapsule.Tali capsule sono prodotte sotto forma di dispersione acquosa o di polvere. Grazie a questo procedimenti le
microcapsule Micronal® PCM possono venire introdotte nei materiali da costruzione.” 1
Basf, sfere di materiale a cambiamento di fase all’interno dell’intonaco
Nel brevetto WO/2007/014284, il nuovo materiale inventato da Stanley Lawton grazie ai fi nanziamenti della Boing,
prevede la miscelazione tra aerogel e materiali a cambiamento fase attraverso un legante formante la matrice che provvede
a trattenere assieme le varie particelle.
Il materiale a cambiamento di fase è capace di immagazzinare energia termica come calore latente.
L’invenzione offre un metodo per produrre un corpo isolante attraverso la co-deposizione, sopra un substrato, di particelle di
aerogel e di particelle, legate attraverso una soluzione formata dalla matrice e da un vettore. Il vettore viene poi rimosso per
formare un corpo isolante solido sul sobstrato.
Una seconda possibilità è quella di avere un metodo per formare un corpo isolante inserendo simultaneamente le due
soluzioni sopra un substrato. La prima soluzione comprende le particelle di aerogel e la seconda la matrice.
Depositandosi separatamente, le due soluzioni prevengono la degradazione e la friabilità delle particelle di aerogel durante la
stessa deposizione. Vengono evitati così i problemi relativi alla diffi coltà di mescolare le particelle di aerogel e la matrice prima
della alla deposizione su substrato.
Vi è poi un’altra invenzione registrata con il numero WO/2007/130315 e dal titolo AEROGEL/POLYMER COMPOSITE
MATERIALS in cui si è sviluppato un nuovo metodo per la produzione di materiali compositi.
Inventato da Martha Williams, Trent Smith, James Fesmire, Luke Roberson, LaNetra Clayton, il materiale è costituito da
aerogel mescolato con un polimero termoplastico in rapporto di 20:100.
Questo accoppiamento garantirà maggiore fl essibilità e minor fragilità a temperature basse rispetto ai materiali termoplastici
usuali.
Anche in questo caso il fi nanziatore è un ente aerospaziale, per la precisione the administrator of the national aeronautics and
space administration del governo degli Stati Uniti d’America.
1: http://www.basf-italia.it:8080/basfcms/product1.jsp?p=84

139
Brevetto WO/2007/014284

140
Brevetto WO/2007/130315

141
Il ruolo di internet nel reperimento delle informazioni relative a innovazioni in genere, e nel campo dell’edilizia in particolare, è
fondamentale in quanto permette di avere un contatto pressoché immediato con le informazioni tecniche.
Poter accedere in tempo reale al sito internet dell’azienda e ai relativi prodotti è certamente un vantaggio per la comunicazio-
ne e la successiva presa in visione dei prodotti; in passato invece il progettista doveva basarsi sulle informazioni che poteva
reperire solo nelle fi ere specialistiche, dagli informatori o dai commercianti.
Nello sviluppo di prodotto è solo nelle ultime fasi che si decide se un’invenzione diventa veramente un’innovazione. Il puro
infl usso tec¬nico è rilevante all’inizio e diminuisce alla fi ne. Il contrario vale per la possibilità di infl uenza degli architetti in
quanto rappresentanti del mercato fi nale. È evidente che con il precoce coinvolgimento di tutti gli operatori alla catena di
creazione del valore si producono innumerevoli possibilità: si possono evi¬tare costosi errori o addirittura impedire proget¬ti
errati già nella fase di sviluppo.
Le possibilità di conoscenza dei materiali attraverso la rete telematica presenta degli aspetti che non sempre favoriscono il
progettista.
Nella ricerca svolta in questa tesi riguardo le membrane tessili e i relativi progetti infatti si è potuto notare come non sempre
l’informazioni tecnica è completa o confrontabile.
Il primo fattore problematico è proprio la non standardizzazione delle informazioni rispetto a materiali con le medesime
funzioni.
Nel caso delle membrane ad esempio le schede tecniche delle aziende si diversifi cano molto e non sempre informazioni
anche importanti sono presenti.
La Gore™ produttrice della membrana Tenera® nelle schede tecniche descrive, sottolineando che quelle che si stanno
leggendo sono “preliminary specifi cation”, i materiali utilizzati attraverso il peso e lo spessore, la larghezza massima, le
principali caratteristiche meccaniche, la percentuale di trasmissione luminosa e la classe di resistenza al fuoco.
Altre informazioni possono essere ricercate nei fi le pdf che si possono scaricare dal sito e che descrivono singole qualità,
come la trasmissione luminosa, l’infi ammabilita, la composizione chimica, la manutenzione ( www.gore.com/en_xx/products/
fabrics/architectural/gore_tenara_textile_products.html)
La Birdair, una delle prime aziende a sperimentare le tensostrutture grazie al fondatore Walter Bird, nell’illustrare il nuovo
materiale Tensotherm® invece,come si è visto, sia nel sito che nei depliant cartacei richiesti via posta, specifi ca solamente
le caratteristiche che rendono performante il materiale, ma non si fa nessun accenno a caratteristiche specifi che in termini
numerici rispetto agli altri parametri. Questo fa si che il progettista non possa confrontare immediatamente i due prodotti, ad
esempio per quanto riguarda la leggerezza.
Si ritiene quindi, che oltre alle specifi che relative alle prestazioni che rendono competitivo il prodotto, sarebbe necessario pre-
disporre uno standard informativo a cui le aziende potrebbero far riferimento per garantire agli addetti ai lavori le informazioni
basilari sui prodotti proposti.
Applicazioni di Gore Tenara: UN Studio, Mercedes Museum, Stoccarda, Germania, 2005; stazione degli autobus in Norvegia
I L R E P E R IM EN TO D E L L E I N F O RMA Z I ON I E I L R UO LO D I I N T E R N E T

142
Realizzazioni Birdair
Bisogna invece sottolineare come, soprattutto nelle aziende estere, meno purtroppo in quelle italiane, l’assistenza al
progettista via telematica è molto più curata. In breve tempo, nel caso delle due aziende sopra citate, è stato possibile ricevere
informazioni cartacee sui prodotti ma soprattutto i campioni di questi.
Infatti non bisognerebbe mai dimenticare che dopo il primo momento in cui il progettista viene affascinato dal materiale o da
una tecnologia, ci dovrebbe essere un riscontro materiale del prodotto stesso.
Sentire con mano la leggerezza dell’Aerogel è tutt’altra cosa che leggerne solamente; capire effettivamente come la luce
solare passa attraverso una membrana è sicuramente più utile al fi ne del progetto e permette di evitare problemi in fase
avanzata esecuzione.

143
STRUTTURE TEMPORANEE
Per quanto riguarda le strutture temporanee, come possono essere le tende e le loro declinazioni più avanzate, l’Italia ha
aggiornata la propria normativa in base alle disposizioni europee.
Dal 2006 infatti è in vigore la norma UNI EN 13782- 2006 dal titolo Strutture temporanee – tende – sicurezza
(Temporary – Tents – Safety) che stabilisce alcuni requisiti da osservare nella progettazione, nella verifi ca ai carichi,
nell’installazione e nella manutenzione di tutte le strutture temporanee.
Di seguito si riportano i passi più signifi cativi per una corretta progettazione.
Interessante è soprattutto la parte che riguarda il libro che deve accompagnare sempre le strutture temporanee, il
quale deve includere la documentazione relativa ai dettagli costruttivi, ai metodi di montaggio e alle relative operazioni di
manutenzione. Tale considerazione è importante per il fatto che le strutture temporanee vengono concepite alla pari delle
strutture statiche, per i componenti delle quali va presentata la documentazione del corretto funzionamento e della relativa
manutenzione.
Il libro allegato alla tenda dovrà contenere specifi catamente:
- La descrizione del progetto e le operazioni di montaggio/disassemblaggio.
- Disegni generali (con presentazione di tutte le risorse; in scala 1:100 o 1:50).
- Disegni di dettaglio (con un’accurata presentazione della struttura e delle sue parti di connessione; in scala 1:10 o 1:5
scale).
- Analisi statiche.
- Rapporti su specifi che ispezioni e controlli.
- Istruzioni scritte nelle lingue in cui verrà distribuito il prodotto (almeno in tedesco, inglese e francese).
Per tende con superfi cie inferiore a 50 m2 però non è necessario produrre un libretto della tenda e il produttore dovra fornire
solo una documentazione riguardante il comportamento al fuoco del tessuto e la stabilità della struttura.
Le principali caratteristiche dei tessuti utilizzati devono essere defi nite e provate attraversi dei test che provino le se-
guenti proprietà:
- Materiale del tessuto e del rivestimento
- Peso totale
- La resistenza a 23°C
- L’adesione
- Comportamento al fuoco
Ulteriori prove sono richieste per materiali contenenti il poliestere e il polivinilcloruro.
Vi sono poi particolari prescrizioni riguardanti i carichi derivanti dal vento e dalla neve per i quali in genere vengono eseguite
delle prove in galleria del vento o attraverso dei programmi di calcolo specifi ci.
Tutti i test dovranno essere eseguiti nel momento iniziale in cui si intende mettere sul mercato il nuovo prodotto, nelle
periodiche attività di monitoraggi richieste, dopo modifi che o incidenti accorsi, durante il controllo dell’adeguata installazione
in loco.
In aggiunta alle prescrizioni della normative sembra giusto sottolineare un fattore importante relativo alla resistenza al fuoco
delle membrane. In genere i tessuti sono diffi cilmente infi ammabili e un eventuale incendio pertanto non verrebbe alimentato
dalla membrana, ma il fattore di rischio principale consiste nello squarcio che il fuoco può produrre entrando direttamente a
contatto con il tessuto strutturale.
Nel caso poi di strutture presso-statiche lo squarcio e l’apertura delle uscite di emergenza causano lo sgonfi amento della
struttura.
Lo squarcio avviene in modo abbastanza rapido con conseguente affl osciamento della struttura se presenta una dimensione
superiore all’1% della superfi cie totale; se invece gli squarci sono inferiori allo 0,6% si è visto che l’aria calda provocata
dall’incendio contribuisce a sostenere la membrana per un certo periodo di tempo.
NORMAT I V E

144
TENDE E COMPONENTI
Telo di copertura, pareti frontali e catino di base, archi pneumatici di sostegno e tubolari di collegamento
- Caratteristiche minime del tessuto senza spalmatura:
Caratteristica Norma di riferimento
Materia prima UNI ISO 2076:2004 e DL n°194 del 22/05/99 e Direttiva 97/37/
CE
Armatura UNI 8099
Titolo fi lato UNI 4783:1983; UNI 4784:1983; UNI 9275:1988; UNI EN ISO
2060:1997
Riduzione trama/ordito UNI EN 1049-2:1996



LE MAXI EMERGENZE,IL PMA E LE A L T R E T I P O L O G I E D I U N I T ÀMOB I L E D I S O C COR SO S AN I TAR I O
04

148

149
“Un progetto non può che essere la risposta a un bisogno e questo non può che essere espresso da una domanda. (…)
Il bisogno espresso non è mai solo ma ne sottende altri, più o meno evidenti, che rendono ambigua la sua prima
interpretazione. È necessario quindi un approfondimento che continua per tutto l’arco del processo di progetto e termina,
temporaneamente, con la sua conclusione” 1
La frase di Enzo Mari riassume in modo molto chiaro quello che è stato l’iter progettuale di questa tesi. Infatti più il progetto
prendeva forma, più si rendevano necessari ulteriori approfondimenti delle tematiche relative all’operatività in campo sanitario
nelle situazioni di emergenza.
È per tale motivo che in questo capitolo non viene solo defi nito che cos’è il Posto Medico Avanzato, cioè la tipologia di
struttura mobile sanitaria che comporta maggiori vincoli progettuali, ma vengono resi noti anche ulteriori dati che, ad una
prima lettura possono essere visti come superfl ui, ma che si sono rivelati utili per la comprensione delle dinamiche dello
stesso PMA e dell’attività dei soccorritori.
“…la qualità delle scelte di progetto dipende da quella della loro implicita ricerca complessiva.Si determina così una contraddizione irrisolvibile: se il processo di ricerca non può avere limiti perché ogni risposta a una domanda contiene in sé la formulazione di domande successive, il progetto deve essere comunque concluso interrompendo il flusso delle domande. Per questo, ogni progetto teso alla globalità è sempre di qualità inferiore a quella della sua ricerca. Paradossalmente fallisce ogni volta: le scelte che vengono attuate nel momento della sua conclusione obbligata quasi sempre sarebbero diverse se si potesse dare risposta alle nuove domande ormai emerse.La qualità del progetto dipenderà quindi da quella del compromesso tra i dati conosciuti e quelli che non si conoscono ancora.” 2
Enzo Mari, fi gura che esprime l’idea di progetto globale
LINEE GUIDA PER LE MAXI EMERGENZE
1-2 Enzo Mari, Progetto e passione, Bollati Boringhieri Editore, 2001, Torino

150
Citando testualmente il testo della Protezione Civile Italiana sulla pianifi cazione dell’emergenza “Non è purtroppo un’evenienza
rara che un ospedale si trovi, a seguito di una maxi-emergenza, a dover improvvisamente soccorrere un gran numero di feriti,
con conseguente inadeguatezza di servizi calibrati per lo svolgimento del normale carico di lavoro delle urgenze. Altrettanto
frequente è la possibilità che la struttura ospedaliera subisca dei danneggiamenti a causa di eventi naturali e non (terremoti,
incendi, ecc.) e che questo comporti ancora una volta la diminuzione della sua operatività, fi no ad arrivare a casi estremi di
evacuazione parziale o totale dei degenti” 3
Generalmente le maxi-emergenze sono quelle situazioni in cui sono coinvolte un numero significativo di
persone, nelle quali il trasporto immediato agli ospedali non è possibile ed è quindi necessaria una
pianificazione e un filtraggio dei pazienti per lo smistamento verso specifici ospedali, che non neces-
sariamente sono quelli più vicini.
È da tener presente che il fi ltraggio verso gli ospedali è indispensabile anche in queile zone che presentano un alto numero di
presidi ospedalieri sul territorio. Non è possibile infatti dirottare tutti i feriti nell’ospedale più vicino.
Basti pensare che un ospedale ha un numero defi nito di medici rianimatori, i quali possono prendere in cura, se la situazione
lo richiede, solamente una persona alla volta. Inoltre bisogna garantire la miglior assistenza possibile ai feriti, per cui se ad
esempio in un incidente vi sono degli ustionati gravi, questi probabilmente andranno dirottati verso un ospedale specializzato
e non in uno generico.
Un esempio di “congestionamento” di un ospedale a seguito di una maxi emergenza è avvenuto a Tokio il 20 marzo 1995,
a seguito dell’attacco con gas nervino Sarin del gruppo terroristico Aum Shinrikyo nella metropolitana, in cui circa 5.000
persone vennero a contatto con i vapori letali. Il fatto che molte persone fortunatamente sono state colpite da sintomi minori a
seguito dall’esposizione al gas, ha fatto si che queste si recassero autonomamente all’ospedale più vicino, che però non era
attrezzato per l’accoglienza di un numero così elevato di pazienti.
In Italia, grazie al DPCM 13 Febbraio 2001, “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi ”, ogni
ospedale dovrebbe avere un piano per le emergenze (P.E.I.M.A.F. piano d’emergenza interno per massiccio affl usso di feriti)
in cui si defi nisce:
- l’assegnazione delle responsabilità alle organizzazioni e agli individui per effettuare azioni specifi che, progettate nei tempi e
nei luoghi, in un’emergenza che supera la capacità di risposta o la competenza di una singola organizzazione;
- la defi nizione delle azioni da coordinare e delle relazioni fra le organizzazioni;
- l’individuazione delle iniziative idonee a proteggere le persone e la proprietà in situazioni di emergenza e di disastri;
- l’identifi cazione del personale, dell’equipaggiamento, delle competenze, dei fondi e delle altre risorse disponibili da utilizzare
durante le operazioni di risposta;
- l’identifi cazione delle iniziative da mettere in atto per migliorare le condizioni di vita di eventuali evacuati dalle loro
abitazioni.
Possiamo dire quindi che le maxi-emergenze causano:
- un elevato numero di vittime, considerando non solo i morti e i feriti, ma anche coloro che sono stati
danneggiati psicologicamente;
- un improvviso, ma temporaneo, squilibrio tra le richieste delle popolazioni coinvolte e gli aiuti
immediatamente disponibili.
Da qui la necessità di organizzare la gestione dei soccorsi fi nalizzandola alla costituzione di una catena dei soccorsi, cioè
una sequenza di dispositivi funzionali e/o strutturali che permettono la corretta gestione dell’assistenza alle vittime, sia che
l’emergenza sia limitata o meno. Specifi camente consiste nell’identifi cazione, delimitazione e coordinazione dei vari settori e
operatori per il salvataggio dei feriti.
La catena dei soccorsi viene messa in moto quando la Centrale Operativa (C.O) del 118 viene allertata.
Una volta giunta la notizia di una catastrofe o di un fatto accidentale che può dar vita ad una calamità, le sale operative dei vari
Enti coinvolti nella gestione dell’emergenza (118, Prefettura, Protezione Civile, ecc.) dovranno poter acquisire
continuamente informazioni sulla situazione che si è determinata, in modo da poter defi nire correttamente la natura e
l’estensione del disastro.
3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria, Comunicato relativo al decreto del ministero dell’Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio 2001 concernente: Adozione dei “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi ”,
Gazzetta Uffi ciale, n°81 del 16 aprile 2001

151
Catena dei soccorsi sanitari , fonte: Manuale della protezione civile, organizzazione dei soccorsi sanitari in situazioni di eccezionale emergenza
In ambito sanitario le informazioni dovranno riguardare:
- l’estensione della calamità;
- eventuali danneggiamenti alle strutture sanitarie e la funzionalità di quelle non danneggiate;
- una previsione del numero dei morti e dei feriti, la natura delle lesioni prevalenti (fratture, ferite, ustioni, intossicazioni, ecc.),
la situazione delle vittime (facilmente accessibili, da liberare, ecc.), le condizioni ambientali;
- l’orientamento sulle modalità di impiego dei mezzi, degli itinerari preferenziali, delle precauzioni per eventuali rischi tossici,
di esplosioni, di crolli, ecc.;
- il rischio ambientale, cioè la possibilità che lo scenario in cui si è verifi cato lo stato di emergenza sia in evoluzione, è molto
importante nella valutazione e nella defi nizione dell’organizzazione dei soccorsi.
Si pensi ad esempio ad uno scenario alluvionale in cui il sito colpito non è ancora in sicurezza e a rischio smottamenti;
in questo caso l’allestimento di ricoveri nella zona colpita sarà sconsigliato e attuato in zone sicure. Un secondo scenario
potrebbe riguardare rischi ambientali di tipo epidemiologico in cui la prima precauzione sarà quella di isolare la zona colpita.
Da ricordare infatti che i soccorritori devono essere sempre portati a lavorare in situazioni di sicurezza, salvaguardando la loro
incolumità. È dimostrato che al ferimento di un soccorritore, almeno due suoi colleghi saranno impegnati per il suo soccorso
e quindi sottratti dallo scenario dell’evento.
Occorre considerare che ogni tipologia di evento calamitoso presenta un andamento bifasico di risposta alle esigenze di
soccorso sanitario:
- risposta rapida, data dagli organi territoriali sulla base delle risorse locali immediatamente disponibili;
- risposta differita, che si andrà ad articolare nelle ore successive all’evento con l’apporto degli aiuti che giungeranno
dall’esterno all’area interessata.

152
Entrambe le risposte prevedono:
- una Fase di allarme, nel corso della quale si cercheranno di acquisire tutti quegli elementi che possono essere utili a
dimensionare l’evento sia sotto il profi lo qualitativo che quantitativo.
Tale fase, qualora ci si trovi di fronte ad un evento prevedibile, può essere preceduta dalle Fasi di Attenzione e di Preallarme.
Nel caso in cui vi sia la possibilità che una situazione, inizialmente stabile, si evolva, è compito delle Autorità competenti
dichiarare lo stato di attenzione e pre-allarme;
- una Fase di emergenza nella quale si effettueranno tutti gli interventi necessari alla realizzazione della “Catena dei
soccorsi”.
A tali fasi corrispondono livelli di allarme delle centrale del 118:
1. Livello 0. E’ il normale livello di funzionamento della Centrale Operativa; sono attivate le risorse ordinarie e si utilizzano le
normali procedure di gestione.
2. Livello1. Viene attivato quando sono in corso situazioni di rischio prevedibili, quali concerti, manifestazioni sportive o altre
iniziative con notevole affl uenza di pubblico ecc. E’ attivato in loco un dispositivo di assistenza, dimensionato sulla base delle
esigenze ed in adesione a quanto previsto da specifi ci piani di intervento. La Centrale Operativa dispone di tutte le informazioni
relative al dispositivo, monitorizza l’evento ed è in grado di coordinare l’intervento.
3. Livello 2. Viene attivato quando vi è la possibilità che si verifi chino eventi preceduti da fenomeni precursori (alluvioni, frane
etc). Le risorse aggiuntive vengono messe in preallarme, in modo che possano essere pronte a muoversi rapidamente in
caso di allarme. Il medico coordinatore della Centrale Operativa può disporre eventualmente l’invio di mezzi sul posto per il
monitoraggio o per assistenza preventiva.
4. Livello 3. Viene attivato quando è presente una situazione di maxiemergenza. Il dispositivo di intervento più appropriato
viene inviato sul posto e vengono attivate le procedure per la richiesta ed il coordinamento di risorse aggiuntive anche
sovraterritoriali.
Anche per fi ni di progettazione di una Unità Mobile di Soccorso Sanitario vale la pena considerare, in particolare nel
caso di catastrofi naturali che:
• le prime ore dopo il disastro sono gestite unicamente dalle persone presenti sul territorio interessato;
• la grande maggioranza dei sopravvissuti si salva in quanto di per sé illesa o perché salvata immediatamente dopo l’evento
da “soccorritori occasionali”, i cosiddetti “testimoni”;
• l’organizzazione di soccorsi, che dopo le prime ore dall’evento può assumere a volte anche una notevole dimensione, a
fronte del grande spiegamento di forze, salva un numero relativamente basso di vittime, in quanto logicamente non
competitiva nei tempi;
• nella prima fase è inevitabile sempre e comunque, qualunque sia la dimensione dell’evento, la sproporzione tra esigenze
e disponibilità di uomini e mezzi;
• in determinate situazioni sarà quasi impossibile ottenere il personale di supporto previsto dai piani (della C.O. 118,
Intraospedalieri, ecc.) in quanto è credibile che tale risorsa sia comunque stata coinvolta fi sicamente o emotivamente
nella situazione, che non possa raggiungere la destinazione per la non percorribilità delle strade, che non sia contattabile
telefonicamente ecc.;
• l’impiego di mezzi su ruote o aerei non va mai dato per scontato per impercorribilità delle strade,
meteo avverso, ecc. ed è necessario evidenziare che a volte è indispensabile l’arrivo di mezzi di
sgombero prima delle autoambulanze;
• le notizie saranno necessariamente imprecise e scarse, e sarà necessario usare la dovuta cautela nelle scelte operative in
quanto poche notizie o poche richieste non sono indice di incidenti di piccola entità. 4
4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria, Comunicato relativo al decreto del ministero dell’Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio 2001 concernente: Adozione dei “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi ”,
Gazzetta Uffi ciale - serie generale- n°81 del 6 aprile 2001 (Suppl. Ordinario n° 116)

153
Nell’ambito degli scenari ipotizzabili in una maxi-emergenza si possono individuare due tipologie di evento:
- evento catastrofi co ad effetto limitato;
- evento catastrofi co che travalica le potenzialità di risposta delle strutture locali.
La prima tipologia di evento é caratterizzata dall’integrità delle strutture di soccorso esistenti nel territorio in cui si manifesta,
nonché dalla limitata estensione nel tempo delle operazioni di soccorso valutata a meno di 12 ore.
L’intervento sarà pressoché basato sulle informazioni provenienti dalle segnalazioni dei “richiedenti soccorso” che dovranno
essere il più precise possibili per razionalizzare al massimo l’invio dei mezzi di soccorso necessari.
La seconda tipologia, sono quegli eventi catastrofi ci che devastano ampi territori e causano un elevato numero di vittime, il
coordinamento degli interventi risulterà estremamente diffi cile, almeno per molte ore, data la prevedibile diffi coltà a stabilire
le comunicazioni con il territorio interessato per mancanza di reti telefoniche attive, di transitabilità di strade, di energia, ecc.
In questo caso è ancora più marcata la sproporzione che si viene a determinare tra richiesta e disponibilità di uomini e mezzi
da impiegare sul campo.
E’ opportuno ribadire che:
- l’esperienza internazionale ha ampiamente documentato che, contemporaneamente o anticipatamente ai soccorsi sanitari,
è opportuno l’intervento di cospicui supporti tecnici per “urbanizzare” d’urgenza le aree colpite;
- la maggior parte dei sopravvissuti, come già detto, si salva in quanto di per sé illesa o perché salvata immediatamente dopo
l’evento da “soccorritori occasionali”. E’ pertanto indispensabile che soprattutto nelle zone ad alto rischio si provveda ad una
formazione diffusa e corretta sulle misure di primo soccorso sanitario.
Conoscere le caratteristiche delle unità mediche sul campo è molto utile ai fi ni progettuali; esse sono:
- possibilità di mobilitazione in tempi brevissimi, possedere una completa autonomia di almeno 3 gg per lo svolgimento
della funzione (materiali, farmaci, energia, ecc.) e per il supporto al personale ed ai mezzi (alimenti, acqua, abbigliamento,
carburante, ecc.) presupponendo l’impiego su qualsiasi tipo di terreno ordinariamente prevedibile ed in qualsiasi contesto
climatico nazionale;
- possibilità di usufruire di un idoneo sistema di tele – radio - comunicazioni che garantisca i collegamenti al di fuori del
normale luogo di impiego;
- presupposti e dimensioni di “colonna mobile” (la singola ambulanza proveniente da un territorio esterno al teatro operativo,

154
scoordinata e senza collegamenti radio, crea solo problemi);
- non penalizzare il territorio di provenienza (dove l’urgenza ordinaria deve continuare ad essere garantita);
- aver reso noto per tempo i dati di eventuale trasportabilità totale o parziale a bordo di elicotteri, navi, aerei, treni;
- aver reso noto la prestazione sanitaria complessivamente fornibile in termini anche di qualità/quantità (naturalmente propor-
zionale alle “fi gure” previste ed alle dotazioni).5
Entrambe le tipologie di eventi, a carattere limitato o meno, hanno comunque in comune le procedure di intervento iniziali.
Nella prima fase di risposta immediata avviene l’attivazione di squadre di “prima partenza” che hanno il compito di
effettuare:
- la ricognizione del sito;
- il dimensionamento dell’evento;
- l’individuazione della tipologia prevalente dell’evento e delle conseguenze sulle persone;
- l’individuazione e segnalazione delle possibilità di accesso;
- l’individuazione dei luoghi più adatti all’allestimento eventuale degli elementi della “catena dei soccorsi” (PMA e UMSS);
- la suddivisione dell’area in settori, in modo tale che le squadre di soccorso abbiano assegnate zone specifi che;
- il primo triage, non appena terminati i compiti sopra riportati.
La fase di risposta differita consisterà invece in :
- mobilitazione delle risorse locali previste per le maxiemergenze;
- allestimento dei vari elementi della catena dei soccorsi.
Nel caso in cui la situazioni presenti un gran numero di persone ferite è opportuno seguire alcune
prescrizioni come quelle di non utilizzare i mezzi sanitari per l’evacuazione degli illesi o dei feriti lievi, evi-
tare l’invio di pazienti con codice verde negli ospedali vicini all’area, dare assistenza ai pazienti di codice
rosso solo dopo lo sgombero veloce dei pazienti a codice giallo nel caso di rischi in via di evoluzione.
In linea di massima nel nostro Paese la prima fase dell’emergenza raramente si prolunga oltre le
prime giornate, dopo le quali si comincia ad avere un graduale ritorno alla normalità e alla funzionalità
delle strutture sanitarie territoriali.
Nel libro “Medicina delle catastrofi ” di Noto, Huguenard e Larcan viene evidenziato come un funzionamento coerente della
catena dei soccorsi sanitari in situazioni di catastrofe, o d’urgenza, presuppone l’esistenza sul territorio di strutture di cura
provvisorie, capaci:
- di assicurare la raccolta ed il trattamento immediato delle vittime più gravi, ma anche quello dei feriti lievi, dei contusi, o dei
soggetti affetti da alterazioni acute del comportamento;
- di consentire l’attesa dei feriti prima dell’evacuazione verso i centri ospedalieri.
5 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria, Comunicato relativo al decreto del ministero dell’Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio 2001 concernente: Adozione dei “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi ”,
Gazzetta Uffi ciale - serie generale- n°81 del 6 aprile 2001 (Suppl. Ordinario n° 116)

155
Pertanto queste strutture di cure provvisorie realizzano, come già sottolineato precedentemente, una
sorta di “struttura tampone” e consento agli ospedali di prepararsi al sovraccarico di lavoro.
Nel contesto dell’organizzazione dei soccorsi sanitari, in campo civile, queste strutture sono rappresentate da.
- posto medico avanzato (PMA)
- centro medico di evacuazione (CME)
- centro di triage
A seconda della grandezza del dispositivo di soccorso messo in atto l’evacuazione sanitaria si attua:
1) tra PMA e CME (piccola noria);
2) tra CME e ospedali (grande noria).
Si fa presente che la parola “noria” corrisponde all’evacuazione sanitaria delle vittime verso le retrovie, ma anche al ritorno
verso la zona avanzata dei mezzi e del personale di rinforzo o di ricambio.
I soccorritori assicurano così un sistema di catena senza fi ne, di rotazione per una utilizzazione permanente dei mezzi a
disposizione.

156
Il termine triage deriva dal verbo francese trier che signifi ca scegliere, smistare. Il primo ad utilizzare un protocollo di triage
fu il barone Jean Larrey, chirurgo della guardia imperiale ai servizi di Napoleone, che nel diciassettesimo secolo lo introdusse
nella classifi cazione dei feriti durante le battaglie contro gli inglesi al fi ne di razionalizzare l’uso dei medicinali disponibili.
Il triage è quel processo di suddivisione dei pazienti in classi di gravità in base alle lesioni riportate ed
alle priorità di trattamento e/o di evacuazione. 6
In campo militare la defi nizione del triage la si può trovare nell’ “Emergency War Surgery handbook” edito dalla Nato:
“Triage is the dynamic process of sorting casualties to identify the priority of treatment and evacua-tion of the wounded, given the limitations of the current situation, the mission, and available resources (time, equipment, supplies, personnel, and evacuation capabilities).…is the return of the greatest number of soldiers to combat and the preservation of life, limb, and eyesight in those who must be evacuated”.
In ambito civile lo scopo del triage è invece ben riassunto dalla massima di derivazione anglossassone: “ the greatest
good for the greatest number of casualties”.
Lo scopo del triage è quindi quello di razionalizzare le risorse, non infi nite, fi nalizzandole al singolo evento o all’insieme degli
eventi che si verifi cano.
I principali obiettivi del triage sono:
- rapida valutazione delle condizioni del paziente;
- immediata assistenza al malato che giunge in stato di emergenza;
- individuazione delle priorità assistenziali in base allo stato di salute del paziente;
- riduzione del rischio di peggioramento dello stato clinico attraverso un’assistenza rapida e una sorveglianza continua;
- smistamento dei pazienti non urgenti;
- riduzione dei tempi di attesa;
- miglioramento della qualità delle prestazioni professionali del personale sanitario;
- riduzione dell’ansia dei pazienti e delle famiglie con informazioni comprensibili e pertinenti;
- compilazione di una scheda con la registrazione dei risultati del triage per la valutazione della qualità dell’assistenza.
IL TRIAGE
6 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria, Comunicato relativo al decreto del ministero dell’Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio 2001 concernente: Adozione dei “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi ”,
Gazzetta Uffi ciale - serie generale- n°81 del 6 aprile 2001 (Suppl. Ordinario n° 116)

157
L’assegnazione di un codice di priorità, in relazione alle possibilità di cura, rappresenta un passaggio fondamentale al fi ne
di stabilire correttamente l’accesso dei feriti ai soccorsi. Pur variando i modelli utilizzati a livello internazionale, il codice
assegnato al paziente è generalmente contraddistinto da una sigla, da un numero o più frequentemente da un colore.
Il sistema a sigla utilizza una scala defi nita attraverso abbreviazioni in cui si distinguono i vari stati del paziente come:
- EU: Estrema urgenza;
- UP: Urgenza primaria;
- US: Urgenza secondaria;
- NU: Nessuna urgenza.
Il sistema a codici numerici prevede:
- codice 3: Emergenza;
- codice 2: Urgenza;
- codice 1: Urgenza differibile.
In genere in Italia il sistema più usato è quello che prevede l’assegnazione di un codice colore al paziente che giunge
nell’area predisposta al triage.
Il codice colore più usato a livello internazionale è il modello S.T.A.R.T. (Simple Triage and Rapid Treatment) elaborato
dall’Hoag Memorial Presbyterian Hospital di Newport Beach, California e facilmente rappresentabile tramite un diagramma
di fl usso.
- codice rosso: priorità assoluta; indica un soggetto con almeno una delle funzioni vitali (coscienza, respirazione, battito
cardiaco, stato di shock) compromessa e che è quindi in pericolo di vita;
- codice giallo: urgente; indica una compromissione parziale delle funzioni dell’apparato circolatorio o respiratorio, non c’è
un immediato pericolo di vita;
- codice verde: urgente minore; il soggetto riporta delle lesioni che non interessano le funzioni vitali ma vanno curate;
- codice nero: paziente deceduto;
- codice arancione: pazienti contaminati;
- codice bianco (nessuna urgenza): indica un soggetto che non necessita del pronto soccorso e può rivolgersi al proprio
medico.
Schema operativo del metodo S.T.A.R.T.

158
Un altro protocollo messo a punto dall’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi prende il nome di C.E.S.I.R.A (Coscienza,
Emorragia, Shock, Insuffi cienza respiratoria, Rotture ossee, Altro) ed è basato sempre sulla valutazione delle funzioni vitali del
paziente ma necessita una preparazione sanitaria dell’operatore di più altro livello rispetto al metodo S.T.A.R.T.
In genere comunque si stima che per una valutazione del paziente attraverso triage sono suffi cienti 60 secondi.
Per quanto riguarda più strettamente le procedure di Triage, possono essere identificate in tre
livelli:
1. Triage primario: viene svolto sul posto del disastro ed ha come scopo quello di valutare
rapidamente la situazione di tutti i feriti per farne una prima selezione, individuando chi necessita di
cure immediate, in modo da poterlo inviare prontamente al P.M.A.;
2. Triage secondario: viene svolto al P.M.A. e serve per rivalutare i feriti, decidere le priorità di evacua-
zione ed individuare gli ospedali idonei al definitivo trattamento;
3. Triage ospedaliero: viene eseguito al momento dell’arrivo del ferito in ospedale al fine di stabilire
priorità ed iter diagnostico terapeutico.
Ne deriva quindi che in una struttura medica mobile è necessario un allestimento adeguato per il triage secondario.

159
Il Posto Medico Avanzato (PMA) è una definizione che viene attribuita a uno spazio, un luogo in cui
avviene il triage secondario in uno scenario di emergenza.
Questo comporta che esso possa essere sia uno shelter, un riparo costituito da tende o supporti mobili attrezzati, ma anche
uno spazio di strutture già esistenti, come può essere una palestra, un centro congressi, una scuola, ecc.
Per lo scopo che si è prefi ssato per questa tesi, si prenderà in considerazione il PMA come presidio mobile, cioè struttura
indipendente dallo scenario.
Da questo punto di vista, il Pma è la struttura sanitaria mobile con più restrizioni progettuali, in quanto deve avere le
caratteristiche di trasportabilità, trasformabilità, fl essibilità, adattabilità tutte sviluppate e potenziate ai massimi livelli per poter
essere disponibile e funzionante nel minor tempo possibile.
Si vedrà durante la descrizione delle varie tipologie di strutture temporanee utilizzate con funzione di PMA come queste
prestazioni vengano relativamente soddisfatte adottando sistemi poco caratterizzati. Questo comporta da un lato una grande
trasportabilità e facilità di montaggio, ma dall’altro si è potuto constatare come l’architettura del sistema non sia a servizio
della funzione che si svolgerà all’interno.
Infatti le tipologie di shelter utilizzate come PMA sono praticamente le medesime che vengono poi utilizzate per sistemi
campali di assistenza medica con prospettive di attività a più lungo periodo.
Secondo la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 20/23, 24.1.2008 (DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20
dicembre 2007 recante modifi ca della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le modalità di applicazione
della decisione 2007/779/CE) che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile, il Posto Medico Avanzato
ha il compito di “Procedere alla selezione (triage) dei pazienti sul sito del disastro. Stabilizzare le condizioni del paziente e
prepararlo per il trasferimento verso la struttura sanitaria più consona perché sia sottoposto al trattamento defi nitivo” e una
capacità tale da “Procedere al triage di almeno 20 pazienti all’ora, disporre di una équipe medica in grado di stabilizzare 50
pazienti in 24 ore di attività, operando in due turni. Disporre di forniture suffi cienti al trattamento di 100 pazienti con lesioni
lievi nell’arco di 24 ore.”
È infatti un dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, localizzato ai margini esterni dell’area di
sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte dell’evento. Può essere sia una struttura (tende, containers), sia un’area
funzionalmente deputata al compito di radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento e organizzare
l’evacuazione sanitaria dei feriti.
Da questa defi nizione si può capire come, secondo le circostanze, per l’allestimento di un PMA è possibile utilizzare le due
alternative già citate, cioè :
- l’impiego degli edifi ci esistenti;
- l’installazione di sistemi modulari (tende, cellule sanitarie autonome, modulari, trasportabili, shelter)
La localizzazione del PMA deve sottostare a vari criteri:
1. non essere troppo lontano dalla catastrofe, pur tenendo conto dell’eventuale rischio evolutivo legato al tipo di catastrofe.
Oltre che in rapporto al rischio, la localizzazione viene scelta in funzione di molti fattori: parametri meteorologici (rischio
legato alla presenza di sostanze tossiche nell’atmosfera), parametri tellurici ( rischio di crolli e movimento del suolo),
parametri di distanza e di latitudine ( rischio di esplosioni e di inondazioni), parametri di protezione da parte delle forze di
sicurezza ( quando si tratta di attentati per mezzo di esplosivi).
2. Vicinanza alle vie di comunicazione, che consentono l’accesso agevole ai diversi veicoli che convergono al PMA
(ambulanze in particolare) e, nello stesso tempo, disponibilità, sempre nelle vicinanze, di una elisuperfi cie, o di un campo
di aviazione.
3. Non trovarsi in una zona del suolo troppo umido, fangoso, malsano, che possa anche ostacolare il trasferimento dei
veicoli, quando si tratti di un PMA in ambiente rurale. 7
IL PMA (Posto Medico Avanzato): LA TIPOLOGIA DI UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO PIÙ VINCOLANTE
7 Rene Noto, Pierre Huguenard, Alain Larcan, Medicina delle catastrofi , Masson Editore, 1989, Milano

160
PMA allestito dalla Croce Rossa Militare italiana durante un’esercitazione
La Struttura sanitaria di Base o Posto Medico Avanzato (PMA), è un punto di passaggio obbligato per ogni persona recuperata
sul luogo del disastro. A questo livello si effettuano:
- la suddivisione delle vittime in funzione della gravità delle loro condizioni (triage);
- le cure di sopravvivenza: rianimazione e chirurgia vitale;
- la preparazione delle vittime all’evacuazione che potrà avvenire via terra, in aereo o in treno;
- il raduno degli sbandati;
- l’isolamento delle persone in preda al panico;
- la regolazione dei trasferimenti in funzione della patologia, delle disponibilità ospedaliere e dei mezzi di trasporto reperibili;
- la compilazione di una scheda di triage;
- la compilazione di una scheda medico-legale di identifi cazione.
Il trasporto delle vittime al PMA avviene in genere mediante barelle, ma possono essere anche utilizzati veicoli portalettighe di
fortuna. Al loro ritorno i soccorritori riportano sul cantiere il materiale necessario alle prime cure e allo sgombero.
Da tener presente che un PMA deve essere disponibile “a partire al massimo entro 12 ore dall’accettazione dell’offerta
(richiesta intervento). Il modulo deve poter essere operativo 1 ora dopo l’arrivo sul posto”.8
Studi sull’epidemiologia dei disastri dimostrano infatti che la maggior parte delle vittime muore, per i traumi riportati, entro le
prime 72 ore con un picco di decessi massimo entro le prime 12 ore.
È quindi ragionevole presupporre che, ad esempio, in caso di un terremoto di notevole entità si debba procedere
all’installazione di più strutture da campo entro le primissime ore allo scopo di praticare manovre di stabilizzazione alle vittime
del disastro.
8 Gazzetta uffi ciale dell’Unione europea, L 20/23, 24.1.2008, DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2007 recante modifi ca della decisione 2004/277/CE,
Euratom per quanto concerne le modalità di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione
civile

161
Generalmente il PMA è suddiviso in tre zone:
1. Area di Triage.
2. Area di Trattamento.
3. Area di Evacuazione.
Organizzazione di un Posto Medico Avanzato, fonte: Manuale della protezione civile, organizzazione dei soccorsi sanitari in situazioni di eccezionale
emergenza
Nel caso in cui vi sia un gran numero di feriti che affl uiscono contemporaneamente al PMA possono essere approntati più
punti di Triage.
L’Area di Triage è l’area in cui il medico valuta le condizioni del paziente trasportato al PMA dal luogo del sinistro in cui
precedentemente era stato eseguito un triage primario dal soccorritore.
L’Area di Trattamento può a sua volta essere suddivisa in altri due settori:
- Settore terapeutico: nel quale vengono eseguiti gli interventi di emergenza al fi ne di stabilizzare le vittime e
renderle idonee al trasporto;
- Settore di attesa: nel quale vengono raccolti i pazienti con ferite ambulatoriali.
L’Area di Evacuazione deve essere costituita da una postazione in cui stazionano per breve tempo i pazienti in attesa della
presa in carico da parte degli equipaggi delle ambulanze e degli elicotteri.
L’evacuazione sanitaria propriamente detta è gestita dai medici, i quali decidono:
- chi evacuare,
- quando evacuare,
- come evacuare e chi lo deve fare,
- verso dove evacuare.
Deve essere infi ne prevista un’Area di raccolta per le vittime decedute. Questa deve trovarsi in un luogo vicino alla PMA, ma
accessibile soltanto al personale che gestisce l’emergenza. In tale area verranno svolte tutte le attività di riconoscimento delle
vittime e di intervento per evitare problemi di salute pubblica.
Le distinzioni tra le aree non è detto sia necessariamente fisica ma deve comunque aiutare i
soccorritori a creara un flusso di pazienti all’interno della struttura, per questo all’interno del PMA il
flusso dei feriti deve essere obbligatoriamente
unidirezionale (Area di Triage — Area di Trattamento— Area di Evacuazione).

162
Nel PMA lavorano soccorritori e medici con i seguenti compiti:
- soccorritori: segreteria, gestione del materiale, collegamenti radiotelefonici, assistenza al personale sanitario;
- medici: medicalizzazione della zona avanzata, valutazione clinica delle vittime trasportate. Triage, prime cure e scelte delle
modalità di evacuazione, controllo dei deceduti e degli scampati. I francesi defi niscono questa serie di azioni con
la regola delle 3 E: Etiquetage, Emballage, Evacuation ovvero Classifi cazione, Stabilizzazione, Evacuazione.
Le componenti fondamentali di un PMA saranno quindi un’ “Equipe medica per ogni turno di 12 ore: triage con 1
infermiere(a) e 1 medico; cure intensive con 1 medico e 1 infermiere(a); lesioni gravi che non comportano pericolo di vita con
1 medico e 2 infermieri(e); evacuazione con 1 infermiere(a); personale specializzato di supporto con 4unità.
Tende: tenda(e) con zone collegate tra loro destinate al triage, al trattamento medico e all’evacuazione,tenda(e) per il
personale, una postazione di comando e un deposito logistico e per le forniture mediche.” 9
A livello di dotazione medica c’è una importante regola internazionale che interessa anche il progettista di PMA quando
prevede che la struttura possa essere trasportata e montata direttamente in loco assieme all’arrivo del materiale medico.
Infatti le squadre sanitarie “di prima partenza” o “di risposta rapida” non si differenziano solo in base ai compiti ma anche
rispetto all’equipaggiamento da quelle di “seconda partenza o di partenza differita”. L’operatività di queste ultime non è molto
diversa da quella abitualmente espressa nella gestione delle emergenze individuali quotidiane, anche se le loro dotazioni
devono essere potenziate con l’assegnazione dei “lotti catastrofe” contrassegnati dai quattro colori secondo i
criteri adottati a livello internazionale e come indicato nella G.U. 116/2001:
a) materiale non sanitario (colore giallo) il qual potrebbe essere utilizzato anche per contrassegnare il
materiale per l’allestimento del PMA;
b) materiale per supporto cardiocircolatorio (colore rosso);
c) materiale per supporto respiratorio (colore blu);
d) materiali diversi (colore verde)
Estremamente diverso è il compito che devono affrontare le squadre di risposta rapida. E’ infatti inverosimile che pochi
operatori possano realizzare gesti medici complessi per un elevato numero di pazienti soprattutto se questi operatori sono i
primi a presentarsi sulla scena del disastro. Le loro dotazioni risulterebbero infatti mediamente insuffi cienti ed il loro impegno
immediato ad erogare tecniche di supporto avanzato delle funzioni vitali si porrebbe in contrasto con le necessità globali di
gestione dello scenario. Pertanto le squadre sanitarie di prima partenza potranno utilizzare quanto abitualmente contenuto
all’interno del mezzo di soccorso.
La Protezione Civile Italiana ha pubblicato una “Guida alla compilazione della scheda censimento delle unità sanitarie
campali” (http://www.protezionecivile.it/cms/attach/guida_compilazione.pdf) in cui distingue molto chiaramente le tipologie di
strutture mobili per l’assistenza sanitaria in caso di emergenza riprendendo il Supplemento Ordinario della G.U. del 25/8/2003
n°196 concernente i Criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un Posto Medico Avanzato di II
livello utilizzabile in caso di catastrofe.
Si distinguono:
- PMA I livello;
- PMA II livello;
- Ospedale da campo.
In generale possiamo dire che i PMA di I e II livello si distinguono per la durata della situazione di emergenza e per la capacità
di trattamento.
Infatti il PMA di I livello viene generalmente allestito in caso di “catastrofe ad effetto limitato” e cioè in eventi caratterizzati dal
mantenimento dell’integrità delle strutture sanitarie esistenti nonché dalla limitata estensione temporale delle operazioni di
soccorso. 10
Tale PMA presenta le seguenti caratteristiche:
- capacità di trattamento limitata (10 pazienti con codice di gravità giallo-rosso);
- impiego rapido (entro 1 h.);
- durata limitata dell’intervento ( max. 12 h.).
9 Gazzetta uffi ciale dell’Unione europea, L 20/23, 24.1.2008, DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2007 recante modifi ca della decisione 2004/277/CE,
Euratom per quanto concerne le modalità di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione
civile
10 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria, Comunicato relativo al decreto del ministero dell’Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio 2001 concernente: Adozione dei “Criteri massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi ”,Gazzetta
Uffi ciale - serie generale- n°81 del 6 aprile 2001 (Suppl. Ordinario n° 116)

163
Il PMA di II livello è invece previsto in quelle situazioni le cui conseguenze travalicano le possibilità di riposta locale e deve:
- essere pronta all’impiego nel più breve tempo possibile dall’allarme max (3 - 4 h);
- essere in grado di trattare 50 pazienti /gg con codice di gravità rosso-giallo per tre giorni;
- avere 72 h di autonomia operativa.
L’ospedale da campo è una “struttura complessa composta da uomini e mezzi in grado di assicurare alle vittime della
catastrofe un livello di cure intermedio tra il primo soccorso ed il trattamento defi nitivo. Offre la possibilità di effettuare
interventi chirurgici di urgenza, assistenza intensivistica protratta, osservazione clinica, medicina di base.
Trattandosi di un complesso campale di notevole entità, la sua installazione sul luogo dell’evento potrà avvenire a distanza di
giorni dall’allarme e rimanere operativo per un tempo prolungato.” 11
Croce Rossa Italiana, Ospedale da campo in Africa, 1942
In generale possiamo dire però che l’architettura del Posto Medico Avanzato è la medesima che esso sia di I
o di II livello (naturalmente il PMA con unità chirurgica richiede attrezzature e accortezze particolari).
L’obbiettivo di progettare una struttura autonoma e facilmente allestibile può comunque garantire una operatività in stato di
comfort per il personale sanitario e per i pazienti per un periodo più prolungato rispetto alle 12 ore limite della classifi cazione
del PMA di I livello.
La capacità di trattamento di un numero maggiore di pazienti in genere può essere affrontata con l’installazione in sito di un
ulteriore PMA, con un corretto approvvigionamento di risorse e con una adeguata rotazione del personale medico.
Un aspetto rilevante della gestione di un P.M.A. è quello relativo all’organizzazione delle scorte di farmaci e di dispositivi medici
in vista di un’eventuale emergenza, in modo da essere immediatamente disponibili in stoccaggi standard, di essere adattati
ad ogni tipologia di emergenza e di essere facilmente rinnovabili.
Per facilitare gli approvvigionamenti si utilizza il codice ATC (Anatomica, Terapeutica, Chimica) che identifi ca ogni farmaco ed
un elenco descrittivo dei dispositivi medici e dei disinfettanti.
I farmaci sono stati suddivisi per classi terapeutiche riportando:
- principi attivi in commercio in Italia;
- dosaggi e formulazioni presenti in Italia;
- via di somministrazione;
- indicazioni generiche sulla posologia;
11 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria, Comunicato relativo al decreto del ministero dell’Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio 2001 concernente: Adozione dei “Criteri massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi ”, Gazzetta
Uffi ciale - serie generale- n°81 del 6 aprile 2001 (Suppl. Ordinario n° 116)

164
- modalità di conservazione, quando necessarie;
- fase in cui il farmaco deve essere immediatamente disponibile;
- quantità da accantonare.
Gli antidoti suddivisi in:
- tossico;
- antidoto;
- via di somministrazione;
- posologia;
- note;
- quantità.
I disinfettanti e antisettici in:
- principio attivo;
- prodotti disponibili;
- indicazioni e applicazioni;
- caratteristiche;
- norme di conservazione e stabilità;
- avvertenze quantità da accantonare.
L’organizzazione per le altre voci relative a materiali di impiego “generico” può essere fatta attraverso al compilazione di una
lista di equipaggiamenti essenziali ma suffi cienti per affrontare i problemi che si incontrano in uno scenario di maxiemergenza.
Materiale indispensabile
(PMA)
Materiale utile
(PMA)
Materiale utile ma ridondante o con
problemi logistici (successive al primo
momento di emergenza)
Barelle
Teli portaferiti
Materiale per protezione termica
Acqua
Torce elettriche a batteria
Batterie
Lampade
Immobilizzatori per arti
Collari cervicali
Immobilizzatori per rachide
Ferri chirurgici di base
Megafoni
Radiotelefoni
Sacchi di plastica per rifi uti
Materassini a depressione
Compressori di aria
Generatori di corrente
Caricabatterie
Dispositivi per riscaldamento
Shelter (tende pneumatiche o altro)
Supporti per barelle
Telefoni cellulari con fax
Un aspetto importante e da sottolineare è che il PMA è utilizzato molto spesso in supporto a manifestazioni in cui si prevede un
grande affl usso di persone e/o della durata di più giorni.
In genere in base al numero di persone previste vengono allestiti uno o più Posti Medici Avanzati affi ancati da ambulanze o
semplici tende di degenza per le patologie minori.
In questo caso il PMA si prefi gge l’obiettivo di assicurare l’assistenza sanitaria in loco, per quanto possibile, senza gravare sul
normale lavoro degli ospedali. Per la maggior parte delle volte le situazioni che il PMA deve fronteggiare nelle manifestazioni non
sono di maxiemergenza ma di semplice assistenza a singoli pazienti.
Purtroppo però nella storia delle manifestazioni, soprattutto quelle in cui vi è un possibile rischio di maxiemergenza, si pensi alle
manifestazioni aeree, concerti con un numeroso affl usso di persone in luoghi con poche vie di fuga, l’esperienza di tragici eventi
ha portato la normativa a garantire la copertura sanitaria in modo massiccio e sistematico.

165
Dallo studio tipologico dei sistemi mobili più utilizzati in caso di emergenze mediche si è visto come questi, in genere, non sono
concepiti partendo dalla funzione che devono ospitare, cioè quella medica, ma sono dei sistemi strutturali generali.
Questi poi divengono dei centri medici allorché viene predisposto un allestimento, alle volte ridotto ai minimi termini, che ne
identifi ca la funzione.
Le seguenti tipologie di shelter in genere possono ospitare sistemi di supporto medico e/o PMA:
- container;
- moduli prefabbricati;
- sistemi furgonati;
- tende.
I container in genere vengono utilizzati in supporto a emergenze sanitarie nelle quali è previsto che la durata dell’intervento
sarà prolungata nel tempo. Non è pensabile utilizzare un container per interventi che durino ore o alcuni giorni. Il trasporto
infatti richiede mezzi specifi ci e di cui si sia già pianifi cato l’utilizzo in fase di predisposizione delle misure da adottare in
situazioni di crisi.
In genere i container vengono utilizzati dagli eserciti o da organizzazioni per allestire gli ospedali da campo in zone di confl itto o
colpite da calamità. I container infatti possono essere facilmente allestiti in modo da poter assolvere a quasi tutte le specialità
che si possono trovare all’interno di un ospedale vero e proprio. Ogni container diviene così un reparto ospedaliero in cui può
trovare luogo il triage, la farmacia, il reparto oculistico, la radiologia, fi no a sale operatorie attrezzate per i casi più gravi.
Il vantaggio del container è che può essere allestito in genere come se fosse un vero e proprio settore dell’ospedale; inoltre
alcune tipologie, come tra l’altra si è già visto analizzando l’architettura mobile in generale, possono essere espandibili, e
quindi aumentare la propria superfi cie disponibile.
Brigata Alpina Julia, container con funzione di laboratorio e postazione di emergenza
Trasporto di un container a scopo medico; container espandibile allestibile per diverse funzioni mediche (www.uniteamcontainer.com)
TIPOLOGIE DI UNITÀ MOBILI DI SOCCORSO SANITARIO

166
I moduli prefabbricati rientrano anch’essi nella tipologia di quei supporti che in genere non può supportare nell’immediato
l’emergenza. Sebbene composti da elementi preassemblati, il trasporto e l’assemblaggio in loco richiedono del tempo.
All’inizio di quest’anno, durante un’esercitazione internazionale di salvataggio in valanga che ha coinvolto il soccorso
alpino valdostano, quello della Repubblica slovacca e polacca, la Gendarmeria francese e il soccorso alpino della Guardia
di Finanza della cittadina di Entrèves, è stato testato un nuovo modulo di soccorso eli-trasportato della Protezione Civile
della Valle d’Aosta. Il modulo è stato progettato e prodotto dalla ditta Sicit S.p.a. in collaborazione con il dott. Pantaleo Lucio
Losapio e il dott. Carlo Vettorato, consulente sanitario della P.C. della Valle d’Aosta.
Il modulo, che si basa sull’esperienza nel campo della prefabbricazione della ditta produttrice, è denominato M.A.P.I.
(modulo multiuso, abitativo e sanitario a componenti elitrasportabili al gancio).
Dalla relazione tecnica si apprende che: “la struttura dispone di un sistema di montaggio rapido, con impiantistica di base e
arredi centrali essenziali a componenti assemblabili sull’area di intervento.
Struttura totalmente autonoma, predisposta per allacciamenti elettrico, idrico, fognario, dotata di angolo con piastre
elettriche, servizi igienici e arredi centrali. Caratterizzata da automonia, trasportabilità, rapidità d’istallazione, fl essibilità di
impiego, recupero totale e utilizzazione ripetuta.
L’elaborato è stato eseguito partendo dal modulo base MAPI, Modulo Abitativo dalla SICIT, e dal MAPI-H, realizzato con la
consulenza FIELD HOSPITALS.”
Quindi trasportabilità e fl essibilità come caratteristiche indispensabili anche nei sistemi prefabbricati.
Protezione Civile della Valle d’Aosta, modulo M.A.P.I. allestito in occasione dell’esercitazione in Valle d’Aosta
La relazione sottolinea inoltre come il modulo sia “scomponibile per l’elitrasporto al gancio e l’impiego in aree montane o
comunque isolate, con criteri di robustezza, elasticità e indeformabilità”. Infatti la Valle d’Aosta è una delle regioni italiane più
problematiche dal punto di vista del raggiungimento dei luoghi e delle comunità, l’orografi a è sicuramente delle più diffi cili.
In fase aperta di esercizio, il modulo è delle dimensioni esterne di cm. 752x617x230h.
Diviso in 3 parti è costituito da un modulo centrale con i blocchi servizi e impiantistica generale preassemblata nel sotto tetto,
comprendente impianto elettrico, illuminazione, riscaldamento, serbatoio acqua da lt.520 completato da impianto idrico di
adduzione e distribuzione e pompa per circuito a pressione.
La superfi cie interna complessiva è di circa mq 44.20, di cui mq 7.80 occupati dai servizi e circa mq 36.40 di superfi cie
utilizzabile a qualsiasi titolo.
“Il modulo MAPI - AOSTA ha, come caratteristica peculiare, quello di essere scomponibile in blocchi del peso massimo di 900
kg per elitrasporto al gancio, per essere impiegato in qualsiasi area, su qualsiasi piattaforma livellata e stabile, di superfi cie
minima di circa 1200x1000cm, di qualsivoglia fi nitura superfi ciale, anche ghiaia.”
Il problema principale, se il modulo dovesse essere utilizzato per fronteggiare una situazione di crisi
nell’immediato, è che ci vogliono ben 10 elitrasporti per poter disporre di tutto il materiale (20 tra
andata e ritorno).
Nelle conclusioni della relazione tecnica però si sottolinea come lo scopo principale sia stato quello di
poter predisporre una struttura di assistenza anche in zone isolate o non raggiungibili, con il
conseguente declassamento della caratteristica di trasportabilità, o, più precisamente, di velocità nella
trasportabilità.

167
Protezione Civile della Valle d’Aosta, allestimento del modulo M.A.P.I con i vari elementi elitrasportati
Ancora dalla relazione tecnica: “il modulo MAPI-AOSTA è stato ridisegnato sulla base progettuale e concettuale dei moduli
MAPI (ad esclusivo uso abitativo) e MAPI-H (ad esclusivo uso sanitario), per essere destinato come modulo multifunzionale
a operazioni in zone isolate o diffi cilmente raggiungibili dai mezzi di trasporto; quindi le singole componenti nelle quali viene
suddiviso, vengono adeguate all’elitrasporto, con possibilità di posizionamento e montaggio dall’alto e di posa in opera, senza
l’ausilio di ulteriori mezzi di sollevamento, con una squadra di montatori composta da un caposquadra coordinatore delle
operazioni, e n° 6-8 persone addette alle singole operazioni, che avvalendosi del Manuale di montaggio, uso e manutenzione,
possono operare in tutta sicurezza all’assemblaggio dei singoli componenti sopra descritti.
Il modulo è pertanto dedicato alle situazioni di emergenza, per esigenze diverse, compresa quella di importante presidio
sanitario, considerando che trasporto e assemblaggio richiedono un tempo massimo di circa 6-8 ore, dipendenti
principalmente dalla distanza del campo base di arrivo del modulo dalla zona delle operazioni.”
Per quanto riguarda l’allestimento interno il modulo è composto da un blocco per i servizi igienici costituito da un elemento
delle dimensioni di circa cm. 250x150x220h, comprendente il pavimento corrispondente, le pareti laterali, il soffi tto, la
porta di accesso da cm. 100x210 (tutti i sanitari e la doccia sono pre-assemblati) e da un blocco denominato cucina-armadi
costituito da un elemento delle dimensioni di circa cm. 250x170x220h, comprendente il pavimento corrispondente, la parete
divisoria fra i due elementi, le due pareti di testata ed il soffi tto.
L’allestimento medico non viene trattato, viene solo mostrato un esploso assonometrico con vista dall’alto di come si confi gura
montato.
I pesi defi niti dalla ditta Sicit fanno riferimento ai moduli prefabbricati standard in produzione, che poi vengono organizzati per
diventare ad uso sanitario. Essi sono:
modello dimensioni chiuso dimensione aperto peso
MAPI 750 largo 2.44m, lungo 7.5 e alto
3.18
largo 7.32m, lungo 7.5 e alto
2.23
7˙5000/9˙200 kg
MAPI 912 largo 2.44m, lungo 9.12
metri e alto 3.18
largo 7.32m, lungo 9.12 e
alto 2.23
9˙200/11˙500kg

168
Protezione Civile della Valle d’Aosta, presentazione dell’allestimento interno del modulo M.A.P.I. H

169
I sistemi furgonati in genere si pongono l’obiettivo di trasportare tutto l’occorrente all’interno del mezzo di trasporto.
Il mezzo può essere un furgone vero e proprio allestito a scopi medici o essere un carrello che viene poi trainato da un
automezzo. In quest’ultimo caso il rimorchio può o essere già allestito per potervi lavorare all’interno o funge solo da trasporto
dell’attrezzatura medica e logistica per poter allestire un PMA attendato.
Il vantaggio di questi supporti sta nel fatto che possono trasportare in modo veloce l’attrezzatura necessaria nel luogo
dell’emergenza e possono rivelarsi più funzionali durante quelle attività di assistenza sanitaria che si svolgono all’interno
di manifestazioni affollate. Infatti, se permesso dalle normative, può risultare suffi ciente ad assicurare il presidio e non vi è
necessità di allestire tende.
I sistemi furgonati, sebbene abbiano all’interno tutto il necessario, hanno spazi molto ristretti e possono garantire l’assistenza
ad una sola persona alla volta, indipendentemente dal numero di personale medico presente. Questo sistema non è pensabile
per intervenire in situazioni che potrebbero comportare un prolungamento della situazione di crisi e un numero elevato di
persone necessitanti cure.
Lo svantaggio dei sistemi furgonati è quello di essere totalmente dipendenti dal mezzo di trasporto
(portable building – sistema semovente). Se da un lato può essere un vantaggio per la possibilità di avere già tutto il materiale
stoccato e pronto alla partenza, in territori con accessibilità limitata o impedita queste tipologie di supporto sono praticamente
inutili.
Esempi di sistemi furgonati

170
Infi ne le tende, le strutture più leggere e più facilmente trasportabili.
In genere vengo utilizzate due tipi di tende: le classiche tende sostenute da pali e quelle invece sostenute tramite struttura
pneumatica.
Le tende tradizionali utilizzano gli stessi principi costruttivi già trattati nella spiegazione dei casi di emergenze umanitarie o nel
campo del tempo libero e dello sport.
Le tende a struttura pneumatica sono state introdotte con il tentativo di abbattere il tempo di montaggio. La struttura infatti
viene eretta tramite l’immissione di aria all’interno dei tubolari pneumatici.
Vi è comunque la necessità di montare delle aste distanziatici degli archi pressurizzati per conferire alla struttura stabilità nel
senso longitudinale.
Anche se le ditte produttrici assicurano che con le valvole di sicurezza la probabilità è remota, esiste la possibilità che alcuni
settori pneumatici, soprattutto in terreni disagevoli, si strappino, provocando uno sgonfi amento parziale. Inoltre in quasi tutti
i prodotti è necessario mantenere costantemente sotto pressione la struttura, con conseguente rumore del compressore e
spreco di energia.
Allestimento di un posto medico avanzato attraverso tende pneumatiche
Eurovinil, tipologie di archi utilizzati nell’allestimento di una tenda pneumatica; le varie parti sono saldate assieme tramite saldatura elettronica ad alta
frequenza; sotto: eurovinil, tenda pneumatica

171
Sia nelle tende pneumatiche che in quelle a scheletro metallico per aumentare l’isolamento termico vengono montati dei
secondi teli all’interno della struttura.
Se già solamente con il telo di copertura la condensa è uno dei problemi maggiori delle tende, con i due teli a contatto e la
mancata aerazione, questo viene amplifi cato.
Per l’utilizzo in ambienti fortemente soleggiati è inoltre necessaria l’installazione di una apposita struttura ombreggiante
esterna ancorata al suolo con picchetti e distanziata dal telo di copertura con appositi tubolari (su idea dell’esercito) per
permettere la ventilazione ed evitare la condensa.
Brigata Alpina Julia, interno di una tenda pneumatica con secondo telo interno per aumentare l’isolamento termico; sistema per creare una camera d’aria
e diminuire il soleggiamento della tenda

172
Le dimensioni delle tende pneumatiche sono in genere simili a quelle tradizionali, l’Eurovinil ad esempio nei modelli TPSE/06-032, TPSE/06-042,
TPSE/06-044, TPSE/06-052, TPSE/06-054, indica una larghezza pari a 540cm per lunghezze di 515cm se la tenda ha 3 archi pneumatici, 755 se ne ha
4 e 995 per 5 archi, con altezza di 2.80metri.
Le pressioni di esercizio al massimo gonfi aggio raggiungono i 0,35 bar e in genere garantiscono una resistenza per venti che arrivano fi no a 80 km/h.
Sempre nelle schede tecniche dell’Eurovinil viene indicato il peso e i colli necessari al trasporto dei vari componenti:
descrizione colli peso (+/-3%)
3A-2P 4A-2P 4A-4P 5A-2P 5A-4P
Tenda 1 120kg 165kg 175kg 210kg 220kg
Paleria 2 9kg 11kg 11kg 13kg 13kg
Picchetti e maz-
za
3 21kg 25kg 23kg 29kg 27kg
Kit gonfi atore
completo
4 9,5kg 9,5kg 9,5kg 9,5kg 9,5kg
PESO TOTALE 160kg 210kg 219kg 262kg 270kg
All’interno delle tende con struttura metallica vi è un dispositivo in produzione presso la ditta Eureka!
(military.eurekatents.com) chiamato Rapidly Deployable Shelter progettato da Chuck Hoberman (www.hoberman.com,
vedi anche Architettura trasformabile, cap.2 ) e premiato dall’Industrial Design Society of America. Questo sistema, che im-
piega le tecnologie utilizzate in realizzazioni più grandi dello stesso progettista, ha una struttura espandibile senza necessità
di montaggio.
Questo riduce notevolmente i tempi di assemblaggio e predispone un sistema a quasi immediato utilizzo.
Questa tenda è stata espressamente concepita su richiesta della Jonhson Outdoor (detentrice del marchio Eureka!) per poter
essere utilizzate in campo militare. Dalla schede tecniche si apprende come in produzione vi siano tre misure di tende: la
prima di 42m2 pesante 307kg, una di 56m2 per 358kg e una di 61m2 di quasi 400kg.
Chuck Hoberman, Rapidly Deployable Shelter

173
Sebbene le tende siano la struttura che più viene utilizzata nelle situazioni d’emergenza (in quanto facilmente trasportabile,
trasformabile, fl essibile, adattabile), è interessante notare come queste non siano propriamente concepite per fi ni medici; la
stessa struttura è la medesima che viene utilizzata per allestire camerate, attività logistiche, ecc.
Si può quindi dire che non esita una “tenda medica”, cioè un riparo concepito per agevolare il lavoro
dei soccorritori, ma bensì è la grande flessibilità del sistema “tenda” che viene sfruttata anche per
ospitare questa particolare attività.
Brigata Alpina Julia, ospedale da campo
Le ditte che producono tende propongono come allestimenti letti per i triage, brande per la degenza, zaini contenenti il
necessario per il primo soccorso, ma non vi è un integrazione tra struttura e allestimento, cioè non vi sono dispositivi che
permettono un utilizzo più funzionale della tenda stessa quando questa diventa un supporto medico. Anche se vi sono ditte
che producono strumenti elettromedicali portatili o medesime facilitazioni, queste non dialogano in nessuna maniera con la
struttura in cui saranno ospitate.
Non vi è una coordinazione organica tra gli elementi componenti il punto medico d’emergenza. Questo comporta che il medico
si trovi a lavorare in situazioni di dis-comfort in quanto nessuno ha progettato il corretto modo in cui i vari elementi devono
posizionarsi ma soprattutto relazionarsi. Si è visto infatti come la necessità di avere un ambiente fl essibile all’interno della
tenda porta a non studiare una configurazione interna e, sebbene la flessibilità sia un requisito fondamentale, il non
progettarla produce un effetto negativo sull’organizzazione interna del lavoro.
Non considerare che gli apparecchi medici hanno dei cavi che possono ostacolare l’attività, signifi ca creare non pochi
problemi agli operatori. In una situazione d’emergenza tutto dovrebbe funzionare secondo i piani predisposti in fase
pianifi catoria, ma se un operatore deve perdere del tempo per trovare un luogo dove poter appendere la fl ebo, per esempio,
questo non solo può creare confusione all’interno della confi gurazione della tenda ma ricade anche sull’umore dello stesso
soccorritore, che inevitabilmente, in una situazione di crisi, si innervosisceper intoppi, magari banali, che si trova ad affrontare
però in situazioni di già pesante tensione emotiva.

174
Posto Medico Avanzato allestito durante una manifestazione sportiva

175
In generale si possono identifi care dei settori progettuali dei quali sarebbe necessario un approfondimento per migliorare la
qualità abitativa della tenda. Se poi questa dovesse essere il supporto per attività sanitarie più importante ancora sarà il lavoro
del progettista nella ricerca di soluzioni volte a garantire uno standard qualitativo maggiore.
Tali settori possono essere individuati come:
- isolamento termico: la garanzia di poter operare in un ambiente adeguato sotto il profi lo climatico crea immediatamente
una sensazione di comfort. La predisposizione di accorgimenti volti alla minor dispersione termica
e alla riduzione del fenomeno della condensa favorisce un ambiente di lavoro più salubre. Garantire
un buon isolamento termico signifi ca minor necessità di climatizzare l’ambiente, ridurre i volumi
dell’attrezzatura necessaria a tale scopo, il peso del materiale trasportato e i consumi.
- Illuminazione: garantire una corretta illuminazione in ogni punto della tenda, soprattutto se utilizzata come punto medico,
permette un sensibile miglioramento dell’attività medica e della vivibilità della tenda stessa.
-Flussi : internamente alla tenda, soprattutto se vi è la necessità di individuare aree con funzionalità diversa, è utile studiare
i possibili fl ussi interni, individuare se è necessario quale sia l’entrata e quale l’uscita.
- Privacy : sempre maggiore deve essere la sensibilità del progettista volta a garantire il rispetto della privacy degli occupanti
della tenda che potrebbero essere costretti, per cause maggiori (come in una situazione di emergenza), a dover
condividere lo spazio interno.
- Servizi: in genere sono esterni alla tenda ma bisogna considerare alcune particolari situazioni in cui o gli occupanti sono
impossibilitati a recarsi all’esterno (persone ferite) o in cui l’abbandono della tenda per un periodo medio lungo
potrebbe creare una situazione critica (soccorritori). Non sempre infatti vi è la possibilità di accedere ai servizi
entro un raggio di pochi metri e per i medici, ad esempio, vi può essere la necessità di lavarsi ripetutamente le
mani, avere uno spazio in cui poter lasciare i propri effetti personali, le scorte dei farmaci, i rifi uti speciali
La grande facilità di trasporto ha portato all’utilizzo delle tende anche per supporti medici che prevaricano la situazione di
crisi circoscritta. Infatti, con la semplice aggiunta di moduli di collegamento, è possibile formare con le singole tende un vero
e proprio ospedale con le varie unità. Gli ospedali da campo possono essere allestiti con tutti i tipi di shelter, tranne quelli che
sono indissolubilmente legati con il mezzo (furgonati); esistono ospedali da campo conteinerizzati o attendati, nel primo caso
il fattore trasporto però potrebbe rivelarsi limitativo, soprattutto se non si dispone di mezzi militari.
Resta il fatto che anche per gli ospedali da campo, se composti con tende, non rappresentano una specifi ca tipologia, ma
hanno solamente, come già detto, un allestimento specifi co per interventi medici, comunque sempre non organizzato con la
struttura.
Inoltre, dall’analisi di alcune schede tecniche di possibili confi gurazioni di ospedali da campo con tende, si nota come lo spazio
dedicato al lavoro dell’operatore medico sia molto spesso ristretto e disagevole.
Bisogna stabilire quanto la fase di emergenza giustifi chi un’operatività scomoda e limitata soprattutto quando vi sono
programmi di pianifi cazione degli interventi sanitari in scenari emergenziali.

176
Eurovinil, dimensionamento di un ospedale da campo

177
ESPERIENZE SUL CAMPO
Durante le ricerche fatte per questa tesi di laurea si sono rivelati fondamentali i suggerimenti dati dalle persone che sono
coinvolte quotidianamente in situazioni di emergenza. Durante i vari incontri fatti con medici, militari, volontari della protezione
civile si sono potute appurare le esigenze, le problematiche e i punti di forza delle varie tipologie di unità mobili di soccorso
sanitario.
Non potendo riportare tuttie le discussioni, i ragionamenti e i suggerimenti dati, si è deciso di predisporre un questionario
comune che è stato sottoposto alle persone coinvolte. Questo per far capire al lettore l’importanza, nel tentaivo di progettare
in modo corretto una unità mobile di soccorso sanitario, del coinvolgimento delle fi gure professionali che dovrebbero essere
gli utilizzatori fi nali.
(il termine shelter viene utilizzato di seguito in modo genrico, nel suo signifi cato primo di riparo, intendendo tutte le tipologie
mobili, ad uso medico e non, e non solamente ad indicare i container attrezzati commercialmente defi niti come shelter)
ANNA POGGI
Dirigente medico I° livello, Dipartimento ad Attività Integrata Medicina Perioperatoria, Terapia Intensiva ed Emergenza (D.A.I. - M.P.T.I.E.) azienda mista Ospedaliero - Universitaria, Ospedali Riuniti - Trieste, Ospedale di Cattinara
_ Professione/attività in cui ha operato con il supporto degli shelter (medico, militare, volontario, ecc.)
Protezione civile, con logistica alpina
_ In quale tipologia di shelter ha operato? Lo shelter era un P.M.A. (Posto Medico Avanzato), un riparo per l´organizzazione
logistica dell´emergenza, un luogo per lo stoccaggio di materiale, ecc.?
Le strutture in cui mi sono trovata ad operare sono state:
1. l’ospedale da campo dell´Associazione Nazionale Alpini sia strutture tendali, standard che tende pneumatiche;
2. come iscritta prima e responsabile dal 1998 del Gruppo Medico Pediatrico (Gruppo formato da sanitari con specifca
competenza materno-infantile, nato nell´ormai lontano 1988 per volere di uno sparuto numero di medici ed infermiere
dell´IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste, formazione regolarmente iscritta nei ruoli del Dipartimento di Protezione Civile e della
Regione Friuli-Venezia Giulia, che, dall´originaria sezione A.N.A. di Trieste, è passata nel corso del 1996 in carico alla Sezione
di Gorizia - Gruppo di Monfalcone), ho operato in un P.M.P.A. (Posto Medico Pediatrico Avanzato) progettato dagli iscritti al

178
Gruppo. Tale P.M.P.A. era costituito da tre tende collegate tra loro, un container, ideato per fungere da sala operatoria con
attrezzature specifi che per eseguire interventi su donne e bambini, ed una tenda collegata a questo tramite un tunnel che ne
garantisse il più possibile l´isolamento. Per la diffi coltà (ed il costo!) di movimentazione del container, le cui dimensioni erano
6,5 x 2,5 x 2,5 metri, il P.M.P.A. è stato montato a volte utilizzando solo la parte tendale.
Dopo il terremoto del Pakistan del 2006, il Coordinamento A.N.A. Regionale ha donato parte della struttura alla Mezza
Luna Rossa Pakistana, ovvero il container e le tende ad esso collegate da tunnel su misura. Mi è stata data l´occasione di
progettare e, grazie al contributo della Fondazione di una Cassa di Risparmio Regionale realizzare, un ambulatorio mobile a
completamento del P.M.A. (questa volta Posto Medico Avanzato “tout-court”).
_ In quali luoghi ha operato operare e qual’era la tipologia d´intervento (catastrofi naturali, aiuti umanitari, ecc.):
Con l´ospedale da campo A.N.A. nel 1997 nel diffi cile momento attraversato dalle popolazioni delle Marche e dell´Umbria
durante il terremoto, nel 2000 a Torvergata per il Giubileo dei giovani e nel 2005 in Sri Lanka;
Come appartenente al Gruppo Medico Pediatrico in occasione di raduni di folla a Gorizia nel 2002, durante il giuramento degli
Alpini della Julia, e nel 2003, in occasione dell´80° della Sezione, durante l´adunata degli Alpini nel 2004 a Trieste e a Faedis
nel 2005 durante il Green Volley. Dal 2006 al 2008 sempre per raduni di folla, Adunate nazionali od esercitazioni Alpine è stato
utilizzato come P.M.A. l´ambulatorio mobile con tende del Gruppo o di altre Sezioni Alpine.
_ In quali tipo di shelter/P.M.A. in cui ha operato (container, tende pneumatiche, tende standard, ecc.):?
Tutti e tre.
_ Ha montato lei lo shelter o c´erano pelle persone addette a questa operazione?
Ho sempre avuto la fortuna di operare con una logistica dedicata, con cui ho cercato di collaborare per quanto mi era
possibile.
_ Ha dovuto intervenire sull’architettura dello shelter in particolari condizioni climatico/ambientali?
Caldo e umidità sono stati i peggiori nemici! A Torvergata, in particolare l´esperienza acquisita operando in tende pneumatiche
mi ha convinto a modifi care il progetto originario del P.M.P.A. in tende standard e non pneumatiche.
L´utilizzo di teli “ombreggianti”, stesi sulle tende o su parte di esse, lasciando uno spazio tra queste strutture, ha ridotto
il riverbero, migliorando la temperatura interna alle tende stesse, peraltro previste con impianto di condizionamento caldo
/freddo.
L´utilizzo di teli di plastica sopra le grelle di pavimentazione hanno consentito una pulizia più accurata delle strutture che, non
dimentichiamo, sono pur sempre dei punti sanitari!
_ Crede ci siano possibili miglioramenti che le renderebbero il lavoro all´interno dello shelter più agevole?
24-72 ore sono a parer mio vivibili con un po´ di spirito d´adattamento in qualunque situazione, se però ci troviamo a
dover operare per lunghi periodi, magari in zone distanti da casa, un minimo di “comfort” ci consente di lavorare bene e
contribuisce così a ridurre l´inevitabile stress di quel momento particolare di vita, personale e lavorativa, che ci vede per nostra
scelta coinvolti. Quando si decide di progettare un P.M.A. è indispensabile pensare ad una struttura a rapido montaggio, di
scarso ingombro, facilmente trasportabile via terra, acqua ed aria, ma per poterlo far funzionare bene si deve anche avere la
fortuna di avere a disposizione un gruppo affi atato che, pur rispettando i ruoli, sappia integrarsi per convivere in armonia tutto
il tempo durante il quale sarà impiegato.

179
ROBERTO PERESSUTTI
Medico presso il dipartimento di anestesia e rianimazione dell’Ospedale civile di Udine
_ Professione/attività in cui ha operato con il supporto degli shelter (medico, militare, volontario, ecc.)
Medico della Croce Rossa Italiana
_ In quale tipologia di shelter ha operato? Lo shelter era un P.M.A. (Posto Medico Avanzato), un riparo per l´organizzazione
logistica dell´emergenza, un luogo per lo stoccaggio di materiale, ecc.?
Per l’adunata nazionale ANA a Udine abbiamo utilizzato diversi PMA: alcuni in aule scolastiche in diversi punti della città ben
segnalati e posti in punti strategici e una struttura articolata su una tenda decagonale con collegati: uno shelter carrellato per
manovre ALS (supporto avanzato funzioni vitali, codici rossi), una tenda per codici gialli in P.zza I Maggio.
In Irak sono andato per allestire una struttura tipo Role 2 (non un PMA di 1° livello, ma un PMA con possibilità chirurgiche)
In Sri Lanka era un PMA attendato con autogonfi abili con aria condizionata in zona controllata da Tamil.
_ In quali luoghi ha operato operare e qual’era la tipologia d´intervento (catastrofi naturali, aiuti umanitari, ecc.):
Terremoto Friuli 1976, terremoto Irpinia 1980, raduni di folla (visita del Santo Padre, adunate ANA, etc.), operazioni in Irak e
Sri Lanka.
_ In quali tipo di shelter/P.M.A. in cui ha operato (container, tende pneumatiche, tende standard, ecc.):?
Tutti e tre.
_ Ha montato lei lo shelter o c´erano pelle persone addette a questa operazione?
Per la maggior parte c’erano persone addette.
_ Ha dovuto intervenire sull’architettura dello shelter in particolari condizioni climatico/ambientali?
Per la maggior parte il problema è il caldo, in Sri Lanka le tende erano protette da contropeli i container hanno l’aria
condizionata
_ Crede ci siano possibili miglioramenti che le renderebbero il lavoro all´interno dello shelter più agevole?
Se è un PMA di primo livello, per essere utile deve essere veloce da montare, con logistica propria e carrello o pallet dotazioni
a parte, può essere svincolato dalla teleria.

180
LUIGI ZIANI
Colonello (ris.) Cav. dell’esercito italiano, Coordinatore della protezione civile A.N.A. Sezione di Udine
_ Professione/attività in cui ha operato con il supporto degli shelter (medico, militare, volontario, ecc.)
Esercito, protezione civile.
_ In quale tipologia di shelter ha operato? Lo shelter era un P.M.A. (Posto Medico Avanzato), un riparo per l´organizzazione
logistica dell´emergenza, un luogo per lo stoccaggio di materiale, ecc.?
Sotto il nome di shelter, almeno nell’Esercito ma credo anche in altri settori, sono individuati quei manufatti atti a contenere
quello che mediamente sarebbe contenuto in una stanza, più o meno grande.
Le confi gurazioni attualmente in uso sono:
- UEO 1 di lungh. 2,2x largh.2,2x alt.2,45 mt;
- UEO 2 di lungh. 4,0x largh.2,0x alt.2,45 mt (per lavanderia, servizi igienici, panifi cio, docce, frigo, uffi cio;
- UEO 1C di lungh. 6,05x largh.2,435x alt.2,435 mt (per frigo monocella, cucina)
Può essere identifi carlo in un uffi cio, un centralino, una sala operatoria, una doccia, un panifi cio, ecc. che abbiamo la
necessità di realizzare in un posto ove non c’è nulla ed in tempi brevi.
Per risolvere, almeno in parte, la necessità di disporre di un locale più o meno grande, si possono posizionare più shelter
in maniera opportuna collegati tra loro da teli di collegamento. Un’alternativa è quella, sempre più usata ancorché più
complessa da posizionare, di impiegare gli shelter a geometria variabile. Da chiuso ha le stesse dimensioni di uno shelter
normale e, una volta posizionato a terra, si allarga quasi del doppio creando una stanza di quasi 14 mq.

181
Qual è allora il concetto d’impiego dello shelter? E’ stato detto che può essere identifi cato in un uffi cio, un centralino, una sala
operatoria, un servizio igienico abbinato a docce o altro da posizionare in un posto qualsiasi ed essere impiegato, per quello
che è stato pensato, in tempi brevi.
Per comprendere meglio riporto alcuni esempi; all’interno di uno shelter adibito a uffi cio troveremo, almeno nelle parti essen-
ziali, un doppione dell’uffi cio in muratura, con dei contenitori da usare per archivio pratiche già appesi alla parete, dei tavoli,
sedie, l’impianto di illuminazione, l’impianto telefonico e l’impianto di condizionamento, il tutto già predisposto e chiuso in una
“scatola” di dimensioni standard e pronto all’uso.
Al momento della necessità saranno caricati i documenti e attrezzature mobili (telefoni, computer, fotocopiatori ecc.) e spedito
in qualche luogo. Quando gli operatori di quell’uffi cio/shelter, avranno raggiunto l’area di dispiegamento troveranno pronto
all’impiego il proprio uffi cio, chiamato shelter. Altro esempio su uno shelter servizi igienici e docce, dove l’interno dello shelter
è diviso in piccoli box attrezzati a doccia, lavabi e gabinetti, basterà, raggiunta la località d’impiego, collegare l’acqua, la cor-
rente elettrica e lo scarico delle acque per avere, in tempi brevi, fi no a 8 gabinetti o 8 docce. Così per un sala operatoria o
una farmacia, un centralino o una sala radio ecc.. I vantaggi che assicurano gli shelter, rispetto le tende, prefabbricati, camper
o roulotte si riassumono in:
- maggior sicurezza per il materiale contenuto;
- superiori prestazioni meccaniche;
- una più lunga durata operativa;
- una predisposizione di attrezzature complesse precedente all’impiego, non attuabile in tenda;
- idoneità all’installazione e protezione di apparecchiature ad alto livello tecnologico (es: centri ripetitori radio e TV, stazioni di
gruppi elettrogeni, stazioni di controllo navigazione aeree, centri sorveglianza geologica, laboratori analisi ecc.)
Da quanto fi nora detto, si comprende che gli shelter non sono adibiti a magazzino, per questo scopo sono impiegati i
containers.
Cos’è allora un container? E’ una sorta di “scatola” di dimensioni standard da 10, 20, 30, 40 e 45 piedi, con una porta o più
porte, a cielo aperto e frigoriferi. Lo sviluppo commerciale ha però privilegiato la diffusione di container da 20 piedi e da 40
piedi, gli unici utilizzati per il trasporto marittimo, dove fa premio gli schemi di caricamento sovrapponibili.
Questa scatole, chiamate Container, possono essere:
- da 20 piedi, 1C, della lunghezza di 6,058 mt x 2,438 x 2,438;
- da 40 piedi, 1A, della lunghezza di 12,19 mt x 2,438 x 2,438;
quelli da 20 piedi possono essere:
- Standard a una porta;
- Open side, può avere anche le porte laterali su tre lati, per facilitare il carico scarico delle merci;
- Open top, che ha la parte superiore, il tetto, aperto e coperto da un telo.
- Tank container che presenta una gabbia con all’interno un serbatoio da 21 m3 .
Esistono anche altre tipologie ad uso specialistico che non prendiamo in considerazione.
_ In quali luoghi ha operato operare e qual’era la tipologia d´intervento (catastrofi naturali, aiuti umanitari, ecc.):
Gli shelters possono essere impiegati in tutti gli ambienti mediamente “vivibili”. Sono stati impiegati con successo in tutte le
operazioni, sia in operazioni militari che di aiuto umanitario a seguito di catastrofi naturali e non. In Italia o all’estero, dall’Africa
australe alle fredde aree scandinave, dal Kosovo all’Afganistan.
_ In quali tipo di shelter/P.M.A. in cui ha operato (container, tende pneumatiche, tende standard, ecc.):?
1. Tende pneumatiche: incontrano il favore degli operatori per la relativa facilità di montaggio, il minor peso a parità di
dimensione da una tenda standard con paleria in ferro e conseguentemente minor tempo e meno operatori per il montaggio.
Questo si traduce anche in minor numero di mezzi da impiegare per il trasporto delle tende. Sono di varie misure che vanno
da 4x4 mt. per usi veloci e urgenti quali pronto soccorso in incidenti, alle tende 6x9 mt. usate per uffi ci, dormitori, infermerie,
degenza per ospedali da campo, alle 9x12, allungabili, mediamente usate per grandi uffi ci, sale briefi ng, refettori, magazzini
ecc.. La vivibilità all’interno di queste tende sono diverse in funzione delle condizioni meteo dell’area di impiego.
2. Tende con paleria standard: rimangono ancora valide per ricoveri di breve e piccola entità. A differenza delle tende
pneumatiche hanno il difetto di pesare di più e occupare più spazio nel trasporto. Hanno il pregio di non “sgonfi arsi” se bucate
come le sorelle pneumatiche e la vivibilità è maggiore grazie alla traspirabilità del tessuto di copertura.
_ Ha montato lei lo shelter o c´erano pelle persone addette a questa operazione?

182
Normalmente la “scatola” shelter viene posta a terra dal mezzo che l’ha trasportata in un punto ben defi nito da un progetto
planimetrico dell’intera base che si vuol costruire. Gli operatori che impiegheranno lo shelter avranno poi il compito di allestirlo
e renderlo operativo e funzionale. Solo i collegamenti elettrici, telefonici e della rete verranno successivamente montati da
personale specializzato al seguito dell’organizzazione.
_ Ha dovuto affrontare particolari problematiche negli shelter in cui ha operato?
No ho trovato grandi problematiche. I cavi vanno sempre interrati nelle zone di attraversamento pedonale o carraio e, se non
possibile, vanno nascosti da apposite guide a prova di mezzi pesanti. I cavi elettrici, telefonici ecc. all’interno della tenda
possono provocare inciampi, ma se opportunamente “fasciati” e fatti scendere dall’alto verso il tavolo di lavoro o posizionando
i tavoli verso le pareti evita l’inconveniente
_ Ha dovuto intervenire sull’architettura dello shelter in particolari condizioni climatico/ambientali?
Nell’Esercito, l’impiego delle tende, degli shelter e dei containers è continuo specie nelle varie operazioni a cui le F.F.A.A.
vengono chiamate a svolgere. Anche grazie a questo continuo e massiccio impiego di tende, le ditte costruttrici sono
sensibili alle richieste di “aggiunte e varianti” al progetto del manufatto iniziale, pertanto, nel corso degli anni si sono raggiunti
standard di funzionalità ottimali. Alcuni esempi: nell’Africa australe le temperature all’interno delle tende era insopportabile
per la vivibilità degli operatori o per i ricoverati negli ospedali da campo. La semplice sovrapposizione di due stati di teli
ombreggianti distanti fra loro e la tenda di circa 20 cm riduceva la temperatura all’interno della tenda di parecchi gradi
tanto renderla vivibile. Con l’aggiunta di condizionatori nelle tende pneumatiche, più stagne di quelle tradizionali a paleria,
si raggiungevano temperature ottimali per la vivibilità, specie nelle sale ricovero. Tutte esperienze che, travasate alle ditte
costruttrici, hanno provveduto alla creazione di teli ombreggianti tenuti sollevati da appositi tubolari lungo tutta la tenda.
L’applicazione di teli coibentanti all’interno della tenda favorisce di molto il mantenimento di un ambiente vivibile specialmente
se abbinati a condizionatori/riscaldatori che immettono aria refrigerata dal basso e aspirano aria calda dall’alto o l’inverso se
usati quali riscaldatori. Con questi accorgimenti siamo sopravvissuti in aree scandinave e baltice con temperature fi no a 20°
sotto zero e in quelle africane con 45° sopra
_ Crede ci siano possibili miglioramenti che le renderebbero il lavoro all´interno dello shelter più agevole?
Come per le tende anche per gli shelter si sono raggiunti standard ottimali di vivibilità, ma le modifi che sono più lente per la
complessità del manufatto e per i costi conseguenti.

183
GIORGIO VISINTINI
Funzionario della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia
_ Professione/attività in cui ha operato con il supporto degli shelter (medico, militare, volontario, ecc.)
Protezione Civile e VV.F. - volontariato
_ In quale tipologia di shelter ha operato? Lo shelter era un P.M.A. (Posto Medico Avanzato), un riparo per l´organizzazione
logistica dell´emergenza, un luogo per lo stoccaggio di materiale, ecc.?
PMA (esercito), sala radio, cucine.
_ In quali luoghi ha operato operare e qual’era la tipologia d´intervento (catastrofi naturali, aiuti umanitari, ecc.):
Durante esercitazioni e soccorsi umanitari (Albania 1999).
_ In quali tipo di shelter/P.M.A. in cui ha operato (container, tende pneumatiche, tende standard, ecc.):?
Container, tende pneumatiche di varie tipologie, unità mobili.
_ Ha montato lei lo shelter o c´erano pelle persone addette a questa operazione?
Montate direttamente se trattasi di tende, da operatori addetti se trattasi di containers.
_ Ha dovuto affrontare particolari problematiche negli shelter in cui ha operato?
Ha dovuto intervenire sull’architettura dello shelter in particolari condizioni climatico/ambientali?
Le tende di tipo pneumatico, offrono sì la rapidità di montaggio, ma, nonostante alcuni miglioramenti apportarti da alcune
ditta(anche su mio suggerimento personale, soprattutto dopo d’emergenza in Pakistan del 2005) in particolare:
- necessità di corrente elettrica per il gonfi aggio
- alcuni modelli necessitano di mantenere costantemente acceso il gonfi atore e, se dovesse mancare corrente, la tenda si
affl oscia in tempi brevi
- fragilità dei cuscini tubolari di struttura, che, qualora necessiti lo spostamento della tenda, rischiano per l’abrasione di
provocare alla base degli stessi dei microfoni che sgonfi ano la tenda
- eccessivo peso dei colli
essendo la struttura composta prevalentemente di gomma, l’unidità e la condensa sono uno dei problemi, sia a tenda montata
(gocciolamento) che in fase di stoccaggio (se non asciutta deteriora il materiale) Alcune ditte hanno risolto il problema con un
controsoffi tto in garza di cotone e migliorando il tessuto (gomma-cotone ad esempio).
Per quanto riguarda i container, a parte l’aspletto climatico, (risolto ormai con i condizionatori-climatizzatori) l’unico aspetto
negativo è quello dell’area di manovra per lo scarrabile e la necessità della presenza di camio-gru o gru per il carico scarico.
Necessità da valutare in sede di allestimento area la presenza dell’impiantistica soprattutto acqua e scarichi per gli shelter-
containers ad uso cucina e sanitari


PROGETTO DI UNA UNITÀ MOBILE DI S O C C O R S O S A N I T A R I O ( U M M S )
05

186

187
Il progetto per una unità mobile di soccorso sanitario (UMSS) vuole essere una sintesi delle informazioni reperite attraverso lo
studio delle varie tematiche affrontate in questa tesi e delle esperienze delle persone che periodicamente lavorano all’interno
di unità mobili.
Per prima cosa si è scelta la tipologia di architettura mobile da adottare tra quelle proposte da Robert Kronenburg (portable
buildings, relocatable buildings, demontable buildings).
La scelta è ricaduta su un sistema totalmente assemblabile e disassembalbile in loco, cioè “demontable”.
Questo perché si è deciso di porre dei vincoli progettuali molto forti al sistema: garantire una totale indipendenza
tra l’unità e il sistema di trasporto, perseguire la massima leggerezza, fornire uno spazio funzionale
e flessibile agli utenti.
Dai numerosi incontri con medici ed operatori del settore e soprattutto grazie alla loro diretta esperienza con i vari tipi di
shelter, si sono potuti inquadrare i punti di forza e le varie problematiche di ogni supporto mobile.
Dai vincoli progettuali si è dedotto che il sistema più attinente allo scopo era la tenda, in quanto facilmente trasportabile e
relativamente leggera. I punti di forza e di debolezza sono:
- vantaggi: facilità di trasporto
leggerezza (rispetto agli altri sistemi)
assemblabile in breve tempo
fl essibile negli spazi
- svantaggi: scarso riparo dagli agenti atmosferici e dalla radiazione solare
mancanza di una organizzazione interna per la predisposizione di facilitazioni per i soccorritori.
In realtà la fl essibilità della tenda allestita per scopi medici è una falsa fl essibilità; l’utente allestisce l’interno in modo
totalmente casuale e non secondo uno schema tipologico di base.
Lo scopo di questo progetto è quello invece di creare una struttura adeguata che assicuri:
- un riparo adeguato dagli agenti atmosferici;
- uno spazio di lavoro dei medici idoneo;
- dei servizi a supporto per gli operatori;
- la massima flessibilità possibile dello spazio;
- la leggerezza;
- la facilità nel montaggio/ disassemblaggio.

188
CONCEPT PROGETTUALE

189

190
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
L’organizzazione funzionale interna all’unità mobile di soccorso sanitario è dettata da regole ben precise prescritte da
normative e protocolli.
Queste in genere riguardano l’organizzazione operativa dei soccorsi e non prendono in considerazione la configurazione
dell’allestimento interno, in quanto devono essere applicate a tutti i supporti logistici operanti in situazioni di crisi.
Queste prescrizioni, derivanti dalla ricerca svolta e riportata nel capitolo 4, sono state riassunte all’interno del progetto in
questi punti chiave:
- per facilitare le operazioni di soccorso si dovrà agevolare l’individuazione di un flusso interno ben
preciso;
- l’unità deve avere una entarta ed una uscita ben distinte;
- la zona in cui si prestano le cure urgenti al paziente dovrà essere in qualche modo separata dalla
zona di degenza;
- gli spazi interni, seppur contenuti, dovranno garantire la facilità delle operazioni di triage, soccorso
e monitoraggio;
- gli spazi interni, seppur contenuti, dovranno essere flessibili;
- le strumentazioni interne non dovranno ostacolare le operazioni dei soccorritori, ma agevolarle.
Queste considerazioni hanno fortemente infl uenzato l’architettura dell’unità mobile, ne hanno determinato la forma, la
struttura esterna ed interna, le soluzioni tecnologiche e il progetto delle attrezzature interne.
Organizzazione dell’unità mobile di soccorso ssnitario
U.M.S.S
OSPEDALE
ACCETTAZIONE
EMERGENZAAREA ROSSA
DEGENZA
EVACUAZIONE
SERVIZI
OSPEDALE
OSPEDALE
ZONA DI CRISI

191
Sviluppo della forma
Organizzazione tradizionale
Organizzazione circolare

192

193
Vista dall’alto: ingombro totale dell’unità mobile; prospetti: ovest ed est_scala 1:75_misure in metri
S
N
EO
INGRESSO
USCITA

194
Layer organizzativi
01_BASE 02_VANI DI SERVIZIO 03_IMPIANTI
01 02
02
03
04_ZONA EMERGENZA 05_ZONA DEGENZA 06_ZONE DI ACCETTAZIONE E
DIMISSIONE
04
05
06
06
ORGANIZZAZIONE ORIZZONTALE DELLE FUNZIONI
ORGANIZZAZIONE
VERTICALE DELLE
STRUTTURE

195

196

197
Organizzazione interna
La parola chiave per l’organizzazione interna è fl essibilità.
Sebbene, come si è visto nel capitolo 4, l’allestimento di posti medici avanzati ovvero unità mobili di soccorso sanitario in
generelale sia regolamentata dal numero di persone coinvolte nell’emergenza, è sempre da considerare la possibilità che
lo scenario che si presenta ai soccorritori sia diverso da quello ipotizzato durante la fase di organizzazione della catena dei
soccorsi.
Per questo il progetto presenta una fl essibilità generale dell’unità, soprattutto nella zona nella quale vengono prestate le prime
cure al paziente.
Anche se gli spazi sono contenuti a causa delle esigenze di trasportabilità e leggerezza, sono state studiate due possibilità
base che rendono la zona “emergenza” fl essibie: la prima prevede la possibilità di allestire l’area con un solo lettino per il
trattamento del paziente; la seconda prevede che invece siano allestite due postazioni di soccorso.
Nella prima disposizione lo spazio per le manovre degli operatori sarà maggiore e permetterà una fruizione più comoda; tale
soluzione potrebbe essere utilizzata nel momento in cui o la situazione prevede il coinvolgimento di un numero relativamente
basso di persone o quando l’unità è allestita come presidio a supporto di manifestazioni che non presentano particolari rischi
di incidenti.
Nella seconda invece gli spazi sono ridotti ma consentono comunque lo svolgimento delle manovre di soccorso.
Per agevolare i fl ussi interni, dei quali si parlerà successivamente, in entrambe i casi è prevista una apertra di servizio che
attraversa il vano tecnico. Nel primo caso non infl uenzerà particolarmente l’organizzazione interna dei movimenti, ma nel
secondo caso, come si vedrà in seguito, sarà fondamentale per non creare interferenze con il fl usso entrante dei feriti.
Questo accorgimento, come ogni soluzione sia organizzativa che tecnica influenza in modo profondo
l’architettura dell’unità mobile di soccorso sanitario. Sebbene tutte le facilitazioni inserite nel layout
siano indipendenti tra di loro, tanto da poter pensare di allestire l’unità senza alcune di queste, esse
si influenzano reciprocamente. Le soluzioni progettuali definite per un elemeto dell’allestimento sono
frutto dello studio della funzione che deve svolgere, del suo posizionamento, della relazione con la
struttura principale, della relazione con gli altri elementi interni ed avendo sempre come sfondo le
parole chiave di questa tesi: trasportabilità, trasformabilità, flessibilità ed adattabilità.
Viste dell’unità mobile di soccorso sanitario con una e due postazioni nell’area emergenza

198
Soluzione con una postazione nel l ’area “emergenza”
A A
Sezione a 2,5m: soluzione con una postazione in area “emergenza”_scala 1:50
Prospetto: linea di sezione a 2,5m_scala 1:100

199
Dimensionamento delle zone “emergenza” e “degenza” nella soluzione con una postazione di soccorso_scala 1:50_misure in metri
Per chiarezza in questo disegno e in quelli successivi si riporterà solamente l’ingombro alla base della struttura primaria
formata dai montanti e dalle due membrane.
Le linee azzurre con relativa freccia indicano i divisori mobili che possono essere aperti o chiusi aseconda delle necessita.
Per maggiori specifi che vedere il paragrafo riguardante l’impianto di illuminazione
INGRESSO
USCITA

200
Fondamentale nella progettazione di una unità mobile di soccorso sanitario stabilire quali debbano essere i fl ussi interni, sia dei pazienti che degli opera-
tori. Questi devono essere agevolati dall’architettura interna e non devono creare impedimenti alle operazioni di soccorso, anzi devono agevolarle.
La forma circolare ha permesso di creare un corridoio che collega l’entrata e l’uscita. Nelle tradizionali forme rettangolari questo corridoio è ricavato in
posizione centrale, tagliando la tenda in due parti. Questa divisione non identifi ca però due aree operative, impedendo una delimitazione funzionale degli
spazi e non garantendo alcun tipo di privacy.
INGRESSO
USCITA
PAZIENTI
Schematizzazione dei fl ussi interni, soluzione con un posto nella zona “emergenza”_scala 1:50
SOCCORRITORI

201
PERSONALE SANITARIO per unità di soccorso mobile con una postazione per l’area “emergenza”
PER LE PRIME 12-24 ORE
ACCETTAZIONE (zona II triage1) :
_ 1 INFERMIERE PROFESSIONALE (anestesista/rianimatore, di terapia intensiva o D.E.A _dipar-
timento d’emergenza/accettazione, di medicina d’urgenza o pronto soccorso)
AREA CODICI ROSSI/GIALLI (emergenza):
_ 1 MEDICO
_ 1 INFERMIERE PROFESSIONALE (anestesista/rianimatore, di terapia intensiva o D.E.A _dipar-
timento d’emergenza/accettazione, di medicina d’urgenza o pronto soccorso)
_ 1 SOCCORRITORE
AREA DEGENZA:
_ 1 MEDICO
_ 1 INFERMIERE PROFESSIONALE (anestesista/rianimatore, di terapia intensiva o D.E.A _dipar-
timento d’emergenza/accettazione, di medicina d’urgenza o pronto soccorso)
_ 1 SOCCORRITORE
TOTALE: 7 PERSONE
1 Il primo triage si svolge all’interno della zona colpita dall’emergenza

202
Soluzione con due postazioni nell’area “emergenza”
A A
Prospetto: linea di sezione a 2,5m_scala 1:100
Sezione a 2,5m: soluzione con due postazioni in area “emergenza”_scala 1:50

203
Dimensionamento delle zone “emergenza” e “degenza” nella soluzione con due postazioni di soccorso_scala 1:50_misure in metri
Anche aggiungendo la seconda postazione nella zona “emergenza” si riesce ad avere uno spazio suffi ciente per l’operatività
dei medici soccorritori.
INGRESSO
USCITA

204
PAZIENTI
Schematizzazione dei fl ussi interni, soluzione con due posti nella zona “emergenza”_scala 1:50
SOCCORRITORI
INGRESSO
USCITA
In questo secondo caso diventa fondamentale l’apertura ricavata attraverso il vano tecnico (1).
Grazie a questo accorgimento si evita di creare confusione (durante il trasporto del paziente in area degenza) nella zona più critica di tutto
il sistema, cioè l’entrata. Questa zona deve essere infatti sempre libera in modo da poter accogliere i feriti che arrivano dalla zona di crisi
e devono essere curati in zona emergenza. In accettazione ci sarà un infermiere professionale che rifarà per la seconda volta la procedura
del triage e potrà aggiornare il medico presente in area emergenza sulle condizioni della vittima.

205
PERSONALE SANITARIO per unità di soccorso mobile con una postazione per l’area “emergenza”
PER LE PRIME 12-24 ORE
ACCETTAZIONE (zona II triage1) :
_ 1 INFERMIERE PROFESSIONALE (anestesista/rianimatore, di terapia intensiva o D.E.A _dipar-
timento d’emergenza/accettazione, di medicina d’urgenza o pronto soccorso)
AREA CODICI ROSSI/GIALLI (emergenza):
prima postazione_ 1 MEDICO
_ 1 INFERMIERE PROFESSIONALE (anestesista/rianimatore, di terapia intensiva o D.E.A _dipar-
timento d’emergenza/accettazione, di medicina d’urgenza o pronto soccorso)
seconda postazione_ 1 MEDICO
_ 1 INFERMIERE PROFESSIONALE (anestesista/rianimatore, di terapia intensiva o D.E.A _dipar-
timento d’emergenza/accettazione, di medicina d’urgenza o pronto soccorso)
_ 1 SOCCORRITORE
AREA DEGENZA:
_ 1 MEDICO
_ 1 INFERMIERE PROFESSIONALE (anestesista/rianimatore, di terapia intensiva o D.E.A _dipar-
timento d’emergenza/accettazione, di medicina d’urgenza o pronto soccorso)
_ 1 SOCCORRITORE
TOTALE: 9 PERSONE
1 Il primo triage si svolge all’interno della zona colpita dall’emergenza

206
Schema del supporto logistico all’unità mobile di soccorso sanitario
TENDA APERTA PER
SUPPORTO LOGISTICO
A supporto di ogni tenda per soccorso sanitario vi sono alcune attrezzature per garantire l’autonomia temporanea della stessa
struttura. In genere tali attrezzature dipendono dal luogo in cui l’unità mobile andrà ad operare.
Si può considerare come strumentazione base un generatore portatile per il supporto di energia elettrica e il sistema di
riscaldamento / condizionamento, ma sono da prendere in considerazione anche quei supporti che possono rivelarsi
fondamentali in luoghi privi di ogni servizio, come possono essere i potabilizzatori, le attrezzature per poter scavare delle fosse
settiche, ecc.
È da considerare che nei luoghi predisposti allo stoccaggio dell’unità mobile di soccorso sanitario (sedi della
protezione civile, ospedali, ecc.) possano essere presenti tutte le attrezzature ma solo nel momento dell’allarme il
responsabile dell’organizzazione dei soccorsi decide quali attrezzature utilizzare.
Tali supporti possano essere trasportati nei luoghi di crisi in tempi diversi, ad esempio per prima cosa si provvederà a
trasportare il generatore elettrico per il supporto alle strumentazioni mentre il gruppo di condizionamento può essere anche
portato in un secondo momento essendo l’unità relativamente autonoma (grazie alle soluzioni tecnologiche adottate).
La scelta di utilizzare una unità esterna è dettata da alcune considerazioni che hanno trovato riscontro dalle esperienze degli
operatori.
Le strumentazioni sono in genere rumorose e per questo possono crearesituazioni di “dis-comfort” per gli utenti. La scelta di
non utilizzare tende gonfi abili è stata dettata anche ad esempio dal fatto di avere continuamente in sottofondo il rumore del
compressore. Inoltre le strumentazioni creano movimenti di aria, che in situazioni con terreno polveroso potrebbero generare
situazioni si scarsa igiene.
Supporto logistico

207
Specifiche tecniche:
Categoria: Professionali
Installazione: Portatile
Potenza Max (monofase)(W): 3400
Potenza Con. (monofase)(W): 3300
Fattore Pot.: 1
Alternatore: Sincrono
Motore: YANMAR
Mod. motore: L 70 E
Raffreddamento: Aria
Cilindrata (cc): 296
Cilindri: 1
Potenza (HP): 6,1
Giri/Min: 3000
Alimentazione: Diesel
Capacità serbatoio (lt): 3,5
Autonomia 3/4 carico (h): 3,5
Capacità carter olio (lt): 1,1
Avviamento: Elettrico
Peso (Kg): 87
Dim. L (mm): 725
Dim. W (mm): 515
Dim. H (mm): 585
Potenza acustica LwA dB(A) 102
Pressione acustica (a 7m.) LpA dB(A) 77
Struttura: Aperta
Accessori disponibili su richiesta: marmitta riduzione
rumore
Gruppo elettrogeno

208

209
SOLUZIONI PROGETTUALI
Pavimentazione l ivel lante
Dall’esperienza maturata negli anni dagli operatori sanitari nell’ambito delle emergenze è stato necessario garantire una
superfi cie di livellamento ma soprattutto di distacco dal terreno per assicurare un minimo isolamento dall’umidità.
In genere i produttori di tende non prevedono una pavimentazione rigida nel set della tenda. L’equipaggiamento base per il
catino è costituito solamente da un telo di polietilene. Chiunque abbia passato una notte in una tenda sa però che questo non
è suffi ciente per garantire una barriera contro l’umidità.
In commercio esistono degli elementi chiamati grelle che provvedono a questa funzione. Si può dire che in genere i dispositivi
più utilizzati sono quelli distribuiti da due ditte: la Ferrino e l’Eurovinil.
Nel primo caso questi elementi misurano 50x50cm ma a causa della loro trama sono stati subito scartati dalla possibilità di
utilizzo nel progetto. Infatti i fori quadrati hanno più volte ostacolato le operazioni di soccorso in quanto le ruote delle barelle o
degli strumenti facilmente si incastrano nei fori. Per ovviare a questo, in genere si utilizzano le grelle fornite dall’Eurovinil che
invece presentano un disegno che impedisce tale inconveniente, ma anzi favorisce lo scorrimento.
Gli elementi misurano 120x60x0,25cm e sono fatte di polietilene a bassa densità. Il loro peso è di 4kg a modulo.
Considerata la superfi cie di progetto si è subito constatato che tale peso avrebbe gravato per circa la metà sul peso totale
della struttura (circa 460kg).
Il dato dunque sembrava in contrasto con la volontà di limitare al massimo il peso dell’unità mobile. Da un lato non si poteva
pensare di eliminare dal progetto questo elemento e dall’altro non era accettabile che la pavimentazione gravasse così tanto
sul peso fi nale. Si è dovuto quindi esplorare in generale il settore della pavimentazione da esterni per cercare una soluzione
alternativa. Fondamentale è stato rivolgersi ad uno dei maggiori rivenditori di attrezzatura da campeggio di Udine che, grazie
alla decennale esperienza, ha saputo capire le esigenze del progetto e indirizzare la ricerca sulle piastrelle che generalmente
si utilizzano per la pavimentazione dei giardini, indicando come possibile riferimento la ditta Brunner.
Dalla ricerca successiva si è potuto riscontrare come un particolare prodotto potesse essere quello che garantiva tutte le
caratteristiche necessarie al progetto. Era leggero, modulare, e permetteva anche la facile e corretta installazione dei picchetti
che permettono l’assemblaggio della struttura principale.
Le piastrelle Polifl ex infatti sono costituite, nella loro minima unità da quadrati di 7x7cm che possono facilmente rimossi o
assemblati tra loro. Si è quindi deciso di predisporre dei moduli di 120x60cm preassemblati.
Alcuni di questi presentano, nei moduli da rimuovere per l’installazione dei basamenti della struttura, un simbolo che indica
la corretta posizione e soprattutto la corrispondenza con i giusti elementi della struttura.
Inoltre ogni modulo è a sua volta contraddistinto da un colore e da un codice che ne permette la facile collocazione nella
pavimentazione nel suo complesso.
In fase di stoccaggio, sempre per agevolare le operazioni di montaggio, i moduli verranno suddivisi in base al loro colore e
codice; questo permetterà di poter facilmente individuare la corretta sequenza di montaggio.
Pavimentazione tradizionale Ferrino ed Eurovinil

210
Visualizzazione delle suddivisione dei moduli della pavimentazione; ogni sequenza corrisponde ad uno stoccaggio, il colore è utilizzato per distinguere le
varie parti e permetterne il corretto assemblaggio. Particolare attenzione è stata posta nell’utilizzare i 4 colori in cui le piastrelle sono commercializzate.
Conseguentemente però sarà necessaria una maggiore attenzione nel disassemblaggio in modo da garantire un corretto staccaggio del materiale.
PIASTRELLE POLIFLEX _ BRUNNER INTERNATIONAL
In polipeopilene resistente ai raggi UV, impiego universale sia in ambienti esterni
che interni. Montaggio e smontaggio rapidissimi, resistente alla maggior parte de-
gli agenti chimici, superfi cie antiscivolo, facile da pulire ed indeformabile.
Misure modulo base 30x30x1,2cm
Peso per m2: 2,5kg
Colori: grigio, rosso, vere chiaro e scuro
Il primo accorgimento per il corretto assemblaggio della struttura è quello di trovare un luogo privo di forti deformità e/o
dislivelli. Deciso il luogo per prima cosa si assemblerà la pavimentazione, la parte probabilmente più diffi coltosa di tutte le
operazioni previste per comporre la struttura.
Gli stoccaggi di piastrelle da utilizzare saranno 9. Il primo, di colore rosso è contraddistinto dal codice –a; i secondi, che
andranno predisposti secondo il disegno allegato, saranno di colore verde chiaro e contraddistinti dai codici bc e il; i terzi,
di colore grigio avranno codice de e mn, i quarti di colore verde scuro e codice fg e op, infi ne i quarti di colore grigio con
codice –h e –q.
La linea base sarà quella defi nita dalle grelle di colore rosso con numeri 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 (i numeri positivi saranno
disposti a destra dello 0, quelli negativi a sinistra), da questa si defi nirà tutto lo sviluppo secondo lo schema riportato.
Per il montaggio si consiglia di eseguire le seguenti istruzioni base:
- prendere il primo stoccaggio rosso -a;
- togliere la prima cinghia;
- separare le due parti di grelle (una contraddistinta con il codice –, l’altra con codice a);
- posizionare la grella 0 nel punto in cui si vuole che venga installato il palo della struttura centrale;
- posizionare le grelle 1 2 3 4 a destra della grella zero e le -1 -2 -3 -4 a sinistra;

211
- posizionare le grelle 0a sotto la grella 0, quelle 1a 2a 3a 4 a sotto le grelle 1 2 3 4 e procedere allo stesso modo per le
grelle -1a -2a -3a -4a.
- prendere i secondi stoccaggi di colore verde chiaro contraddistinti dai codici bc e il;
- posizionare lo stock bc sotto le grelle precedentemente posizionate con codice a e lo stock il sopra le linea base;
- procedere nel posizionamento delle grelle della linea b e sotto queste quelle della linea c;
- contemporaneamente è possibile che un’altra persona/squadra posizionino gli stock i e l
- procedere con gli altri stoccaggi come nei precedenti casi e secondo lo schema riportato
Alla fi ne si dovrà ottenere delle righe di grelle con la corretta sequenza numerica -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 e delle colone che
avranno una sequenza, dal centro verso il basso, di – a b c d e f g h, dal centro verso l’alto di – i l m n o p q

212
Dopo aver terminato le operazioni di posizionamento delle grelle sarà necessario sostituire quelle contrassegnate, con gli
appositi attacchi a terra della struttura.
Svolta questa operazione si posizionerà il telo di polietilene. Questo telo è provvisto di occhielli ai bordi per il fi ssaggio agli
attacchi della struttura e nei punti in cui è prevista la struttura secondaria interna.

213
Defi nizione della pavimentazione, posizionamento degli attacchi a terra della struttura in relazione alle grelle del modulo in cui sono localizzati
_scala 1:75
77,4 m2 = 193,5Kg di pavimentazione piastrelle Polifex
- 266,5kg rispetto pavimentazione Eurovinil

214
Struttura principale
La struttura dell’unità mobile per soccorso sanitario è composta da 10 montanti di diametro 60mm.
Questi a terra si agganciano a dei picchetti formati da una base delle dimensioni di 15x15cm alla quale sono fi ssati 4
picchetti che permettono un sicuro ancoraggio a terra. Alla base è saldato inoltre l’alloggio per l’inserimento dei montanti;
alto 15cm è dotato di un sistema per il bloccaggio delle membrane. Gli occhielli delle due membrane principali e del telo di
pavimentazione vengono agganciati ai tre elementi avvitabili che ne bloccano i movimenti. La base è dotata di un incastro
laterale che permette la facile giunzione con gli elementi costituenti la pavimentazione.
I montanti, superiormente si agganciano ad un anello. Questo è agganciato ad un profi lato circolare estensibile che permette
il facile montaggio della struttura a terra, senza dover ricorrere ad operazioni in quota.
A completare il sistema del sostegno verticale vi sono due piatti sui quali vengono fi ssate le membrane.
Infi ne vi è un sistema di correnti orizzontali, posti a quota 2m di diametro 50mm, che garantiscono un irrigidimento della
struttura. Anch’essi si uniscono gli uni agli altri tramite un sistema ad incastro.
La struttura è stata prevista in due diversi materiali, a seconda delle possibilità produttive ed economiche:
- fi bra di carbonio
- duralluminio (avional serie 2000)
Tale distinzione è stata inoltre mantenuta tenendo presente la necessità di garantire la massima leggerezza del sistema.
È necessario chiarire che i diametri dei vari elementi potrebbero cambiare a seconda del materiale. Quelli proposti si
riferiscono ad elementi costituiti con fi bra di carbonio.
modulo di elasticità alla fl essione
N/mm2
carico di rottura alla trazione
N/mm2
peso specifi co massa volumica
kg/dm3
fi bra di carbonio 130000 1400 1,56
avional 72500 345 2,7

215
montanti verticali
struttura orizzontale
anello centrale
Pianta: struttura dell’UMSS_scala 1:50
Ogni montante viene identifi cato con una lettera. Questo permetterà il corretto assemblaggio con le relative basi e con i
correnti laterali.

216
passaggio struttura orizzontale
diametro 60mm
A causa della forma data all’U.M.S.S. per
garantire la corretta fruizione degli spazi, la
struttura non è simmetrica e ciò si ripercuote
anche sulla lunghezza dei montanti.
Per evitare di dover far produrre 10 pezzi unici, si
è deciso di produrre profi lati a due a due uguali,
sciegliendo tra montanti di lunghezza simile, e
recuperare il diasavanzo sull’anello centrale.
Questo infatti è dotato di profi lati che, oltre a
permettere l’incastro con il montante stesso,
danno la possibilità di recuperare le lunghezze
mancanti.
Prospetti: schema della produzione dei montanti_scala 1:50

217
aggancio ad anello centrale
aggancio giunti per il
fi ssaggio delle membrane
La regolarizzazione delle lunghezze permette un migliore stoccagio dei profi lati.
Prospetto: sistema d’assemblaggio del montante con l’elemento per il fi ssaggio a terra_scala 1:50
Tutti gli elementi costituenti gli 10 montanti della struttura

218
incastro da i due elementi del montante
incastro tra montante e giunto
distanziatore delle membrane
incastro tra montante e giunto
distanziatore delle membrane
Esploso assonometrico: sistema di incastro tra gli elementi costituenti il montante
Stoccaggio degli elementi costituenti la struttura principale

219
Pianta: correnti orizzontali, denominazione e possibilità di sticcaggio_scala 1:50
A
A
L1
L
A2-D2
F1-I2
F
E1
E
A1
A2
B
B1
B2
C
C1
C2
D
D1
D2
E
E1
F
F1
F2
G
G1
G2
H
H1
H2
I
I1
I2
LL1

220
Anel lo centrale e palo di sostegno
Come già accennato, l’anello centrale permette il fi ssaggio e il recupero delle
diverse lunghezze dei montanti. Per la corretta installazione, anche sull’anello
verranno segnalate le corrispondenze con i montanti attraverso le lettere A B C D
E F G H I L.
Il palo centrale garantisce maggiore stabilità alla struttura e ne favorisce il
montaggio. E’ costituito infatti da un elemento estensibile mediante l’azionamento
di una manovella che permette di eseguire le prime operazioni di allestimento
delle membrane senza pericolo.
MONTAGGIO:
1: installazione della base (operazione eseguita con il posizionamento delle grelle)
2: azionare la manovella per far salire il montante D quanto basta per operare
comodamente
3:inserire l’elemento F sul quale successivamente verrà montata la linea di luci
centrale per poi essere innalzata
4: inserire all’interno del montante D il piatto G
5: posizionare l’anello H sul piatto G
6: inserire l’ultimo piatto i all’interno del profi lato del piatto G
7: bloccare il sistema con lo spinotto a scatto predisposto
Pianta: anello centrale_scala 1:25; esploso del palo centrale; immagine dello spinotto a scatto per tubi
raggio esterno: 0.85m
raggio interno: 0,75m
diametro 60mm
I
H
G
F
D E
C
B
A

221
blocca-membrane
membrana interna
telo pavimento
membrana esterna
vite di sicurezza
base con incastro laterale
per connessione con le grelle
Fissaggio a terra
Il fi ssaggio a terra avviene mediante una base costituita da
un elemento circolare di diamtro 64mm e alto 150mm, per
il posizionamento dei montanti verticali, e da 4 picchetti che
permettono il corretto ancoraggio a terra.
Il montante, una volta in sede, viene bloccato grazie ad una vite
di sicurezza posta a lato della sede stessa.
Sempre nella sede è previsto un sistema costituito da tre
elementi avvitabili (due verso l’interno ed uno verso l’esterno)
che permettono di bloccare le membrane (quella interna, il telo
di pavimentazione e quella esterna) in modo da garantirne la
tensione.
La base inoltre è dotata di un aggancio laterale che permet-
te l’integrazione dell’elemento con il sistema delle grelle di
pavimentazione.
sede del montante diametro
interno 64mm
picchetti
elementi per il fi ssaggio
della membrana interna
e del telo di pavimentazione
elemento per il fi ssaggio
della membrana esterna
Pianta e prospetto: base per fi ssaggio a terra della struttura_scala 1:5
montante

222
picchetti
Sezione AA: base per fi ssaggio a terra della struttura_scala 1:5
blocca-membrane
membrana interna
telo pavimento
membrana esterna
montante

223
Membrane
L’aria interna ad una struttura può veicolare il vapore acqueo prodotto da utenti ed apparecchiature e la quantità di vapore
che l’aria può assorbire aumenta con la sua temperatura. Questo fenomeno fa si che l’umidità relativa possa aumentare con
il raffreddamento dell’aria, sebbene la quantità di vapore acqueo non muti.
Se la temperatura cala ulteriormente, l’aria raggiunge la sua temperatura di saturazione e il vapore condensa in gocce (punto
di rugiada). Il vapore acque condensa su quelle superfi ci che hanno una temperatura più bassa del punto di rugiada.
La condensa, oltre a creare notevole disagio agli utenti, riduce signifi cativamente la vita utile dei materiali e può dare luogo a
muffe, corrosione su materiali metallici e degrado delle prestazioni termiche dei materiali isolanti.
La vulnerabilità delle membrane tessili è dovuta essenzialmente alla bassa inerzia termica e alle loro ridotte proprietà isolanti
ed all’idrorepellenza delle membrane prodotte con tessuti rivestiti.
In questo progetto si è cercato di ridurre la vulnerabilità utilizzando una membrana ad alte prestazioni isolanti, la Ten-
sotherm™ della Birdair.
Inoltre per non fare entrare in contatto gli utenti con una superfi cie che può essere luogo di deposito della brina, la
membrana isolante è stata accoppiata con un’ altra membrana, Tenera® della Gore™, in modo da costituire un sistema
formato da 2 membrane separate da uno spazio in cui vi è aria in movimento.
Tale soluzione è stata possibile inserendo la struttura dell’unità mobile di soccorso sanitario tra le due membrane e
distanziando quest’ultime ultime con dei giunti.
Membrana Tensotherm™ Birdair, membrana Tenara® Gore™
Caratteristiche principali:
Tensotherm™, Birdair: R-value 12, migliore isolamento (resistenza termica 2,1Km2/W)
Diffusione della luce
Attenuazione dei rumori
Tenara®, Gore™, modello 3T40HF: Light transmission 45%
Peso 925gr/m2

224
DISAGIO PER GLI UTENTI
CIRCOLAZIONE DELL’ARIA
MIGLIORAMENTO DELLA
CONDIZIONE INTERNA
ISOLAMENTO
ULTERIORE MIGLIORAMENTO
DELLA CONDIZIONE INTERNA
MEMB. ESTERNA
MEMB. INTERNA
LA MEMBRANE ESTERNA FUNGE ANCHE DA
PROTEZIONE RISPETTO A QUELLA INTERNA
Per le membrane è stato deciso di mantenere la colorazione bianca.
Non è una scelta solamente dettata dalla maggior facilità nel reperimento delle membrane di questo colore ma anche dal
fatto che in campo internazionale vi è un rigido protocollo che regola la colorazione delle divise e dei supporti delle varie
organizzazioni. Ad esempio per gli eserciti sono codifi cati precisi colori e disegni a seconda dello Stato di provenienza.
Il colore bianco è identifi cato invece con organizzazioni o missioni umanitarie, basti pensare alle tende della Croce Rossa o
alle missioni di pace dell’Onu.
Per questo, essendo stata pensata per l’uso civile, l’unità mobile di soccorso sanitario avrà colore prevalentemente bianco che
potrà essere integrato con eventuali simboli delle organizzazioni che la utilizzeranno.

225
Giunti per l ’aggancio del le membrana al la struttura
sistema di posizionamento
dei giunti per il fi ssaggio delle
membrane
Per permettere il corretto tensionamento delle membrane è necessario l’utilizzo di giunti.
Questi vengono integrati all’interno dei montanti, attraverso il loro posizionamento nei punti di giunzione dei vari elementi.
Il loro incastro è garantito dal solito sistema ad incastro con cilindri retrattili. Sul montante infatti sono presenti quattro
elementi per l’incastro: due sulla parte fi nale, la quale viene inserita nel modulo successivo, e due sulla parte iniziale.
In questo modo si garantisce un incastro sia tra i montanti, sia tra il giunto e ciascun montante.
I giunti hanno diametro di 67mm (sp.5mm), per permettere il loro inserimento nei montanti, e lunghezza di 150mm.
Leggermente diverso è il giunto che di trova a 2metri di altezza; questo infatti presenta dei fori laterali per permettere ai
correnti orizzontali il passaggio attraverso i montanti. Questo deve essere infi lato totalmente sul montante e fatto scorrere fi no
al punto in cui le sfere del montante si incastreranno nei fori del giunto. Lo scorrimento è reso possibile dal mantenimento
della medesima curvatura tra montante e giunto.
Prospetto: sistema montanti-giunti_scala 1:50
Vista del giunto a 2metri

226
Il fi ssaggio delle membrane alla struttura principale avviene
attraverso un sistema di incastri maschio/femmina.
Nella membrana viene pre-installato una parte del giunto;
al momento di installare la membrana esterna, le due parti
vengono incastrate facendo una pressione laterale sulla parte
fi ssata al giunto.
Per garantire l’integrità del sistema, un elemento come
quello fi ssato alla membrana viene posto a protezione della
parte ancorata al giunto nel momento in cui il sistema viene
disassemblato.
Sistema A
Sistema di fi ssaggio delle membrane alla struttura
Sistema di fi ssaggio delle membrane alla struttura_scala 1:5

227
Sistema B
piastra magnetica
membrana in neoprene con elementi radiali magnetici
apribile manualmente
Nel secondo metodo di fi ssaggio è previsto l’utilizzo di un
sistema formato da una piastra magnetica e una membrana in
neoprene in cui sono inseriti degli elementi radiali magnetici.
La membrana interna sarà dunque provvista di un foto nel
quale passerà il disco di neoprene.
Questo, dopo la sua apertura si salderà magneticamente alla
piastra che si trova dall’altro lato della membrana.
membrana aperta
Sistema di fi ssaggio delle membrane alla struttura
Sezione e pianta: sistema di fi ssaggio del giunto alla membrana esterna_scala 1:5
membrana rinforzata
membrana
piatto di fi ssaggio
piatto di fi ssaggio
attacco m/f
Grazie al sistema di prefi ssaggio
studiato è possibile, in caso di
rottura, sostituire l’attacco m/f
senza dovere sostituire tutta la
membrana .

228
Piegatura del le membrane per lo stoccaggio
Per facilitare le operazioni di montaggio delle membrane è necessario ripiegare il tessuto nella maniera rappresentata dalla figura
precedente. Per prima cosa si ripiegherà la membrana dall’esterno verso l’interno partendo da due lati (fase 1); successivamente
si procederà nella direzione perpendicolare alla precedente (fase 2).
PIanta: metodo di piegatura della membrana; prospetto A, prospetto B: vista degli ingombri della membrana dopo la prima piegatura e dopo la
seconda_scala 1:20
Prospetto A: ingombro laterale della membrana piegata dopo la fase 1
Prospetto B: ingombro laterale della membrana piegata dopo la fase 2

229
Tiranti
Per garantire la sicurezza della struttura anche sotto l’effetto dei venti è necessario predisporre dei tiranti che dalla membrana
giungono fi no a terra. Per fare ciò è necessario predisporre un’asola di rinforzo sulla membrana esterna, nella quale viene
saldata una banda di tessuto. Il tessuto è lo stesso della membrana esterna per evitare diversi comportamenti e risposte
meccaniche. Prima della saldatura tra l’asola di rinforzo e la fettuccia di tessuto, in quest’ultima viene inserito un anello
metallico, sul quale si aggancierà il tirante grazie ad un moschettone.
Questo anello è lo stesso che permette l’innalzamento della membrana esterna nelle fasi di montaggio della struttura.
asola di rinforzo
fettuccia di tessutoanello metallico
moschettone
tirante
membrana esterna
struttura
membrana interna
Pianta: vista del posizionamento dei tiranti sulla membrana esterna; pianta e sezione: composizione interfaccia tirante-membrana esterna

230
Tensionamento del la membrana nel la parte terminale
membrana esterna
struttura
tasca per l’inserimento dei
pali in fi bra di vetro
Per garantire il corretto tensionamento della membrana nella parte terminale è utile inserire la paleria apposita in fi bra di vetro all’interno
delle tasche già predisposte nelle due membrane.
membrana interna
tasca per l’inserimento dei
pali in fi bra di vetro
membrana esterna
struttura
Particolari: tensionamento ulteriore della parte inferiore delle membrane

231
Sequenze di montaggio del la struttura pr incipale e del le membrane
01_ posizionamento del primo piatto sul palo
centrale; fi ssaggio della prima membrana sul
piatto stesso.
02_ posizionamento dell’anello centrale e del
primo montante della struttura.
03_montaggio di altri due montanti della struttura, dei giunti e dei correnti orizzontali; ricordarsi di togliere la parte a
protezione del giunto distanziatore prima di iniziare l’operazione successiva; inserire gli elementi di aggancio delle luci alla
struttura.
persone da utilizzare nel montaggio: minimo 5

232
04_ posizionamento del secondo piatto sul palo
centrale e fi ssaggio della membrana esterna.
05_fi ssaggio della membrana esterna ai giunti distanziatori; posizionamento dei sistemi per innalzare in sicurezza la struttura
(A)
A

233
06_innalzamento della struttura tramite il palo centrale e gli elementi estensibili posti in corrispondenza di 4 montanti;
per facilitare l’operazione si deve o alzare manualmente la membrana o fi ssarla tramite il gancio predisposto agli anelli
utilizzati per l’aggancio dei tiranti; posizionamento dell’ultimo elemento del montante nella sede della base.
punti di fi ssaggio dei
puntelli estensibili
07_fi ssaggio della parte terminale della membrana esterna, inserimento della paleria in fi bra di vetro nelle apposite tasche
(vedi dettagli delle membrane); fi ssaggio della membrana interna (questa operazione può essere effettuata anche ad altezze
intermedie), prima di agganciare la membrana interna agli ultimi due giunti, togliere il puntello estensibile.

234
Struttura secondaria
La struttura denominata secondaria permette la separazione degli spazi interni e la determinazione dei vani di servizio.
Grazie ad essa infatti possono trovare luogo all’interno della tenda i servizi per il personale medico e per i degenti.
Una carenza che da sempre i soccorritori riscontrano nelle tradizionali tende è il fatto di non avere a disposizione dei vani
tecnici in cui sitemare le attrezzature e un luogo in cui poter lavarsi le mani senza dover uscire dall’unità.
Questa struttura è totalmente indipendente da quella principale, per cui in caso di utilizzo diverso da quello previsto, la tenda
può diventare uno spazio unico.
Pianta: struttura interna_scala 1:50_misure in metri

235
Prospetto: struttura interna_scala 1:50
montanti estensibili
attacco a terra
giunti

236
membrana in neoprene saldata al telo del pavimento
per impedire imfi ltrazioni
base del montante
grella modifi cata
Pianta e prospetto: grella-base per i montanti interni_scala 1:2_misure in millimetri

237
vano tecnico vano tecnico
servizi
soccorritori
servizi
degenti
spogliatoio
soccorritori
deposito
medicinali
deposito
rifi uti
Pianta: distribuzione funzionale della struttura interna
Distribuzione funzionale

238
Pianta: misure della struttura interna; le frecce indicano gli accessi ai vani_scala 1:50_misure in metri

239
Pezzi componenti la struttura secondaria_scala 1:50
I montanti sono indicati con le lettere maiuscole, i correnti orizzontali con le lettere minuscole, i
correnti orizzontali curvi delle parti laterali con i nuneri
MONTAGGIO:
1_Montaggio delle due zone laterali 1 e 2-3; montaggio delle parti curve sui montanti: HH AA
BB CC su 3 HH HH su 2 agganciare i due pezzi;
2_Installazione dei pezzi centrali GG GG FF (che si posizioneranno, nella parte superiore, grazie
al movimento telescopico, sulle guide predisposte nelle lampade per dare maggior sostegno
alle stesse);
3_Montaggio dei pezzi lll;
4_Montaggggio ii ii ii mm;
5_Innalzamnto delle parti;
6_Aggancio tra GG ed EE con correnti ii ed FF AA con correnti mm.
I montanti sono telescopici per permettere una più facile installazione e stoccaggio.
I teli divisori sono gia inseriti nei correnti orizzontali curvi, mentre si dovranno installare i tre teli
che separeranno i servizi
A
A
B
E
C
C C
AE
D
D
D
ED
B
B
F
F
F
G
G
G
G
G
H
H H
H H
H H
H H
HH
i
i i i
i i i
l
l l l
m
m
m
1
1
2
2
3
3
I montanti sono telescopici per permettere una più facile installazione e stoccaggio.
I teli divisori sono gia inseriti nei correnti orizzontali curvi, mentre si dovranno installare i tre teli che separeranno i servizi dal
vano tecnico e il deposito dei medicinali dal guardaroba.

240
I teli utilizzati per schermare sono in Nylon Ripstop (55gr/m2) le cui proprietà principali sono la leggerezza, la resistenza al
fuoco e l’idrorepellenza. Per le sue qualità meccaniche, oltre al campo delle tende per escursionismo, è utilizzato anche per
la produzione di vele per imbarcazioni, palloni per mongolfi ere e paracadute.
Particolare dell’aggancio della tenda alla struttura secondaria

241
Sezione AA: inserimento degli impianti all’interno della struttura secondaria_scala 1:50_misure in metri
Vano tecnico: inser imento degl i impianti
Impianto di riscaldamento/condizionamento dell’aria
1
2
3
Per il sistema di condizionamento si è deciso di utilizzare un sistema di riscaldamento/raffrescamento integrato prodotto dalla ditta
Danterm. Il sistema prevede la possibilità di poter utilizzare un singolo elemento contemporaneamente anche per il condizionamento di
due unità, grazie a due uscite d’aria. Nell’eventualità di dover allestire due unita mobili di soccorso sanitario quindi non servirà trasportare
sul luogo un secondo elemento.
Il modello è AC-M7(H) MK, condizionatore di tipo portatile equipaggiato con riscaldamento elettrico con guaina
flessibile da 225mm, sviluppato appositamente per il condizionamento e riscaldamento di tende o altre strutture temporanee.
Dalla scheda tecnica sappiamo: “L’unità è progettata per lavorare all’esterno dell’ambiente da condizionare/riscaldare. La fornitura e la
ripresa di area da e verso l’ambiente da condizionare/riscaldare è effettuata tramite guaine di tipo coibentato. Sviluppata in ambito militare,
l’unità è estremamente robusta e facilmente trasportabile. La movimentazione manuale è possibile grazie alle ruote gommate (amovibili e
collocabili nella cofanatura) collocate alla base dell’unità. Utilizzando le apposite incanalature l’unità può essere movimenta tramite veicoli
dotati di forche, o sollevata tramite gru attraverso gli anelli posti sulla cofanatura.”
Particolare 1: dettaglio sistema di condizionamento

242
Specifiche tecniche:
potere refrigerante: 7,6 kW
potere riscaldante: 7,2 kW
gas refrigerante: R 134a
alimentazione: 3 x 400 V x 50 Hz
colorazione: verde Nato (RAL 6014)
Guaine fl essibili coibentate per la ripresa e la mandata dell’area, facilmente trasportabili.
Termostato con cavo, per la regolazione della temperatura all’interno dell’ambiente da
condizionare.
Disegno tecnico tratto dal manuale della ditta Dantherm; guaina fl essibile; termostato.

243Particolare 2: dettaglio linee
TERMOSTATO
CONTROLLO
LUCI
LINEA ELETTRICA
PER PRESE
LINEA ELETTRICA
PER LUCI
1
1
2
2
3
3
3
3
2
2
4
4
23 1
1_ zip saldata
2_ rinforzo della membrana
3_ membrana in neoprene
4_ membrana esterna
5_ membrana interna
6_ guaina fl essibile coibentata
7_ linea elettrica 12V
8_ linea termostato
6
78
Dettaglio dell’apertura nella membrana: vista esterna e sezione_scala 1:5
1
1
2
2
3
3
3
3
2
2
5
5

244
Impianto elettrico per il collegamento di dispositivi elettromedicali ed elettrici
Per facilitare tutte quelle operazioni che necessitano l’utilizzo di energia elettrica si sono predisosti degli elementi di interfaccia
tra la rete di adduzione della linea elettrica e l’utente.
Attualmente il sistema è quello di bloccare alcune prese volanti alla struttura della tenda. Vi è però il problema che i fi li di
tali prese rimangono ad intralcio degli operatori. Il progetto propone una soluzione in cui vi è un sistema di interfaccia dotato
di prese che viene installato sui correnti orizzontali della struttura interna. I fi li di adduzione sono nascosti dal vano tecnico
(coperto dai teli integrati al sistema di illuminazione) e l’utente vede solamente l’elemento di interfaccia.
Prospetto: quadro prese per alimentazione elettrica dotato di spine esterne CEE incassate nella scocca dotate di sportellino di chiusura;sportellini chiusi
ed aperti_scala 1:5_misure in millimetri
INTERRUTORE DI
SICUREZZA

245
Vista laterale: quadro prese di alimentazione elettrica posto sulla struttura secondaria; lato sinistro zona emergenza, lato destro zona degenza_
scala 1_5_ misure in millimetri
TELO DIVISORIO LINEA ELETTRICA
CORRENTI ORIZZONTALI
TELO DIVISORIO
Nel telo divisorio sono già predisposte le bucature
per l’inserimento degli elementi
SCOCCA IN PLASTICA ABS La plastica ABS è ottenuta per copolimerizzazione
di acrilonitrile, butadiene e stirene.
È ut i l izzata per la produzione di manufatt i
particolarmente resistenti all’urto.
INTERRUTORE DI
SICUREZZA
SPINA DI
ALIMENTAZIONE

246
Servizi, spogliatoio e depositi
Nel progetto si è ritenuto necessario provvedere a garantire un livello di servizi minimo per il personale e per i degenti.
La richiesta è venuta direttamente dagli operatori in quanto trovano scomodo non poter, ad esempio, lavarsi le mani all’interno della tenda,
Attualmente devono infatti uscire e cercare un luogo fornito di tali servizi.
Inoltre, sebbene la struttura sia concepita per il trattamento di persone soggette a pericolo di vita, c’è stata la richiesta di installare anche
un servizio per i degenti per rispondere ad una necessità di fl essibilità della struttura. Può capitare ad esempio che unità predisposte per
l’accoglienza di codici rossi e gialli venga utilizzata anche da persone che non necessariamente sono immobilizzate. Per questo bisogna
garantire un livello minimale di servizi anche nell’area degenza.
Una ulteriore richiesta è stata quella di fornire un luogo in cui il personale medico può riporre i propri effetti personali per garantire un
maggiore ordine all’interno dell’unità.
Questa zona è stata individuata accanto al servizio igienico per i soccorritori per due ragioni individuare una area “riservata” al personale
e creare una zona di rispetto tra l’area in cui si opera e il servizio stesso.
Infi ne si è ritenuto necessario designare due luoghi per il deposito del materiale sanitario e dei rifi uti.
Per il primo è stata individuata l’area più vicina alla porta d’accesso in modo da non ostacolare le operazioni dei soccorritori interne alla
tenda; per il secondo si è invece individuata una zona lungo il corridoio di servizio in modo da garantire, quando necessario, la rapida
evacuazione dei rifi uti senza dover passare attraverso la zona d’emergenza.
Toilette portatile modello PP 365
dimensioni: 379 x 419 x 414 mm (l x p x h)
sistema di risciaquo: manuale, pompa a pistone
capacità serbatoio di scarico: 21l
capacità serbatoio dell’acqua pulita: 15l
peso netto: 3,7kg
Toilette portatile
Servizi
Il sistema per garantire ai sanitari la possibilità di lavarsi le mani è stato pensato partendo dagli attuali sistemi che prevedono
un telaio generalmente di acciaio e l’utilizzo di taniche rigide (quando non ci sia la possibilità di allacciamento alla rete
idrica).
Sistemi esistenti di lavandini pieghevoli; Offi cine Stefanutto e Ferrino

247
Guardaroba
Jumbo Box CS: armadio guardaroba con resistente asta
portavestiti, un ripiano interno ed un ripiano superiore
esterno. La parete posteriore dispone inoltre di un’apertura di
ventilazione.
Peso 5,4 Kg
57 x 47 x H140 cm aperto
70 x 50 x H12 cm chiuso
Il lavandino proposto prevede 4 montanti telescopici su cui
sono inseriti 4 ripiani in plastica abs.
Nel primo e nell’ultimo troveranno alloggio le due taniche
ripiegabili ( e che quindi in fase di stoccaggio non
occuperanno eccessivo posto).
Una guarnizione con tappo avvitabile permetterà di
agganciare lo scarico del lavandino con la tanica inferiore
che servirà da vaso di raccolta.
Un tradizionale tappo con rubinetto permette il dosaggio
dell’acqua.
Sistema telescopico
Armadietto Jumbo Box Cs, Brunner International

248
Impianto di i l luminazione
LAMPADA A
LAMPADA B
LAMPADA A
LAMPADA C
L’impianto di illuminazione è stato progettato in modo da garantire una corretta illuminazione dell’interno ed agevolare le
attività mediche.
Durante la progettazione si è deciso di integrare il sistema delle luci con i teli divisori mobili che permettono di delimitare o
meno le diverse aree.
Conseguentemente, per garantire la più ampia fl essibilità dello spazio interno all’unità sanitaria, si è deciso di mantenere il
sistema appeso, senza presenza di montanti che possono ostacolare le attività.
In questo modo gli operatori sono totalmente liberi di scegliere la confi gurazione spaziale più idonea al momento.
Le lampade individuate con la lettera A hanno dei teli mobili divisori che presentano un appesantimento della parte inferiore
(tramite una fascia di materiale tessile aggiuntivo o piccole sfere di piombo) per impedire che con l’aria abbiano un effetto
vela. Nel caso in cui non servissero, i divisori possono essere agganciati tramite una clip al telo della struttura secondaria
posta sulla sinistra.
Le lampade C non presentano teli divisori ma hanno integrato l’interruttore per l’accesione o lo spegnimento delle luci.
Infi ne i teli delle lampade B copriranno il vano tecnico costituito dalla struttura secondaria.
Queste lampade, essendo appese solo al palo centrale, per sicurezza, avranno la possibilità di poggiare sui montanti centrali
del vano tecnico, realizzati leggermente più alti degli altri proprio per assolvere a questa necessità.
Impianto di illuminazione_scala 1:50_misure in metri
Elemento per il fi ssaggio del
telo divisorio tra due postazioni in area
d’emergenza

249
Lampada A
1
2
2
3 3
4
5
6
1_ Aggancio alla struttura principale
2_Incastri per collegamento con altri
moduli
3_Lampade led
4_Vano si passaggio corrente elettrica
5_Sfera per lo spostamento del telo
separatore
6_Telo separatore
7_apertura della scocca per passaggio
luce con element in plastica trasparente
8_taglio nella scocca per permettere
(dopo l’allentamento delle viti di
colegamento) la sostituzione delle
lampade guaste
Scocca in materiale plastico antiurto
(ABS);aggancio a struttura in fi bra di
carbonio
2
2 77
8
Profi lo, sezione interna e prospetto della lampada A_scala 1:2_misure in millimetri

250
Sezione lampada A_scala 1_2; profi lo lampada B; sezione lampada B _scala 1:5_misure in millimetri
Per permettere un facile stoccaggio delle lampade e dei teli separatori le parti terminali delle lampade hanno un tappo
rimovibile. In questo modo i teli con le relative sfere possono essere messi o tolti a seconda delle situazioni.
Lampada B
Le lampade B hanno una forma tale da permettere ai teli di coprire il vano tecnico in cui sono inseriti gli impianti.

251
Schema di controllo delle luci e posizionamento degli interruttori
linea A
linea B
Per l’accensione e lo spegnimento alcuni moduli sono provvisti di un interruttore. Questo è collegato alla lampada attraverso un cavo
avvolgibile che permette di essere esteso quando le lampade sono installate. Al momento del disassemblaggio l’interruttore trova alloggio
all’interno del profi lo modifi cato della scocca della lampada.
Lampada C
Sezione lampada C con interruttore_scala 1:2_misure in millimetri

252
B
Pianta: punti di agganzio delle lampade sulla struttura_scala 1:50
Aggancio alla struttura
B
B

253
Sezione BB: interno dell’unità mobile di soccorso sanitario_scala 1:50_misure in metri
Particolare dell’aggancio delle lampade alla struttura principale_scala 1:5
MEMBRANA ESTERNA
MONTANTE
ELEMENTO PER IL
FISSAGGIO ALLA STRUTTURA
LAMPADA
ELEMENTO DI AGGANCIO
diametro 20mm

254
Particolare dell’aggancio della tenda di separazione tra le due postazioni in zona emergenza in corrispondenza della lampada B

255
Pianta: carrello con attrezzature sanitarie_scala 1:10_misure in millimetri
1_ lampada
2_ binario per scorrimento lampada
3_ porta fl ebo e tubi
4_ prese per alimentazione elettrica
5_ porta rotolo di carta
6_ presa di corrente generale
1
2
3
4
5
6
Il binario su cui scorre la lampada è dotato di una guaina elastica che segue il movimento dell’apparecchio in modo da coprire
lo stesso binario e impedire allo sporco di entrare. Per bloccare la lampada in una posizione è suffi ciente azionare i fermi
posti a lato.
La prima principale attrezzatura utilizzata dai medici in una unità mobile per il soccorso sanitario è un carrello o armadietto in
cui sono contenuti farmaci e attrezzature.
Nel progetto si è ripensato l’elemento some sistema integrato di tutte quelle facilitazioni utili al lavoro del medico.
Per prima cosa si è ritenuto necessario integrare al carrello una lampada che serve al soccorritore per vedere in maniera
ottimale la zona del corpo su cui interviene. Attualmente la lampada è indipendente e, a causa del cavo di alimentazione e
della pesantezza, interferisce notevolmente con le operazioni.
Il nuovo punto luce può invece scorrere lungo il carrello e raggiungere le zone da illuminare comodamente, grazie anche al
braccio fl essibile. In questo modo si dovrà solamente avvicinare il carrello al paziente per avere a disposizione il necessario.
Sul braccio rigido è stato predisposto un elemento ruotabile il quale presenta delle scanalature per il posizionamento di
eventuali tubi per la resipirazione/aspirazione e due portafl ebo
A supporto delle attrezzature elettromedicali sono state predisposte delle prese di corrente localizzate in posizione centrale;
è stato integrato un sistema per il fi ssaggio del rotolo di carta assorbente e a lato si è predisposto un piano ribaltabile che
all’ocorrenza può aumentare la superfi cie utile del carrello.
Il piano di lavoro ha un bordo rialzato per evitare la tracimazioni di eventuali liquidi dispersi.
Il carrello è dotato di 5 cassetti colorati secondo le prescrizioni per individuare in modo immediato la localizzazione di un tipo
specifi co di attrezzatura o medicinale (rosso: cardiocircolatorio, blu: supporto respiratorio; verde: materiali diversi) e di uno
scompartimento a ribalta da utilizzare come cestino).
La corrente elettrica viene attinta attraverso una presa di corrente posta sul retro.
Il basamento è completo di quattro ruote piroettanti, di cui due con freno.
Carrello medico

256
Vista anteriore e posteriore: carrello con attrezzature sanitarie_scala 1:10_misure in millimetri

257

258
Lettino piegevole per le prime cure e brandine degenza
A completamento dell’allestimento dell’unità mobile di soccorso sanitario vi sono i lettini della zona emergenza e le brandine
per la zona degenza.
Sono già disponibili sul mercato elementi pieghevoli e facilmente trasportabili.
Per l’area emergenza si è adottato il lettino pieghevole per triage, mentre per l’area degenza la brandina de luxe tutto della
ditta Ferrino.
Nel secondo caso, per la scelta del prodotto, si è deciso di scegliere una brandina che fosse abbastanza comoda (che signifi ca
larghezza adeguata) ma che al contempo avesse un peso contenuto.
La brandina de luxe ha le seguenti caratteristiche:
_ misure aperta: 200x75x45 cm
_ misure chiusa: 100x20x13 cm
_ peso: 6,5 kg
In robusto alluminio con telo in poliestere leggermente imbottito per garantire un maggior isolamento
dall’umidità del terreno e con misure più ampie per un migliore comfort. Custodia con tracolla per il
trasporto.
Brandina de luxe, Ferrino
Per quanto riguarda il lettino in cui si prestano le prime cure nell’area emergenza si è aggiunta una modifi ca al lettino
pieghevole in commercio della Ferrino.
Dall’analisi dei fl ussi e della movimentazione dei feriti era necessario pensare a come i pazienti venissero trasportati
dall’area emergenza a quella degenza. Naturalmente un codice rosso-giallo non può camminare, in situazioni di emergenza
non vengano trasportate sul luogo della crisi e utiliizate, almeno nelle prime ore, barelle dotate di ruote e le tavole o i teli che
utilizzano i soccoritori per il recupero dei feriti devono essere riutilizzate nlela zona “cantiere” (si veda l’organizzazione dei
soccorsi_cap.4; cantiere: luogo dell’incidente seprarato dalla postazione di soccorso)
Prendendo quindi il lettino già in commercio è stato inserito un piano scorrevole sotto di esso in cui è lagata una tavola spinale
dalla ditta Kong (X trim 1). La caratteristica di questa tavola è quella di essere molto leggera, in quanto prodotta in fi bra di
carbonio, pieghevole in in due moduli e dallo spessore di 5mm. Questo tipo di prodotto è stato concepito per il trasporto su
eliambulanza, dove peso e spazio occupato devono essere ridotti al massimo.
Per permettere lo scorrimento del piano su cui è poggiata la tavola spinale è necessario porre il porta rotolo di carta (che serve
per garantire l’igiene ad ogni cambio di paziente) sul lato dove si posizionerà la testa del ferito.
Caratteristiche tecniche:
- LETTINO PIEGHEVOLE PER TRIAGE
_ peso: 24 kg
_ misure aperto: 200 x 60 x H 70 cm
_ misure chiuso: 100 x 60 x H 10 cm
Pratico lettino pieghevole per uso sanitario, ha un’ottima stabilità. Il materiale di rivestimento è
facilmente lavabile e disinfettabile
- X-TRIM 1 (Tavola spinale in carbonio)
_ peso: 4,5kg

259
Nuova tavola spinale in fibra di carbonio. Peso ed ingombro ridotti al minimo, meno di 5 kg per uno
spessore di 5mm, importantissimo per facilitare la manovra “roll on”. Priva di qualsiasi parte in
metallo, è completamente radio-trasparente e quindi può essere inserita direttamente in T.A.C.,
risonanza magnetica e altri apparati diagnostici, evitando lo spostamento del paziente.
Concepita e realizzata per qualsiasi tipologia di soccorso: ambulanza,moto-mediche, elicottero, ecc...
Particolarmente adatta all’impiego in ambiente impervio, studiata nei particolari per l’abbinamento
con teli verricellabili (es: KONG mod. EVEREST), ideale per l’utilizzo in elisoccorso.
Cinghie di bloccaggio paziente (mod. TAYLAN) fornibili separatamente.
Ferrino, lettino pieghevole
Kong, tavola spinale in fi bra di carbonio
Si ritiene necessario pensare che l’unità mobile di soccorso sanitario sia fornita di più di una o due (a seconda delle postazioni
per l’emergenza) tavole spinali X trem 1. Questo perchè potrebbe rivelarsi utile nella gestione del paziente pensare che questo
possa essere posizionato sulla tavola spinale e non più slegato da essa fi no al trasporto in ospedale, riducendo al minimo
il rischio lesioni spinali e non. Naturalmente ci sarebbe poi il problema del recupero delle tavole per renderle nuovamente
disponibili nell’U.M.S.S. ma si ritiene che la gestione paziente-supporto debba essere valutata da coloro che organizzano la
catena dei soccorsi e non può rientrare nelle competenze del progettista.
Rimane il fatto che può rivelarsi comunque utile la presenza di un numero maggiore di tavole spinali rispetto a quello minimo
da garantire.

260
Vista dall’alto con tavola spinale e prospetto laterale: letto per la zona emergenza_scala 1:20_misure in millimetri

261

262INGRESSO
Porte e collegamenti con alte U.M.S.S.
USCITA

263
La protezione dagli agenti atmosferici per le aperture d’ingresso ed d’uscita può essere fatta utilizzando due montanti
predisporti e innalzando la parte di membrana che si può aprire grazie a delle zip e che corrisponde all’ingresso (o uscita)
dell’unità. La membrana aperta può essere o arrotolata e fi ssata attraverso i ganci predisposti o appunto tesa sui due mon-
tanti. È poi possibile, attraverso i teli in dotazione, garantire anche la protezione laterale. Tutti i teli infatti sono dotati di zip che
permettono un rapido montaggio. La connessione di più moduli è resa possibile da un telo centrale dotato di due asticelle in
fi bra di vetro curvate che permettono all’acqua di scorrere verso i lati.
Nel caso in cui non si dovessero agganciare più moduli ma solo proteggere la singola entrata o uscita, la curvatura è resa
possibile dalle asticelle in dotazione per il tensionamento delle membrane nella parte inferiore.
È possibile inoltre installare sul lato interno della membrana esterna una zanzariera per ventilare l’interno evitando l’ingresso
di insetti.
Vista laterale del collegamento tra due moduli_scala 1:50_misure in metri
Schema degli elementi costituenti il collegamento tra i moduli_scala 1:50_misure in metri
Particolare dell’apertura delle membrane; particolare dell’attacco della zanzariera, vista interna

264
Possibile organizzazione di più unità

265
CALCOLO DEI PROBABILI PESI DELL’ U.M.S.S.
Di seguito si cerca di dare una indicazione relativa ai possibili pesi dell’U.M.S.S. per verifi care se lo scopo iniziale della tesi,
quello di garantire una struttura mobile relativamente leggera, che può essere trasportata con la maggior parte dei mezzi sia
stato raggiunto. In particolare si voleva cercare di limitare il peso della vera e propria struttura a meno di 1400kg, limite di
carico a gancio baricentrico dei modelli di elicottero civili utilizzati in Friuli Venezia Giulia dall’Elifriulia.
Da tenere in considerazione che tali pesi sono calcolati in base ai materiali e al dimensionamento ma potrebbero variare in
funzione delle lavorazioni.
In “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero” si sottolinea come “allo scopo di ridurre
i tempi di intervento di soccorso primario e di trasporto secondario a mezzo elicottero, nonché di poter disporre di maggiori
risorse immediatamente attivabili in caso di calamità o di maxi emergenze per ottimizzare l’utilizzo dei mezzi,
razionalizzandone l’impiego ed i costi relativi, si conviene di poter stipulare tra Regioni limitrofe confi nanti, e comunque nelle
zone interessate dalle possibilità operative dei mezzi aerei, convenzioni che assicurano il reciproco intervento degli elicotteri
disponibili per operazioni di soccorso”.1
Si riportano di seguito le caratteristiche dell’elicottero Ecureuil AS 350 B3 prodotto dall’Eurocopter utilizzato dalla ditta Elifriulia
per le attività di soccorso della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia:
Motori: 1 Turbomeca Arriel 2B
Potenza: Max al decollo 847 HP, MAX continua 728 HP
Posti: 1 pilota + 5 passeggeri
Pesi: Max al decollo kg 2250; carico pagante kg 950; gancio baricentrico kg 1400
Dimensioni: Lunghezza m.12,9 larghezza m.2,53 altezza m.3,14 diametro rotore m. 10,7
Prestazioni: Hovering fuori effetto suolo m. 3500, quota tangenza m. 5000 (pratica); velocità salità
m/sec 9,25: velocità max Kh/h 287; velocità max di crociera Km/h 245
Carburante: Serbatoio litri 540
Autonomia: Km 662
Verricello: Elettrico lunghezza cavo m.50; carico utile kg 204
Barella: Piguillem e Barella universale
AS 350 B3, immagini del modello e trasporto con gancio baricentrico
1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province automome di Trento e Bolzano, Accordo, ai sensi dell’art.4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recante “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso dei servizi di soccorso sanitario con elicottero”

266
ELEMENTO MATERIALE DIMENSIONI PESO PER UNITÀ TOTALEfi bra carb.
TOTALEavional
struttura principale
montanti verticali fi bra di carbonio
avional (duralluminio)
52100cm3/0,0512m3
52100cm3/0,0512m3
1560kg/m3
2700kg/m3
81,2kg
140,6kg
correnti orrizontale fi bra di carbonio
avional (duralluminio)
52100cm3/0,0512m3
52100cm3/0,0512m3
1560kg/m3
2700kg/m3
32,5kg
56,26kg
palo centrale con anello fi bra di carbonio
avional (duralluminio)
52100cm3/0,0512m3
52100cm3/0,0512m3
1560kg/m3
2700kg/m3
12kg
20kg
giunti fi bra di carbonio
avional (duralluminio)
52100cm3/0,0512m3
52100cm3/0,0512m3
1560kg/m3
2700kg/m3
8kg
15kg
struttura secondaria
divisori interni fi bra di carbonio
avional (duralluminio)
52100cm3/0,0512m3
52100cm3/0,0512m3
1560kg/m3
2700kg/m3
60kg
105,3kg
membrane
membrana interna Birdair Tensotherm circa 100m2 1.8kg/m2 180kg 180kg
membrana esterna Gore Tenara 3T40HF circa 100m2 0,925kg/m2 92,5kg 92,5kg
pavimentazione
livellante
Polifl ex
Brunner International
circa 77m2 2,5kg/m2 192,5kg 192,5kg
telo pavimento polietilene bassa densità circa 70m2 0,2kg/m2 14kg 14kg
teli divisori interni
mobili e fi ssi
Nylon Ripstop 70D circa 88m2 0,055kg/m2 4.8kg 4.8kg
totale: 677,6kg
totale: 820,6kg1
lampade2 plastica abs, altro - - -
ACCESSORI QUANTITÀ PESO PER UNITÀ TOTALE
lettini emergenza 2 24kg 48kg
tavole spinali 2 4,5kg 9kg
brandine degenza 4 6,5kg 26kg
ripostiglio vestiario 1 6,2kg 5,4kg
wc chimico 2 3,7kg 7,4kg
totale 96.6 773,4 916,4
lavandino portatile2 2 - - - -
carrello medico2 2 - - - -
1 Da considerare che il peso potrebbe essere maggiore vista la probabile necessità di aumentare il diametro dei profi lati rispetto a quelli in fi bra di
carbonio
2 Non è possibile calcolare il peso degli elementi progettati ex novo in quanto il loro peso non dipende solamente dai materiali prescelti per realizzarli

267
MODELLINO

268

269


C O N C L U S I O N E


273
Trasportabilità, trasformabilità, fl essibilità, adattabilità e infi ne temporaneità sono stati i requisiti che hanno accomunato le
ricerche fatte per questa tesi nei diversi campi.
Il progetto di una unità mobile di soccorso sanitario (U.M.S.S.) ha infatti stimolato la curiosità verso tutti quegli aspetti che in
qualche modo infl uenzano e determinano le confi gurazioni delle architetture temporanee.
Fondamentale è stato capire che ruolo hanno avuto ed hanno tutt’oggi i progettisti nel momento in cui vengono chiamati a
defi nire un’architettura a supporto di una situazione di emergenza.
Come per ogni progetto, anche quello per l’emergenza richiede in prima istanza delle prestazioni basilari, ma se si cominciano
ad approfondire anche solo alcuni aspetti, si intuisce come la ricerca architettonica sia un continuo di rimandi, di richieste e
di esigenze che portano il progettista a percorrere una spirale di ricerca che sembra non avere mai termine.
Come dice Enzo Mari nel libro più volte citato “Progetto e passione”, “le diramazioni di ricerca individuate via via come prio-
ritarie corrispondono, secondo alternanze reciprocamente funzionali, a idee, procedure, materiali, tecniche e quant’altro” e “
se il processo di ricerca non può avere limiti perché ogni risposta a una domanda contiene in sé la formulazione di domande
successive, il progetto deve essere comunque concluso interrompendo il fl usso di domande.”
In questa tesi di certo non sono mancate le domande e i campi in cui si vedeva una possibile risposta a queste.
Ci siano stati principalmente due diversi fronti su cui si è realizzata la ricerca: il campo dell’architettura mobile e quello
dell’emergenza sanitaria, e come il progetto fi nale volesse essere un punto di sintesi di tutto il percorso fatto.
Fondamentale è stata poi la curiosità di scoprire come veramente vengano affrontate le emergenze direttamente da coloro i
quali le hanno scelte come scenario lavorativo.
Le competenze degli operatori della protezione civile, dei militari e dei medici (di cui sono riportati degli stralci delle interviste)
si sono rivelate imprescindibili per la progettazione di una unità mobile di soccorso sanitario che vuole essere funzionale e
realizzabile.
Dal punto di vista architettonico ho potuto appurare come il concetto di mobilità è portatore di innumerevoli rimandi, come
quello della leggerezza, della fl essibilità e dell’adattabilità, concetti che sono molte volte da stimolo per l’innovazione
tecnologica.
L’approfondimento che è stato fatto rispetto all’aerogel ha evidenziato come la ricerca prestazionale all’interno di quel settore
che è considerato per eccellenza il campo della leggerezza in architettura, cioè quello delle membrane tessili, ha portato
benefi ci a tutto il campo architettonico che richiede alti isolamenti termici.
È per questo motivo che ritengo che l’architettura mobile è da considerare di pari dignità di quella tradizionalmente intesa, ed
anzi, debba divenire il campo della possibile e vera sperimentazione architettonica. Ho infatti più volte sottolineato come nel
campo dell’edilizia le innovazioni tecnologiche in genere derivino da transfert tecnologici e non da “rivoluzioni” interne.
Nella defi nizione della nuova unità mobile di soccorso sanitario ho constatato come progettare un elemento dalle dimensioni
ridotte ma che richiede prestazioni eccellenti pone questioni e problematiche che non possono essere tralasciate; non
progettare e defi nire un particolare in una architettura mobile signifi ca molto probabilmente il fallimento in fase realizzativa.
Tutti i componenti infatti devono essere visti prima nella loro specifi cità e poi all’interno della globalità progettuale.
Il cambiamento di un componente comporta delle ripercussioni generali.
Se poi l’architettura mobile deve provvedere anche alle esigenze sanitarie la necessità di affrontare il progetto in modo
organico è fondamentale. Le alte prestazioni non devono essere garantite solamente dall’involucro, ma anche dalle risorse
interne, le quali a loro volta devono integrarsi con la struttura.
In conclusione si può dire che la progettazione di un’unità mobile di soccorso sanitario e di un’architettura mobile in generale
fa capire come il progetto architettonico è da considerarsi alla stregua di un viaggio nel quale vi sono delle tappe obbligate,
defi nite dalle richieste prestazionali di base, e delle tappe che non sono state pianifi cate in fase organizzativa, ma che il
viaggiatore-progettista ha voluto fare perché incuriosito o spinto dalla corrente delle idee.
Può succedere che durante il percorso il viaggiatore sia confuso, che alle volte non capisca proprio perché si ritrovi in quel
luogo, ma è alla fi ne del viaggio che diviene chiaro ed esplicito il fi ne di tutto, perché tutte le esperienze si concatenano
e trovano una loro posizione nel tutto. Credo che il progetto sia da considerarsi come la fi ne del viaggio, un sistema di
esperienze maturate nel tempo, di sensazioni e di pensieri. Sicuramente il viaggio poteva essere diverso e avrebbe portato
anche a risultati diversi ma
“ognuno di noi è al centro d’una leggenda meravigliosa: tutto il passato che conosciamo (e quindi viviamo nel nostro
presente), tutto il presente che conosciamo (e che quindi viviamo), tutto il futuro che intuiamo e prepariamo (e quindi viviamo:
operare è soltanto per il futuro) sono simultanei nella nostra conoscenza: esistono soltanto nella nostra esistenza….
La vita è una meravigliosa leggenda, ricchissima, inesauribile, nella quale concorrono simultaneamente il passato e il presente
che conosciamo, ed è una meravigliosa simultaneità di luoghi, di tutti i paesi che sappiamo.”
Giò Ponti_ Amate l’Architettura_


B I B L I O G R A F I A


277
AA.VV, Domebook 2, Pacifi c Domes, 1971, Bolinas , California, USA
AA.VV, I materiali sintetici, Quaderni del manuale di progettazione edilizia, Ulderico Hoepli Editore, 2003, Milano
Aldo Rossi, Autobiografi a scientifi ca, Nuova Pratiche Editrice, 1999, Milano
Alessandra Zanelli, Trasportabile/Trasformabile. Idee e tecniche per architetture in movimento, Libreria Clup, 2003, Milano.
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Uffi cio stampa dell’Agenzia di Protezione Civile (a cura di), Manuale per
le Emergenze, 2001, Roma
Architecture for Humanity, Design Like You Give a Damn, Architectural Responses to Humanitarian Crisis, Published by
Metropolis Books, 2006, New York
Bernard Tschumi, Architecture in/of Motion, NAi Publishers, 1997, Rotterdam
Bernard Tschumi, Architettura e disgiunzione, Edizioni Pendragon, 1996, Bologna
Brian Foster, Marijke Mollaert, Associazione Tensinet, Progettare con le membrane, tensostrutture e presso strutture, materiali
e tecnologie, ed. italiana a cura di Alessandra Zanelli, Maggioli Editore, 2007, Santarcangelo di Romagna, Rimini.
Bruno Munari, Design e comunicazione visiva, Editori Laterza, 1968, Bari
Croce Rossa Francese, Associazione Italiana Medicina delle catastrofi , Manuale di protezione civile, organizzazione dei
soccorsi sanitari in situazioni di eccezionale emergenza,1994, Edizioni Piemme
Department of defence of the United States of America, Emergency War Surgey, 2004, USA
(Scaricabile in http://www.bordeninstitute.army.mil/other_pub/ews/TableOfContents.pdf)
Enzo Mari, Progetto e passione, Bollati Boringhieri Editore, 2001, Torino
Giancarlo Cataldi, a cura di, Attualità del primitivo e del tradizionale in architettura, Alinea, 1989, Firenze
Giovanni Corbellini, Ex Libris, 16 parole chiave dell’architettura contemporanea, 22 Publishing, 2007, Milano
Gio Ponti, Amate l’architettura, l’architettura è un cristallo, Cusl editore, 2004, Milano
Giovanni Damiani, a cura di, Bernard Tschumi, Rizzoli|Skira, 2003, Milano
Hans-Joachim Shock, Atlante delle tensostrutture, Utet, 2001, Torino
Hegger Auch-Schwelk, Fuchs Rosenkranz, Atlante dei materiali, Utet, 2005, Monaco
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Global Programme Shelter, edito da International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies, 2006, Ginevra
Italo Calvino, Le città invisibili, Arnoldo Mondadori Editore, 2004, Milano
Joachim Krausse, Claude Lichtenstein, Your Private sky, R. Buckminster Fuller, the art of design science, Lars Muller Publisher,
1999, Baden, Svizzera
John Chilton, Atlante delle strutture reticolare, Utet, 2002, Torino
Kari Jormakka, Olandesi volanti, il movimento in architettura, Testo e immagine, 2002, Torino

278
Laura Angeletti, Innovazione tecnologica ed architettura, Gangemi Editore, Roma
Laura Montanaro, Simona Toppan, Andrea Borsarelli, I materiali per l’ingegneria, vol.2 La tecnologia dei materiali, Celid, 1999,
Torino
Mario Massimo Simoncelli, Assistenza Alloggiativa in Emergenza, Aree di accoglienza, in Elvezio Galanti, Il Metodo Augustus,
da www.ispro.it
Matilda McQuaid, Shigeru Ban, Phaidon Press, 2003, Londra
Mathias Schwartz-Clauss, Alexander von Vegesack, a cura di, Living in motion, Design and architecture for fl exible dwelling,
Vitra Design Museu, 2002, Weil am Rhein
Michael John Gorman, Buckminster Fuller, Architettura in movimento, Skira editore, 2005, Milano
Nicola Sinopoli, Valeria Tatano, a cura di, Sulle tracce dell’innovazione. Tra tecniche e architettura, Angeli, 2002, Milano.
Offi ce for the Coordination of Humanitarian Affair, Tents, A Guide to the use of family tents in humanitarian relief, 2004, United
Nations Publication
Pilar Echavarria M., Architecture portative, environnements imprevisibles, Arian Mostaedi editore, Barcellona, Spagna
(titolo edizione italiana: Architettura portatile, paesaggi imprevedibili)
Regione Piemonte, Organizzazione dei soccorsi sanitari in caso di catastrofe
Rene Noto, Pierre Huguenard, Alain Larcan, Medicina delle catastrofi , Masson Editore, 1989, Milano
Renzo Piano, La responsabilità dell’architetto, Passigli Editore, 2007, Bagno a Ripoli (Firenze)
Renzo Piano, Le città visibili, Triennale Electa, 2007, Milano
Robert Kronenburg, Portable Architecture. Design and Technology, Birkhauser Verlag AG, 2008, Basel- Boston - Berlin.
Robert Kronenburg, Flexible,architecture that responds to change, Laurence King Publishing, 2007, Londra
Roberto Mango, Ermanno Guida, Abitare l’emergenza, studi e sperimentazioni progettuali, Electa Napoli, 1988, Napoli.
Roberto Pinto, Nicolas Bourriaud, Maia Damianovic, Lucy Orta, Phaidon Press, 2003, Londra
Sigfried Giedion, Spazio, Tempo, Architettura, Ulrico Hoepli editore, 1965, Milano
Simon Sadler, Architecture without architecture, Massachusetts Institute of Technology, 2005, Londra
The Sphere Project, Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, edito da The Sphere Project, 2004,
Ginevra
Torvald Faegre, Tende: architettura dei nomadi, edizioni Dedalo, 1981, Bari
U.S Department of Homeland Security, National Incident Management System, 2004, Washington DC, USA
Valeria Tatano, Dal manuale al web, Cultura tecnica, informazione tecnica e produzione edilizia per il progetto di architettura,
Offi cina edizioni, 2007, Roma

279
RIVISTE
Pierluigi Nicolin, Architettura “light”, Lotus International, n° 105, 2000, pagg. 30-31
AA.VV., Serpentine Gallery Pavilion, Lotus International, n° 122, 2004, pagg. 51-61
Ignasi de Solà-Morales, High-Tech. Funzionalismo o retorica?, Lotus International, n° 78, 1993, pagg. 66-72
Tita Carloni, La tenda mobile di Mario Botta, Lotus International, n° 78, 1993, pagg. 80-87
Alessandra Zanelli, Luminosità tessile, Arketipo, n°21, marzo 2008, pagg. 44-55
Bruce Sterling, Architecture in Estreme Enviroments/3, Thailandia Hybrid Muscle, Domus, n°870, maggio 2004, pagg. 41-
49
Fabrizio Gallanti, Architecture in Estreme Enviroments/1, Antartide/Antartica EPTAP 1999-2004, Domus, n°870, maggio
2004, pagg. 28-35
Giuseppe Turchini, Soluzioni in evoluzione, Arketipo, n°21, marzo 2008, pagg. 44-55
Joseph Grima, Architecture in Estreme Enviroments/2, Australia Longitude 131°, Domus, n°870, maggio 2004, pagg. 36-
41
Mark Irving, Scultura mangia architettura, Domus, n°853, novembre 2002, pagg. 65-73
Mark Wigley, Il Fun Palaca di Cedric Price, Anti-edifi ci e anti-architetti, Domus, n°866, gennaio 2004, pagg. 14-23
Paolo Deganello, La vecchia guardia non muore mai, Domus, n°908, novembre 2007, pagg. 76-84
Redazione Domus, a cura di, Architettura temporanea/2, Domus, n°907, ottobre 2007, pag. 6
F. Hörz, M. E. Zolensky, Impact Features and Projectile Residues in Aerogel Exposes on Mir, Icarus, n° 147 del 2000, pagg.
559-579
H. Yokogawa, M. Yokoyama, Hydrophobic silica aerogels, Journal of Non-Crystalline Solids, n° 168,1995, pagg. 23-29
Lawrence W. Hrubesh, Aerogel applications, Journal of Non-Crystalline Solids, n° 225, 1998, pagg. 335-342
M. Schmidt, F. Schwertfeger, Application for silica aerogel products, Journal of Non-Crystalline Solids, n° 225,1998, pagg.
364-368
P.B. Wagh, R. Begag, G.M. Pajonk, A. Venkateswara Rao, D. Haranath, Comparison of some physical properties of silica
aerogel monoliths synthesized by different precursors, Material Chemistry and Physics, n° 57,1999, pagg. 214-218
P.B. Wagh, S.V. Ingale, Comparison of some physio-chemical properties of hydrophilic and hydrophobic silica aerogels,
Ceramics International, n°28, 2002, pagg. 43-50

280
NORMATIVA SULLE STRUTTURE TEMPORANEE
UNI EN 13782- 2006, Strutture temporanee – tende – sicurezza (Temporary – Tents – Safety)
NORMATIVA E DOCUMENTI RELATIVI AL SETTORE MEDICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Gazzetta uffi ciale dell’Unione europea L 20/23, 24.1.2008
Decisione della Commissione del 20 dicembre 2007 recante modifi ca della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto
concerne le modalità di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un
meccanismo comunitario di protezione civile.
Accordo ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province automome di
Trento e Bolzano, “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso dei servizi di soccorso sanitario con elicottero”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria, Pianifi cazione
dell’emergenza intraospedaliera a fronte di una maxi-emergenza, settembre 1998
Gazzetta Uffi ciale, n. 44 del 23 febbraio 2005, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidenza de Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, “Linee Guida per l’individuazione delle Aree di Rico-
vero per Strutture Prefabbricate di Protezione Civile”
Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 1243 del 24 marzo 2005 (approvato con)
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, “Manuale tecnico per l’allestimento delle aree di
ricovero per strutture prefabbricate di Protezione Civile”
Gazzetta Uffi ciale - serie generale- n°81 del 6 aprile 2001 (Suppl. Ordinario n° 116), ALLEGATO A, “Criteri di massima
sulla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un Posto Medico Avanzato di II livello utilizzabile in caso di catastrofe” in,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria, Comunicato relativo
al decreto del ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile 13 febbraio 2001 concernente:
Adozione dei “Criteri massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi ”
Gazzetta Uffi ciale – serie generale – n. 81 del 6 aprile 2001 (Suppl. Ordinario n° 116), decreto,
“Criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un Posto Medico Avanzato di II livello utilizzabile in caso
di catastrofe”

281
SITOGRAFIA
AEROGEL
video: www.kqed.org/quest/television/view/776
www.cnn.com/TECH/9705/13/aerogel/aerogel.13.mov
Lawrence Livermore National Laboratory: www.llnl.gov/
ipo.llnl.gov/technology/profi le/aerogel/Aerogels/
ipo.llnl.gov/technology/profi le/aerogel/AerogelFabrication/index.php
ipo.llnl.gov/technology/profi le/aerogel/Terms/
Environmental Energy Technology Division - Lawrence Berkeley National Laboratory: //eetd.lbl.gov/ECS/Aerogels/sa-home.html
Nasa: http://curator.jsc.nasa.gov/stardust/aerogel.cfm
http://stardust.jpl.nasa.gov/tech/aerogel.html
http://stardust.jpl.nasa.gov/news/status/060207.html
Brevetti internazionali: www.wipo.int
Aziende che utilizzano l’aerogel in architettura:
www.airglass.se
www.aerogel.com
w1.cabot-corp.com
www.cabot-corp.com/cws/Objects.nsf/objects/Nanogel_landing_page.html/$fi le/Nanogel_landing_page.html
www.kalwall.com
www.kalwall.com/nanogel.htm
www.stoakes.co.uk
www.scobalit.ch/en/index.php
www.scobalit.ch/en/scobatherm.html
www.acralight.com
www.acralight.com/nanogel.html
www.cptsystems.com
www.alcaud.fr/site/rubrique.php3?id_rubrique=112
www.duo-gard.com
www.supersky.com
www.wascoskylights.com
www.roda.de/welcome.php
www.xtralite.co.uk
www.pilkington.com
www.okalux.de
www.birdair.com
PROGETTISTI - STUDI DI ARCHITETTURA -PROGETTI
www.adpsr.org
www.arqchile.cl/modulos_habitables.htm
www.arq.utfsm.cl _Departamento de arquitectura de la Universidad Tecnica Federico Santa
Maria, Val Paraiso, Chile
www.architectureforhumanity.org
www.architetturatessile.polimi.it
www.bfi .org _ Richard Buckminster Fuller Institute
www.burohappold.com
www.cameronsinclair.com
www.concretecanvas.org.uk
www.coop-himmelblau.at
www.fabermaunsell.com

282
www.ftlstudio.com
www.future-systems.com
www.grunch.net/snelson
www.hoberman.com
www.homeandspace.org
www.itdg.org
www.kennethsnelson.net
//kierantimberlake.com/home/index.html
www.maki-and-associates.co.jp/e/index.shtml
www.noguchi.org
www.noxarch.com/
www.planning.org/25anniversary/infl uentials.htm
www.plataformaarquitectura.cl
www.shelterproject.org
www.strongangel.telascience.org
www.studiogang.net
www.tensinet.com _Associazione per lo studio interdisciplinare sulle tensostrutture
www.tilke-ac.de
www.under-construction.it
//worldshelters.org
TENDE - CONTAINER - CARRELLI
www.aerosekur.it
www.bertonitende.it
www.camp.it
www.edyprogetti.it
www.eurovinil.it
www.ferrino.it
www.gggele.it/pma.html
military.eurekatents.com
www.mschall.de
www.plastic-sheeting.org _download “Guidelines July 2007: Plastic sheeting 2007”
www.protezionecivile.ferrino.it
www.thenorthface.com
www.uniteamcontainer.com
ACCESSORI
www.kong.it _Sicurezza sul lavoro, accessori per soccorso alpino
www.brunnerinternational.com _Prodotti per attività outdoor
PROTEZIONE CIVILE
www.ispro.it _Istituto studi e ricerche sulla protezione e difesa civile
www.protezionecivile.it
www.protezionecivile.fvg.it
www.regione.vda.it/protezione_civile/default_i.asp
SANITÀ - ORGANIZZAZIONI UMANITARIE
www.118er.it _8 Emilia Romagna con manuali e normativa di riferimento
www.cri.it _Croce Rossa Italiana
www.doctorswithoutborders.org
www.icrc.org _International Committee of the Red Cross
www.ifrc.org _International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
www.mfs.org _Medici Senza Frontiere
www.nsis.ministerosalute.it _Linee guida per l’emergenza del ministero della salute
www.oxfam.org _confederazione internazionale di 13 organizzazioni umanitarie non

283
governative
//orgmail2.coe-dmha.org/dr/fl ash.htm _book online su disaster response, principle of preparation and
coordination
www.redr.org _Croce Rossa Inglese
www.sanita.segreteria.sm _CEMEC - Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi
www.sphereproject.org _È possibile scaricare il manuale “Humanitarian Charter and minimum
Standards in Disaster Response”
www.unhcr.org _Alto Commissariato ONU per i Rifugiati
www.usaid.gov _United State Agency for International Development
www.who.int _Organizzazione mondiale della sanità


R I N G R A Z I A M E N T I


287
I primi ringraziamenti vanno a tutti coloro che mi hanno aiutato durante questa avventura e senza i quali probabilmente non sarei mai
riuscita a sapere tutte le cose che mi sarebbero servite per il progetto:
la dottoressa Anna Poggi, sempre disponibile ad ogni mia richiesta
il colonnello Luigi Ziani, fonte di inesauribili informazioni
Giorgio Visintini della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Franco Picilli e Arrigo Natolini della sezione di Majano
il dottor Perraro, il primo che mi ha dato informazioni sulle emergenze sanitarie
il dottor Roberto Peressutti, per le fonti bibliografi che e non
Marco Villettaz, dell’uffi cio pianifi cazione e progettazione emergenza della protezione civile della Valle d’Aosta, che non ho mai
conosciuto di persona ma che mi ha mandato in tempi rapidissimi tutte le informazioni tecniche e le fotografi e del modulo di soccorso
elitrasportato M.A.P.I. H
l’Eurovinil e Umberto Zanobi per tutte le informazioni sui loro prodotti
Alessandro Aita e Christian Purdel per tutte le preziose informazione sull’aereogel e sul settore aeronautico
Francesco Sicchiero, grande amico, sempre disponibile e che senza di lui probabilmente non avrei mai conosciuto alcune delle persone
sopra citate.
il primo ringraziamento non tecnico è per mantenere una promessa fatta:
alla mia mamma...che quando ho cominciato la scuola materna pensava che non avrei mai potuto fi nire i tre anni previsti (in effetti uno
l’ho evitato grazie ad azioni di sabotaggio); che quando ho iniziato la scuola elementare pensava non sarei mai riuscita ad imparare a
leggere e scrivere; che quando ho iniziato la scuola media pensava, non si sa per quale motivo, non avrei mai studiato il dovuto; che
quando ho deciso di andare al Marinelli pensava che non ce l’avrei mai fatta; che quando ho deciso di andare a Milano si è rivolta a
tutti i santi disponibili, ma che dopo la prima laurea gli è sorto qualche dubbio.
A mia mamma che quando ho deciso di cambiare rotta e tornare a Udine mi ha sostenuto, anche se sapeva che quella scelta era
forse la più diffi cile che avessi mai preso.
Alla mia mamma che in realtà, sotto sotto, mi ha sempre spinto a seguire le mie passioni e a perseguire quello che desideravo.
Un grazie a papà (alla fi ne ce l’hai fatta a farmi laureare in Architettura!) per il sostegno e la sua preziosa esperienza, a Sabry per i
messaggi “incoraggianti” lasciati durante le visite a casa, naturalmente grazie a Luca per il supporto su tutti i fronti e per il fatto di essere
l’unico che ha letto e che probabilmente leggerà la tesi dall’inizio alla fi ne.
Un grazie ai nonni, perchè mi hanno insegnato tutte quelle cose che nessuna università potrà mai insegnare.
Infi ne gli amici, quelli di una vita, Alessia e Michele, quelli milanesi, la Ke, Carlo ed Ettore che sono stati per tre anni la mia seconda
famiglia (e un pò, sebbene la lontananza, lo sono ancora) , quelli udinesi, Alessia, Dario, Emanuele, Erica e Alessandro che nell’ultimo
anno hanno condiviso con me gioie e dolori univeristari.