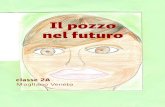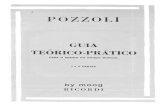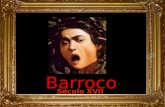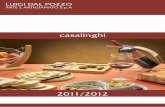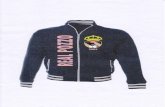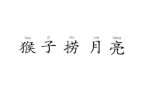Pozzo
description
Transcript of Pozzo

Riccardo Pozzo
L’ontologia nei manuali di metafisica della Aufklärung
Nel seguito vorrei proporre una ricostruzione del problema di come declinare intermini intellegibili agli studenti delle università tedesche nell’epoca dellaAufklärung l’esposizione della scienza dell’essere in quanto essere (Metaph., IV,1, 1002b21). Per questa ragione ho scelto di occuparmi solo di manuali, ossia discritti esplicitamente destinati a corsi di metafisica, e ciò, permettetemi di es-sere ancora più preciso, in ottemperanza agli statuti delle rispettive università.Tra un paragrafo introduttivo e uno conclusivo, mi occuperò delle tre fasi nellequali si suole periodizzare la filosofia del diciottesimo secolo nell’area di cultu-ra tedesca: Früh-, Hoch- e Spätaufklärung, la prima dall’inizio fino agli anniTrenta, la seconda a cavallo della metà del secolo e la terza tra gli anni Settan-ta e la fine del secolo.
1. Status quaestionis
Come punto d’arrivo di questo contributo mi sono proposto la definizione for-mulata nel 1894 da Karl Frick per il volume Ontologia del Cursus philosophicusin usum scholarum dei gesuiti: «scientia rerum, prout sub rationibus maxime ab-stractis et communissimis exhibentur»1. Si dice scienza, spiega il padre Frick,poiché è conoscenza per cause, e scienza delle cose, poiché «obiectum est ensreale» e poiché in essa si considerano solo le ragioni che per massima astrazio-ne sono comuni a tutte le cose. Il compito dell’ontologia è dunque da una parteespandere, illustrare e confermare il valore oggettivo di queste rationes e dal-l’altra costituire, dichiarare, emanare i principi primi che emanano da esse2.
1 K. FRICK, S.J., Ontologia sive metaphysica generalis [Herder, Friburgi Brisgoviae 1894], Herder,Freiburg 19292 («Cursus philosophicus in usum scholarum», 2), p. 1.
2 FRICK., Ontologia cit., p. 1.
«Quaestio», 9 (2009), 285-301 • 10.1484/J.QUAESTIO.1.100707

286 Riccardo Pozzo
Trentatre anni prima di Sein und Zeit, Frick tentava ancora di tenere sotto con-trollo quelle che saranno le questioni poste dall’ontologia fondamentale specifi-cando che, appunto,
«istae vero rationes communes non considerantur subiective, i.e. prout sunt actusmentis (conceptus subiectivi), sed obiective, i.e. illud ipsum, quod continent (con-ceptus obiectivi), nimirum rationes obiectivae seu realitates precisione mentis a rebusabstractae»3.
Il controllo non riuscì, come sappiamo, ma questo è un altro discorso. Eppu-re, e questo è il filo conduttore del mio intervento, la concezione epistemologi-ca dell’ontologia, secondo la quale, appunto e contrariamente a quanto auspica-to dal padre Frick, i concetti comuni dell’ontologia avrebbero avuto relazionecon gli atti della mente aveva invece una tradizione di tutto rispetto che risaleall’illuminismo e agli autori dei quali sto per trattare.
Come ho detto, mi limito alla considerazione di un genere letterario che va-le anche per il libro filosofico: il manuale. Notava Hans-Georg Gadamer rifa-cendosi a Friedrich Schleiermacher che così come la parola appartiene al con-testo della frase, «così il singolo testo appartiene all’unità dell’opera di un auto-re, e questa opera appartiene a sua volta all’insieme del genere letterario o al-l’insieme della letteratura»4. Parlerò, dunque, solo di testi pensati ad usum au-ditorum. Si tratta di un approccio limitato, ma universitaria è la ricezione dellafilosofia di Aristotele, ben più di quella accademica di Platone5, e ciò vale an-cora di più per la stessa Aufklärung, se solo la si confronta con il nostro Illumi-nismo, lo Enlightenment, le Lumières e la Ilustración6. Le ricerche sui manualidi ambito tedesco sono state condotte da Max Wundt, che nelle sue ricerche sul-la “metafisica di scuola tedesca del diciassettesimo secolo” per primo ha men-zionato il corso manoscritto di metafisica tenuto da Cornelius Martini a Helm-stedt dal 1597 al 1599, che divenne poi la base di una versione apocrifa appar-sa a Strasburgo e poi di una seconda, licenziata questa volta dall’autore, a Jena.Ponendosi il problema dell’assenza della metafisica in Philipp Melanchthon ein Jacopo Zabarella e confrontandosi con l’addirittura derisoria considerazione
3 FRICK, Ontologia cit., p. 1.4 H.-G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Mohr, Tübingen 1972, 19601, p. 296; tr. it. Verità e meto-
do, a cura di G. Vattimo, Bompiani, Milano 2000, p. 603.5 C. SCHMITT, Platon et Aristote dans les universités et les collèges du XVIe siècle: l’introduction de la
philosophie platoni cienne dans l’enseignement des universités à la Renais sance, in J.C. MARGOLIN (éd.), XVIe
Colloque international de Tours. Platon et Aristote à la Renaissance, Vrin, Paris 1976 («Publications duCentre d’études supérieures de la Renaissance», 16), pp. 93-104.
6 N. HAMMERSTEIN, Die deutschen Universitäten im Zeitalter der Aufklärung, «Zeitschrift für histori-sche Forschung», 10 (1983), pp. 73-89.

L’ontologia nei manuali di metafisica della Aufklärung 287
di Pierre de la Ramée («Quatuordecim metaphysicos libros, quatuordecim logi-carum tautologiarum cumulos esse statuo [...] quaeraturque utrum tota Aristote-lis metaphysica nil aliud sit, quam logica logicis plurimis et theologicis quibu-sdam sophismatis obscurata: Id enim est, quod praecipue disserendum, demon-strandumque mihi proposui»7), Martini era il primo a dare una risposta alla do-manda di come rispondere alla ricezione di Aristotele da parte di Francisco Suá-rez nelle università protestanti, di come scrivere, come ho indicato nel titolo, unmanuale per l’insegnamento dei quattordici libri della Metaphysica senza farealcun riferimento alla prima scolastica e solo il minimo indispensabile alla se-conda scolastica8.
Sempre a Wundt va ascritto il merito di aver per primo trattato estesamentela “filosofia di scuola tedesca nell’epoca dell’illuminismo” trattando tutti i ma-nuali dei quali sto per trattare e molti di più, cercando esaustività geografica ecronologica9. Dal punto di vista lessicologico, vanno segnalate le liste di dizio-nari disciplinari preparate da Giorgio Tonelli (e aggiornate da Eugenio Canonee Margherita Palumbo) come pure il progetto coordinato dallo stesso Canone vol-to a presentare in un grande ipertesto non solo la versione elettronica del reper-torio tonelliano ma anche un gran numero dei testi stessi10.
2. Frühaufklärung
Nel suo prezioso Lessico filosofico della Frühaufklärung, Dagmar von Wille hamostrato come, di fatto, Christian Thomasius trascurò del tutto la disciplina11.Anche Johann Franz Budde, negli Elementa philosophiae theoreticae (che pure
7 P. DE LA RAMÉE, Scholae in liberales artes, ed. W.J. Ong, Olms, Hildesheim 1970, 15691, fol. Nn2r.8 C. MARTINI, Compendium metaphysicum ad libros Metaphysicorum archiphilosophi Aristotelis alio-
rumque Metaphysicorum commentaria rectius cognoscenda: traditum in illustri Julia, Ms. Herzog AugustBibliothek Wolfenbüttel 52.4 Aug. fol. (1); ID., Metaphysica commentatio, a cura di Thrasibulus Phila-lethes [= Caspar Bartholinus], Carolus, Strasbourg 1604; ID., Metaphysica brevibus quidem, sed methodi-ce conscripta, Beithmann, Jena 1622. Cf. M. WUNDT, Die deutsche Schulmetaphysik des 17. Jahrhunderts,Olms, Hildesheim 1992, 19391 («Heidelberger Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte»,29), 59; R. POZZO, Petrus Ramus’ metaphysics and its criticism by the Helmstedt Aristotelians, in M. FEIN-GOLD / J.S. FREEDMAN / W. ROTHER (Hrsgg.), The influence of Petrus Ramus. Studies in sixteenth and se-venteenth century philosophy and sciences, Schwabe, Basel 2001 («Schwabe Philosophica», 1), pp. 92-106.
9 M. WUNDT, Die deutsche Schulphilosophie im Zeitalter der Aufklärung, Olms, Hildesheim 1992,19441 («Heidelberger Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte», 32).
10 G. TONELLI, A short-title list of subject dictionaries of the sixteenth, seventeenth and eighteenth cen-turies, a cura di E. Canone e M. Palumbo, Olschki, Firenze 2006, 19701 («Lessico intellettuale Europeo»,102). Per l’ipertesto, Cf. www.iliesi.cnr.it
11 D. V. WILLE, Lessico filosofico della Frühaufklärung. Christian Thomasius, Christian Wolff, JohannGeorg Walch, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1991 («Lessico intellettuale Europeo», 54), p. 133.

288 Riccardo Pozzo
contengono una metafisica), seguiva John Locke nell’escludere l’ontologia e con-siderava invece le res ipsae solo secondo il punto di vista della descrizione lin-guistica che ne possiamo dare12. Budde si limitava a proporre una trattazione diDio e una delle res naturales, dunque partendo da Dio e arrivando alle creature,dalla teologia alla fisica e alla psicologia13. Va però anche ricordato che la posi-zione degli aristotelici protestanti, una ramificazione della seconda scolastica,era viva e vegeta in molte università. Nel Cursus philosophicus del professore or-dinario di logica e metafisica all’Alma Albertina, Paul Rabe, il soggetto dell’on-tologia era detto essere l’«ens qua ens» e l’ontologia scienza universale, «qua ensin universali consideret»14. Anticartesiano quanto Giambattista Vico e suo con-temporaneo, Rabe notava come i neoteroi, «in primis [...] novarum scientiarumfabricatores», abbiano aggiunto le seguenti discipline «ontologia, noologia, gno-stologia et pneumatologia et has omnes a metaphysica distincte esse dictam». Laquale metafisica invece si occupa per Rabe propriamente di Dio come l’esserepiù alto15.
Chi diede una finale sistemazione alla riformulazione della metafisica dopole sperimentazioni dei secoli sedicesimo e diciassettesimo fu Christian Wolff,che ravvivò la metafisica aristotelico-scolastica nel quadro, come notò già G.W.F.Hegel, delle due tradizioni dell’empirismo di Francis Bacon e John Locke e delrazionalismo di René Descartes e Gottfried Leibniz16. Si deve a Wolff la siste-mazione, rimasta nell’insegnamento comune, dell’ontologia come introduzionegenerale alla cosmologia, alla psicologia e alla teologia naturale. Nella DeutscheLogik, Wolff ricorda come la parte della filosofia «nella quale viene trattata laconoscenza universale delle cose si chiami ontologia o scienza fondamentale [dieOntologie oder Grund-Wissenschaft]. La scienza fondamentale, la dottrina deglispiriti e la teologia naturale sono le parti che costituiscono la metafisica ovverola scienza capitale [die Metaphysick oder Haupt-Wissenschaft]»17. Nell’ontologiawolffiana vengono mantenuti i principi generali della metafisica aristotelica,
12 J.F. BUDDE, Elementa philosophiae theoreticae: seu institutiones philosophiae eclecticae tomus se-cundus, Waisenhaus, Halle 1703. Cf. M. ALBRECHT, Eklektik. Eine Begriffsgeschichte mit Hinweisen aufdie Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1994(«Quaestiones», 5), p. 447.
13 WUNDT, Die deutsche Schulphilosophie cit., p. 69.14 P. RABE, Cursus philosophicus: sive compendium praecipuarum scientiarum philosophicarum, Boye,
Königsberg 1703, § 28, p. 1205.15 RABE, Cursus philosophicus cit., § 28, p. 1205.16 G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Philosophie des Mittelalters und der
Neuzeit, hrsg. v. P. Garniron / W. Jaeschke, Meiner, Hamburg 1986 («Vorlesungen», 9), pp. 72, 116, 136.17 CH. WOLFF, Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen
Gebrauche in Erkenntnis der Wahrheit, hrsg. v. H.W. Arndt, Olms, Hildesheim-New York 1978, 17131
(«Gesammelte Werke», I/1), p. 119; tr. it. Logica tedesca, a cura di R. Ciafardone, Patron, Padova 1978,p. 100. Cf. V. WILLE, Lessico filosofico della Frühaufklärung cit., p. 133.

L’ontologia nei manuali di metafisica della Aufklärung 289
l’essenza e la sostanza, le proprietà essenziali di una cosa distinte dagli acci-denti mutevoli e specialmente l’esistenza, in quanto principio di omnimoda de-terminatio. Nella Deutsche Metaphysik, Wolff rinunciava dunque a usare il ter-mine greco-latino di ‘ontologia’, usando al suo posto il sintagma «primi principidella nostra conoscenza e tutti gli enti in generale» [Von den ersten Grundsätzenunserer Erkäntniß und allen Dingen überhaupt]. Sintagma che va tradotto comecongiunzione, non come genitivo, poiché i primi principi della nostra conoscen-za non sono gli stessi delle cose. Vi sono principi della conoscenza e principidelle cose: i primi sono specificamente il principio di contraddizione e di ragionsufficiente18, i secondi spaziano dall’essenza fino ai gradi di perfezione19.
Debordante, invece, l’uso del termine e della definizione aristotelica nellaversione latina, la Philosophia prima: sive ontologia: «Ontologia seu Philosophiaprima est scientia entis in genere, seu quatenus ens est»20, nella quale Wolff ri-prende il neologismo di Jakob Lorhard ripreso da Rudolph Goclenius, quest’ul-timo non a caso predecessore di Wolff all’Alma Philippina di Marburgo21. Ma sitratta di un lessico autenticamente scolastico-cartesiano, per dirla con ÉtienneGilson22. Con Descartes, ha ricordato Jean École, si opera una profonda trasfor-mazione che si traduce in una riduzione e al contempo in un ampliamento deldominio della metafisica aristotelica. Da una parte Descartes escludeva quasitutta l’ontologia, a eccezione di qualche briciola nella prima parte dei Principiaphilosophiae, dall’altra introduceva la psicologia a fianco della teologia, come sivede dalle dimostrazioni affiancate dell’immortalità di Dio e dell’anima nelleMeditationes de prima philosophia23.
Nelle primissime righe della Deutsche Metaphysik, Wolff sceglieva il se-guente incipit: «Siamo coscienti di noi e di altre cose, del che non può dubitarenessuno che non sia completamente privato dei propri sensi, ovvero folle [...].Ora, però, chi è cosciente di ciò che nega o di cui dubita è la medesima perso-na. E quindi è chiaro che noi siamo»24. Sono d’accordo con Pietro Kobau quan-
18 CH. WOLFF, Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Mensche: auch allen Dingenüberhaupt, hrsg. v. C.A. Corr, Olms, Hildesheim-New York 1983, 17191 («Gesammelte Werke», I/2»);trad. it. Metafisica tedesca, a cura di R. Ciafardone, Bompiani, Milano 2003, § 10-32, pp. 60-81.
19 WOLFF, Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen cit., § 33-191, pp. 81-183. 20 CH. WOLFF, Philosophia prima: sive ontologia: methodo scientifica pertractata: qua omnis cognitio-
nis humanae principia continentur, ed. J. École, G. Olms, Hildesheim-New York 1977, 17281 («Gesam-melte Werke», II/2), § 1, p. 1.
21 M. LAMANNA, Sulla prima occorrenza del termine ‘Ontologia’, «Quaestio», 6 (2006), p. 568. 22 É. GILSON, Index scolastico-cartésien, Vrin, Paris 1979, 19131.23 J. ÉCOLE, Des différentes parties de la métaphysique selon Wolff, in W. SCHNEIDERS (Hrsg.), Christian
Wolff: 1679-1754. Interpretationen zu seiner Philosophie und deren Wirkung, Meiner, Hamburg 1986(«Studien zum achtzehnten Jahrhundert», 4), pp. 121-128, qui 122.
24 WOLFF, Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, tr. it. cit., § 1, pp. 60-61.

290 Riccardo Pozzo
do sostiene che l’argomentazione preontologica di Wolff appartenga «fin dalprincipio a una psicologia metafisica costituita su basi osservative» e che l’in-tera sua ontologia venga poi a costituirsi come «una teoria delle categorie som-mamente generali del possibile, ovvero del reale, in quanto il reale vi è intesoinnanzitutto come concepibile e significabile – e questo, di nuovo sulla base diuna psicologia metafisica costituita osservativamente»25. Wolff recepiva la ria-bilitazione dell’ontologia voluta da postcartesiani come Johannes Clauberg eJean-Baptiste du Hamel26. La filosofia wolffiana, ha osservato Luigi Cataldi Ma-donna, «è tutt’altro che deduttivismo estremo, né il metodo di Wolff è identifi-cabile con il procedimento sintetico, ma si serve in uguale misura anche di quel-lo analitico»27. C’è da chiedersi se ciò che vale per tutte le scienze del sistemawolffiano valga anche per l’ontologia. Cataldi Madonna non si stanca di ripete-re che, per Wolff, «i principi delle scienze non sono stabiliti a priori, attraversomere operazioni intellettuali, ma sono acquisiti attraverso una vera e propria ri-cerca guidata dall’intelletto e dalla ragione, il primo capace di rappresentarsi di-stintamente qualcosa, l’altra capace di vederne la connessione con il complessodelle verità già note»28. Olivier-Pierre Rudolph non ha esitato a parlare di “coe-rentismo” nella concezione wolffiana dell’ordine costitutivo di un contesto espe-rienziale. Secondo Wolff, appunto, l’ordo è «similitudo obvia in modo, quo resjuxta se invicem collocantur, vel se invicem consequuntur»29. Wolff si distingueda Descartes in quanto Descartes si presenta come difensore di una filosofia fon-data in ultima analisi sulla combinazione, appunto, della fondazione ontologicacon una concezione coerentistica del sapere30, posizione, questa, che BoguslawPaz ha efficacemente ricostruito ritrascrivendola (in terminologia contempora-nea) in quanto “verità epistemologica”. In altre parole: per decidere della veritàdi una proposizione dobbiamo prima avere perspicua l’essenza della cosa sullaquale viene espresso il giudizio31. Come dice Wolff, «et horologii essentiam per-spicimus, dum ejus structuram perspectam habemus»32.
25 P. KOBAU, Essere e qualcosa: ontologia e psicologia in Wolff, Trauben, Torino 2004 («Laboratorio diontologia»), pp. 27-28.
26 ÉCOLE, Des différentes parties de la métaphysique selon Wolff cit., p. 122. 27 L. CATALDI MADONNA, Christian Wolff und das System des klassischen Rationalismus, G. Olms, Hil-
desheim-Zürich-New York 2001 («Wolff Gesammelte Werke», III/62), p. 19.28 CATALDI MADONNA, Christian Wolff cit., p. 19.29 WOLFF, Philosophia prima cit., § 472, p. 360.30 O.-P. RUDOLPH, Das Fundament des Wolffschen Systems der Philosophie, in J. STOLZENBERG / O.-P.
RUDOLPH (Hrsgg.), Christian Wolff und die europäische Aufklärung, G. Olms, Hildesheim-Zürich-NewYork 2007 («Wolffiana», II/2), vol. 2, pp. 15-24, qui p. 23.
31 B. PAZ, Methode und Wahrheit bei Wolff, in STOLZENBERG / RUDOLPH (Hrsgg.), Christian Wolff unddie europäische Aufklärung cit., vol. 2, pp. 259-272, qui p. 268.
32 WOLFF, Philosophia prima cit., § 155, p. 127.

L’ontologia nei manuali di metafisica della Aufklärung 291
Chiude questa prima fase di introduzione dell’ontologia il bilancio dato daJohann Georg Walch sub voce nel Philosophisches Lexikon:
«la dottrina dell’ente [die Lehre vom Ente], ed è una denominazione con cui alcuni nuo-vi metafisici connotano la metafisica, intendendo la scienza che tratta dell’ente in ge-nerale e delle sue proprietà [diejenige Wissenschafft, die vom Ente überhaupt und des-sen Eigenschafften handelt] [...]. In tempi recenti ci si è limitati a questa dottrina, men-tre la dottrina degli spiriti fu assegnata a una nuova disciplina che ricevette il nomedi pneumatica; a ogni modo, ad alcuni il titolo di ontologia [Ontologie] piacque più diquello di metafisica»33.
L’ontologia è diventata di casa nelle università della Aufklärung.
3. Hochaufklärung
La Deutsche Metaphysik di Wolff venne adottata per corsi a Königsberg da Hein-rich Oelmann già nel Sommersemester 1720, nel Sommersemester 1722, nel Win-tersemester 1722/23, nel Sommersemester 1723, nel Wintersemester 1723/24, nelSommersemester 1724, nel Wintersemester 1724/25, da Georg Friedrich Rogallnel Wintersemester 1726/27, nel Sommersemester 1727 e da Konrad GottliebMarquardt nel Sommersemester 173634. A mia conoscenza, nessuna traccia diannunci di corsi che indichino l’adozione della Philosophia prima di Wolff nel-l’epoca della Aufklärung, ma non si trattava, in effetti, di un manuale destinatoalle lezioni universitarie.
Quando Kant studiò metafisica, durante il secondo anno, come richiesto al-l’Alma Albertina, seguì con tutta probabilità il corso tenuto nel Sommersemester1740 da Johann David Kypke, «ex praescripto, Ontologiam, Cosmologiam, Psy-chologiam et Theol. Naturalem in compendio publice»35. Negli annunci dei cor-si metafisici degli anni precedenti, Kypke non aveva indicato nessun manuale.Ma la formula dell’annuncio del corso seguito da Kant lascia riconoscere la ma-trice wolffiana e più precisamente il titolo e il sottotitolo del manuale di Frie-drich Christian Baumeister, le Institutiones metaphysicae: ontologiam, cosmolo-giam, psychologiam, theologiam denique naturalem complexae. Infatti, un anno
33 J.G. WALCH, Philosophisches Lexikon, Olms, Hildesheim 1968, 17261, sub voce, p. 1926. Cf. V. WIL-LE, Lessico filosofico della Frühaufklärung cit., p. 133; KOBAU, Essere e qualcosa cit., p. 13.
34 Vorlesungsverzeichnisse der Universität Königsberg (1720-1804), hrsg. v. M. Oberhausen / R. Poz-zo, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1999 («Forschungen und Materialien zur Universitäts-geschichte,» I/1), pp. 11, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 44, 47, 101, 777.
35 Vorlesungsverzeichnisse der Universität Königsberg cit., p. 124.

292 Riccardo Pozzo
dopo, nel Sommersemester 1741, Kypke menzionava per intero il compendio disua scelta: «ad ductum Institutionum Metaphysicarum celeb. Baumeisteri, pu-blice»36. Apparse nel 1735, le Institutiones metaphysicae presentano il duplicevantaggio di essere wolffiane e di essere in latino37. Lo stesso Kant le usò per icorsi di metafisica che tenne nel Sommersemester 1757 e nel Sommersemester175838. Per Baumeister, l’ontologia è la disciplina che
«generalissimos conceptus et notiones distincte explicet, in quo autem conceptu om-nia conveniunt, quod entia sint, eum tractandi ontologiam trine observabimus, ut prae-structis primis omnium veritatum principiis, ab entis conceptu generaliori primordiacapiamus, ex eo communissimas et generalissimas positiones deducturi»39.
L’ontologia svolge un ruolo di primo piano nei Praecognita ex ontologia, psy-chologia et theologia naturali preposti al manuale di diritto di un filosofo di Hal-le assai poco noto, Martin Heinrich Otto, morto a soli trentadue anni nel 1738,nel ruolo di professore straordinario all’Academia Fridericiana, dove ebbe comecollega Alexander Gottlieb Baumgarten e fu maestro di Georg Friedrich Meier.Degna di nota è la considerazione dell’ontologia dal punto di vista pratico oltreche teoretico, che Otto dichiara essere indispensabile agli studenti di legge:
«Consilium erat Ius Naturae et Gentium in iuvenem studiosorum usum conscribendi,et cum santissima illa disciplina non sine principiis, ex Metaphysica desumptis, com-poni possit; aut ipsi praemittenda in uno conice, aut peculiari libro comprehendenda,aut aliorum systemata citanda erant. Primum et ultimum non commodum satis et con-veniens videbatur: ergo medium elegi. Continet nempe hocce opusculum necessariaex metaphysica et doctrina rationali principia, ita, ut ille, qui ea evolvit, iuris naturaepraecepta complete possit demonstrare»40.
Un anno dopo le Institutiones di Baumeister usciva la Metaphysica di Baum-garten, anch’essa adottata da Kant, questa volta per decenni e decenni di fila.L’ontologia è per Baumgarten metaphysica universalis e indaga i predicati uni-
36 Vorlesungsverzeichnisse der Universität Königsberg cit., pp. 130-131.37 F.C. BAUMEISTER, Institutiones metaphysicae: ontologiam, cosmologiam, psychologiam, theologiam
denique naturalem complexae, Olms, Hildesheim-New York 1988, 17381 («Wolff Gesammelte Werke»,III/25).
38 E. ARNOLD, Charakteristik von Kants Vorlesungen über Metaphysik und möglichst vollständiges Ver-zeichniss aller von ihm gehaltener oder auch nur gehaltenen Vorlesungen, in ID., Kritische Exkurse im Ge-biet der Kant-Forschung, hrsg. v. O. Schöndörffer, Cassirer, Berlin 1909 («Gesammelte Schriften», 5), pp.3-324, qui: pp. 183-187.
39 BAUMEISTER, Institutiones metaphysicae cit., § 8, pp. 8-9.40 M.C. OTTO, Iuris divini caeterarumque erudtionis practicae disciplinarum praecognita ex ontologia,
psychologia et theologia naturali, Renger, Halle 17382, 17371, fol. 4r.

L’ontologia nei manuali di metafisica della Aufklärung 293
versali dello ens, distinti tra predicati interni ed esterni. Muovendo dal nihil,Baumgarten deriva attraverso il principio di non contraddizione le nozioni di ali-quid e possibile. Introdotto il principio di ragion sufficiente, Baumgarten enucleale affectiones entis, i modi e gli attributa per giungere alla definizione di ente inquanto existentia, ossia in quanto un possibile da determinare. Attraverso il prin-cipium rationati, l’esistenza diviene substantia e la sostanza monas41.
Nel 1766, quattro anni dopo la morte del suo maestro Baumgarten, Meier tra-dusse in tedesco la Metaphysica, ma prima ne compose una più ampia versionein tedesco pubblicata a suo nome benché sulla base dei dictata di Baumgarten,come Meier candidamente dichiarava nella prefazione. Come già indicato dalsuo maestro Otto, l’obiettivo di Meier è «trattare i concetti della metafisica chesono utili e pratici [die brauchbaren und practischen Begriffe der Metaphysik] inun modo tale che non solo siano fertili e fondati, ma comprensibili e intelligibi-li per chiunque voglia conoscere la natura di questa scienza»42. Specialmente,l’ontologia è utile in quanto contiene i lineamenti della teoria della conoscenza.In altre parole, Meier interpreta la metafisica epistemologicamente. All’ontolo-gia spetta la mediazione tra scientiae sermocinales e scientiae reales. La cono-scenza umana è capace «di una certezza piena» e infatti devono esserci «prin-cipi o verità fondamentali siffatti [...], che sono i primi principi di tutta la cono-scenza umana»43. Persino gli scettici devono ammettere, «che vi sono molti con-cetti e giudizi che nel genere umano sono accettati come ragioni sulle quali sifonda la più piena convinzione»44. Si tratta insomma di usare l’ontologia senzapregiudizi, e qui Meier va ben al di là di Locke e sostiene tesi che né Wolff néBaumgarten avevano formulato. Bisogna infatti distinguere tra una «vera» e «ge-nuina» metafisica e le sue forme degenerate. Dove la ächte Metaphysik è certa-mente ancora quella di Wolff e dunque è «una conoscenza distinta sulla base diragioni certe e indistruttibili»45, che appunto merita il nome di scienza e devepoter «dimostrare nel modo più fondato fintanto che lo permettono i limiti del-l’intelletto umano [so weit es die Schranken des menschlichen Verstandes zulas-sen]»46.
41 A.G. BAUMGARTEN, Metaphysica, Olms, Hildesheim-New York 1982, 17391; tr. ted. Metaphysik, hrsg. v. G.F. Meier, Hemmerde, Halle 1766. Cf. M. CASULA, La metafisica di A.G. Baumgarten, Mursia,Milano 1973 («Studi di filosofia», 5).
42 G.F. MEIER, Metaphysik, Olms, Hildesheim-Zürich-New York 2007, 17551 («Wolff GesammelteWerke», III/108.1), fol. 2v. Cf. R. POZZO, Georg Friedrich Meiers «Vernunftlehre». Eine historisch-syste-matische Untersuchung, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2000 («Forschungen und Mate-rialien zur deutschen Aufklärung», II/5), pp. 159-161.
43 MEIER, Metaphysik cit., § 1, p. 2.44 MEIER, Metaphysik cit., § 1, p. 3.45 MEIER, Metaphysik cit., § 4, p. 7.46 MEIER, Metaphysik cit., § 3, p. 6.

294 Riccardo Pozzo
Meier si mostra in ogni caso molto vicino al Condillac del Traité des systèmesdel 1749, che distingueva i «veri» sistemi fondati sull’esperienza dai sistemi«astratti» fondati su principi e ipotesi47. L’esprit de système corrisponde al «gra-ve errore» di chi
«volesse accettare nella metafisica qualcosa che non si potrebbe spiegare; se qualcunosupponesse qualcosa e lo volesse senza ragione alcuna accettare o respingere; se qual-cuno volesse contentarsi di mere e filosofiche opinioni e così dimostrare in modo schiet-to che in tal modo nessuna certezza piena e matematica ne potrebbe esser prodotta»48.
L’esprit systématique, invece, è ciò che solo può fare della metafisica la verae genuina scienza
«di Dio, del mondo, dell’anima umana e delle cose in generale [...]. Infatti, tutte le no-stre conoscenze nelle arti e nella vita comune ci rappresentano o cose che riguardanoDio, il mondo, l’anima o le cose in generale, al di là di queste l’essere umano non puòpensare nulla correttamente. I concetti corretti di Dio, del mondo, dell’anima e dellecose in generale comprendono pertanto tra di loro ciò che noi esseri umani possiamopensare e sono pertanto i primi fondamenti di tutte le conoscenze umane. Di conse-guenza è identico se diciamo che la metafisica è una scienza che contiene i primi fon-damenti della conoscenza umana o se diciamo che è una scienza che tratta di Dio, delmondo, dell’anima e delle cose in generale. Con che presunzione si potrebbe infattirimproverare la ragione, quando essa si occupa di cose tanto eminenti?»49.
Sempre dibattuta è la questione dello sviluppo di Meier verso lo scetticismonei Beyträge zu der Lehre der Vorurteile des menschlichen Geschlechts, del 1766,nei quali in effetti Meier parla del «pregiudizio fondamentale della conoscenzarazionale [Grundvorurteil der Vernunfterkenntis]»50, conseguenza di un uso sur-rettizio della conoscenza probabile e più che mai si applica all’ontologia51, mache risulta bilanciato dal «pregiudizio fondamentale della conoscenza empirica[Grundvorurteil der Erfahrungserkenntnis]»52, altrettanto gravoso, visto che laconoscenza sensibile è la più esposta ai pregiudizi53. Ho ipotizzato che il corso
47 E. BONNOT DE CONDILLAC, Traité des systèmes, éd. par G. Le Roy, PUF, Paris 1947, 17491 («Oeuvresphilosophiques», 1); tr. it. Trattato dei sistemi, a cura di M. Garin, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 6.
48 MEIER, Metaphysik cit., § 4, p. 7.49 MEIER, Metaphysik cit., § 3, p. 6.50 G.F. MEIER, Contributi alla dottrina dei pregiudizi: edizione critica, a cura di H.P. Delfosse / N. Hin-
ske / P. Rumore, ETS, Pisa 2005 («Philosophica», 20), § 21, pp. 64-65. Cf. L. CATALDI MADONNA, La riabi-litazione dei pregiudizi. I Beyträge di G.F. Meier, «Studi Kantiani», 20 (2007), pp. 133-139.
51 MEIER, Contributi cit., § 23, p. 68-69.52 MEIER, Contributi cit., § 28, p. 80-81.53 MEIER, Contributi cit., § 37, p. 104-105.

L’ontologia nei manuali di metafisica della Aufklärung 295
tenuto da Meier a Halle nel Sommersemester 1754 sulla traduzione latina delloEssay upon Human Understanding di Locke54 abbia ulteriormente acuito il di-stacco dal razionalismo a favore della formulazione di una forma di scetticismoempirico55.
Resta da dire, per tornare ai precedenti posti da Thomasius e Budde chenemmeno consideravano l’ontologia, che anche Christian August Crusius re-stringeva drasticamente l’ontologia al solo ambito della realtà esperibile, facen-done dunque una teoria della conoscenza sensibile, peraltro assai scarna, vistoche rifiuta di individuare fondamenti conoscitivi a priori, riguardanti «perchéqualcosa è [warum was ist]» e si concentra su quelli a posteriori, ossia sul «chequalcosa è [daß etwas ist]»56. E lo stesso vale per Johann Heinrich Lambert, conla differenza che la teoria della conoscenza di Lambert è articolata addiritturasu quello che Paola Basso ha definito un algoritmo metafisico57. Ma anche nelcaso di Crusius e Lambert non si tratta di manuali destinati alle lezioni univer-sitarie.
4. Spätaufklärung
Nel tardo illuminismo primeggia l’influsso britannico, più specificamente scoz-zese, che ebbe grande influenza a Göttingen. Tra i risultati vi fu quella molto spe-cifica forma di eclettismo, sincretismo, indifferentismo ovvero scetticismo me-todico che è la filosofia di Johann Georg Heinrich Feder58. La cosa interessanteè che, nella generale apertura verso gli opposti, l’empirista lockiano tedesco ac-coglie in pieno l’ontologia wolffiana. Feder scriveva una Logik und Metaphysikche esce in prima edizione tedesca nel 177159 e poi in ottavo e in latino con il
54 G.F. MEIER, Zuschrift an seine Zuhörer, worin er ihnen seinen Entschluß bekannt macht, ein Colle-gium über Locks Versuch vom menschlichen Verstande zu halten, Hemmerde, Halle 1754; J. LOCKE, LibriIV de intellectu humano, transl. lat. ed. G.H. Thiele, Georg, Leipzig 1741. Cf. POZZO, Meiers «Vernunf-tlehre» cit., p. 106.
55 POZZO, Meiers «Vernunftlehre» cit., p. 174. 56 C.A. CRUSIUS, Entwurf der nothwendigen Vernunft-Wahrheiten, hrsg. v. G. Tonelli, Olms, Hildesheim
1970, 17451 («Philosophische Hauptwerke», 2), § 35, p. 100. Cf. G. TONELLI, Da Leibniz a Kant, a curadi C. Cesa, Guida, Napoli 1987 («La filosofia classica tedesca», 7), pp. 31-35.
57 P. BASSO, Filosofia e geometria. Lambert interprete di Euclide, La Nuova Italia, Firenze 1999 («Pub-blicazioni della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Milano», 183), p. 86.
58 L. MARINO, I maestri della Germania. Göttingen 1770-1820, Einaudi, Torino 1975 («Piccola Biblio-teca Einaudi», 250), pp. 161-181; tr. ted. Praeceptores Germaniae. Göttingen 1770-1820, Vandenhoeck &Ruprecht, Göttingen 1995 («Göttinger Universitätsschriften», A/10), pp. 169-187; M. KUEHN, ScottishCommon Sense in Germany. A contribution to the history of critical philosophy, McGill-Quinn’s UniversityPress, Kinsgton-Montreal 1987 («McGill-Quinn Studies in the History of Ideas»), p. 43.
59 J.G.H. FEDER, Logik und Metaphysik, Dieterich, Göttingen 1769.

296 Riccardo Pozzo
titolo di Institutiones logicae et metaphysicae nel 1777. Poco noto è forse che l’e-dizione del 1781 chiuda i prolegomeni alla metafisica (si noti: alla metafisica!)con un cenno a Kant e non poteva che trattarsi del Kant della Kritik der reinenVernunft: «Consulendi nobis in Metaphysicis praeter ipsum Aristotelem, eiu-sque aliquot Commentatores, videntur in primis Leibnitius, Wolf, Bilfinger,Baumgarten, Ploucquet, Crusius, Hollmann, Lambert, Kant»60. L’ontologia oc-cupa il primo capitolo della metafisica, in tutto venti paragrafi e si occupa del-la sostanza (con riferimento a Locke), delle monadi (con riferimento a Leibniz),di sostanze finite, infinite, necessarie e contigenti (con riferimento a Descartese Malebranche), di spazio, tempo e moto (con riferimento a Hutcheson, Bayle eWolff). Se si aggiungono i riferimenti polemici a Crusius, Hollmann, Helvetiuse Mendelssohn e il sincero apprezzamento di Aristotele (condiviso dal suo col-lega Christian Garve, che in quegli anni traduceva l’Ethica nicomachea61), l’im-pressione è di un eclettismo sine pari62.
Nella Vorlesung über philosophische Enzyklopädie rinvenuta e pubblicata nel1961 e datata attorno al 1775, Kant adotta il Grundriss der philosophischen Wis-senschaften di Feder63. Kant spiega che: «Gli oggetti che sono dati attraverso lamera ragione pura appartengono all’ontologia. Sono essi oggetti reali? No, sonoun mero pensiero. L’ontologia non contiene dunque alcun oggetto, ma solo con-cetti, leggi e principi del pensiero puro»64. Più avanti sostiene che le categoriesono i concetti che danno l’ipostasi dei giudizi della logica: «Quelli che in logi-ca sono giudizi nell’ontologia sono concetti sotto i quali noi portiamo le cose»65.
Del resto, nella De mundi sensibilis atque in telligibilis forma et principiis dis-sertatio pro loco, del 1770, Kant non ha difficoltà a scrivere di metafisica: «Phi-losophia autem prima continens principia usus intellectus puri est Meta -physica»66. Nella Dissertatio, l’intellectus purus ha una duplice pertinenza. Dauna parte esso infatti, come spiega Kant nei §§ 5 e 6, considera l’intuitum pu -rum, se riferito alla conoscenza sensibile, dall’altra l’idea pura, se riferito alla
60 J.G.H. FEDER, Institutiones logicae et metaphysicae, Dieterich, Göttingen 17812, 17771, Metaph. §3, p. 149.
61 C. GARVE, Die Ethik des Aristoteles übersetzt und erläutert, hrsg. v. K. Wölfel, Olms, Hildesheim1987, 17981 («Werke», III/1).
62 FEDER, Institutiones logicae et metaphysicae cit., § 4-24, p. 150-173. 63 J.G.H. FEDER, Grundriss der philosophischen Wissenschaften nebst der nöthigen Geschichte zum Ge-
brauch seiner Zuhörer, Findeisen, Coburg 1769. Cf. ARNOLD, Charakteristik von Kants Vorlesungen überMetaphysik cit., p. 240.
64 I. KANT, Vorlesungen VI: Ergänzungen, hrsg. v. G. Lehmann, de Gruyter, Berlin 1983 («Gesammel-te Schriften», 29, 1, 2), p. 12.
65 KANT, Vorlesungen VI: Ergänzungen cit., p. 37.66 I. KANT, De mundi sensibilis atque intelligibilis, in Vorkritische Schriften, hrsg. v. E. Adickes, de
Gruyter, Berlin 1905 («Gesammelte Schriften», 2), p. 395.

L’ontologia nei manuali di metafisica della Aufklärung 297
conoscenza intel lettuale67. Anche la ratio pura viene menzionata nella Disserta-tio, nel § 23, in quanto sede dei principi che stanno a fonda mento delle duescienze par excellence, la matematica e la metafisica. Kant speci fica che l’espo-sizione delle leggi della ragion pura costituisce la chiave per com prendere la ge -nesi di tutte le scienze: «expositio legum rationis purae est ipsa scientiae gene -sis, et earum a legibus suppo siticiis distinctio criterium veritatis»68.
Mi permetto di includere Kant tra gli autori di manuali di ontologia dellaAufklärung perché Kant di fatto un manuale di ontologia lo scrisse. Per esserepiù precisi: iniziò a scriverlo come manuale, ma ne cambiò la destinazione in iti-nere. Mi riferisco alla Kritik der reinen Vernunft. A supporto di questa ipotesi pos-so portare il sedicesimo intitolato Einleitung: Idee einer transzendentalen Logik(A50-64/B74-89), che per numero di pagine, tono protrettico-propedeutico edevidente allotria rispetto alle sezioni precedente e successiva del testo si lasciaidentificare come una Einladungsschrift, come un programma accademico, ungenere letterario che nel diciottesimo secolo i professori usavano per invitarestudenti a lezione utilizzando poche argomentazioni ma pungenti. La mia ipote-si è che Kant abbia preparato la Idee einer transzendentalen Logik all’inizio de-gli anni Settanta come programma per i corsi che avrebbe tenuto sulla sua logi-ca e sulla sua metafisica69, come richiesto dalle Methodologische Anweisungen,dalla guida dello studente, introdotte a Königsberg nel 1770, che prevedevano,appunto, che l’ordinario di logica (e Kant lo divenne proprio nel 1770) inse-gnasse la logica nel Wintersemester e la metafisica nel Sommersemester70. Era in-fatti uso (e veniva esplicitamente richiesto dal ministero) che gli ordinari di fre-sca nomina pubblicassero quanto prima un manuale sulle discipline di loro com-petenza.
67 KANT, De mundi sensibilis atque intelligibilis cit., p. 394. Nella Dissertatio, Kant ritiene ancora pos-sibile che l’intellectus purus abbia come oggetto la conoscenza sensibile, come si evince dal § 23, p. 410:«In omnibus scientiis, quarum principia intuitive dantur, vel per intuitum sensualem (experi entiam), velper intuitum sensitivum quidem, at purum (conceptus spatii, temporis et numeri), h. e. in scientia natura-li et mathesi, usus dat methodum». Come noto, questa posizione viene a cadere nell’Estetica trascenden-tale della Kritik der reinen Vernunft (A21/B36), tr. it., Critica della ragion pura, a cura di C. Esposito, Bom-piani, Milano, 20042, pp. 115-117, che Kant non per nulla definisce «una scienza di tutti a priori della sen-sibilità», nella quale, appunto, la sensibilità deve essere isolata dall’intelletto, «separando da essa tutto ciòche l’intelletto ne pensa con i suoi concetti, così che non resti altro se non l’intuizione empirica».
68 KANT, De mundi sensibilis atque intelligibilis cit., p. 411. Per una pregevole ricostruzione della di-stinzione tra intelletto e ragione nella Dissertatio e nelle Reflexionen dei primi anni Settanta rimando al-la dissertazione di M. J. VÁZQUEZ LOBEIRAS, Die Logik und ihr Spiegelbild. Das Verhältnis von formaler undtran szen dentaler Logik in Kants philosophischer Entwicklung, Lang, Frankfurt a.M.-Berlin-New York-Pa-ris-Wien 1998 («Studien zur Philosophie des 18. Jahrhunderts», 6), pp. 106-112.
69 R. POZZO, Kant within the tradition of modern logic. The role of the «Introduction: idea of a tran-scendental logic», «Review of Metaphysics», 52 (1998), pp. 295-310, in particolare pp. 296-299.
70 ACADEMIA ALBERTINA, Methodische Anweisungen für die Studierenden in allen vier Facultaeten, Har-tung, Königsberg 1770, pp. 17-20.

298 Riccardo Pozzo
Quando Kant dice che il soggetto della metafisica è l’Objekt selbst, intende loens reale dell’ontologia e quando dice che la logica tratta solo di astrazioni in-tende lo ens rationis. Del resto, nelle pagine dedicate al fondamento della di-stinzione «di tutti gli oggetti in generale [aller Gegenstände überhaupt]» in fe-nomeni e noumeni dell’Analitica dei principi, Kant ricorda che «il nome super-bo di ontologia, la quale pretende di fornire conoscenze sintetiche a priori sullecose in generale [von Dingen überhaupt] in una dottrina sistematica (ad esempioil principio di causalità), deve cedere il posto al nome modesto di una sempliceanalitica dell’intelletto puro»71. Nella Metaphysik Vigilantius (K3), la trascri-zione di uno dei suoi ultimi corsi (il frontespizio porta la data 1794/95), Kantconfina la metafisica nella parte materiale della filosofia:
«La metafisica appartiene alla parte materiale della filosofia, o piuttosto comprendein sé questa parte e si basa, in quanto presuppone oggetti reali, su leggi, ovvero prin-cipi della conoscenza (prin cipiis) degli oggetti reali, e si basa inoltre su ciò che ap-partiene all’esistenza delle cose. Dalla metafisica si distingue pertanto la parte pura-mente formale della filosofia, ovvero le leggi del pensiero esposte nella logica, poichéquest’ultima astrae dagli oggetti stessi»72.
Nella Reflexion 3946 (datata da Erich Adickes alla fase k), Kant spiega chela logica tratta relazioni tra concetti e invece la metafisica tratta oggetti ontolo-gicamente fondati:
«Tutta la filosofia pura è o logica o metafisica. La prima [...] contiene solo la subordi-nazione dei concetti sotto la sfera degli altri, il che avviene o immediatamente, nei giu-dizi, o mediatamente, nei sillogismi. Ma la logica lascia indeterminati gli stessi con-cetti che devono essere subordinati l’uno all’altro e non scopre quali predicati ineri-scano alle cose secondo le leggi della ragion pura»73.
Se dunque la logica si ferma agli entia rationis, la metafisica ha un ambito assaipiù ampio, che è poi quello dell’ontologia wolffiana, ossia «i primi concetti fon-damentali con i quali giudichiamo attraverso la ragion pura [...] e i principi [dieersten Grundbegriffe, womit wir durch die reine Vernunft urtheilen (...) und dieGrundsätze]»74. Nella Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik, scritta peril concorso della Academia Regia Scientiarum di Berlino del 1791, Kant ribadi-sce che l’ontologia è
71 KANT, Kritik der reinen Vernunft, B303, tr. it. cit., p. 465.72 KANT, Vorlesungen VI. Ergänzungen cit., p. 945.73 I. KANT, Kant’s handschriftlicher Nachlaß IV. Metaphysik, hrsg. v. E. Adickes, de Gruyter, Berlin
1926 («Gesammelte Schriften», 17), p. 359.74 KANT, Metaphysik cit., p. 359.

L’ontologia nei manuali di metafisica della Aufklärung 299
«la scienza (in quanto parte della metafisica) che costituisce un sistema di ogni con-cetto dell’intelletto e principio, ma solo fintanto che investono oggetti che sono dati daisensi e pertanto possono essere documentati dall’esperienza. Essa non tocca il sopra-sensibile, che è un fine ultimo della metafisica e appartiene dunque a questa solo co-me la propedeutica, l’ingresso, l’anticamera della metafisica autentica e viene chia-mata filosofia trascendentale, poiché contiene le condizioni e gli elementi di tutte lenostre conoscenze a priori [und wird Transzendental-Philosophie genannt, weil sie dieBedingungen und ersten Elemente aller unserer Erkenntniß a priori enthält]»75.
Permettetemi di mettere la chiave di volta sul nesso che lega la logica e lametafisica. Questa chiave di volta è la logica trascendentale. Nella MetaphysikVolckmann (datata da Gerhard Lehmann all’inverno 1784-1785), leggiamo che:«La filosofia trascendentale è rispetto alla metafisica ciò che la logica è rispet-to all’intera filosofia. La logica contiene le leggi generali del nostro intelletto, siaesso fondato sull’esperienza o no, ed è anche un’introduzione all’intera filosofia.La filosofia trascendentale è un’introduzione alla filosofia pura, la quale è unaparte dell’intera filosofia»76. Come la logica introduce all’intero della filosofia,cosí la filosofia trascendentale introduce alla filosofia pura, che è una parte del-la filosofia. Nella Kritik der reinen Vernunft, Kant osserva che l’oggetto della fi-losofia tra scen dentale non è l’ens rationis, ma è piuttosto l’ens reale, ancorché ilpiú generale tra gli entia realia, la nostra conoscenza di oggetti a priori. La con-clusione di questo argomento la si trova sempre nella Metaphysik Volckmann, do-ve Kant definisce senza mezzi termini la filosofia trascendentale come una logi-ca particolare e dunque epistemica: «Ma rispetto all’uso puro della ragione siavrà bisogno di una logica particolare che si chiama filosofia trascendentale; inessa vengono ponderati non gli oggetti ma piuttosto la nostra stessa ragione, co-me del resto accade anche nella logica generale»77.
5. Aetas Kantiana
Il dibattito sull’ontologia prende nei manuali dell’Aetas Kantiana due direzioni.La prima è più antica, si afferma già nel 1782, e da Nicolas de Malebranche at-traverso Gottfried Ploucquet porta a G.W.F. Hegel, la seconda è più tarda, risa-le agli anni Novanta, e da Kant attraverso Carl Christian Erhard Schmid porta aJakob Friedrich Fries.
75 I. KANT, Kant’s handschriftlicher Nachlaß VII, hrsg. v. G. Lehmann, de Gruyter, Berlin 1942 («Ge-sammelte Schriften», 20), p. 260.
76 I. KANT, Vorlesungen V: Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie, hrsg. v. G. Lehmann,de Gruyter, Berlin 1968 («Gesammelte Schriften», 28, 1), p. 359.
77 KANT, Vorlesungen VI cit., p. 359.

300 Riccardo Pozzo
Ploucquet intende la logica come identica all’ontologia, in quanto la logicaha come oggetto immediatamente l’essere, le cose, le sostanze: «Res est id, quodconcipi potest, e.g. numerus, figura, vir, arbor, motus, etc.»78. Il ruolo dell’intel-letto si limita, appunto, alla intellectio, che fa da presupposto alla considerazio-ne formale delle proprietà di una cosa: «Idea seu notio est rei intellectio»79. Lafondazione ontologica della logica rende Ploucquet molto più vicino ad Aristo-tele che a Descartes e a Wolff, e un immediato predecessore di Hegel, che perl’esame del Magister Artium all’Academia Eberhardo-Carolina di Tubinga do-vette discutere trenta tesi tratte dall’edizione del 1782 delle Expositiones diPloucquet80.
Invece, il Grundriß der Metaphysik di Schmid si occupa sì di ontologia, ma diontologia nel senso di Condillac e Meier: «La metafisica in senso stretto si oc-cupa: 1) positivamente in quanto Analitica della conoscenza degli oggetti realifintanto che sono conoscibili. 2) negativamente come Dialettica e Iperfisica deitentativi vani e da respingere criticamente di conoscere le cose e i predicati inse stessi»81. In questo contesto, la metafisica è analitica e dunque
«scienza dei predicati universali e necessari degli oggetti reali [Wissenschaft der all-gemeinen und nothwendigen Prädicate realer Gegenstände], fintanto che essi sono fon-dati nelle leggi della facoltà rappresentativa [in sofern sie in den Gesetzen des Vorstel-lungsvermögens gegründet sind], ed è ontologia, scienza delle cose in generale fintan-to che sono rappresentabili [ist: 1) Ontologie; Wissenschaft der Dinge überhaupt, in so-fern sie vorstellbar sind]»82.
Arrivati fin qua, è utile fermarsi sull’avverbio überhaupt, che rimanda allacelebre definizione della filosofia trascendentale nell’introduzione alla primaedizione della Kritik der reinen Vernunft: «Chiamo trascendentale ogni cono-scenza che si occupa non di oggetti, ma dei nostri concetti a priori degli oggettiin generale [mit unseren Begriffen a priori von den Gegenständen überhaupt]»83.
78 G. PLOUCQUET, Expositiones philosophiae theoreticae, hrsg. v. M. Franz, Olms, Hildesheim-Zürich-New York 2006, 17821 («Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie», 72), pp. 2-3.
79 PLOUCQUET, Expositiones philosophiae theoreticae cit., pp. 4-5. 80 G. PLOUCQUET, Der Inauguralthesen metaphysischer Teil (1790), hrsg. v. M. Franz / R. Pozzo, in M.
FRANZ (Hrsg.), «...im Reiche des Wissens cavalieremente?». Hölderlins, Hegels und Schellings Philo-sophiestudium an der Universität Tübingen, Isele, Tübingen 2005 («Schriften der Hölderlin Gesellschaft»,23/2), pp. 30-37, 39-69.
81 C.C.E. SCHMID, Grundriß der Metaphysik, Seidler, Altenburg 1799, § 13, p. 7. Cf. H. SCHRÖPFER,Carl Christian Erhard Schmidt: der ‘bedeutendste Kantianer’ an der Universität Jena im 18. Jahrhundert,in N. HINSKE / E. LANGE / H. SCHRÖPFER (Hrsgg.), Der Aufbruch in den Kantianismus. Der Frühkantiani-smus an der Universtät Jena 1785-1800, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1995 («For-schungen und Materialien zur deutschen Aufklärung», II/6), pp. 38-83.
82 SCHMID, Grundriß der Metaphysik cit., § 14, p. 7. 83 KANT, Kritik der reinen Vernunft, A12, tr. it. cit., p. 102.

L’ontologia nei manuali di metafisica della Aufklärung 301
Con Ploucquet e Schmid, si chiude il cerchio del percorso che ho svolto trai manuali di ontologia della Aufklärung. Se toccò a Hegel l’onore di andare ol-tre Ploucquet, bastarono poche osservazioni di G.S.A. Mellin a riempire di dif-ficoltà il percorso che da Schmid avrebbe portato a Fries. Non abbiamo ancora,scriveva Mellin nel 1804, nessuna «metafisica sistematica esposta a misura del-la Critica della ragione pura [nach Maßgabe der Kritik der reinen Vernunft]» enemmeno Schmid ha colmato questa lacuna, per quanto lodevole sia stato il suotentativo, visto che nel suo Grundriß manca la dimostrazione di una dottrina deltempo e dello spazio ovvero di come «una loro conoscenza razionale sia possi-bile sulla base di meri concetti a priori [eine Vernunfterkenntnis derselben ausbloßen Begriffen möglich ist]» e inoltre Schmid non ha dato prova della «com-pletezza della tavola dei praedicabilia [der Vollständigkeit der von ihm an-geführten Prädicabilien]» e tantomeno ha dato una loro deduzione ordinandoliin una tavola di praedicabilia, si noti, non di praedicamenta84. La richiesta diMellin, curiosamente, era già stata auspicata da Hegel, che nel frammento Dassdie Philosophie... dalle sue lezioni jenesi di Logica et Metaphysica del Winterse-mester 1801/02 prometteva, appunto, una sistematizzazione della «forme dellafinitezza, e cioè non ammassate empiricamente alla rinfusa, bensì nel modo incui esse sono messe in risalto dalla ragione»85. All’inizio del diciannovesimo lastrada è ancora lunga per arrivare all’Ontologia del padre Frick.
84 G.S.A. MELLIN, Enzyklopädisches Wörterbuch der Kantischen Philosophie, Scientia, Aalen 1971,1797-18041, vol. IV/1, pp. 275-276.
85 G.W.F. HEGEL, Schriften und Entwürfe (1799-1808), hrsg. v. R. Baum / K.R. Meist unter Mitwirkungv. T. Ebert, Meiner, Hamburg 1998 («Gesammelte Werke», 5), p. 272.
![[XLS]Riviste Eni - Ecos 2/2001 - Un pozzo da primato e... · Web viewFonti Termini perforazione Termini pozzo TABLE TABLE_2 ENI Cappello del pozzo in superficie, che assicura la separazione](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5add4f417f8b9a4a268d61e1/xlsriviste-eni-ecos-22001-un-pozzo-da-primato-eweb-viewfonti-termini-perforazione.jpg)




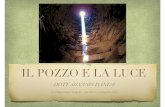

![INFORMAZIONI PERSONALI [DEL POZZO A Via Roma, 21 – … · [DEL POZZO Annalisa] F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome [DEL POZZO ANNALISA] ... Spa](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5cc7788c88c993c4398bb697/informazioni-personali-del-pozzo-a-via-roma-21-del-pozzo-annalisa-f.jpg)