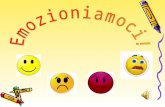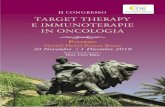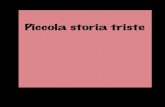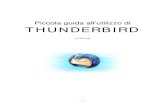Piccola Storia Della Lingua Italiana, De Blasi
-
Upload
luca-balestrino -
Category
Documents
-
view
513 -
download
1
description
Transcript of Piccola Storia Della Lingua Italiana, De Blasi

Piccola storia della lingua italiana
Cap. 1Il De Vulgari Eloquentia descrive gli idiomi parlati nella penisola attraverso esempi concreti. Dante è certo che il modo di parlare si modifica nei luoghi, nel tempo (diacronia) e nello spazio (sincronia), e vuole che il volgare sia stabile come il latino, cercando una lingua letteraria usata da tutti i letterati. [analisi Tanto gentile e tanto onesta pare: gentile = donna dotata di sentimenti nobili, elevati ed elette qualità morali. Onesta = donna dotata di superiorità morale unita a decoro e dignità. Pare = rivelarsi palesemente. Donna = domina, signora, padrona. Ella = lei. Altrui = pronome: ciascuno, chiunque].
Cap. 2 La comunicazione scritta e parlata si modifica per vai fattori. In alcuni graffiti di Pompei, risalenti al 79 DC, vi erano forme particolari di scrittura. Lo scrivente improvvisato non coglie la differenza tra lingua parlata e scritta, usa un modo veloce, poco formale.Le lingue volgari hanno una continuità rispetto a quella parlata, parliamo di latino volgare che si distingue dal latino classico, cioè letterario scritto; la scuola cerca di insegnare una lingua scritta diversa da quella parlata, si vuole insegnare ciò che non si sa. [ Appendix Probi: documento didattico, IV sec , è una lista di 227 parole, per ognuna di esse è indicata la forma corretta ed errata].Il latino parlato induceva gli insegnanti a suggerire la forma giusta poiché molte parole sono distanti da quelle del latino classico letterario.Il latino si modificò in base ad alcuni fattori: interferenze con lingue già usate, chiamate lingue di sostrato, crisi del potere di Roma, novità sociali come l’arrivo di popolazione e la diffusione del cristianesimo che diffondeva il messaggio evangelico oralmente.Vi erano notevoli differenze tra il latino parlato e il latino scritto, dal modo di parlare del popolo cioè il latino volgare derivano le lingue volgari, neolatine o romanze, le varietà locali italiane tradizionali e le varietà dei centri minori.
Cap. 3Normalmente la lingua scritta resta stabile mentre quella parlata evolve. La lingua parlata si allontana da quella scritta provocando un uso diverso dalla norma della scrittura, per esempio l’uso di preposizioni, articoli, tempi e modi verbali nuovi e un ordine di parole rigido, in seguito questa lingua si propose come alternativa al latino. La scrittura si differenzia dal parlare perchè serve per la comunicazione più formale, con la scrittura si salvaguarda la tradizione linguistica.Ovunque e sempre coesistono diversi modi parlare e scrivere, è una correlazione tra le diverse varietà della lingua. Con la crisi e il cambiamento del latino abbiamo la nascita delle lingue volgari, il latino viene usato in determinate circostanze e studiato ( es. politica, scuola e Chiesa). Il percorso della lingua latina è un continuum in diacronia, si modifica dell’uso. La trasmissione orale di una lingua è una delle principali manifestazioni di continuità della culturale orale che rende stabile la lingua tra le generazioni. Il volgare si adatta nella scrittura perché ci si accorge che la lingua si è modificata, l’oralità è il luogo del cambiamento, mentre nella scrittura si osserva il cambiamento con distacco oggettivo. Nei secoli di passaggio tra latino e italiano si sentì la necessita di usare nella scrittura la lingua parlata che si allontanò e divenne autonoma dal latino scritto.
Cap. 4L’interferenza di lingue diverse entra anche nelle scritture latine vicini alla lingua quotidiana che accolgono forme di lingua parlata. La scrittura viene usata per fini istituzionali e rivela scorrettezze grammaticali, gli atti notarili mostrano volgarismi

lessicali, fonetici e morfologici come nel documento di Tito redatto nell’ 823. Le parole quotidiane hanno condizionato la lingua, sono elementi che rimandano alla vita materiale e agli oggetti di uso comune.Nei Placiti Capuani vi è una consapevolezza di differenze tra le lingue. E’ il più antico atto notarile redatto a Capua nel 960 in cui vi è un uso scritto e consapevole del volgare italiano. Vengono convocati tre testimoni per definire le proprietà dell’abbazia che da trent’anni possiede delle terre, la frase dei testimoni è riportata in volgare [analisi del passo]. I testimoni sono chierici e notali che usano il latino e sono consapevoli di ciò che dicono.La scelta di usare il volgare è legata al fatto di dare massima pubblicità e ufficialità ala testimonianza, serve per una prospettiva futura perché il volgare è più adeguato per il futuro. E’ un elemento qualificante ed è segno che la scrittura è il luogo di formalità per futura memoria. È usato anche il costrutto della dislocazione a sinistra in cui un elemento nominale è anticipato e poi ripreso col pronome, il soggetto è spostato a fine frase, l’ oggetto è anticipato e poi replicato con il pronome. Il volgare italiano nasce con i crismi dell’ufficialità e della formalizzazione della scrittura.L’indovinello veronese (fine VIII sec e inizio IX) una prova di penna scherzosa, ha difficile interpretazione e varie traduzioni. Nasce da un’iniziativa occasionale e afferma l’importanza della scrittura. Il copista pratica la scrittura per professione, conosce il latino ma esalta i volgarismi per esigenza di realismo mimetico, abbiamo un latino misto al volgare.Il Graffito della catacomba di Commodilla ( IX sec) è fatto da lettere di diverso carattere e grandezza. E’ un testo insolito ma soprattutto esposto su superficie alla vista di più persone. Questo scritto è stato fatto su iniziativa individuale con consapevolezza di usare il volgare. L’ autore è una persona informata sulle novità liturgiche, un religioso che vuole ricordare in nuovo uso o un promemoria regolativo. La lingua inusuale è usata per esigenze più concrete di scrittura sintetica e immediata, è la lingua suggerita per le omelie come sancisce il Concilio di Tours nell’ 813 in cui veniva raccomandato per la predicazione l’uso della rustica romana lingua.Nella grafia vengono ripetute alcune caratteristiche della pronuncia, il graffito è una raccomandazione per i celebranti a “non dire ad alta voce le segrete orazioni”, un promemoria veloce.
Cap. 5Il problema costante della lingua italiana è il rapporto dialettico tra unità e molteplicità, si cerca un’unità culturale. La lingua parlata e quella scritta possono essere usate in modi diversi. Il latino è la lingua scritta mentre il volgare è quella parlata, si ha così il fenomeno della “diglossia” cioè la compresenza di due lingue diverse. Il volgare scritto si diffonde nel dodicesimo secolo a seguito di esigenze di alcuni ambienti, come quelle del ceto commerciale.La prima esposizione di un interesse per il volgare la offre Dante nel Convivio e nel De Vulgari Eloquentia. In quest’ ultimo definisce un confronto tra volgare e latino: il primo si riceve per abitudine attraverso l’uso, il secondo è una lingua secondaria richiedere lunga applicazione e studio assiduo; tutti possono conoscere il volgare ma pochi conoscono il latino usato anche per la grammatico e quindi prima arte del Trivio che forniva le conoscenze delle arti liberali. La lingua parta svolgeva una funzione didattica importante, infatti dante nel Convivio lo apprezza con “perfettissimo amore”.Dante afferma che il volgare è uno strumento iniziale di conoscenza. Tuttavia il problema retorico e di stile che si pone è quello su quale volgare utilizzare, perche bisognava sceglierne uno tra i molteplici. Tutti i volgari però sono inadeguati, hanno limiti intrinseci e suoni sgradevoli. Nel De vulgari eloquentia, Dante parla dell’esistenza di quattordici volgari che a loro volta si differenziano, l’autore usa il numero iperbolico “mille”. Gli unici volgari apprezzati sono quelli dei poeti siciliani e bolognesi come Guido Delle Colonne e Guido Guinizzelli. Dante apprezza la formalizzazione stilistica e retorica

mentre critica il siciliano comune e parlato dei modi di parlare chiamati “blasoni popolari”, che mettono in risalto la peculiarità di ogni volgare.A differenza del volgare il latino è una lingua uniforme e stabile perché artificiale ideata da dotti. Il volgare parlato è naturale non ha regolarità grammaticali.
Cap. 6Il volgare scritto è quello usato da notai e mercanti, i primi per le scritture formulari latine e per trascrivere gli aspetti della realtà, i secondi per esigenze di scrittura pratica e di commercio.Nella scuola di notai il volgare era usato per conoscere il latino, la tradizione in volgare era usata per motivi di ufficio. I notai imparavano il latino ma scrivevano in volgare, trasferivano nella scritture ciò che si ascoltava. I mercanti usavano la scrittura per necessità concreta, concretezza e profitto.L’insegnamento privato era affidato a chierici con lo studio dell’abaco e del far conto; l’ istruzione pratica e veloce è un investimento per i figli perché è garanzia per il futuro dell’azienda.In Toscana nei più antichi testi volgari di uso pratico si nota l0insegnamento di notai, chierici ed elementi di novità che fanno riferimento a un nuovo ambiente sociale che utilizza specificamente il volgare scritto.Nasce una contrapposizione tra cultura rurale tipica delle attività manuali e cultura urbana dedita alle attività del leggere e scrivere con alto tasso di alfabetizzazione grazie allo sviluppo economico. La diffusione della letteratura porta la circolazione dei libri in volgare anche per un pubblico femminile e vi era ricettività per la letteratura anche nei testi morali e religiosi.
Cap. 7La cultura e la lingua siciliana viene usata da Dante e da altri come modello di scrittura letteraria, a Firenze la cultura era ricettiva e sensibile verso le altre produzioni. Il toscano si diffonde con la persuasione della sua letteratura ed è un mezzo di diffusione del suo prestigio. I toscano hanno un’attenzione particolare verso la cultura in volgare e incoraggiano l’impiego dei versi volgari, il volgare più usato è quello toscano e la letteratura più letta è quella toscana grazie anche al’opera di Dante. La diffusione di queste opere provoca un’attenzione per il toscano anche in ambiente ligure e napoletano dove il fiorentino è usato come strumento di espressione letteraria e quindi mezzo per la lingua scritta, perche è comune e intellegibile. A Napoli la versificazione in volgare viene coltivata, circolano prove poetiche di autori che scrivono in volgare toscano (Bartolomeo da Capua e famiglia Acciaioli). Anche il Veneto accoglie la cultura toscana come modello linguistico da imitare, sempre grazie all’influenza dantesca e i contatti frequenti tra Petrarca e Boccaccio.
Cap. 8Con “le prose della volgar lingua” di Bembo, si costruiscono le norme grammaticali fondate sull’auctoritas di Petrarca e Boccaccio.In precedenza Leon Battista Alberti si impegnò nella valorizzazione del volgare e delle sue valenze letterarie nella “Grammatichetta”, considerato il primo scritto filo linguistico in Italia. Obiettivo di Alberti era quello di scrivere senza errore, poiché la grammatica precede tyutto. Egli vuole descrivere l’uso della lingua parlata con regole precise e conoscibili. Le prime regole fissate sono quelle della grafia: l’ordine delle lettere non è alfabetico perché l’autore vuole fasr riflettere sulla forma dei segni grafici, infatti egli riprende il discorso da dove terminavano le conoscenze di un alfabetizzato; per la prima volta si da grande importanza alla grafia perché si vogliono descrivere i segni grafici più funzionali.L’opera di Alberti è destinata alla riflessione personale ed è spesso collegata alle polemiche linguistiche dei filologi. (scrivere senza corruptela)

Uno di questi dibattiti riguarda l’unicità della lingua latina: secondo Bruni esistevano due lingue latine diverse, una per i colti e l’altra per il popolo. Per Biondo invece il latino era una lingua unica, quello classico era la modulazione letteraria fatta dagli scritturi e la differenza tra colti e popolo stava nel modo e nei gradi. Quindi per bruni il sermo vulgaris era privo di regole e ciò contrastava con la teoria di Alberti che riteneva il volgare una lingua grammaticale, Alberti voleva dimostrare che il volgare parlato aveva regole che potevano essere individuate e descritte. Alberti scrive in volgare per farsi comprendere da tutti, cerca di attenersi a regole morfologiche quindi deve descrivere le regole della grammatica in modo tale che sia qualcosa di utile a tutti (docere).Egli propone la regolarità del volgare affermata quando si accusano i vizi dell’uso linguistico cioè l’usare un nome nuovo improprio o concordare male quelli in uso, quindi vi è la necessità di usare una lingua corretta priva di vizi.
Cap. 9Il toscano grazie al prestigio letterario e alla sua diffusione condiziona anche i testi non letterati. Nella lettera del milanese Visconti a Gonzaga si notano tre diverse componenti: tratti toscani, latini e locali. In latino troviamo le forme di saluto iniziali, alcuni tratti grafici e fonetici; in toscano la dittongazione può/ suoi, l’articolo plurale gli, la preposizioni articolate de’ e al, il condizionale in –ei, il congiuntivo imperfetto in –i; in lombardo abbiamo alcune consonanti scempie, la preposizione de, la finale –e, costrutti con pronomi atoni el e la.Si denota quindi l’esigenza di avere una lingua per comunicare oltre il proprio ambito locale e il prestigio è dato al toscano.Nelle scuole di grammatica del 500, il latino è l’unica lingua studiata ma il libro in volgare è gradito come diversivo; la volontà di apprendere il volgare nasce come libera e spontanea esigenza. Nelle scuole di grammatica si scriveva in volgare per le necessità quotidiane o professionali, ma la lingua usuale era il latino.Da una testimonianza di Varchi sappiamo che il volgare poteva distogliere dallo studio e che la prima preoccupazione di un genitori era quella di sapere una corretta lettura del latino. Vi era la tendenza tra gli scolari a leggere di nascosto Petrarca, letterature clandestine o la grammatica volgare come le regole di Fortunio o le prose di Bembo, tutto ciò per approfondire la padronanza del volgare. Secondo Trissino l’italiano si impara da sé.Nel 500 viene riconosciuto il valore del volgare letterario appreso con lo studio per avere un’adeguata padronanza della lingua letteraria.. Secondo la maggioranza dei letterati tutti avevano una propria lingua materna in volgare e poi tutti acquisiscono il latino come lingua di cultura per cui tutti per avere padronanza di una lingua volgare scritta avrebbero dovuto studiare.I ceti popolari fanno domanda di istruzione, frutto di un’esigenza di alfabetizzazione per cui molti sono capaci di scrivere il proprio volgare materno, le opere del 300 venivano usate come libri di lettura in famiglia, Borghini garantisce in un suo scritto che sempre furono letti e studiati i massimi autori di quel secolo, anche Fortunio afferma che in gioventù ha dedicato il suo tempo libero alla lettura di Dante, Petrarca e Boccaccio.L’iter linguistico e didattico si basava quindi su una competenza trilingue per cui al volgare materno e spontaneo si accostavano le lingue letterarie di Petrarca e Virgilio a seconda dei diversi ambiti di comunicazione; già nel 500 tuttavia si preferiscono come autori Dante e Petrarca .Secondo Gelli la letteratura dei volgari non escludeva quella latina, egli infatti afferma d dover studiare il latino per comprendere Dante, si cercano quindi letture compatibili con quelle latine.
Cap.10

Bembo in una prima fase lavora come filologo e fissa il testo classico della letteratura volgare con l’edizione di Petrarca che da inizio alla filologia applicata ai testi volgari.Oltre a questo abbiamo anche “la raccolta aragonese” che selezione le opere dei poeti italiani dal 200 al 400, fatta per Federico D’Aragona, questo è sintomo che la letteratura volgare sta acquistando prestigio; si afferma il principio per cui la letteratura volgare può durare nei secoli e aspirare allo status dei classici.Bembo avverte l’esigenza di formalizzare il volgare. Nelle prose della volgar lingua, un trattato dialogico in tre libri, riflette sulle leggi e le regole del volgare; sottolinea le differenze tra il parlare e lo scrivere, secondo cui con lo scritto si arriva lontano mentre il modo di parlare essendo vario non può essere riportato fedelmente allo scritto. Bisogna scrivere leggi e regole stabili nel tempo perché lo scrivere è il parlare pensato, e individuare leggi e regole stabili nel tempo.La lingua scritta deve modellarsi sugli autori e quindi si da al volgare il principio di autorità con riferimento a Boccaccio per la prosa e a Petrarca per la poesia.Il modello bembesco è efficace per i letterati italiani, l’uniformità del Petrarca offre compattezza di stile, di argomento e di lingua; il volgare diventa l’alternativa al latino.Vi furono durante il 500 molte opinioni relative alla questione della lingua: chi sostiene la superiorità del toscano e del fiorentino parlato come Gelli e Giambullari, la prospettiva della teoria cortigiana che si riferisce al prestigio della corte romana di Colli e Castelvetro, la teoria del Calmeta che favorisce il pregio della lingua usata a Roma di influenza toscana, Castiglione che preferisce il parlare toscano degli antichi, e Trissino secondo cui la lingua di Dante e Petrarca era già italiana non fiorentina.La lingua dell’uso è diversa in ogni luogo e si avverte l’esigenza di avere un modello oggettivo e stabile; la teoria di Bembo è semplice e lineare, utile per i letterati italiani.La stampa è un mezzo di contatto della letteratura per tutti, la vita culturale si estende anche nel piccoli centri; esempio lampante è quello della poetessa Isabella Morra che scrisse un breve canzoniere amoroso indice del fatto che ella si alfabetizza con Petrarca e quindi può scrivere in una lingua uniforme anche nelle aree più periferiche.La lingua d’uso viene usata per esigenze quotidiane come quelle dei notati e degli ecclesiastici, abbiamo quindi un italiano locale, mentre nelle carte d’archivio troviamo una realtà autentiva e complessa itrisa di variazioni linguistiche.La lingua di Bembo era per poche persone colte, tuttavia ciò non impedisce la nascita di una letteratura dialettelale scritta da autori bilingui su temi di vita quotidiana.
Cap. 11Nei testi italiani nel secoli XIV – XVIII vi è l’incidenza del toscano e la conseguenze tensione dinamica con gli elementi locali, collegati tra loro con tratti latineggianti. Colui che vuole scrivere in modo letterario deve eliminare gli elementi della lingua madre e accogliere i tratti latineggianti, quelli di cultura media erano per le scritture pratiche usate per motivi di lavoro; ogni atto di scrittura ha luogo nella consapevolezza di procedimenti da sovrapporre all’oralità.Bruni riconosce tre categorie di testi: al livello più basso troviamo i testi ai limiti della comprensibilità per scarsa coesione e coerenza intrisi di elementi locali (scritture semicolte), al livello medio vi è una limitata padronanza nella scrittura con tracce dialettali, al livello più elevato ci sono scritti elaborati con una lingua adeguata.
Cap. 12Nel 1859 viene promulgata la legge Casati che prevede un biennio di istruzione obbligatoria per tutti, si vogliono avvicinare tutti gli italiani alla lingua scritta e letteraria. Nell’ 800 i parlanti parlavano una lingua italiana con tratti dialettali oppure un dialetto intriso di elementi italiani, avevano quindi competenza passiva dell’italiano standard. Si vogliono dotare gli italiani di uno strumento linguistico unitario, il primo fu la scuola per tutti i bambini e in seguito il libro scolastico.Nel 1868 il ministro Broglio nomina una commissione di esperti per risolvere la questione sul tipo di lingua da diffondere e da insegnare. Vi erano due

sottocommissioni, una milanese presieduta da Manzoni e una fiorentina presieduta da Lambruschini; loro compito quello di ricercare i modi per rendere universale la buona lingua e la buona pronuncia.Secondo Manzoni più idiomi diventano un ostacolo per l’unità, non c’è concordia nemmeno sul mezzo da usare per superare la molteplicità; egli vuole prendere come modello il vocabolario dell’accademia francese in cui vi è una stretta relazione tra la lingua e la società parlante. Il modello di lingua da adottare è senza dubbio quello toscano letterario colto, in particolare il modello e la varietà colta di Firenze. Manzoni si concentra sul vocabolario perché unità della lingua è unità di lessico; i libri devono essere scritti, rivisti da autori toscano e bisognava istituire un vocabolario “novo” economico e accessibile a tutti, usando una nomenclatura scienti diva comune.Manzoni tuttavia propone il modo per arrivare alla conoscenza della lingua viva mentre Broglio chiedeva i mezzi per diffondere la buona lingua, merito dall’autore è quello di aver combinato la teoria con una prospettiva attenta agli aspetti concreti dell’istruzione.
Cap. 13La commissione fiorentina si muove invece su prospettive diverse. Si servono di altre fonti lessicografiche usando una lingua dettata dai libri e come modello il vocabolario dell’accademia della crusca; il nuovo vocabolario doveva essere limitato a una parte della lingua. Si propone l’utilizzo di adottare come consulenti persone esperte della lingua parlata che conoscono la corruttela, possono rappresentare l’uso, questi devono suggerire parole di uso corretto, puro e ideale. Questa teoria assumeva dunque un’impostazione censoria e arcaicizzante.Ascoli pubblico un saggio, il Proemio, un cui vuole ridare il primato alla lingua scritta, questo intervento si configura come sistemazione teorica perche la tesi fiorentinista manzoniana si scontrava con la tradizione puristica libresca o con un purismo toscani sta lambruschiano.Esgli critica il titolo del “Novo vocabolario” perché la considera una forzatura, una rigida adesione al modello del fiorentino di uso vivo avrebbe provocato un disorientamento nei parlanti che dovevano adeguarsi a forme nuove modificando le abitudini ( in Italia da tempo tutti conoscevano la forma Nuovo). Secondo lui l’unità poteva essere raggiunta con uno scritto di base toscana.La soluzione manzoniana poteva produrre effetti negativi poiché c’era una diffusione di un malinteso fiorentinismo; l’accoglimento dell’uso quotidiano potrebbe condurre alla consacrazione di improprietà e scorrettezze.I punti principali su cui Ascoli dissente da Manzoni sono: il rifiuto di riconoscere la precedenza del parlato sullo scritto, e la convinzione che la cultura di una nazione non si misuri sulla vicinanza o meno tra lingua parlata e scritta. Tuttavia il proemio non deve intendersi totalmente contro Manzoni bensì contro il purismo letterario che esaltava la buona lingua del popolo, mentre Ascoli sperava che non si predesse l’italiano scritto tradizionale scientifico e culturale.
Cap. 14Nelle scuole degli ultimi decenni dell’ 800/900 l’attenzione è stata posta verso la correttezza della lingua letteraria, il conoscere le buone regole, cioè l’esprimersi per iscritto.Di solito si era accettato il modo di parlare spontaneo correggendo l’espressione scrittaa, secondo Mioni la lingua parlata era trascurata.L’obiettivo primario della scuola era quello di condurre gli alunni a parlare una lingua diversa da quella appresa spontaneamente,per l’italiano è usata la didattica del latino.Amenta distingue due linguaggi: uno comune cioè l’imperfetto del volgo, l’altro perfetto parlato dalla gente civile, per nobile egli intendo una lingua frutto di studio ed educazione, viene contrapposta la figura della balia e un luogo ammaestramento allo studio; secondo l’altrui la scuola deve essere indirizzata all’insegnamento dell’italiano.

Anche per De Sanctis lo studio dell’italiano è necessario,è una lingua scritta normativa, “un’altra cosa”. Per entrambi la scuola è il luogo di diffusione della lingua e della norma linguistica . adottare un modello linguistico alterativo era una strada obbligatoria per staccarsi dal modo locale di parlare, e la scelta di continuare a studiare era una decisione consapevole e meditata. Lo studio dell’italiano come lingua di cultura era un preciso progetto culturale famigliare. Quindi per la tradizione didattica un interesse per l’italiano parlato di manifestata attraverso la preoccupazione di una buona pronuncia e l’attenzione alle forme e all’uso parlato.
Cap. 15Per imparare la lingua gli unici strumenti erano i maestri e i libri. Doveva essere curata la buona pronuncia e il modello toscano o il fiorentino era quello delle persone che meglio parlavano.Per proporre un concreto esempio di pronuncia i manuali insistevano sula pronuncia da evitare, si procedeva quindi con meccanismi di negazione che rendevano il dialetto un uso da rifuggire.De Amicis descrive l’ansia ipercorretti sta di aderire al modello toscano nel “romanzo di un maestro” che suscita a lungo andare l’ilarità nei piemontesi. D’Annunzio invece rievoca il proprio entusiasmo per il vivente linguaggio di toscana, tuttavia l’autore subì un’ “irrisione feroce” da parte dei compagni di scuola per la pronuncia abruzzese nativa.Mancini, descrive la situazione postunitaria, affermando la necessità di avere una lingua comune per gli scambi e gli spostamenti , dato che l’Italia è una provincia, bisogna avere una lingua. Era sempre apprezzata una pronuncia prima di incertezze come si deduce dai testi della Baccini, che pur essendo toscana, trasferitasi in Liguria non perde il puro accento toscano, cosa che suscitava l’ammirazione negli insegnanti, questa era la dimostrazione che l’italiano parlato, unito al dialetto non cancellavano le tracce del dialetto di nascita.La buona pronuncia era affidata spesso ai libri, Petrocchi suggerisce si segnalare con accenti il grado di apertura delle vocali, perché una buona pronuncia corrisponde a una perfetta educazione, bisognerebbe addirittura insegnare con moderazione la gorgia tipica toscana, il maestro è il mediatore tra gli scarabocchi scritti dei libri e l’uso parlato che gli scolari dovranno apprendere.. i maggiori sforzi didattici erano concentrati sia vero il possesso della competenza della lingua scritta sia verso un lessico unitario di base fiorentina; si cercavano soluzioni lessicali alternative, ne derivava che la lingua doveva modellarsi poiché l’uso vivo a Firenze era molto complesso. Oltre a ciò vi era l’interferenza tra dialetto e italiano, che fece nascere una varietà intermedia chiamata lingua arbitraria. Secondo Romani una pronuncia corretta doveva orientarsi verso la lingua di uso comune , il monolinguismo fiorentino era segno di altri tempi: un utile varietà nell’unità; egli afferma che l’italiano parlato non è identificabile con il dialetto fiorentino.Davanzati sottolinea in un testo, quanto in una classe di alunni possano esserci, il bell’accento toscano, il milanese che ha soggiornato in varie parti d’Italia, il siciliano che suscita ilarità; il maestro poi afferma il nuovo ruolo della città di Roma, diventata luogo di incontro tra famiglie di tutta Italia.L’unità della patria si identifica nell’unità della lingua parlata realizzata con lo scambio comunicativo. Nei libri di dialoghi scolastici era vivo l’interesse autentico verso la lingua parlata, questo genere doveva illustrare il lessico specie le voci di arti e mestieri che venivano definite in uno stile lontano alla lingua parlata; dopo il 1868 tuttavia gli strumenti didattici si uniformarono all’esigenza di orientare verso una lingua vivente la norma trasmessa dalla scuola, l’attenzione andò verso la sintassi del parlato.
Cap. 16

L’italiano si diffuse grazie al teatro. Le compagnie filodrammatiche amatoriali giravano in località piccole e quindi il pubblico fu messo in contatto con la lingua. Ricordiamo le commedie di Fiorillo, che con le sue egloghe tosco napoletane presentava una variazione linguistica di realtà composita e Maggi che abitua il pubblico a fare i conti con una varietà diversa dalla propria infatti propoone la lingua della scrittura e della letteratura all’ascolto.Nel 900 i fratelli De Filippo portavano in scena brani imparati a memoria attinti dalla tradizione orale, si ricorda la disperazione di Peppino nell’imparare una battuta aulica, diversa dal proprio parlato; il teatro ha diffuso la lingua italiana. La lingua letteraria era affidata ai cantastorie, sottoforma di storie raccontante oralmente al fine di intrattenere un pubblico popolare; Di Giacomo ricorda il forte coinvolgimento con cui il pubblico popolare segue le avventure cavalleresche, Russo pone il ruolo del cantastorie al centro di una sua opera, il pubblico ascolta e commenta e il contatto tra lingua letteraria e dialetto è stretto quasi contiguo.Un altro mezzo di diffusione della letteratura popolare erano i fogli volanti, Claps racconta in toni veristi che alcuni girovaghi vendevano fogli volanti con la stampa della “lettera di Gesù cristo”; anche le prediche e le omelie rivolte a un uditorio cittadino erano mezzi di diffusione della lingua: il predicatore con l’aiuto della teatralità delle immagini entrava in eventi comunicativi di forte impatto emotivo, si ricordino in questo caso S. Alfonso de Liguori e la scuola di dottrina che diede impulso decisivo all’istruzione popolare.Anche in tribunale circolava l’italiano parlato, privo di accento, come ci ricorda D’Andrea, era il luogo di produzione e conservazione dei testi scritti e anche il carcere era luogo di diffusione dell’italiano (Malerba) e il servizio militare (Verga).La facilità degli spostamenti favorì il turismo e lo sviluppo industriale e della manodopera. Mancini ci ricorda l’importanza delle strade ferrate, che furono determinanti per i contatti tra le popolazioni. Ultimo strumento era il libro anche quelli di carattere religioso e scolastico; lo stampatore Remondini produce libri per ambia circolazione, e Solimena afferma di aver imparato a leggere grazie al parroco del paese e in seguito studiò l’italiano, il latino e il greco.
Cap. 17La scuola grazie ai libri di lettura e i sussidiari cercò di difendere l’italiano parlato e a stabilire il lessico; fece la fortuna di molti frasi celebri di uso comune anche i modi di dire che fanno riferimento alle scritture sono situazioni tipiche scolastiche; molte espressioni libresche vengono prese da Pinocchio e da I promessi sposi.
Cap. 18Tra il 300-500 il toscano diventa la lingua dei letterati mentre l’italiano era lo strumento per mettere in contatto i contemporanei. L’italiano del 500 era una lingua da studiare, la lingua unitaria era diffusa nelle scritture, in cui troviamo sempre un italiano stabile; i dialetti si sono inseriti in seguito nella letteratura e sono stati valutati in maniera positiva, Di Giacomo mostra un certo interesse per i dialetti.La codificazione dell’italiano letterario e il principio dell’istruzione per tutti sono stati i momenti fondamentali della storia della lingua. La scuola aveva fissato norme e regole; e quindi la didattica comporta che l’alunno dirigente impara la lingua nuova e ha una consapevolezza linguistica più ampia.Secondo Guicciardini vi erano differenza tra lingua parlata e quella imparata. Per Ascoli la riflessione sulle differenze linguistiche fa nascere una consapevolezza su alcun aspetti della grammatica grazie anche all’esperienza diretta e concreta.Attraverso l’incontro con persone e realtà nuove, spostamenti, cambiamenti notiamo come viene condizionata la lingua.