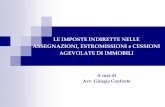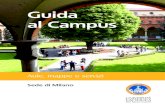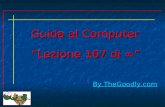Piano Triennale 2012-14 PianoTriennale2012-14 · 2020-05-04 · LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE...
Transcript of Piano Triennale 2012-14 PianoTriennale2012-14 · 2020-05-04 · LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE...

Piano Triennale 2012-14Istituto Nazionale di Fisica NuclearePiano Triennale 2012-14Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Piano Triennale 2012-14Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

HIGHLIGHT 2011 46PROSPETTIVE 48MILESTONE DEL PERIODO 2012-2014 50
3.7 IL CALCOLO E LE RETI 50ATTIVITÀ 2011 50PROSPETTIVE 51Adeguamento alla rete 52Potenziamento dei servizi a livello nazionale 52
3.8 I PROGETTI STRATEGICI E I PROGETTI SPECIALI 52PROGETTO STRATEGICO INFN-ENERGIA 52Trasferimento tecnologico 53ADS, reattori veloci, bruciamento e trasmutazione scorie 54Tecniche di produzione e monitoraggio di neutroni veloci 55Fisica del reattore 55Fusione nucleare 55
PROGETTO STRATEGICO NTA 56HIGHLIGHT DEL 2011 57PROGETTO SPECIALE APE 58Il SuperCalcolo in ambito INFN: stato e prospettive 58Strutture INFN e altre istituzioni partecipanti 60Sorgenti di finanziamento e ammontare 60
PROGETTO SPECIALE SPES 61Obiettivi 61Principali linee di attività 61Principali risultati conseguiti nel 2011 61Progetto di rilevanza scientifica SPES-ISOL 62Progetti di rilevanza applicativa LINCE, LARAMED, ADS 62Collaborazioni internazionali e interazioni con altri componenti della rete di ricerca: SPES 63Risorse finanziarie 64
HIGHLIGHT 2010-2011 64MILESTONE 2012 64PROGETTI SPECIALI GRID 65Progetto speciale INFN-GRID 65
PROGETTO SPECIALE IGI (ITALIAN GRID INFRASTRUCTURE) 66PROGETTO SPECIALE ELN (ELOISATRON) 68Descrizione generale del progetto 68Strutture INFN e altre Istituzioni partecipanti 68
HIGHLIGHT 2011 693.9 I PROGETTI EUROPEI 69
ATTIVITÀ 2009-2011 69PROSPETTIVE 74
3.10 I PROGETTI CONGIUNTI CON ALTRI ENTI NAZIONALI E REGIONALI 74IL LABORATORIO LABEC 75LA FONDAZIONE CNAO 77IL GALILEO GALILEI INSTITUTE FOR THEORETICAL PHYSICS (GGI) DI ARCETRI (FIRENZE) 80IL CENTRO ENRICO FERMI PER IL PROGETTO EEE 80LA FONDAZIONE ETTORE MAJORANA (FEMCCS) 81LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER (FBK) 81IL CONSORTIUM GARR 81
3.11 I PROGETTI FIRB, PRIN 82PROGETTI FIRB 82PROGETTI PRIN 82
3.12 I PROGETTI REGIONALI E I PROGETTI LOCALI 82
IV CAPITOLOI LABORATORI NAZIONALI, IL CNAF E LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA 88
4.1 I LABORATORI NAZIONALI: LNF, LNGS, LNL, LNS 89I LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI (LNF) 89Principali risultati scientifici conseguiti nel 2011 90Attività nei prossimi tre anni 93
MILESTONE DEL PERIODO 2012-2014 94LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO (LNGS) 95
PIANOTRIENNALE2012-14/ IN
DICE
II
I CAPITOLOINTRODUZIONE 2
II CAPITOLOL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE: STATO E PROSPETTIVE 6
2.1 L’ISTITUTO 7LA MISSIONE E LE ORIGINI 7LA STRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE 7
2.2 LE ATTIVITÀ DI RICERCA 8LE LINEE SCIENTIFICHE 8I costituenti fondamentali e le loro interazioni 9Le particelle e la radiazione nel cosmo 12I sistemi nucleari 13Le “questioni” della fisica teorica 14Le ricerche tecnologiche e interdisciplinari 15
I PRINCIPALI FILONI DI RICERCA 15I LUOGHI DELLA RICERCA 17Le Sezioni e i Gruppi collegati 17I Laboratori Nazionali 17I principali centri di attività all’estero 20
III CAPITOLOPIANO PROGRAMMATICO DI ATTIVITÀ SCIENTIFICA 22
3.1 L’INFN E LA SUA MISSIONE SCIENTIFICA 233.2 LA FISICA SUBNUCLEARE 25
MISSIONE 25COMPOSIZIONE 26ESPERIMENTI 26HIGHLIGHT DEL 2011 27PROSPETTIVE E SCENARI 28MILESTONE DEL PERIODO 2012-2014 29
3.3 LA FISICA ASTROPARTICELLARE 29MISSIONE E STRUMENTI 29PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI NEL 2011 30CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA CNS2 34PROSPETTIVE A MEDIO TERMINE 34HIGHLIGHT DEL 2011 35MILESTONE DEL PERIODO 2012-2014 35RISORSE ADDIZIONALI (2012-2114) 35INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA (2012-2014) 35INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE 35
3.4 LA FISICA NUCLEARE 36ATTIVITÀ DI RICERCA 36La struttura e la dinamica degli adroni 36 Transizioni di fase nella materia adronica 37Struttura nucleare e meccanismi di reazione 38Astrofisica nucleare e ricerca interdisciplinare 39
PROSPETTIVE 40HIGHLIGHT DEL 2011 41MILESTONE DEL PERIODO 2012-2014 41
3.5 LA FISICA TEORICA 42PREMESSA 42ATTIVITÀ SCIENTIFICA 42SETTORI DI RICERCA E COMPOSIZIONE 43PC CLUSTER DI PISA 44GALILEO GALILEI INSTITUTE (GGI) 44TRAINING E ALTRE ATIVITÀ EDUCATIVE 45HIGHLIGHT 2011 45MILESTONE DEL PERIODO 2012-2014 45
3.6 LE RICERCHE TECNOLOGICHE E INTERDISCIPLINARI 46
PIANOTRIENNALE2012-14/ IN
DICE
I

Il CUG E IL PIANO DI AZIONI POSITIVE 2011-2013 160Dai Comitati per le Pari Opportunità (CPO) ai Comitati Unici di Garanzia (CUG) 160Le azioni positive 161
Il PROGETTO EUROPERO GENIS LAB – THE GENDER IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 1657.6 GLI SCAMBI INTERNAZIONALI DEL PERSONALE DI RICERCA 166
FONDO AFFARI INTERNAZIONALI (FAI) 166BORSE PER LO SCAMBIO DEI RICERCATORI 166
7.7 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE DEL PERSONALE 167LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE NELL’INFN TRA PASSATO E FUTURO 167ASSEGNAZIONI 2012 167
VIII CAPITOLOLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 170
8.1 LA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LA COMUNITÀ 172LA COMUNICAZIONE DA E VERSO I MEDIA 172LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 172LA COMUNICAZIONE INTRANAZIONALE 173
8.2 LA RIVISTA ASIMMETRIE 1738.3 MOSTRE E MULTIMEDIA 174
LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 174LE MOSTRE 174La mostra “Estremo – Le macchine della conoscenza” 174La mostra “An italian History of innovation” 175L’allestimento “L’essenziale è invisibile agli occhi” 175L’allestimento “L’universo a portata di mano” 175
8.4 EVENTI DI DIVULGAZIONE 176LE CONFERENZE PER IL PUBBLICO 176LA COMUNICAZIONE E LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PROMOSSA LOCALMENTE 177
8.5 PROSPETTIVE 177
IX CAPITOLOLE ATTIVITÀ DI IMPATTO SOCIO-ECONOMICO E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 180
9.1 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 1819.2 CONTO TERZI 1829.3 SPIN-OFF 1829.4 BREVETTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 183
X CAPITOLOIL PIANO DI RIAMMODERNAMENTO GESTIONALE 186
10.1 IL QUADRO NORMATIVO 187LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI 187
10.2 IL SISTEMA INFORMATIVO 187
XI CAPITOLOLA VALUTAZIONE INTERNA 190
11.1 PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA 19211.2 UNA PROSPETTIVA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE 19411.3 CONFRONTO INTERNAZIONALE 196
INDICE DELLE FIGURE E DELLE TABELLE 200CREDITI ICONOGRAFICI 204
APPENDICE INFN CVI (COMITATO VALUTAZIONE INTERNAZIONALE) REPORT 2011 210
PIANOTRIENNALE2012-14/ IN
DICE
IV
Principali risultati scientifici ottenuti nel 2010 96Conclusioni e prospettive 102Milestone del periodo 2012-2014 103
I LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO 103Legnaro oggi 103Recenti risultati salienti (highlight) del laboratorio 104LNL nel prossimo triennio 105Milestone del periodo 2012-2014 107
I LABORATORI NAZIONALI DEL SUD (LNS) 107Principali risultati scientifici raggiunti nel 2011 108Attività nei prossimi tre anni 110Conclusioni e prospettive 110Milestone del periodo 2012-2014 111
4.2 IL CNAF 111Attività 2011 111Piani di sviluppo per i prossimi anni 113
4.3 LE NUOVE INFRASTRUTTURE DI RICERCA: SUPERB, KM3NET, GRID 114IL PROGETTO SUPERB 114L’INFRASTRUTTURA KM3NeT 117GRID 120Consortium IGI 120
4.4 PROFILI FINANZIARI DELLE NUOVE INFRASTRUTTURE DI RICERCA 124SUPERB 124Descrizione delle fasi di attività e del relativo finanziamento 124Copertura finanziaria 124
KM3NET 125Obiettivo del progetto 125Prospettive 126
GRID 127Attività e finanziamenti nel periodo 2010-2011 127Piani per il periodo 2012-2014 127
V CAPITOLOCOOPERAZIONE E ACCORDI CON ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 130
5.1 LE COLLABORAZIONI E GLI ACCORDI NAZIONALI 1315.2 LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI, A SOCIETÀ, A FONDAZIONI 1345.3 LE COLLABORAZIONI E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI 1395.4 ACCORDI PER LA COMUNICAZIONE VERSO LA COMUNITÀ SCIENTIFICA E L’OPEN ACCESS 140
VI CAPITOLORAPPORTI E CONVENZIONI CON LE UNIVERSITÀ 142
INFN E UNIVERSITÀ: SIMBIOSI E SINERGIA 143SIMBIOSI DELLE STRUTTURE 143PERSONALE ASSOCIATO 143ALTA FORMAZIONE 144
VII CAPITOLO PIANO DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 148
7.1 LE RISORSE DI PERSONALE DELL’ISTITUTO 1497.2 LE RISORSE FINANZIARIE 154
EVOLUZIONE FINANZIARIA 2002-2010 154IL PROFILO TRIENNALE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLA SPESA 2012-2014 157Entrate 158Spese 158Spesa amministrativa 159
7.3 IL CONTRIBUTO DEL PERSONALE ASSOCIATO 1597.4 LA FORMAZIONE E LE AZIONI DI SOSTEGNO DEI GIOVANI 1607.5 LE PARI OPPORTUNITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE
COME ELEMENTI DI SVILUPPO DI UNA SCIENZA CONSAPEVOLE 160
PIANOTRIENNALE2012-14/ IN
DICE
III

1. INTRODUZIONE

della competenza nei sistemi di accelerazione e nelle sorgenti di luce di sincrotrone.I prossimi tre anni sono anche gravidi di potenziali scoperte: il Large Hadron Collider di Ginevra,
i cui esperimenti principali sono a guida italiana, è a un passo dal gettare certezze sul bosone diHiggs che costituirà una scoperta fondamentale, che potrebbe permettere, attraverso segnali dinuove simmetrie, di far luce sul problema della materia oscura e sulla unificazione delle forze fon-damentali. La SuperB, prevista funzionare nella seconda metà del decennio potrebbe fornire i tas-selli mancanti ad un mosaico che l’LHC si appresta ad abbozzare. Il laboratorio del Gran Sasso, altermine della fase di sperimentazione con il fascio di neutrini spedito dal Cern, alla fine del 2012potrebbe sempre più caratterizzarsi come centro mondiale par la ricerca della materia oscura eper la rivelazione di effetti rari derivanti dall’esistenza di nuovi tipi di neutrini, detti di Majorana,con esperimenti con potenzialità di scoperta. I laboratori di fisica nucleare svilupperanno il pro-gramma degli ioni radioattivi in una sinergia sempre maggiore ulteriormente rafforzata da uneventuale laboratorio congiunto per la produzione di isotopi radioattivi con finalità medicali. Il la-boratorio di Frascati, oltre ad essere il laboratorio di riferimento per lo sviluppo del progetto SuperB,continuerà la sperimentazione all’acceleratore Dafne dopo gli interventi di miglioramento dellasua luminosità e svilupperà nuovi sistemi di accelerazione di particelle con fasci laser. I prossimi treanni saranno decisivi anche per il progetto KM3net, un enormerivelatore sottomarino al largo di Capo Passero in Sicilia dedicato all’astronomia con neutrini e sor-gente di molte applicazioni interdisciplinari nel campo della geologia e dell’oceanografia.Va ricordato inoltre che l’Istituto ha dato un apporto fondamentale alla realizzazione del CNAO
di Pavia per il trattamento di patologie oncologiche con fasci di protoni e ioni carbonio. Il centroha iniziato nel settembre 2011 le attività cliniche sperimentali con il trattamento dei primi pazienti.L’adozione del nuovo statuto offre strumenti per una maggiore trasversalità della programmazionescientifica tramite l’aiuto del Consiglio Tecnico-Scientifico, per un maggior coordinamento e cen-tralità amministrativa attraverso la figura del Direttore Generale e per un miglior collegamentocon il MIUR attraverso la presenza nella Giunta Esecutiva di un membro designato dal Ministero.La nomina del Direttore Generale ha permesso di avviare il processo per alcune modifichestrutturalidedicate ad una minore incidenza delle spese di funzionamento sul bilancio complessivo dell’Ente.
Fernando Ferroni - Presidente INFN
PIANOTRIENNALE2012-14/ IN
TRODUZIONE
4
Il Piano Triennale 2012-2014 presenta il piano di sviluppo delle attività dell’Ente nei prossimitreanni a partire dal bilancio delle attività in corso. È accompagnato da una scheda di sintesi (/executive summary/) che fornisce un compendio delpiano stesso mettendone in rilievo gli aspetti salienti. Questo piano incorpora i cambiamenti avvenuti nella legislazione a partire dallo scorso anno. Con riguardo alla pianta organica e il suo sviluppo nei prossimi tre anni abbiamo tenuto conto
della restrizione all’utilizzo del 20 per cento del budget di personale rimasto libero dal turn overdell’anno precedente. Ciò modifica in modo sostanziale e decisamente negativo le prospettive disviluppo e ha profonde conseguenze sulla capacità di assorbimento da parte dell’Istituto di pro-fessionalità consolidate negli anni e acquisite tramite contratti a tempo determinato.Un parziale respiro va ricercato nell'utilizzo sempre più sinergico dei progetti della comunità
europea con le attività istituzionali dell’Ente e rende necessaria una crescita dell’attività di pro-grammazione globale di tali progetti. Nei prossimi anni l’Ente intende anche ottimizzare la propriacapacità di partecipazione ai progetti regionali a partire dall’esperienza di grande successo con laRegione Abruzzo incentrata sui Laboratori Nazionali del Gran Sasso.Il cambio dovuto all’accantonamento nel fondo di funzionamento degli Enti di ricerca di una quota
pari al tredici per cento del bilancio da distribuire su base premiale e per lo sviluppo dei progetti ban-diera non è ancora pienamente operativo. Il premiale 2011 non è stato infatti ancora distribuito.A questo proposito l’Istituto, da sempre favorevole a finanziamenti basati sul merito, è in serie dif-
ficoltà perchè la quota dovuta non è stata assegnata nell'anno fiscale 2011. Il decreto ministerialeche ha fissato i riferimenti della valutazione per i progetti premiali è stato emanato molto tardi e ci hacomunque permesso di presentare 17 progetti divisi tra quelli a carattere scientifico di base, in lineacon la missione centrale dell’Ente, e quelli con orientamento applicativo. I primi sovente rappresentanola continuazione di linee di ricerca alle quali il nostro Paese attraverso l’INFN ha già dedicato notevoliinvestimenti e nel Piano viene evidenziato come i finanziamenti di oggi siano essenziali per poter tra-sformare quegli investimenti passati in conoscenza e tecnologia. Va ribadito che l’affievolirsi della vi-gorosa attività di competizione internazionale per sostenere tali sfide arresterebbe il filone innovativoche ne deriva. La seconda tipologia individua alcuni nuovi progetti che entrano a far parte di uninsieme di attività sempre più vasto diretto all’utilizzo in campo sociale delle innovazioni tecnologichederivanti dalle sfide della fisica di frontiera. Abbiamo inteso questi ultimi progetti anche come unaforte volontà di entrare nel campo della competizione per i fondi europei che saranno disponibili nelprossimo programma quadro Horizon2020. Inoltre per consolidare la forza della ricerca italiana versol’Europa l’Ente si è fatto promotore di una proposta condivisa con CNR e Elettra per la partecipazionealle Infrastrutture di Ricerca Europee in esercizio e costruzione.Una quota del bilancio degli Enti viene salvaguardata per consentire l’attuazione per ora di al-
cuni progetti bandiera, in particolare per l’INFN SuperB. Il passo cruciale per lanciare il progettoSuperB è stato compiuto con la formazione del Consorzio Cabibbo Laboratory, inizialmente par-tecipato dall'INFN e dall'Università di Tor Vergata e aperto a future partnership. Ricordiamo infattiche la finestra temporale per un impatto internazionale del progetto richiede un passo spedito,precisi accordi e una governance che definisca il progetto esecutivo e permetta dopo l'analisi finaledi costi e tempi di esecuzione il compimento del progetto. I prossimi tre anni saranno cruciali e, seben spesi, segneranno il ritorno dell’Italia a un’eccellenza mondiale nel settore delle alte energie,
PIANOTRIENNALE2012-14/ IN
TRODUZIONE
3

2. L’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICANUCLEARE: STATO E PROSPETTIVE
Per informazioni di carattere generalesull’Istituto si consulti il sito web:http://www.infn.it/.
Il presente capitolo illustra lo stato e leprospettive dell’Istituto nel prossimotriennio e fornisce una sintesi di quantoè oggetto dei capitoli successivi, alla cuilettura si rinvia per maggiori dettagli.

L’organizzazione manageriale e scientifica si ègradualmente affinata. La sua funzionalità èfrutto anche di buone esperienze consolidatenel tempo, che ne hanno fissato dettagli operativiessenziali. Essa rappresenta un efficace equilibriotra organizzazione centralizzata e decentrata,tra vertice e base, frutto dell’esperienza.Di particolare rilievo è l’entrata in esercizio, nel2009, del nuovo Sistema Informativo che costi-tuisce uno strumento essenziale che consentiràsempre di più una gestione integrata, efficiente,trasparente e ottimizzata dei processi ammini-strativi dell’Istituto.
2.2 LE ATTIVITÀ DI RICERCA
Le linee scientificheLa missione dell’INFN è il progresso nella cono-scenza degli aspetti fondamentali dell’Universo,dalle proprietà dei suoi costituenti elementari(micro-cosmo) alle sue caratteristiche sulle scaledei tempi e delle lunghezze più grandi (macro-cosmo). Il tema principale di ricerca dell’INFN –i costituenti elementari della materia e le loro in-terazioni – nasce, in senso moderno, alla finedell’Ottocento, quando si affermò l’idea dellamateria fatta di atomi. Lo studio di fenomeninaturali (radioattività, raggi cosmici) portò, nellaprima metà del Novecento, a svelare la strutturadell’atomo e dunque alla nascita della fisica delnucleo atomico.La seconda metà del Novecento, corrispondenteall’arco di vita dell’Istituto, ha visto il successivoincessante progresso – tuttora in atto – nella co-noscenza dei costituenti fondamentali della ma-teria e dell’origine dell’Universo, basato sulcostante sviluppo degli acceleratori e degli ap-parati rivelatori di particelle. Il corpo di cono-scenze così prodotto ha portato alla sintesiteorica del Modello Standard, che inquadra i co-stituenti della materia e le loro interazioni in unoschema coerente, semplice ed elegante.
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
8
2.1 L’ISTITUTO
La missione e le originiL’INFN è l’ente pubblico nazionale di ricerca, vi-gilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-sità e della Ricerca, dedicato allo studio deicostituenti fondamentali della materia e delleleggi che li governano e svolge attività di ricerca,teorica e sperimentale, nei campi della fisicasubnucleare, nucleare e astroparticellare.Le attività di ricerca dell’INFN si svolgono tutte inun ambito di competizione internazionale e instretta collaborazione con il mondo universitarioitaliano, sulla base di consolidati e pluridecennalirapporti. La ricerca fondamentale in questi settoririchiede l’uso di tecnologie e strumenti di ricercad’avanguardia che l’INFN sviluppa sia nei proprilaboratori sia in collaborazione con il mondo del-l’industria.L’INFN venne istituito l’8 agosto 1951 da gruppidelle Università di Roma, Padova, Torino e Mi-lano al fine di proseguire e sviluppare la tradi-zione scientifica iniziata negli anni ‘30 con lericerche teoriche e sperimentali di fisica nuclearedi Enrico Fermi e della sua scuola. Nella secondametà degli anni ‘50 l’INFN progettò e costruì ilprimo acceleratore italiano, l’elettrosincrotronerealizzato a Frascati dove nacque il primo Labo-ratorio Nazionale dell’Istituto.Nello stesso periodo iniziò la partecipazionedell’INFN alle attività di ricerca del CERN, il Cen-tro europeo di ricerche nucleari di Ginevra, perla costruzione e l’utilizzo di macchine accelera-trici sempre più potenti.Oggi il contributo dei ricercatori dell’INFN è ri-conosciuto internazionalmente non solo nei varilaboratori europei, ma in numerosi centri di ri-cerca mondiali.Nell’adempimento della sua missione, inoltre,l’Istituto:
La struttura e l’organizzazioneL’attività dell’INFN si basa su due tipi di strutturedi ricerca complementari: le Sezioni e i Labora-tori Nazionali (vedi figura 2.1).I quattro Laboratori nazionali, con sede a Cata-nia, Frascati, Legnaro e Gran Sasso, ospitanograndi apparecchiature e infrastrutture messe adisposizione della comunità scientifica nazionalee internazionale.Le 20 Sezioni e gli 11 Gruppi collegati alle Se-zioni o Laboratori hanno sede in altrettanti di-partimenti di fisica universitari e realizzano lastretta connessione tra l’Istituto e le Università.Della struttura complessiva attuale fanno ancheparte:• Il consorzio EGO, European Gravitational Ob-servatory, a Cascina (Pisa);
• Il CNAF, Centro Nazionale per la Ricerca e Svi-luppo nelle Tecnologie Informatiche e Tele-matiche, a Bologna;
• L’Amministrazione centrale, a Frascati;• La Presidenza, a Roma.
Il nuovo Statuto, previsto dal decreto legislativo31 dicembre 2009 n.213 pubblicato su GU seriegenerale n.25 del 1-2- 2010 riguardante il rior-dino degli EPR, è stato elaborato e deliberato dalConsiglio Direttivo integrato con 5 esperti no-minati dal MIUR e formalmente approvato dalMinistro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-cerca. L’organizzazione manageriale e scientificaè mostrata in figura 2.2. Per lo svolgimentodell’attività scientifica, l’Istituto si avvale di cin-que Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN),consultive del Consiglio direttivo.Esse coprono rispettivamente le seguenti lineescientifiche: fisica subnucleare (CSN1), fisicaastroparticellare (CSN2), fisica nucleare (CSN3),fisica teorica (CSN4), ricerche tecnologiche e in-terdisciplinari (CSN5).
Fig.2.1: Le strutture dell’INFN. In blu le Sezioni, in grigio i Gruppicollegati, in rosso i Laboratori Nazionali, in verde il Centro Nazionaleper Ricerca e Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche.
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
7
Collabora con le istituzioni di ricerca scienti-fica e tecnologica, italiane e straniere, contri-buendo al processo di rafforzamento dell’areaeuropea della ricerca;Opera con efficacia organizzativa nel rispettodella libertà di ricerca e della Carta europeadei Ricercatori;Promuove la formazione dei giovani nelcampo della ricerca fondamentale e appli-cata;Cura la diffusione della cultura scientifica, in-nanzitutto tra i giovani;Persegue l’eccellenza scientifica sviluppandostrumentazione avanzata, con il coinvolgi-
mento dell’industria nazionale;Intensifica l’interazione delle attività di ricercacon quelle di trasferimento di conoscenza perrendere più competitive le imprese italiane alivello internazionale;Sviluppa l’applicazione delle tecniche nuclearie subnucleari alla medicina, ai beni culturalie all’ambiente.
•
•
•
•
•
•
Fig.2.2: L’organizzazione manageriale e scientifica dell’INFN secondoil nuovo Statuto.

PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
10
Il risultato più rilevante delle ricerche portateavanti dall’Ente in questi ultimi anni è stata unasempre più approfondita comprensione del-l’unità di fondo dei fenomeni relativi alla fisicadei nuclei e dei costituenti subnucleari con quellirelativi all’evoluzione dell’Universo (cosmologia)e di strutture su scala cosmica (astrofisica).In effetti lo studio dell’”infinitamente piccolo”si è sempre più collegato, negli ultimi anni, allostudio dell’”infinitamente grande”, nel sensoche tematiche tipiche delle ricerche INFN sullastruttura intima della materia e delle interazionifondamentali possono contribuire a fornire ri-sposte a domande quali l’origine e l’evoluzionedell’Universo, la natura e la composizione dellamateria e energia oscura, a noi ancora ignote,che costituiscono oltre il 95% dell’energia del-l’universo, alla separazione fra materia e anti-materia nell’Universo. (vedi figure 2.3, 2.4, 2.5,2.6) La ricerca fondamentale, condotta sia attraversola sperimentazione, sia attraverso metodologieteoriche, e le ricerche tecnologiche e interdisci-plinari correlate, sono coordinate complessiva-mente da cinque commissioni scientifichenazionali:CSN1: Fisica subnucleareCSN2: Fisica astroparticellareCSN3: Fisica nucleare
CSN4: Fisica TeoricaCSN5: Ricerche tecnologiche e interdisciplinari
e trovano il loro completamento in un insiemedi progetti strategici, progetti speciali, progettiinseriti nella programmazione europea, progettinazionali e infine progetti regionali che sono in-dirizzati sia alle applicazioni verso il mondo so-ciale-produttivo-economico sia agli sviluppi difrontiera preparatori a future sperimentazioniper la ricerca fondamentale o comunque tesi acontribuire alla realizzazione di infrastrutture perlo “spazio europeo della ricerca”.
Descriviamo più in dettaglio i principali temiscientifici.
I costituenti fondamentali e le loro intera-zioni Le ricerche riguardanti tale tematica sono coor-dinate dalla Commissione Scientifica Nazionale1 (CSN1). I principali obiettivi delle attuali ricer-che, sperimentali e teoriche, sulle interazionifondamentali sono da una parte il completa-mento del Modello Standard, dall’altra la suaestensione e, infine, il suo inevitabile supera-mento.Particolare interesse rivestono gli esperimenti,sia alla frontiera dell’energia sia alla frontieradell’intensità, capaci di offrire indicazioni dinuova fisica, ossia di fenomeni non spiegabilinel quadro attuale. I costituenti elementari dellamateria si dividono in due classi (vedi figura 2.6):
Gli elementi delle due categorie sono classificatiin tre generazioni, ciascuna costituita da unacoppia, con massa progressivamente crescente.I quark più leggeri (i quark u e d) sono i costi-tuenti dei protoni e dei neutroni, a loro volta co-stituenti dei nuclei atomici. I quark delle famigliepiù pesanti (s, c, b, t) sono i costituenti di parti-celle instabili che, oltre a essere presenti nellaradiazione cosmica secondaria, sono normal-mente generate nelle collisioni ad alta energiaprodotte con macchine acceleratrici. Ciascunadelle tre generazioni di leptoni è costituita da un
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
9
Fig.2.3: La composizione dell’Universo
ENERGIA OSCURA
70%
MATERIA OSCURA
25%NEUTRINI
0,3%
ELEMENTI PESANTI
0,03%
IDROGENO ED ELIO
LIBERI
4%
STELLE
0,5%
i leptoni, che hanno solo interazioni elettro-magnetiche e deboli, queste ultime identifi-cate, negli anni ’30 da Enrico Fermi, comeresponsabili dei decadimenti dei nuclei;i quark, che sono sensibili anche alle intera-zioni forti, le forze che legano i protoni e ineutroni nei nuclei atomici.
•
•

La consistenza della teoria ne richiede l’esten-sione a teorie che prevedono l’esistenza di nuovifenomeni alla scala d’energia pari a circa 1000volte la massa del protone. Il modello al mo-mento più popolare, il Minimal SupersymmetricStandard Model, prevede che, per ciascuna par-ticella conosciuta, esista una corrispondenteparticella con proprietà simili, ma con momentoangolare intrinseco, lo spin, differente di mezzaunità. In tali teorie lo spettro di particelle diHiggs è più ricco che nel Modello Standard. Laricerca dei bosoni di Higgs e delle nuove parti-celle previste dalle teorie supersimmetriche – inbreve, le particelle supersimmetriche – sono tragli obiettivi primari del settore di ricerca fonda-mentale che va sotto il nome di fisica subnu-cleare. La sperimentazione avviata nel novembre2009 per un periodo programmato di oltre 10anni presso il Large Hadron Collider (LHC) alCERN (vedi figura 2.8), con il contributo fonda-mentale dell’INFN e dell’Italia, fornirà rispostecruciali sull’esistenza del o dei bosoni di Higgs,sull’evoluzione dell’Universo e sulla natura del-l’energia-materia oscura e su eventuali segnalidi fisica oltre il Modello Standard (supersimme-tria, ecc.)Tema di paragonabile rilievo è lo studio della sim-metria materia-antimateria, tecnicamente indicatacon la sigla CP (Charge-Parity). Tale simmetria eradata per scontata all’inizio della moderna fisicadelle particelle, ma esperimenti di grande rilievoconcettuale hanno invece mostrato l’esistenza diuna piccola asimmetria nel comportamento delleparticelle che noi classifichiamo come materia(elettroni, protoni, neutroni, ecc.) rispetto a quellodelle corrispondenti particelle classificate comeantimateria (positroni, antiprotoni, antineutroni,ecc.). Il Modello Standard permette una violazionedella simmetria CP. Esperimenti recenti hannoesteso la conoscenza di tale violazione. La speri-mentazione alle attuali e future intense sorgentidi mesoni K e B renderà disponibili ulteriori crucialiinformazioni.Collegata alla violazione della simmetria CP è lafondamentale questione legata all’osservazioneche l’Universo visibile sembra essere costituitoesclusivamente di materia e non, come ci si po-trebbe aspettare dalla teoria del Big Bang, diisole di materia e isole di antimateria. In realtàla violazione di CP è condizione necessaria manon sufficiente per sviluppare un’asimmetriamateria-antimateria a partire da una situazionesimmetrica; occorrerebbe infatti tener contoanche della violazione del numero barionico,
della violazione della simmetria di sola C e dellagrande velocità di espansione dell’Universo cheimpedisce il ripristino delle distribuzioni di equi-librio barioni-antibarioni. Anche su questopunto, la sperimentazione futura fornirà impor-tanti risposte chiarificatrici.
Le particelle e la radiazione del Cosmo Le ricerche riguardanti tale tematica sono coor-dinate dalla Commissione Scientifica Nazionale2 (CSN2). Nel Modello Standard, ivi compresa la sua esten-sione supersimmetrica, le interazioni elettrode-boli e forti sono indipendenti tra loro. Esistonoteorie che prevedono una completa unificazionedelle forze: le Teorie della Grande Unificazione.La verifica diretta di queste teorie richiederebbelo studio di fenomeni a energie di gran lunga su-periori a quelle disponibili, o anche solo ipotiz-zabili, con le macchine acceleratrici. Questeenergie, tuttavia, corrispondono a quelle preva-lenti nei primi istanti di vita dell’Universo, se-condo la teoria del Big Bang.Un possibile metodo di verifica delle teorie diGrande Unificazione consiste nella ricerca dei re-sidui di queste interazioni nella radiazione co-smica (le particelle fossili). Un altro metodoconsiste nel cercarne l’effetto in decadimentirari della materia, quali il decadimento del nu-cleone, cui si è già accennato (nei fatti se neparla a pagina 53), o il decadimento nuclearedoppio-beta senza emissione di neutrini. L’uni-ficazione della gravità con le altre forze è atutt’oggi uno dei maggiori problemi aperti: da
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
12
leptone carico e da uno neutro, detto neutrino.Un ruolo particolare è svolto dai neutrini, sensibiliesclusivamente alle interazioni deboli. In corri-spondenza ai tre leptoni carichi - l’elettrone, ilmuone e il tau – si conoscono tre tipi di neutrini.Molte evidenze sperimentali, alcune ottenute neiLaboratori Nazionali del Gran Sasso, fra le quali irisultati scientifici dell’esperimento OPERA che ri-ceve neutrini generati da acceleratori al CERN,hanno definitivamente confermato l’esistenza delfenomeno delle oscillazioni tra neutrini, ovvero latrasformazione di un neutrino di un dato tipo inun neutrino di tipo diverso, con una probabilitàche oscilla con la distanza percorsa. L’osserva-zione dell’oscillazione dei neutrini (fenomeno ipo-tizzato da Bruno Pontecorvo negli anni ’60),implica che questi abbiano una massa diversa dazero. La loro massa è così piccola da renderne dif-ficile la misura diretta. Dato che il Modello Stan-dard prevede che i neutrini siano rigorosamentedi massa nulla, ne deriva che le oscillazioni neu-triniche sono un’evidenza cruciale di nuova fisicaal di là del Modello Standard.
Insieme all’esistenza della materia oscura di ori-gine non barionica, tali oscillazioni costituisconol’evidenza sperimentale più forte che abbiamoche vi siano nuove particelle e interazioni al dilà da quelle presenti nel MS.Lo studio approfondito del fenomeno delleoscillazioni di neutrino è uno dei grandi temidella ricerca contemporanea. Esso è effettuatomediante neutrini provenienti da sorgenti di na-tura molto diversa: i reattori nucleari, i fascid’alta energia prodotti alle macchine accelera-trici, le reazioni di fusione all’interno del Sole, le
collisioni dei raggi cosmici nell’atmosfera. Laquestione della massa del neutrino riveste unparticolare interesse cosmologico, dovuto allamassiccia presenza di queste particelle nell’Uni-verso attuale, residuo del Big-Bang iniziale. Que-sti neutrini fossili non sono mai stati osservatidirettamente, ma possiamo stimare che, posse-dendo una massa, essi renderebbero conto, sep-pure solo in piccola parte, della cosiddettamateria oscura dell’Universo. Tale materia è dinatura per ora ignota, ma la sua presenza è rive-lata attraverso i suoi effetti gravitazionali. Studi re-centi hanno individuato anche l’esistenza diun’energia oscura dell’Universo. In definitiva lamateria a noi nota dovrebbe costituire non più del5% della massa-energia totale presente ogginell’Universo (vedi figura 2.3). Il mondo microsco-pico è popolato, oltre che da quark e leptoni (chesono fermioni), dai quanti di energia caratteristicidei diversi tipi d’interazione (che sono bosoni): ilfotone per le interazioni elettromagnetiche, i bo-soni Z0 e W per le interazioni deboli, i gluoni perle interazioni forti.
A questi vanno aggiunti i gravitoni per le forzegravitazionali, sebbene la gravità non sia adoggi integrata nel Modello Standard (vedi figura2.7). Analoga ai quanti associati alle interazioniè la particella denominata bosone di Higgs, re-sponsabile, secondo il Modello Standard, delcruciale meccanismo di generazione della massadelle particelle fondamentali. Il valore dellamassa del bosone di Higgs non è prevedibile,ma potrebbe essere poco superiore a 100 voltela massa del protone, secondo le indicazioni ri-sultanti dagli esperimenti attuali.
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
11
Fig.2.7: Le interazioni fondamentali e i loro mediatori.
Fig. 2.8: L’anello di 27 km del Large Hadron Collider (LHC) al CERN diGinevra

più alta energia, il modo in cui le distribuzionidei costituenti elementari dei nucleoni sono al-terate quando questi ultimi formano a loro voltala materia nucleare. Le ricerche in questo camposono condotte con fasci incidenti di elettroni dialta energia, o di protoni o antiprotoni.La teoria della QCD prevede che la materia nu-cleare, in condizioni estreme di densità e tempe-ratura, subisca una transizione ad una fasedenominata plasma di quark e gluoni, in cui i co-stituenti elementari non sono più confinati all’in-terno dei singoli nucleoni. Le prime indicazionisperimentali di questa transizione di fase sonostate ottenute nello studio delle collisioni tra nu-clei di piombo. La collisione tra ioni a energie ul-trarelativistiche è caratterizzata da densità dienergie sufficientemente elevate da permettereuna transizione dalla materia adronica ad unostato de-confinato di quark e gluoni. Si presumeche questa fase abbia avuto luogo nell’Universoprimordiale, nei primi dieci milionesimi di secondodopo il Big Bang, e che sia possibile ricrearla in la-boratorio attraverso la collisione tra ioni pesanti aenergie ultrarelativistiche. Le prime indicazionisperimentali di questa transizione di fase sonostate ottenute nello studio delle collisioni tra nu-clei di piombo all’SPS (CERN) e nuclei di oro aRHIC (BNL).
Lo studio del delle proprietà del quark-gluonplasma è l’ambizioso obiettivo scientifico del-l’esperimento ALICE all’LHC del CERN.
Le “questioni” della fisica teoricaLe ricerche riguardanti tale tematica sono coor-dinate dalla Commissione Scientifica Nazionale4 (CSN4). Le principali questioni fondamentali
che sono oggetto della ricerca con metodologieteoriche riguardano:
Le attività teoriche, svolte da circa 1000 scien-ziati provenienti da tutte le sezioni dell’INFN edai quattro laboratori nazionali e articolate se-condo “iniziative specifiche” che aggregano ri-cercatori di varie strutture per comuni finalitàscientifiche, sono tutte sviluppate in stretta col-laborazione col mondo accademico e compren-dono i seguenti settori:a) Stringhe e teoria dei campib) Fenomenologia delle particellec) Fisica adronica e nucleared) Metodi matematicie) Astroparticelle e cosmologiaf) Teoria dei campi e meccanica statistica
La ricerca teorica in ambito INFN svolge un ruolodi grande rilievo internazionale, come dimo-strano il grandissimo numero di citazioni, l’in-tensa attività di presentazioni alle più importanticonferenze internazionali, l’imponente produ-zione scientifica su riviste internazionali con re-feree (oltre 1200 lavori all’anno), la strettacollaborazione con ricercatori di tutto il mondo,lo scambio di studiosi sia a livello di giovani siaa livello di senior, grazie anche a una serie diconvenzioni tra l’INFN e ITEP, JINR e IGEP (Rus-sia), MEC (Spagna), MIT (USA).La partecipazione dei giovani in formazione è
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
14
estrapolazioni dalle basse energie ciò dovrebbesuccedere ad una scala di energia di 1019 GeVo ad una scala delle distanze di 10-35 m (vedifigura 2.9).La ricerca di fenomeni rari collegati alle Teorie diGrande Unificazione è stata, storicamente, la ra-gione dello sviluppo dei laboratori sotterranei,in particolare dei Laboratori del Gran Sasso, checostituiscono il più grande complesso di questotipo oggi esistente al mondo. L’impiego di ap-parati rivelatori di particelle nell’ambiente sot-terraneo ha poi esteso il campo delle ricerche alsettore astrofisico, con lo studio dei neutrini so-lari e dei neutrini da collasso gravitazionale.Di grande attualità e crescente sviluppo è la ri-cerca della materia oscura (Dark Matter), chepotrebbe essere direttamente collegata alla pre-senza nell’Universo della piu’ leggera particellasupersimmetrica, il neutralino, che trova ancoranei LNGS un’opportunità all’avanguardia. Gliesperimenti dedicati a questa ricerca sono infattibasati sull’osservazione di eventi rari o segnalideboli e richiedono condizioni particolari, comequelle che si possono ottenere nelle sale speri-mentali sotterranee dei Laboratori del GranSasso, al riparo dal disturbo dei raggi cosmici.Il favorevole ambiente del LNGS permette anchel’installazione di efficienti esperimenti di oscilla-zione dei neutrini, che misurano direttamenteparametri fondamentali del modello standard eche in prospettiva potranno permettere di esplo-rare la violazione di CP leptonica, un importan-tissimo tassello mancante per comprenderel’asimmetria materia-antimateria nell’Universo. Una volta consolidata, la fisica astroparticellareha poi trovato nuovi sbocchi in ambienti con ca-ratteristiche complementari a quello sotterra-neo, come lo spazio, dove la radiazione cosmicaprimaria è direttamente accessibile, i laboratorid’alta quota, per la astronomia di raggi gammadi alta energia o i laboratori sottomarini perl’astronomia con neutrini di alta energia. Infine,un settore di ricerca anch’esso collocato al con-fine tra lo studio delle interazioni fondamentalie l’astrofisica, nel quale i fisici italiani hannosvolto e svolgono un ruolo d’avanguardia, èquello della rivelazione delle onde gravitazionalisia mediante antenne criogeniche a barra riso-nante, già ampiamente sviluppate, sia con lo svi-luppo dei grandi rivelatori interferometrici, orapienamente in funzione, tra cui spiccano l’italo-francese VIRGO (vedi figura 2.10) a Cascina(Pisa), e gli statunitensi LIGO, in Louisiana e aSeattle.
I Sistemi NucleariLe ricerche riguardanti tale tematica sono coor-dinate dalla Commissione Scientifica Nazionale3 (CSN3). Le ricerche in fisica nucleare oggi ri-guardano la struttura e la dinamica di sistemicomposti, alla luce della teoria delle interazionifondamentali. In quest’ottica, le tematiche tra-dizionali della fisica nucleare sono spesso estesea prospettive più vaste, che includono temi di fi-sica subnucleare. Esempi di estensioni di questotipo sono lo studio delle funzioni di struttura deinucleoni, le ricerche sulla spettroscopia degliiperoni o la ricerca di nuovi stati in cui possa esi-stere la materia nucleare.Le ricerche tradizionali della fisica nuclearehanno portato alla formulazione di modelli chedescrivono con successo le proprietà dei nucleiatomici come sistemi legati di protoni e neu-troni. Questi modelli sono sottoposti a verifichesempre più stringenti, grazie allo sviluppo di tec-niche sperimentali che consentono lo studio dinuclei in condizioni estreme, prossime ai limitidi stabilità: nuclei notevolmente deformati convalori elevati del momento angolare, oppure nu-clei con valori estremi del rapporto tra protoni eneutroni. Questi temi sono affrontati in esperi-menti che utilizzano fasci di ioni accelerati finoa energie comprese nell’intervallo tra la barrieracoulombiana e 100 MeV/nucleone.
La descrizione del nucleo in termini di nucleoni(i protoni o i neutroni) che interagiscono attra-verso lo scambio di mesoni è un’approssima-zione, valida alle basse energie, per riassumeregli effetti dei costituenti elementari (i quark e igluoni) che compongono i nucleoni stessi. Conil progredire delle conoscenze sul comporta-mento dei costituenti subnucleari, sarà possibilespiegare i modelli nucleari a partire dalla teoriafondamentale delle interazioni forti, la cromo-dinamica quantistica (QCD).A tal fine è interessante studiare, in collisioni a
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
13
Fig. 2.9: L“Unificazione” delle forze.
Fig. 2.10: L’Interferometro per onde gravitazionali Virgo,nella pianura di Cascina (PI)
l’origine della massa delle particelle fonda-mentali;l’individuazione della natura e delle proprietàdella materia oscura;la “fisica del sapore” e la violazione delle sim-metrie discrete;la spiegazione dell’asimmetria materia-anti-materia nell’Universo;l’unificazione delle forze fondamentali, in-clusa la gravità;lo studio della natura fondamentale dellospazio-tempo e i problemi connessi alla quan-tizzazione della gravità;la fisica adronica e nucleare, inclusi i processiall’epoca del Big-bang e la successiva evolu-zione dell’Universo. Tali studi teorici si avval-gono e si avvarranno sempre di più dei risultatisperimentali attesi all’LHC, dai molti esperi-menti di fisica astroparticellare e dalle “fabbri-che” per la produzione di mesoni B fra cuiquella rappresentata dalla nuova macchina ac-celeratrice SuperB in Italia.
•
•
•
•
•
•
•

che dimostrano il crescente impegno dell’Entenell’utilizzo e nel trasferimento delle cono-scenze e delle tecnologie acquisite in campi
trasversali a forte impatto socio-economico,quali la Medicina, i Beni Culturali e l’Am-biente, l’Energia.
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
16
dimostrata dall’elevato numero di tesi di laureauniversitarie (circa 300/ anno), sia di primo chedi secondo livello, e di esi di dottorato (circa70/anno).Di particolare significato e rilievo è l’attività del-l’Istituto Galileo Galilei (GGI) di Arcetri, di cuil’INFN è ente promotore e sostenitore finanzia-riamente. Il GGI ospita di solito tre workshopall’anno, di durata variabile tra 8 e 12 settimane,oltre a scuole per giovani post-doc e incontri sutemi di interesse per la fisica teorica.Di grande impulso per la ricerca teorica italianae internazionale nel campo delle interazioniforti è stato lo sviluppo da parte dell’INFN dimacchine di calcolo parallelo attraverso il pro-getto APE (The Array Processor Experiment).
Le ricerche tecnologiche e interdisciplinariLe ricerche riguardanti tali tematiche sono co-ordinate dalla Commissione Scientifica Nazio-nale 5 (CSN5). L’INFN pone particolareattenzione, ai fini dello svolgimento della suamissione scientifica e del suo impatto socioe-conomico, agli sviluppi nel campo della fisicadegli acceleratori
(vedi figura 2.11), dei rivelatori di radiazione,dell’elettronica, dell’informatica e della fisicainterdisciplinare, e in tali attività collabora in-tensamente con ricercatori e tecnologi di dif-ferente estrazione culturale e di differentiafferenze (CNR, INAF, INGV, INFM, ASI). Nellaricerca e sviluppo per i futuri acceleratori l’Isti-tuto gioca un ruolo di eccellenza e si ponecome solido riferimento culturale e realizzativo
per l’intera comunità nazionale e internazio-nale; i campi di R&D (Research and Develop-ment, Ricerca e Sviluppo) riguardano gliacceleratori di elettroni ad alta energia e in-tensità per la fisica del sapore (SuperB), gli ac-celeratori lineari di altissima energia edintensità nell’ambito del progetto ILC (Interna-tional Linear Collider) e del progetto CLIC(Compact Linear Collider), gli acceleratori diprotoni per la produzione di fasci radioattivi,gli acceleratori di protoni e ioni per le applica-zioni in adroterapia, gli acceleratori per la pro-duzione di radiazione elettromagnetica dialtissima energia ed altamente coerente (X-FEL) con i progetti SPARC e SPARX, il progettoESS (European Spallation Source) in costru-zione a Lund, la test facility per il sistema diIniezione a Atomi Neutri per il progetto ITER(International Thermonuclear Experimental Re-actor). La capacità dell’Istituto di costruire ac-celeratori (X-FEL, ESS, SparX, ITER) utilizzabilida altre comunità scientifiche (scienze e inge-gneria dei materiali, biologia, chimica, energe-tica, medicina) costituisce una risorsa digrande valore per l’intera comunità nazionalee internazionale. Di grande impatto sono leapplicazioni interdisciplinari delle tecniche svi-luppate dall’INFN nel campo dell’imaging me-dico, della terapia del tumore con adroni, dellosviluppo di piani di trattamento in radioterapiacon fasci di protoni e ioni, della dosimetria eper lo studio della evoluzione cellulare, dellamodellistica neurologica oltre che nel campodel patrimonio storico-artistico-archeologico,dei gran di processi ambientali.I rapporti con l’industria, con le organizzazionied istituzioni operanti nel settore della sanitàe della salute, nel settore dei beni culturali edell’ambiente, pongono sempre di più l’Isti-tuto al centro dell’attenzione del Paese qualefattore essenziale di innovazione e sviluppo.
I principali filoni di ricercaIn tabella 2.1 sono elencati i principali esperi-menti e i principali Laboratori Nazionali e luo-ghi di ricerca dove si svolgono le attività.La tabella evidenzia il ruolo fondamentale deiLaboratori nazionali ed il contesto internazio-nale nel quale si svolgono le attività.Accanto ai filoni scientifici di competenza dellecommissioni scientifiche nazionali, vannomenzionati i progetti strategici nei settoridell’Energia, della Medicina e delle Nuove Tec-niche di Accelerazione ed i progetti speciali
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
15
Fig.2.11: Ricadute tecnologiche dello sviluppo degliacceleratori di particelle.
Principali linee e filoni scientifici Principali esperimenti e attività Principali laboratori e luoghi di ricerca
Fisica subnucleare
Sperimentazione ad alta energia - LHC ATLAS, CMS, LHC-b, LHC-f, TOTEM, UA9 CERN
LEP (Large Electron Positron collider) ALEPH, DELPHI, L3, OPAL CERN
Studio della simmetria materia-antimateria KLOE, NA62, MEG, PMU2E, BABAR, LNF, CERN, PSI-Zurigo, SLAC, BEPC Beijing
BESIII
Fisica adronica COMPASS, CDF, ZEUS, HERA-B, J-FNAL, CERN, FERMILAB,DESY-Amburgo
E-831
Nuova frontiera dell'alta intensità P-SUPERB, P-ILC
Fisica astroparticellare
Fisica dei neutrini OPERA, ICARUS, BOREXINO, T2K LNGS, JPARK-Giappone
Ricerca di fenomeni rari CUORE, GERDA, DAMA, WARP, XENON LNGS
Radiazione cosmica in superficie e nelle ARGO, AUGER, ANTARES, MAGIC, Yangbajing (Cina) , Malargue (Argentina),
profondità marine NEMO Tolone (Francia), LNS, La Palma (Canarie/
Spagna)
Radiazione cosmica nello spazio PAMELA, AMS, FERMI, JemEUSO Spazio
Ricerca sulle onde gravitazionali VIRGO, LISA pathfinder, ROG, AURIGA EGO-Cascina + Spazio
Ricerche in Fisica generale fondamentale MAGIA, MICRA, MIR, PVLAS, …
Fisica nucleare
Struttura e dinamica degli adroni MAMBO-JLAB12-PAX-PANDA, KAONNIS JLab, LNF, GSI, Bonn
Transizioni di fase della materia adronica ALICE, EXOCHIM, FRAG CERN, LNS, GSI
Struttura e reazioni nucleari NUCL-EX, EXOTIC, GAMMA, PRISMA, LNL, LNS, GSI, GANIL
LNS-STREAM, SPEME
Astrofisica nucleare e ricerca ERNA, LUNA, ASFIN, NTOF, AEGIS LNGS, LNS, CERN
interdisciplinare
Fisica teorica
Stringhe e teoria dei campi
Fenomenologia delle particelle
Fisica adronica e nucleare
Metodi matematici
Astroparticelle e cosmologia
Teoria dei campi e meccanica statistica
Ricerche tecnologiche e interdisciplinari
Interdisciplinare Dosimetria, piani di trattamento con LNL, LNS, LNF, LNGS, GSI, ISS, CNAO
adroni, radiobiologia, tecniche avanzate
di imaging (PET, RMN ad Alto Campo, X
monocromatici), beni culturali, geofisica
Rivelatori Rivelatori silicio ad integrazione verticale e LNL, LNS, LNF, LNGS CERN, FBK, POLI
di grande area, SiPM, rivelatori diamante, MI, POLI TO
rivelatori di vertice per esperimenti alta
energia e alta luminosità fotorivelatori a
nanotubi di carbonio.
Elettronica Elettronica di readout veloce, link seriali alta LNL, LNS, LNF, LNGS, POLI MI, POLI TO,
velocità FBK, POLI BA
Acceleratori Acceleratori per adroterapia, FEL, LNL, LNS, LNF, GSI, CERN, GANIL, SLAC,
accelerazione in plasmi alta densità, BNL, RIKEN
sorgenti di ioni ed elettroni ad alta brillanza,
acceleratori alla frontiera dell'energia e della
luminosià, sorgente compton
Tab. 2.1: Principali filoni scientifici e luoghi di ricerca

I Laboratori Nazionali di Frascati, sin dalla loroistituzione nel 1959, sono dedicati principal-mente alla fisica subnucleare, studiata in parti-colar modo mediante anelli d’annichilazioneelettrone-positrone. AdA, la prima macchina almondo di questo tipo, è stata concepita e svi-luppata proprio a Frascati. Ad essa succedetteADONE, che per molti anni ha rappresentato lafrontiera dell’energia per quel tipo di macchine,consentendo di ottenere le prime indicazionidell’esistenza della carica di colore dei quark.ADONE è stata anche per diverso tempo l’unicasorgente di luce di sincrotrone in Italia. Il funzio-namento di ADONE è terminato nel 1993.Nel 1997, al suo posto, è entrato in funzionel’anello d’annichilazione elettrone-positroneDAFNE, intensa sorgente di coppie di mesoni K,con energia totale di 1 GeV. Gli apparati speri-mentali KLOE, FINUDA e DEAR/ SIDDHARTA vihanno studiato fino al 2010 rispettivamente laviolazione della simmetria materia-antimateria,gli ipernuclei e gli atomi mesici. Dal 2000 al2007 DAFNE ha operato a una luminosità senzaprecedenti alla sua energia di collisione. Neglianni 2008-2009 nei LNF, è stata sviluppata unatecnologia innovativa, denominata “schema dicollisioni crab-waist”, che ha dimostrato la pos-sibilità di un aumento in luminosità di un fattore4-5 ed è attualmente oggetto di studio ancheper il progetto in corso del nuovo acceleratoreSuperB. La divisione acceleratori del laboratorioè impegnata in due progetti internazionali di svi-luppo di nuovi collisori lineari elettrone-posi-trone: l’ILC, l’International Linear Collider, eCLIC al CERN di Ginevra. In tale ambito di ricer-che si situa il progetto SPARC, finanziato dalMIUR, che costituisce anche un importantepasso verso lo sviluppo di tecniche innovativeper la produzione di radiazione X, mediante FreeElectron Laser (FEL). I Laboratori Nazionali di Legnaro, presso Padova,furono istituiti nel 1968 per lo studio della strut-tura e della dinamica dei nuclei atomici. Essisono dotati di un acceleratore Tandem e, dal1994, di un acceleratore lineare di ioni, ALPI, ba-sato su tecnologie superconduttive. Tali accele-ratori attraggono una vasta comunità nazionaleed europea di ricercatori che vi conducono studisulle collisioni fra ioni. Nel corso dell’ultimo de-cennio, i Laboratori hanno registrato importantisviluppi tecnologici, ad esempio nella costru-zione di cavità superconduttive, nella radiobio-logia, nella scienza dei materiali. Da alcuni anniil laboratorio, in collaborazione con altre istitu-
zioni italiane e straniere, è impegnato nello svi-luppo di tecniche di produzione di fasci intensidi protoni, mirati non solo alla realizzazione diuna futura infrastruttura per esperimenti di fi-sica nucleare, ma anche d’applicazioni in altricampi. Tali sviluppi hanno portato all’approva-zione, da parte dell’Istituto nel 2003, del pro-getto SPES, un acceleratore di protoni ad altaintensità, con energia di 40 MeV. Da citare an-cora è IFMIF (International Fusion Materials Irra-diation Facility), il progetto di una macchina perlo studio degli effetti dell’irraggiamento neutro-nico sui materiali di un reattore a fusione. Il la-boratorio di Legnaro, assieme a quelli di Frascatie del Sud, partecipa alla realizzazione del pro-getto CNAO, Centro Nazionale di AdroterapiaOncologica a Pavia. Il Laboratorio è anche sedeper la preparazione d’esperimenti di fisica sub-nucleare e nucleare, condotti da gruppi INFNpresso altri centri. Inoltre, esso ospita AURIGA,un rivelatore ultracriogenico di onde gravitazio-nali, che opera in coincidenza con analoghi ri-velatori.I Laboratori Nazionali del Sud, istituiti a Catanianel 1975, sono dedicati alla fisica nucleare confasci di ioni leggeri e pesanti. Essi sono dotati diun acceleratore Tandem e di un Ciclotrone su-perconduttore, in funzione dal 1994, in gradodi accelerare ioni pesanti sino a energie di 100MeV per nucleone. Il funzionamento del Ciclo-trone è stato potenziato con l’entrata in fun-zione di una sorgente di ioni, SERSE, concaratteristiche avanzate. L’attività sperimentaleè rivolta allo studio delle collisioni tra ioni pe-santi e si avvale di strumentazione d’avanguar-dia a livello internazionale, come quella costruitaper gli esperimenti OUVERTURE e CHIMERA.È notevole la presenza di ricercatori stranieri.Nel 2002, il primo centro italiano di protontera-pia per la cura dei tumori oculari, CATANA, ba-sato sull’uso del fascio di protoni da 60 MeV delciclotrone superconduttore, ha iniziato con suc-cesso il trattamento di pazienti, in collabora-zione con i medici dell’Università di Catania.L’esperienza di CATANA costituisce la base perla futura costruzione di un centro dedicato, pro-mosso dalla Regione Sicilia, e per la collabora-zione dei laboratori al progetto CNAO di Pavia.I laboratori hanno anche dato vita a un’impor-tante attività applicativa delle tecniche nucleariai Beni Culturali. Infine LNS è impegnato nellarealizzazione di un telescopio per neutrini co-smici di alta energia con dimensioni dell’ordinedel km3 a profondità abissali nel Mar Mediter-
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
18
i luoghi della ricercaL’attività di ricerca si svolge in Italia presso le Se-zioni, i Gruppi collegati, i Laboratori Nazionali,e all’estero presso i più importanti laboratoristranieri o internazionali sedi di attività di ricercaanaloghe.
Le sezioni e i gruppi collegatiLe attività sperimentali nelle Sezioni e nei Gruppicollegati, tutte svolte in stretta collaborazionecon il personale universitario associato all’INFN,normalmente riguardano la preparazione e laconduzione degli esperimenti presso i labora-tori, nazionali o esteri, con particolare riguardoall’analisi e all’interpretazione dei dati sperimen-tali raccolti. Le Sezioni possono essere sede diesperimenti, normalmente basati su apparati dipiccola mole, con un’importante eccezione: ilcaso dell’interferometro gravitazionale italo-francese VIRGO, inaugurato nell’estate 2003, aCascina presso Pisa. Nel 2000 l’INFN e il CNRSfrancese hanno costituito il consorzio EGO – Eu-ropean Gravitational Observatory – con sede aCascina, quale struttura per ospitare VIRGO efuture attività nel campo della gravitazione. LeSezioni e i Gruppi collegati, inoltre, svolgonosempre di più da qualche anno l’importantefunzione di raccordo fra l’INFN e il territorio - ti-picamente università, imprese ed enti pubblici oprivati nelle corrispondenti regioni - sia perquanto riguarda la ricerca fondamentale sia perquanto riguarda il trasferimento di conoscenzee di tecnologie nonché la diffusione della culturascientifica.Le collaborazioni fra tutte le strutture si espli-cano, anche attraverso i rispettivi servizi tecnicie amministrativi, nella cooperazione nell’ambitodegli esperimenti comuni nonché nello scambiodi esperienze tecniche e scientifiche e di ge-stione delle numerose tematiche generali qualil’igiene e la sicurezza sul lavoro, la formazionee le pari opportunità. A titolo di esempio vienemostrata in figura 2.12 la partecipazione (evi-denziata in rosso) delle strutture INFN alla speri-mentazione all’LHC nei quattro maggioriesperimenti.
I Laboratori NazionaliI 4 laboratori nazionali LNL, LNGS, LNF, LNS rap-presentano un’ossatura fondamentale per tuttele iniziative dell’INFN ed in particolare ospitanoinfrastrutture e facilities messe a disposizionedella comunità internazionale.
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
17
Fig.2.12: In rosso, partecipazione delle strutture INFNalla sperimentazione a LHC in ATLAS, CMS, ALICE E LHCb.

lo scopo principale del progetto CNGS (CernNeutrinos to Gran Sasso), il cui primo fascio dineutrini muonici è arrivato nell’agosto 2006 aiLaboratori Nazionali del Gran Sasso dove gliesperimenti OPERA e ICARUS ne registranol’arrivo. OPERA ha già mostrato la prima evi-denza al mondo in modo diretto della oscilla-zione di un neutrino mu in un neutrino tau.L’esperimento ICARUS, un innovativo rivela-tore da 600 tonnellate di Argon liquido, tec-nologia sviluppata da gruppi italiani, continuaa mostrare le eccezionali capacità di fornireuna visione in tre dimensioni degli eventi regi-strati. Di grande rilevanza sono state nel 2011le misure del flusso di neutrini solari dell’espe-rimento Borexino, l’unico al mondo in gradodi misurare in tempo reale i neutrini di piùbassa energia dello spettro solare e uno deidue soli esperimenti al mondo in grado di rile-vare neutrini provenienti dal centro della terra,i geoneutrini, fondamentali per meglio com-prendere la produzione e il trasporto del caloreall’interno del nostro pianeta.Altri temi d’elevato interesse riguardano lostudio di processi rari di decadimenti di parti-celle tramite gli esperimenti GERDA e CUORE.Nel 2011 l’esperimento GERDA ha iniziato lapresa dati, mentre prosegue la costruzione diCUORE. Altro argomento di grande interesseè la caccia alle particelle della materia oscuradell’Universo con gli esperimenti DAMA,XENON 100 e CRESST. Mentre DAMA con-ferma la modulazione annuale del segnalecompatibile con un effetto da materia oscura,Xenon 100 ha mostrato i migliori limiti diesclusione per l’interazione elastica di WIMPsintorno a 50 GeV.
I principali Centri di attività all’esteroLa naturale e sistematica tendenza verso laconcentrazione delle ricerche di fisica subnu-cleare e nucleare presso grandi centri interna-zionali, dotati d’acceleratori di energia eintensità dei fasci di particelle sempre più ele-vate, ha gradualmente intensificato l’attivitàdei ricercatori italiani all’estero, a fronte dellaquale va considerata la notevole presenza diricercatori stranieri nei Laboratori nazionali.Ambedue gli aspetti sono inquadrati nell’am-bito di iniziative multilaterali di collaborazionescientifica tra enti di ricerca di Paesi diversi. Il laboratorio più rilevante per l’attività di ricercadell’INFN all’estero, il CERN - l’Organizzazioneeuropea di fisica subnucleare e nucleare di Gi-
nevra fondata nel 1954 - è oggi il più impor-tante laboratorio al mondo di fisica delle parti-celle con acceleratori.Al CERN opera la macchina acceleratrice LHC(Large Hadron Collider) che rappresenta con isuoi 7 TeV di energia nel centro di massa la fron-tiera dell’energia della fisica subnucleare e apieno regime LHC raggiungerà l’energia finaledi 14 TeV nel centro di massa (il progresso dellafrontiera di tale energia dagli anni ’30 a oggi èraffigurato nella fig. 2.13). L’Italia è tra i suoimaggiori Paesi membri e la partecipazione deigruppi italiani è interamente coordinata dal-l’INFN.Accanto al CERN, molti altri sono i laboratoriesteri nei quali è significativa la presenza del-l’INFN. Una lista, peraltro non esaustiva, diquesti si può evincere dalla tabella 2.1; le atti-vità INFN che vi si svolgono verranno descrittenel successivo capitolo 3.
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
20
raneo (progetto NEMO). Nell’ambito del pro-getto i LNS hanno già realizzato l’infrastrutturasottomarina di Portopalo di Capo Passero, co-stituita dalla stazione di terra (on-shore) colle-gata a un cavo elettro/ottico che termina a 80km off-shore in un vasto plateau a 3500 m diprofondità, sito ideale per l’installazione del te-lescopio. La stazione di terra di Capo Passero ècollegata con la rete GARR a 10 Gbit/s. La col-laborazione italiana guidata dai LNS, partecipaal consorzio europeo KM3NeT, inserito nella ro-admap europea per le grandi infrastrutture di ri-cerca elaborata dall’European Strategy Forumon Research Infrastructures. Il progetto NEMO èd’interesse anche per altre discipline e vede inparticolare la partecipazione dell’INGV.I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (L’Aquila),costituiti da tre grandi sale sotterranee e tunneldi servizio per una superficie totale di 17800m2,
accessibili dall’omonimo tunnel autostradale,sono operativi dal 1988. L’assorbimento dellaradiazione cosmica dovuto alla spessa coperturadi roccia, le grandi dimensioni e le notevoli in-frastrutture di base ne fanno il più grande e im-portante laboratorio al mondo per la rivelazionedi segnali deboli o rari, d’interesse per la fisicaastroparticellare, subnucleare e nucleare.I temi principali di ricerca del laboratorio, fre-quentato da quasi 1000 ricercatori di cui circail 60% stranieri provenienti da tutto il mondo,sono lo studio delle proprietà dei neutrinid’origine naturale o artificiale, in tutti i suoiaspetti: fisici, astrofisici e cosmologici, la ri-cerca diretta di materia oscura dell’Universo, ela misura delle sezioni d’urto dei processi nu-cleari che avvengono all’interno delle stelle. Lostudio della proprietà dei neutrini di trasfor-marsi da una famiglia all’altra (oscillazione) è
PIANOTRIENNALE2012-14/ L’ISTITU
TONAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
19
Fig. 2.13: Evoluzione della frontiera dell’energia per gli acceleratoridi particelle

3. PIANO PROGRAMMATICODI ATTIVITÀ SCIENTIFICA

antimateria, perché oggi non c’è più traccia diquesta antimateria primordiale e perché la ma-teria di cui siamo fatti non è scomparsa nell’an-nichilazione con l’antimateria pochi istantidopo il Big Bang?Più di quarant’anni fa il fisico russo Sacharov ciha detto che la risposta a questi cruciali quesitideve stare nella comprensione della violazionedella simmetria CP. Nuovamente incontriamotracce di nuova fisica al di là dal Modello Stan-dard perché per originare una asimmetria tramateria e antimateria partendo da una situa-zione simmetrica nelle loro rispettive abbon-danze è necessario avere una più potentesorgente di violazione di CP rispetto a quellapresente nel Modello Standard. Più di recenteè stato osservato che proprio le nuove parti-celle responsabili della massa così piccola deineutrini possono essere alla base della soprav-vivenza della materia sull’antimateria. Ecco chei nostri esperimenti sulla fisica relativa alla vio-lazione di CP e sulla fisica del neutrino si ac-compagnano alle teorie di nuova fisica per unaspiegazione dinamica dell’asimmetria cosmicamateria-antimateria (“bariogenesi”). Ma l’an-timateria potrebbe esistere in zone dell’Uni-verso lontane da noi, ecco perché necerchiamo le tracce nei raggi cosmici con espe-rimenti nello spazio, ad esempio sulla StazioneSpaziale Internazionale.
5) Ma ancora la materia stessa continua a porcirilevanti domande: se i costituenti fondamen-tali della materia sono i quark, come si passadai quark ai protoni e neutroni e come da que-sti si arriva ai nuclei degli atomi le cui com-plesse proprietà influiscono sulla nostra vitaquotidiana e che sono state alla base dei feno-meni fisici che 13 miliardi di anni fa seguironoil Big Bang e diedero origine alla prima sintesidi nuclei (“nucleosintesi”)? I vari modelli teoriciche cercano di rispondere a queste domandevengono vagliati in una vasta gamma di espe-rimenti, in particolare nei nostri due laboratorinazionali dedicati alla fisica nucleare, quello diLegnaro e quello del Sud. In questi laboratorisi stanno concentrando notevoli sforzi per laproduzione di nuclei non presenti in natura, inuclei esotici, con i quali si avrà accesso ad una“terra incognita” della materia nucleare, an-cora poco esplorata.
6) E, infine, vi è forse la domanda più difficilee che finora ha fornito alcune delle più sor-
prendenti risposte: di che cosa è fatto il nostroUniverso? Ambiziosamente, noi abbiamo chia-mato “mattoni fondamentali” dell’Universoquelle particelle elementari (quark, elettroni,neutrini) di cui pensavamo fosse fatta tutta lamateria esistente. Ma non è così. Una messe diosservazioni indipendenti tra loro, a partiredallontano 1933, ci confermano che, inaspettata-mente, la materia costituita dai familiari atomirappresenta solo una piccola frazione della ma-teria presente nell’Universo, mentre piùdell’80% di questa è fatta da particelle chenon fanno parte del Modello Standard (la co-siddetta “materia oscura”). È ovvio che com-pito primario di un Ente come l’INFN è cercaredi scoprire che cosa sia la materia oscura. In-fatti da dieci anni almeno la cerchiamo inmodo diretto nei suoi rarissimi urti con nucleiordinari nel laboratorio del Gran Sasso, maanche in modo indiretto con esperimenti spa-ziali o a terra attraverso i prodotti dell’annichi-lazione di materia ed antimateria oscura nellanostra galassia o nel centro del Sole (in parti-colare ricerche di antiparticelle e di fotoni dialta energia negli esperimenti spaziali o digamma-astronomia sulla superficie terrestre oricerca di neutrini in esperimenti sottomarinicome quello in progettazione al largo dellecoste siciliane).Alcuni di questi esperimenti hanno già eviden-ziato degli effetti che potrebbero essere dovutialla “materia oscura” e quindi stiamo guar-dando con grande interesse ai risultati che ver-ranno da LHC. Infatti la materia oscuracostituisce la più formidabile evidenza dellapresenza di nuova fisica, forse quella stessa fi-sica che LHC o le “macchine del flavour” ci ri-veleranno. Il candidato di materia oscura più“accreditato” al momento è proprio la più leg-gera di quelle nuove particelle supersimmetri-che che potremo identificare a LHC.
7) Ma l’Universo non ha finito di sorprendercicon la materia oscura. Ancora più sconvol-gente è stato scoprire che la materia (sia essaquella atomica o quella oscura) non rappre-senta che circa un quarto di tutta l’energia pre-sente nell’Universo. I restanti tre quarti sonochiamati “energia oscura”. L’origine di questapotrebbe essere legata a deviazioni dalla gra-vità descritta dalle teorie di Newton prima e diEinstein poi (relatività generale). Nuove teoriedello spazio-tempo vengono studiate dai teo-rici dell’Ente e intanto sperimentalmente cer-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
24
3.1 L’INFN E LA SUA MISSIONE SCIENTIFICA
La missione dell’INFN è il progresso nella cono-scenza degli aspetti fondamentali dell’Uni-verso, dalle proprietà dei suoi costituentielementari (micro-cosmo) alle sue caratteristi-che sulle scale dei tempi e delle lunghezze piùgrandi (macro-cosmo). Il risultato più rilevantedelle ricerche portate avanti dall’Ente in questiultimi anni è stata una sempre più approfon-dita comprensione dell’unità di fondo dei fe-nomeni relativi alla fisica dei nuclei e deicostituenti subnucleari con quelli relativi al-l’evoluzione dell’Universo (cosmologia) e distrutture su scala cosmica (astrofisica). Questosignificativo progresso è stato indirizzato dallerisposte che la ricerca sperimentale e teoricadell’INFN ha saputo dare o sta cercando di daread alcune fondamentali questioni. Vediamonele principali.
1) Anche grazie all’intenso lavoro svolto dal-l’INFN alle macchine acceleratrici (in particolareal LEP del CERN e più recentemente al Tevatrondel Fermilab), oggi abbiamo accurate verifichesperimentali delle predizioni del Modello Stan-dard delle interazioni fondamentali, teoria chesi basa sulla presenza di una nuova simmetriain natura (la “simmetria elettrodebole”) dallecui proprietà (in particolare la cosiddetta “rot-tura della simmetria elettrodebole”) dipendonole masse e interazioni di tutte le particelle ele-mentari. Quale nuova fisica è legata all’origine dellamassa delle particelle elementari che compon-gono l’Universo? È, questa origine, connessaall’esistenza di una nuova particella elemen-tare, il famoso bosone di Higgs?Quali altre interazioni e mattoni fondamentalidella natura comporta questa nuova fisica?Alle più alte energie mai prima raggiunte, po-tremo vedere il passaggio dai protoni e neu-troni ai quark liberi che li costituiscono? Questaè la “terra incognita” dove hanno cominciatoad avventurarsi gli esperimenti dell’INFN all’ac-celeratore LHC del CERN. È una terra su cui sonoconcentrati i maggiori sforzi teorici dell’Ente: aLHC troveremo un nuovo mondo di mattonifondamentali, le nuove particelle delle teorie su-persimmetriche, oppure vedremo aprirsi nuovedimensioni spaziotemporali al di là del mondoquadridimensionale trasmesso dai nostri sensi,come suggerito dalla fondamentale “teoria del -le stringhe”?
2) Le particelle elementari della materia hannomasse molto diverse tra loro, si mescolano inmodo più o meno intenso e nelle loro intera-zioni violano (anche se di pochissimo) una sim-metria correlata alla presenza di materia eantimateria chiamata CP. Che cosa sta alla basedi tutte queste proprietà fondamentali dellamateria? Pensiamo che la risposta a questoproblema, chiamato problema del flavour, siaracchiusa ancora una volta nella nuova fisicaoltre il Modello Standard, fisica che studieremoa LHC (frontiera dell’alta energia), ma anche inmacchine dedicate allo studio del flavour in cuile energie sono più basse, ma l’intensità (cioèil numero) di particelle che collidono è altissimo(frontiera dell’alta intensità). In particolare il la-boratorio nazionale di Frascati è un importantecentro di studio della fisica del flavour e po-trebbe accrescere la sua rilevanza mondiale nelcampo con il suo coinvolgimento nella costru-zione e fisica di una macchina ad alta “inten-sità” dedicata allo studio del quark chiamatobeauty.
3) Il mattone fondamentale più misterioso: ilneutrino. Curioso destino quello del neutrino,la particella più leggera e che interagisce menodi tutte, ma che racchiude in sé alcune delledomande più fondamentali sull’Universo in cuiviviamo. Dal fenomeno di trasformazione di untipo di neutrino in un altro tipo di neutrino(“oscillazione di neutrini”), sappiamo che ineutrini hanno una massa diversa da zero. Ora,il Modello Standard prevede che i neutrinisiano di massa rigorosamente nulla. Quindi leoscillazioni dei neutrini sono un’inequivocabiletestimonianza di nuova fisica al di là del Mo-dello Standard. Ma quanto vale la loro massa?E il meccanismo che conferisce loro la massa èlo stesso (quello legato al bosone di Higgs) chedà massa a tutte le altre particelle oppuresiamo in presenza di un nuovo meccanismocon nuove particelle? La fondamentale simme-tria CP è violata nelle interazioni dei neutrini?
In particolare, nel nostro laboratorio sotterra-neo del Gran Sasso cerchiamo una risposta aqueste domande guidati dalle predizioni di teo-rie legate a quella nuova fisica già investigatanelle frontiere dell’alta energia e alta intensità. 4) Una delle più profonde domande puntadritto alla nostra esistenza: se nell’Universo pri-mordiale ad altissima temperatura doveva es-serci una pari abbondanza di materia e
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
23

ComposizioneLa partecipazione dei ricercatori dell’INFN agliesperimenti della Commissione 1 è folta. Si trattadi 1000 scienziati, che pesati per la loro percen-tuale di partecipazione costituiscono circa 821FTE (ricercatori e tecnologi Full Time Equivalent),provenienti da tutte le sezioni INFN e ovviamentedal laboratorio specializzato in questo tipo di ri-cerca (Frascati).Nella CSN1 sono rappresentate tutte le tipologiedi ricercatori: i dipendenti dell’Ente, gli universitariassociati alle ricerche, i borsisti e assegnisti e glistudenti che preparano la tesi di Dottorato. Inoltremolti tecnologi (informatici, elettronici, meccanici)fanno anche essi parte dei gruppi di ricerca.La tabella 3.1 fotografa la composizione dellacommissione nell’anno 2011 e fornisce un qua-dro complessivo dei finanziamenti erogati negliultimi tre anni.
EsperimentiGli esperimenti in carico alla CSN1 sono moltie diversi, e mirano a coprire i due filoni princi-pali di ricerca descritti sopra. Un ruolo assolu-tamente preminente in questa momento èoccupato dalla sperimentazione al Large Ha-dron Collider del CERN, che si indirizza allafrontiera dell’energia con gli esperimentiATLAS, CMS, TOTEM e LHCf, mentre LHCb siprefigge lo studio della fisica del flavor a LHC.Questi esperimenti continuano il lavoro svoltoal Tevatron di Fermilab (spento definitivamentenel settembre 2011 dopo 25 anni di operati-vità) dai due esperimenti CDF e D0, che hannoesplorato questo campo fino ad ora. Stanno nel frattempo terminando l’analisi deidati raccolti gli esperimenti che hanno illumi-nato con i loro risultati l’ultimo decennio. Pro-prio CDF al Tevatron è stato tra questi, ponendolimiti sperimentali sempre più stringenti sull’esi-stenza di nuovi fenomeni e raggiungendo inmolti settori risultati di una precisione inattesaper un esperimento che operi ad una macchinaadronica (protone- antiprotone). Un ruolo par-
ticolare hanno avuto poi quelli effettuati alla“fabbrica di B” a SLAC (BaBar), negli USA e aquella di φ a LNF (KLOE), che hanno sfidato di-verse misure di estrema precisione. Altri esperi-menti hanno coperto settori altrettantoimportanti. ZEUS alla macchina elettrone-pro-tone di DESY ha studiato la struttura dei nu-cleoni. Altri sono ancora in presa dati:COMPASS al CERN, che studia la struttura dispin del protone, e MEG al PSI di Zurigo, checerca il decadimento di un muone in un elet-trone e un fotone, un segno inequivocabile diuna fisica al di là del Modello Standard.Oggi e negli anni a venire è comunque il tempodi LHC: il grande acceleratore sta dando agliesperimenti grandi quantità di dati e continueràsenza soste significative fino alla fine del 2012,per poi riprendere dopo una sosta di 18 mesiper raddoppiare l’energia della macchina. La ri-cerca del bosone di Higgs sta dando già ora ri-sultati importanti: l’analisi dei dati di LHCpermettere di escludere il bosone di Higgs inuna regione di massa molto più ampia di quellaprecedentemente riportata dagli esperimenti alTevatron (fig. 3.2) e potrebbe essere possibile lascoperta per la fine del 2012.
La partecipazione italiana agli esperimenti diLHC è estremamente importante: nel 2011circa 650 persone tra ricercatori e tecnologipartecipano agli esperimenti supportati dallaCSN1, il 65% di tutta la CSN1, occupandospesso posizioni di rilievo e di grande respon-sabilità negli organi decisionali delle Collabo-razioni.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
26
FTE INFN staff + art.23,15 (anno 2011) 275FTE Associati staff (anno 2011) 321Assegnisti, borsisti, dottorandi (anno 2011) 225Totale risorse finanziarie spese 2009-2011 (M€) 64,3
di cui spese per investimenti(inventario, apparati) 2009-2011 (M€) 18,5
Linea scientifica CNS1
Tab. 3.1: Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN1
Fig. 3.2: Risultati dell'esperimento CMS sulla ricerca del bosone di Higgs.In funzione della massa del bosone di Higgs viene mostrato il limite al95% di livello di confidenza sulla sezione d'urto di produzione normaliz-zato alla sezione d'urto attesa dal Modello Standard; valori inferiori a 1escludono l'esistenza del bosone di Higgs a quella massa con questo li-vello di confidenza (CERN, 13 dicembre, 2011).
chiamo di osservare per la prima volta una dellecruciali predizioni della relatività generale diEinstein, la presenza di onde gravitazionali. Inparticolare vicino a Pisa l’Ente ha partecipatoalla costruzione e alle misure di un apparec-chio, chiamato interferometro, atto a rivelarele minutissime conseguenze del passaggio diun’onda gravitazionale. La realizzazione dei so-fisticati esperimenti richiesti per esplorare lefondamentali questioni di cui sopra comportalo sviluppo di tutte le tecniche e tecnologie ne-cessarie a tali ricerche, il dar vita a nuovi stru-menti di misura, oltre all’utilizzo delletecnologie di punta già esistenti. Questo sforzodi ricerca tecnologica induce un “circolo vir-tuoso” nei rapporti dell’Ente con le nostre in-dustrie tecnologicamente più avanzate e haimmediate ricadute applicative in settori cru-ciali per la nostra società (ad es. in campo me-dico, in quello energetico, in quello spaziale, inquello sottomarino).La profondità e varietà delle questioni fonda-mentali sopra menzionate spingono l’Ente aduna vasta attività di ricerca che è tuttavia ca-ratterizzata da un unificante denominatore co-mune: la ricerca di nuova fisica lungo le tregrandi frontiere dell’alta energia, dell’alta in-tensità e della fisica astroparticellare.Tre strade che si intersecano in continuazione(per fare un esempio, si pensi alla ricerca di par-ticelle supersimmetriche condotta simultanea-mente e sinergicamente a LHC, nella fisica delflavour e attraverso le ricerche dirette e indi-rette di materia oscura) e che si esplicitanonelle attività delle cinque commissioni scienti-fiche nazionali dell’Ente.La ricerca fondamentale, condotta sia attra-verso la sperimentazione, sia attraverso meto-dologie teoriche, e le ricerche tecnologiche einterdisciplinari correlate, coordinate comples-sivamente dalle cinque commissioni scientifi-che nazionali, trovano il loro completamentoin un insieme di progetti strategici, progettispeciali, progetti inseriti nella programmazioneeuropea, progetti nazionali e infine progetti re-gionali che sono indirizzati sia alle applicazioniverso il mondo sociale-produttivo-economicosia agli sviluppi di frontiera preparatori a futuresperimentazioni per la ricerca fondamentale ocomunque tesi a contribuire alla realizzazionedi infrastrutture per lo “spazio europeo dellaricerca”. Passiamo ora a considerare in qualchedettaglio le specifiche attività e prospettive.
3.2 LA FISICA SUBNUCLEARE
L’attività descritta in questo paragrafo è coordi-nata dalla Commissione Scientifica Nazionale 1(CSN1). La descrizione dettagliata delle attivitàdella CSN1 è disponibile al sito web:www.infn.it/csn1/
MissionePer spingere la frontiera della conoscenza versolimiti sempre più ambiziosi, la sperimentazionein fisica subnucleare moderna utilizza due prin-cipali linee di ricerca complementari. Quella dellafrontiera dell’energia, esemplificata oggi dalLarge Hadron Collider (LHC), l’acceleratore chefornisce l’energia più alta al mondo, e quindipermette la formazione di nuove particelle finorainaccessibili, e quella della fisica del “flavor” incui misure di precisione estrema sono sensibili apossibili effetti dovuti dell’esistenza di nuovi tipidi particelle.Questa seconda linea si sviluppa con esperimentidedicati a più macchine acceleratrici, incluso lostesso LHC; in passato particolare rilevanzahanno avuto le “fabbriche per la produzione dimesoni B” (B factories), PEP-II negli Usa e KEKBin Giappone. Evoluzioni di queste macchine conprospettive d’intensità dei fasci grandemente au-mentata sono in fase di sviluppo in Giappone ein Italia. La fisica subnucleare richiede apparatidi grande dimensione ed estrema complessitàdove trovano applicazione le tecnologie più mo-derne nel campo dei rivelatori, dell’elettronica,dei sistemi di acquisizione dati e di calcolo. Lecollaborazioni che partecipano alla costruzionedi questi apparati sono composte da centinaia(nel caso di LHC, migliaia) di fisici provenienti daistituti e laboratori di tutto il mondo e rappresen-tano degli esempi molto importanti di vera coo-perazione internazionale.Queste collaborazioni sono inoltre dei preziosipunti di accumulazione dove i migliori fisici ditutto il mondo possono entrare in contatto traloro: i giovani possono così acquisire fondamen-tali esperienze nel lavoro di gruppo ad altissimilivelli. In questo contesto i gruppi INFN parteci-pano con contributi di eccellenza, spesso figu-rando nei livelli decisionali degli esperimenti, intutte le fasi del lavoro, dallo sviluppo tecnologicotipico della fase di proposta, passando alle variefasi di costruzione, sino all’analisi dei dati.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
25

• LHCb misura una significativa asimme-tria nella produzione di mesoni charmati;
• LHCb misura la differenza di larghezzae la fase di mixing del mesone Bs conprecisione superiore agli esperimenti alTevatron;
• TOTEM misura la sezione d’urto pro-tone-protone a 7 TeV con precisione del 3%;
• CDF continua a produrre risultati com-petitivi nella ricerca di bosoni di Higgsdi bassa massa;
• CDF misura una significativa asimmetriaavanti-indietro nella produzione di quarktop non prevista dagli attuali modelli;
• MEG aggiorna l’analisi con la statisticaraccolta nel 2010 e pone il miglior limiteal mondo sul rapporto di decadimentodel mesone �in elettrone e fotone.
Prospettive e scenariLHC produrrà fisica per ben più di un decennioa venire e questa è la certezza della CSN1 per ilfuturo. Ci si aspetta innanzitutto la scoperta delbosone di Higgs, la verifica cioè di gran lungapiù attesa del Modello Standard, la cui rivela-zione costituirebbe un enorme passo in avantiverso la comprensione della struttura del micro-cosmo. Se il bosone non fosse osservato, sa-rebbe necessario rivisitare buona parte dellenostre attuali teorie.Il secondo, ma non meno importante, obiettivoè di riuscire a osservare particelle di quella materiache le misure astrofisiche sull’Universo ci indicanocome abbondante, addirittura cinque volte mag-giore di quella di cui sappiamo dare una spiega-zione e della quale è fatto il mondo in cuiviviamo. Sono particelle che formano quella chechiamiamo Materia Oscura, che non conosciamoe che speriamo siano osservabili tra i prodottidelle collisioni con gli esperimenti a LHC.E in particolare (ma non solo) da LHCb ci siaspetta poi un contributo fondamentale allacomprensione del perché della assenza della an-timateria, che all’inizio dei tempi esisteva inquantità uguale alla materia e successivamenteè scomparsa. Non è un fatto di poco conto,visto che noi dobbiamo la nostra stessa esi-stenza a questo fenomeno.E come è stato per ogni acceleratore, che apreuna nuova frontiera di energia, con i suoi espe-rimenti si spera di esplorare l’ignoto e rivelare lesorprese che esso potrebbe nascondere.Oltre a questa robustissima base ci saranno treesperimenti che cercheranno Nuova Fisica attra-
verso i sottili effetti che essa potrebbe indurre aenergie più basse: MEG a PSI (Paul Scherrer In-stitute) in Svizzera, che sta pianificando un si-gnificativo potenziamento, NA62 al CERN, chesta completando la fase di costruzione, e KLOEa LNF.Quest’ultimo esperimento ha iniziato una se-conda campagna di raccolta dati la cui duratadipenderà dalla qualità del funzionamento del-l’acceleratore DAFNE, la cui affidabilità si è ri-dotta a causa dell’invecchiamento di molti deisuoi componenti dopo oltre dieci anni di funzio-namento; è comunque in corso un intenso pro-gramma di sostituzione delle parti più critiche.DAFNE è stato inoltre recentemente modificatoper aumentarne significativamente le presta-zioni, grazie a una soluzione molto innovativasulla configurazione dell’ottica dei fasci.Questa innovazione ha portato al disegno con-cettuale di un acceleratore che sarà il successoredelle “fabbriche di B” del decennio scorso, PEP-II e KEKB, e che sarà complementare a una mac-china analoga in costruzione in Giappone.Questo acceleratore, che supererà di un fattore100 le prestazioni del passato, sarà realizzatonell’area dell’Università di Tor Vergata e costi-tuirà un elemento di primato per la fisica delleparticelle italiana.Questo progetto è stato approvato e ne è ini-ziato il finanziamento da parte del MIUR. Que-sta nuova iniziativa influenzerà certamentel’evoluzione delle risorse, finanziarie e umane,della CSN1. La frontiera dell’energia e la fisica del flavor ri-marranno quindi il campo di ricerca della CSN1a breve, medio e lungo termine. LHC ci pro-mette infatti ben più di un decennio di lavorofruttuoso e nel prossimo decennio la ricerca inItalia sarà anche illuminata dall’esistenza dellamacchina regina della fisica del flavor (SuperB).Se rimane chiaro che i risultati di fisica di LHCindicheranno i passi successivi di questa ricerca,risulta altresì evidente che le ricerche svolte allaSuperB in sinergia con la fisica di LHC costitui-ranno un cruciale volano di sviluppo per la no-stra esplorazione e comprensione della nuovafisica al di là del Modello Standard. La conoscenza degli angoli di mescolamento trai quark al livello del percento, lo studio di nuovemanifestazioni di violazione di CP nei decadi-menti del quark b, lo studio di processi rarissimimai prima osservati sia nella fisica del b che deimesoni tau e mu ci permetteranno sia di com-prendere meglio la natura della nuova fisica che
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
28
In riferimento al personale e al budget, LHCcostituisce l’impegno primario e assorbe il54% delle risorse della CSN1. La spesa glo-bale sostenuta per questi esperimenti sino adora (su un periodo di più di 10 anni) rag-giunge i 250 M€. Nel periodo 2009-2011, persostenere la fine delle costruzioni, la messa inopera e il funzionamento, la CSN1 ha dedi-cato il 56% del suo budget (quindi circa 36M€) a LHC.Questo grande impegno, umano e finanziario,si riflette nei contributi che i ricercatori italianihanno dato alla costruzione dei giganteschiapparati di LHC. La realizzazione di questi co-lossi ha comportato una lunga fase di ricercae sviluppo, realizzata spesso in collaborazionecon industrie nazionali.L’eccellenza dei risultati raggiunti ha permessoai gruppi italiani di acquisire posizioni di rilievonella costruzione di gran parte degli apparatisperimentali e anche l’aggiudicazione di im-portanti commesse alle industrie stesse.Un esempio preclaro di quest’ultimo risultatoè la realizzazione da parte di Ansaldo ASG siadel solenoide di CMS sia del magnete toroi-dale di ATLAS, rispettivamente il più potente eil più grande magnete superconduttore maicostruito. I ricercatori italiani hanno realizzatopoi frazioni importanti dei tracciatori internidegli esperimenti, dei calorimetri e dei traccia-tori esterni per muoni, insieme alla corrispon-dente elettronica di lettura e di trigger. L’acceleratore è ora operativo alla energia nelcentro di massa di 7 TeV e ha raggiunto unaluminosità di picco di 3.6 x 1033 cm-2s-1 supe-rando le previsioni iniziali. Gli esperimentihanno già raccolto una notevolissima quantitàdi eventi che hanno permesso non solo di ve-rificarne il corretto funzionamento ma anchela produzione di risultati di fisica sia nell’am-bito del Modello Standard che della ricerca dinuova fisica.In particolare segnaliamo i nuovi limiti inferiorisulla massa di eventuali particelle supersimme-triche, come ad esempio mostrato nella figura3.3, e la recente misura, da parte di LHCb, deiparametri che regolano la violazione della sim-metria di CP nel decadimento del mesone Bs,mostrata in figura 3.4.La tecnologia di calcolo basata su Grid si è di-mostrata funzionale. Gli esperimenti hanno ri-costruito gli eventi raccolti in tempo reale e leanalisi fisiche sin qui condotte hanno dimo-strato la funzionalità del complesso sistema di
gestione della grande quantità di dati raccolti.
HIGHLIGHT del 2011 • ATLAS e CMS rimisurano il modello stan-dard con precisioni comparabili ai pre-cedenti esperimenti al Tevatron;
• ATLAS e CMS escludono l’esistenza delbosone di Higgs in un’ampia regione dimassa;
• ATLAS e CMS mettono i limiti inferioripiù alti al mondo sulla massa delle par-ticelle supersimmetriche;
• LHCb e CMS mettono il miglior limite sulrapporto di decadimento BR(B→μ+μ−);
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
27
Fig. 3.3: Limiti alla massa di squarks e gluini ottenuti dall’esperimentoATLAS (linea arancione) confrontati con i precedenti risultati ottenuti aLEP e al Tevatron (CDF e D0) (HCP, Parigi, Novembre 2011).
Fig. 3.4: Misura della differenza di larghezza e della fase di mixing delmesone Bs a LHCb confrontata con i precedenti risultati ottenuti al Teva-tron (HCP, Parigi, Novembre 2011).

presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso(LNGS). Questo settore comprende esperi-menti con sorgenti naturali come i neutrinisolari (es BOREXINO), o con fasci di neutriniartificiali (OPERA, ICARUS-T600, T2K);
• Lo studio dei processi rari si svolge anch’essoprincipalmente ai LNGS. Questo settore com-prende gli esperimenti per la materia oscura(DAMA, WARP, XENON), per il doppio deca-dimento beta senza neutrini (CUORE, GERDA)e per la ricerca di neutrini provenienti da collassi gravitazionali stellari (LVD);
• Lo studio dei raggi cosmici a terra si svolgecon esperimenti ad alta quota o sottomarini.Questo settore comprende esperimenti suiraggi gamma (ARGO, MAGIC), sui raggi co-smici di altissima energia (AUGER) ed il nuovosettore dell’astronomia neutrinica (ANTARES,NEMO);
• Lo studio della radiazione cosmica con espe-rimenti nello spazio comprende l’astronomiacon i raggi gamma di alta energia (AGILE,FERMI) la ricerca di antimateria primordiale elo studio della composizione dei raggi cosmici(PAMELA, AMS02). Gli esperimenti spazialisono realizzati in collaborazione con l'Agen-zia Spaziale Italiana (ASI);
• La ricerca diretta delle onde gravitazionali èsvolta utilizzando esperimenti a barre crioge-niche (AURIGA, ROG), oppure i moderni rive-latori interferometrici a terra (VIRGO) e nellospazio (LISA-Path Finder);
• Lo studio della fisica fondamentale: questosettore comprende esperimenti sulla gravitàe sulle proprietà del vuoto quantistico.
Principali risultati ottenuti nel 2011Lo studio dei messaggeri dell’Universo, le varieforme della radiazione cosmica, che vanno dalleparticelle cariche e dai neutrini alla radiazione elet-tromagnetica e alle onde gravitazionali, rappre-senta un settore che in questi anni vede uncontinuo, significativo progresso grazie ad uncontinuo flusso di nuovi risultati sperimentali. Nelseguito è presentato un breve sommario del con-suntivo scientifico del 2011, con l’obiettivo di de-lineare lo stato delle linee di ricerca senzanecessariamente elencare tutte le attività in corso.Lo studio delle proprietà del neutrino è uno deitemi portanti della fisica astroparticellare. Neglianni ’90 lo studio dei neutrini atmosferici haportato alla scoperta del fenomeno delle oscil-lazioni tra i diversi tipi di neutrini, scoperta pre-miata con il Nobel nel 2002. Questo fenomeno
è studiato ai Laboratori del Gran Sasso sia con ineutrini solari (esperimento BOREXINO) che conil fascio di neutrini provenienti dal CERN (pro-getto CNGS, esperimento OPERA ed esperi-mento ICARUS). Il 2011 ha portato a dei risultati di grande rile-vanza in questo settore. In Italia la misura di pre-cisione da parte di BOREXINO del flusso deineutrini solari della sequenza del 7Be ed il limitesull’asimmetria giorno/notte, misure che hannopermesso di validare in modo indipendente l’ “effetto materia” nelle oscillazioni di neutrino,nel caso del Large Mixing Angle (LMA); la rive-lazione da parte di ICARUS del primo spettro dineutrini interamente misurato nell’argon li-quido; la misura preliminare da parte dell’espe-rimento OPERA della velocità superluminale deineutrini del fascio CNGS (Cern – Gran Sasso),che ha trovato confutazione in seguito ad accu-rate verifiche da parte della stessa collabora-zione OPERA di esperimenti LVD e OPERAhanno inoltre presentato risultati sulla velocitàdei muoni cosmici, evidenziando la possibile sor-gente di errore nella precedente misura della ve-locità dei neutrini di OPERA.L'esperimento OPERA, principale utilizzatore delfascio di neutrini del CNGS per lo studio delleoscillazioni νμ→ ντ, ha continuato nel 2011 adaccumulare statistica. Il fascio CNGS ha otte-nuto risultati particolarmente positivi in questoperiodo, offrendo ~ 5 1019 pot nel corso di 223giorni: nel periodo 2008-2011 il CNGS ha for-nito 12,7 1019 pot, oltre il 50% del valore di pro-getto pari a 22,5 1019 pot. La decisione diestendere le operazioni di LHC fino alla fine del2012 dovrebbe consentire di raggiungere, conun fascio CNGS operante in condizioni stabili,una luminosità integrata vicina al valore di pro-getto. L'analisi dei dati OPERA procede costan-temente e siamo in attesa di nuovi risultatirelativamente alle oscillazioni νμ→ ντ.In Giappone, l'esperimento T2K, che vede lapartecipazione dell’INFN, ha invece osservato laprima evidenza dell’oscillazione νμ→νe, un fe-nomeno che è sensibile all'angolo di mixing θ13,l'unico parametro rimasto ancora sconosciutonella matrice che mescola i tre tipi di neutrini.Utilizzando solo 1,4 1020 protoni su bersaglio(pot), che corrisponde solo al 2% della statisticaattesa, sono stati osservati 6 candidati, da con-frontare con 1,5 eventi di fondo attesi. L'osser-vazione corrisponde ad un effetto di 2,5 σ. Unavolta che l’acceleratore J-PARC riprenderà leoperazioni dopo il terribile terremoto che ha col-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
30
cominceremo ad osservare a LHC sia, addirit-tura, di estendere il territorio della nuova fisicaesplorata da LHC mostrandoci segnali relativi anuove particelle oltre il TeV attraverso i loro ef-fetti quantistici di tipo virtuale. Inutile dire chela pazienza è d’obbligo e che il futuro verrà di-segnato da quanto scoperto a LHC. Per fare unesempio, le misure di precisione necessarie a ca-pire la natura della eventuale Nuova Fisica sve-lata a LHC, potrebbero richiedere, oltre allaSuperB, la costruzione di un Linear Collider elet-trone-positrone, per il quale un vigoroso pro-gramma di ricerca e sviluppo è in corso da moltianni e la comunità è ben preparata.Si tratterà dunque dal punto di vista del finan-ziamento di trovare risorse aggiuntive a quellenecessarie allo sfruttamento ottimale degli espe-rimenti a LHC che già ora assorbono buonaparte del bilancio della Commissione e che neiprossimi tre anni vedranno il completamento deirivelatori con quelle potenzialità mancanti allapartenza e vedranno anche la necessità di di-spiegare tutta la potenza di calcolo necessariaper l’analisi dei dati.Abbiamo di fronte tre anni di capitale impor-tanza per la fisica delle particelle agli accelera-tori. LHC coprirà l’intero range di possibilità dimassa per il bosone di Higgs e quindi la sua sco-perta è una delle attese. Una vasta porzione dispazio delle fasi per le particelle supersimmetri-che verrà coperto e quindi è possibile ipotiz-zarne la scoperta. Grazie a LHCb nuovi limitiverranno esplorati nel campo della fisica del Bin attesa che la SuperB e/o un Linear Colliderprenda il testimone e spinga ancora oltre lafrontiera della conoscenza.
MILESTONE del periodo 2012-2014• Raccolta di una luminosità integrata aLHC (CERN) negli anni 2012 e 2014 chepermetterà ai grandi esperimenti ATLASe CMS di verificare la validità del ModelloStandard attraverso la scoperta (o il suocontrario nel caso di assenza) del bosonedi Higgs. Ricerca di particelle di Nuova Fi-sica fino a scale di massa superiori al te-raelettronvolt;
• Analisi dei dati raccolti dall’esperimentoLHCb al LHC per la misura della probabi-lità di decadimento di un mesone Bs inuna coppia muone antimuone che costi-tuisce un test molto importante per ilModello Standard;
• Completamento della costruzione di
NA62 (CERN) negli anni 2012 e 2013 e ini-zio della presa dati nel 2013 per la misuradel decadimento ultrararo K+→ π+ νν;
• Costruzione nel 2012 con presa dati apartire dal 2013 di nuovi rivelatori del-l’esperimento COMPASS (CERN) per unanuova campagna volta allo studio dellafunzione di struttura traversa dei partoniche dovrebbe gettare luce sul problemadella costruzione dello spin del protonea partire da quello dei suoi costituenti;
• Compimento del ciclo di misure dell’espe-rimento MEG (PSI) che ha la possibilità ditrovare il decadimento muone in elet-trone-fotone che costituirebbe la provadell’esistenza di una fisica al di là del Mo-dello Standard;
• Compimento del ciclo, venticinquennale,di misure dell’esperimento CDF (Fermi-lab) con la possibiltà di trovare evidenzadel bosone di Higgs in un appropriato in-tervallo di massa;
• Inizio della costruzione del rivelatore perl’acceleratore SuperB.
3.3 LA FISICA ASTROPARTICELLARE
L’attività descritta in questo paragrafo è coordi-nata dalla Commissione Scientifica Nazionale II(CSN2). La descrizione dettagliata delle attivitàdella CSN2 è disponibile al sito web:www.infn.it/csn2/
Missione e strumentiLa comprensione delle proprietà dei neutrini, la ri-velazione diretta delle onde gravitazionali, l’iden-tificazione dei costituenti della materia oscura, laspiegazione dell’assenza dell’antimateria nell’Uni-verso e lo studio della radiazione cosmica costi-tuiscono oggi alcuni tra gli obiettivi fondamentalialla frontiera della fisica fondamentale e corri-spondono agli obiettivi scientifici della CSN2.Queste ricerche si svolgono spesso in particolariambienti, naturali (es. spazio, profondità del mare)o artificiali (es. laboratori sotterranei), in modo daottimizzare il rapporto tra segnale e fondo. Le attività della CSN2 possono essere divise in 6linee scientifiche: fisica del neutrino, ricerca di fe-nomeni rari, radiazione cosmica in superficie esotto il mare, radiazione cosmica nello spazio,onde gravitazionali e fisica generale:
• La fisica del neutrino si svolge principalmente
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
29

FERMI conferma la crescita della frazione di posi-troni oltre i 100 GeV osservati per la prima voltada PAMELA.
PAMELA ha proseguito senza problemi il suoquarto anno di attività nello spazio, fornendomisurazioni di alta precisione della composi-zione dei raggi cosmici e del loro spettro ener-getico. In particolare sono stati ottenuti duenuovi importanti risultati: l'osservazione di unimprevisto cambiamento della pendenza spet-trale di protone ed elio ad energie superiori a200 GeV e l'osservazione di una fascia di anti-protoni intrappolati nelle fasce di Van Allen,misurati all'interno dell’Anomalia del Sud A -tlantico. Gli antiprotoni intrappolati in questafascia hanno una intensità di flusso 1000 voltesuperiore a quello di origine galattica, a testi-monianza di un efficace meccanismo di accu-mulo ed intrappolamento nel campo ma gneticoterrestre, probabilmente causato dal decadi-mento degli antineutroni prodotti nelle intera-zioni dei raggi cosmici con l’atmosfera ter restre.
Il 16 maggio 2011, il rivelatore AMS-02 è statomesso in orbita sulla Stazione Spaziale Inter-nazionale (ISS) durante la missione STS-134dello Shuttle, da dove ha iniziato a raccoglieredati maggio.Dopo quasi 17 anni di preparazione ed esat-tamente un secolo dopo la scoperta dei raggicosmici da parte di Victor Hess, il grande spet-trometro magnetico per la ricerca dell’ antima-teria ha iniziato le sue misure.Con la sua grande accettanza e la decennaleoperatività, AMS-02 fornirà un sostanziale au-mento in sensibilità nella ricerca nei raggi co-smici di fenomeni rari e/o nuovi.
Nel settore della radiazione cosmica da terraci sono stati molti risultati importanti sui raggigamma, la misura dei raggi cosmici di energiaestrema (EECR) e l'astronomia neutrinica. Nel settore dei raggi gamma di alta energia idue telescopi Cerenkov del rivelatore MAGICoperano ora in modalità stereo, con una sensi-bilità significativamente più alta per i raggigamma di bassa energia: la soglia è attualmenteal di sotto dei 50 GeV, la più bassa per questotipo di rivelatori, permettendo a MAGIC di so-vrapporre i suoi risultati con le misure di rive-latori spaziali come FERMI.Un gran numero di risultati sono stati ottenutidall’esperimento ARGO in Tibet, tra cui leprime osservazioni del Granchio e di altriemettitori di gamma di altissima energia conun rivelatore di superficie.
ARGO ha inoltre osservato l’esistenza di una ina-spettata anisotropia nel flusso dei raggi cosmicia livello di frazioni di per mille. Una spiegazione
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
32
Fig. 3.8: Spettro del flusso di protoni e nuclei di elio cosmici, registratodall’esperimento satellitare PAMELA - in orbita dal Giugno 2006.
pito il Giappone nel marzo 2011 vi è ampio spa-zio per determinare con precisione il valore diθ13, migliorando notevolmente la statistica. Ilriavvio dell’attività sperimentale a J-PARC è pre-visto per l'inizio del 2012.
Sempre ai LNGS, ICARUS T600 sta registrando,da più di un anno, gli eventi prodotti dal fasciodi neutrini CNGS. È la prima volta che un granderivelatore ad Argon liquido è utilizzato per unlungo periodo come "camera a bolle" per neu-trini: questo tipo di rivelatore ha la massa suffi-cientemente grande per rivelare le interazionedei neutrini, ma allo stesso tempo è in grado difornire un’immagine 3D ad alta risoluzione deglieventi prodotti.
Questa tecnologia, inventata da Carlo Rubbia esviluppata negli ultimi dieci anni dall'INFN, è par-ticolarmente adatta a sviluppare una nuova ge-nerazione di rivelatori di neutrini, rivelatori dimateria oscura o rivelatori di decadimento delprotone.
La determinazione della massa del neutrinoè un altro tema importante in fisica del neutrino:se i neutrini sono particelle di Majorana, la massadel neutrino può essere determinata tramite ildoppio decadimento beta senza neutrini nellostato finale (0ν2β). L’INFN sta sviluppando dueesperimenti volti a rilevare il decadimento 0ν2β:un rivelatore di medie dimensioni che nel 2011è entrato in funzione e che utilizza cristalli di ger-manio (GERDA e in previsione GERDA II) e un rive-latore di grandi dimensioni in fase di costruzione(CUORE), composto da circa 1000 bolometri crio-genici di ossido di tellurio, in grado di miglioraredi circa un ordine di grandezza la sensibilità deirivelatori oggi in funzione. La costruzione diCUORE, che vede una significativa partecipa-zione degli Stati Uniti, dovrebbe essere comple-tata nel 2014.
Studio diretto della radiazione cosmica nellospazio.Nel 2011 i rivelatori satellitari AGILE e FERMIhanno osservato significative variazioni di intensitànella Nebulosa del Granchio, una fonte di raggigamma che è stata sempre considerata come unacandela di riferimento per i raggi gamma. Perquesta importante misura AGILE ha ricevuto ilpremio Bruno Rossi per il 2011, un premio asse-gnato ogni anno dall’American Astronomic So-ciety, il riconoscimento internazionale più ambitonel campo della fisica astroparticellare delle alteenergie. Durante questo periodo FERMI ha pub-blicato numerosi lavori scientifici di alto livello, al-cuni dei quali molto rilevanti per la fisica delleastroparticelle. In particolare, ha esteso la misuradel rapporto positroni/elettroni fino a 250 GeV,sfruttando abilmente il campo magnetico terre-stre come spettrometro di carica. Il risultato di
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
31
Fig. 3.5: Prima evidenza dell’oscillazione dei neutrini νμ→νe, osservata inGiappone dall'esperimento T2K che vede la partecipazione dell’INFN.
Fig. 3.6: Crescita del valore di luminosità integrata di CNGS dal 2008al 2011.
Fig. 3.7: Interazione di un νμ del CNGS osservata dal rivelatore ICARUSal LNGS
Fig. 3.9: L’esperimento AMS-02, installato sulla Stazione Spaziale In-ternazionale nel Maggio 2011
Fig. 3.10: Anisotropia nei raggi cosmici a energie dell’ordine del TeV, os-servata dall’esperimento ARGO, in Tibet.

MICRA, basati sull’impiego dell’interferometriaatomica nei condensati di Bose Einstein, suscitamolto interesse a causa della potenziale sensi-bilità di queste tecniche che potrebbero permet-tere di ridurre la complessità degli interferometrilaser per le onde gravitazionali. Lo studio delleproprietà del vuoto quantistico è un altro temadi interesse della Commissione con gli esperi-menti MIR, dedicato allo studio dell’ effetto Ca-simir dinamico e PVLAS dedicato alla misuradella birifrangenza quantistica del vuoto.Nel settore spaziale, il lancio del satellite LARES,progettato per testare accuratamente l’effettoLense-Thirring, e previsto per l’inizio di febbraio2012, permetterà un grande miglioramentodella sensibilità dei test di relatività generale.
Caratteristiche delle attività di ricerca della CNS2I risultati ottenuti dalla comunità italiana nel set-tore astroparticellare rappresentano il risultato diun continuo sviluppo tecnologico e di una accu-rata pianificazione, in cui esperimenti esploratividi prima generazione precedono i grandi esperi-menti dotati di sensibilità molto maggiore ma chenaturalmente richiedono maggiore impegno eco-nomico e maggiori garanzie di ritorno scientifico.Date le dimensioni e la complessità di tali esperi-menti, essi sono svolti nell’ambito di collabora-zioni internazionali, sia in ambito europeo cheglobale. Molti esperimenti astroparticellari preve-dono tempi di misura molto lunghi. Si tratta di verie propri osservatori che ricercano fenomeni rari,che hanno origine al di fuori della Terra: neutrinidal Sole, particelle di origine cosmologica, esplo-sioni di supernovae, eventi rari nella radiazionecosmica ordinaria, impulsi di onde gravitazionali.In questi casi quindi la programmazione e l’effet-tuazione degli esperimenti procede in modi diversida quelli tipici degli esperimenti agli acceleratorie richiede una grande flessibilità. Le misure dieventi molto rari implicano sensibilità non otteni-bili in presenza del rumore di fondo causato neirivelatori da eventi indotti dai raggi cosmici: i La-boratori Nazionali del Gran Sasso, che fornisconouno schermo adeguato ai raggi cosmici ordinari,sono la sede ideale per questi esperimenti dipunta. L’elevato numero di fisici italiani e stranieriche operano nei LNGS dimostra il ruolo mondialedi questi laboratori nelle ricerche in corso. L’atti-vità spaziale dell’INFN ha raggiunto nel 2011 deirisultati scientifici di assoluta importanza, chehanno fornito all’Istituto visibilità e leadership in-ternazionali.È confermata la rilevanza di questo settore nel-
l’ambito delle attività della CSN2, settore su cuil’Istituto è impegnato dalla metà degli anni ’90,nell’ambito di una forte collaborazione con l’ASI.Gli sviluppi nel settore della strumentazione nellospazio realizzati dall’INFN in collaborazione conl’industria nazionale sono sorgente di ricadute ap-plicative e arricchimento tecnologico con impor-tanti risvolti per la competitività del sistemaindustriale nazionale.La composizione del personale e le risorse finan-ziarie sono descritte in tabella 3.2.
Prospettive a medio termineGli investimenti fatti dall’Istituto nei settori di ri-cerca della CNS2, hanno posizionato in modoottimale l’Istituto a livello internazionale. Gliesempi più significativi sono probabilmente i La-boratori del Gran Sasso, VIRGO, ed il settorespaziale. Le prospettive della ricerca delle ondegravitazionali dopo l’upgrade dell’interferome-tro di Cascina riguardano la realizzazione di unfuturo grande laboratorio europeo ma, allostesso tempo, vedono il settore spaziale prota-gonista con il progetto LISA Pathfinder.I Laboratori del Gran Sasso sono attualmente ilaboratori sotterranei migliori al mondo: oltrealle importanti ricerche nel settore della fisicadel neutrino e delle sue oscillazioni, una forteattività nel settore della ricerca della materiaoscura e dei decadimenti ultrarari sono proba-bilmente le direzioni lungo cui si svilupperannole attività sperimentali di questa infrastruttura diricerca, rispondendo in questo modo ad unaspecifica richiesta della comunità internazionale.Nel settore spaziale, la messa in orbita di AMS-02 permetterà di effettuare un progresso so-stanziale nella ricerca delle componenti rare deiraggi cosmici. Lo studio dei raggi cosmici a energie estreme rap-presenta infine una consolidata linea di sviluppodell’INFN, con esperimenti sia a terra (AUGER) chein prospettiva nello spazio (JEM-EUSO).L’approvazione del progetto KM3NET, a Cata-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
34
FTE INFN staff + art.23,15 (anno 2011) 153FTE Associati staff (anno 2011) 260Assegnisti, borsisti, dottorandi (anno 2011) 198Totale risorse finanziarie spese 2009-2011 (M€) 42.12
di cui spese per investimenti(inventario, apparati) 2009-2011 (M€) 9.86
Linea scientifica CNS2
Tab. 3.2: Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN2.
convincente di questi effetti non è ancora stataproposta. Dal suo completamento alla fine del 2008, ilgrande rivelatore Auger in Argentina ha funzio-nato senza interruzioni, confermando con sem-pre maggiore evidenza l’esistenza del cutoffprevisto da GZK. L’altra importante indicazionesperimentale ottenuta con i dati 2010, ovvero-l’evidenza della presenza di sorgenti di raggi co-smici di altissima energia (EECR), non è statainvece confermata con l’aumentare della stati-stica, e ad oggi è piuttosto debole (2-3 σ). Nelle profondità del mare Mediterraneo il tele-scopio per neutrini ANTARES ha continuato aprendere dati con tutti e 12 le torri di rivelazionein condizioni di funzionamento stabile. Alla finedel 2011 è stato approvato su fondi PON il pro-getto KM3NET presso il laboratorio del Sud del-l’INFN (LNS): si tratta della realizzazione, neiperiodo 2012-2014, di 20 torri da installarenelle acque del mar Ionio, di fronte a Capo Pas-sero. Si tratta del primo passo importante per larealizzazione di un rivelatore sottomarino digrande volume in grado di affrontare la ricercadi neutrini di origine galattica.
Nel settore della ricerca della materia oscurasono in corso ricerche sia di tipo diretto, pressoi LNGS, che indiretto, con esperimenti nello spa-zio e a terra. Nel 2009, studiando accuratamentela composizione dei raggi cosmici carichi nello spa-zio, prima che vengano assorbiti dalla nostra atmo-sfera, il satellite PAMELA ha ottenuto indicazioni dinuovi fenomeni fisici che potrebbero confermarel’esistenza di una componente dominante dellamassa dell’Universo composta da particelle chenon emettono luce, la cosiddetta materia oscura.Queste indicazioni si aggiungono ai risultatidelle misure effettuate nel corso dell’ultimo de-cennio dall’esperimento DAMA nei Laboratorisotterranei del Gran Sasso.Si tratterebbe di unnuovo tipo di materia dalle 6 alle 8 volte più ab-bondante di quella di cui siamo composti. Que-sta linea di ricerca vede l’INFN alla frontieradella competizione internazionale: negli annifuturi, nuovi esperimenti dell’INFN a terra(XENON1t approvato nel 2011 e DARK-SIDE incorso di approvazio ne) e nello spazio (AMS-02, lanciato nel 2011) nonché le misure a LHCdaranno un contributo auspicabilmente deci-sivo alla comprensione di questo importantis-simo problema della fisica con temporanea.
Per quanto riguarda in particolare la ricerca diretta
della materia oscura, il Laboratorio del Gran Sassoè il riferimento mondiale per questo tipo di ricer-che, ospitando 4 tra gli esperimenti più importantiin questo campo, DAMA/LIBRA, XENON100,CRESST e, prossimamente, DARK-SIDE.DAMA/LIBRA è un rivelatore basato su scintillatoria bassissimo fondo di NaI: nel 2011 DAMA haproseguito la presa dati con dei nuovi fotomolti-plicatori che garantiranno una migliore sensibilitànella regione critica al di sotto di 2 keV. Ad oggiDAMA è ancora l'unico esperimento che mostraun chiaro effetto (9 σ) di modulazione stagionale,che potrebbe essere dovuto alla materia oscura.Nel 2011, tuttavia, l'esperimento US Cogent an-nunciato una prima evidenza per un analogo ef-fetto di modulazione, in questo caso con unrilevatore di germanio. Questa misura richiede unmiglioramento della significanza statistica, ma èevidentemente importante, poiché sarebbe laprima conferma indipendente delle misure diDAMA, misure che sono ancora al centro di undibattito all’interno della comunità internazionale.Nel 2011 è stata approvata la partecipazionedell’INFN all'esperimento XENON100 e al futuroesperimento XENON1t. XENON100 ha presen-tato un miglioramento statistico di dieci volte ri-spetto ai dati pubblicati nel 2010: conun’espo-sizione di 100,9 giorni x 62 kg, sono stati osservati3 eventi nella regione del segnale, contro 1, 8eventi di fondo attesi. Questa misura rappresentaattualmente il migliore limite sulla materia oscuraottenuto con esperimenti basati su liquidi crioge-nici. Nel corso del 2011 il Consiglio Direttivo del-l’INFN ha approvato la partecipazione italianaall'esperimento XENON1T presso i LNGS, confer-mando il ruolo di leader mondiale dei LNGS nelsettore della Materia Oscura.
La rivelazione diretta delle onde gravitazionali,previste dalla relatività generale, è una dellegrandi sfide della fisica sperimentale contempo-ranea: nel 2009 è iniziato il potenziamento del-l’interferometro VIRGO a Cascina, strumentoche nel 2014 dovrebbe raggiungere la sensibilitànecessaria per l’osservazione di onde gravitazio-nali da terra (progetto Advanced VIRGO, AV). Apartire dall'estate 2011 e fino al 2014 l'interfe-rometro VIRGO non sarà operativo: per questomotivo l’INFN manterrà in funzione due delle trebarre criogeniche, Nautilus e Auriga; la terza,Explorer, è stata chiusa alla fine del 2010.
Nel settore della Fisica Generale lo sviluppo diesperimenti ultrasensibili come MAGIA e
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
33

Tali attività sono sostenute con gli appositi fondiper la formazione messi a disposizione dall’INFN.
3.4 LA FISICA NUCLEARE
L’attività descritta in questo paragrafo è coordi-nata dalla Commissione Scientifica Nazionale III(CSN3). La descrizione dettagliata delle attivitàdella CSN3 è disponibile al sito web:www.infn.it/csn3/
Attività di ricercaI progetti di Fisica Nucleare dell’INFN realizzatipresso i laboratori nazionali ed esteri (tra cui ilCERN) vedono il forte coinvolgimento dei ricer-catori italiani in ambito internazionale con ruolidi responsabilità e seguono orientamenti forte-mente sostenuti dall’ESF (European ScienceFoundation) attraverso il NuPECC, comitato diprogrammazione europeo a cui l’INFN partecipa.L’obiettivo scientifico della Fisica Nucleare mo-derna è quello d’indagare l’origine, l’evoluzione,la struttura dei nuclei e dei loro costituenti (dettiadroni) e le diverse fasi della materia nucleare.Questa missione rappresenta una sfida molto im-pegnativa e richiede la risposta a una serie di do-mande chiave relative alla genesi dell’Universo ealla nucleosintesi primordiale nonché alla com-prensione del meccanismo di formazione deglielementi dalle esplosioni stellari. l tema unifi-cante è quello di comprendere come oggetticomplessi a molti corpi possano essere ricondottia ingredienti semplici come i loro costituenti, leloro interazioni, le proprietà di simmetria e leleggi di conservazione. La descrizione di questisistemi richiede modelli teorici diversi a secondadella scala considerata: il modello a quark per icostituenti del nucleo (nucleoni), i modelli acampo medio (shell e collettivi) con interazionitra nucleoni microscopiche o efficaci per i nuclei(vedi fig. 3.11).Seguendo la classificazione del NuPECC, la spe-rimentazione in fisica nucleare dell’INFN è orga-nizzata in 4 linee:
• struttura e dinamica degli adroni (protoni,neutroni e le particelle soggette alla forza nu-cleare forte, alla base della formazione dei nuclei);
• transizioni di fase della materia adronica; • struttura e reazioni nucleari; • astrofisica nucleare e ricerca interdisciplinare.
In tutti questi settori i ricercatori INFN (oltre 520ricercatori equivalenti la cui distribuzione tra levarie categorie professionali e l’ammontare deifondi investiti per le attività scientifiche dellaCSN3 nell’ultimo triennio sono mostrati in ta-bella 3.3) sono fortemente coinvolti, con molteposizioni di leadership in ambito internazionale.Essi ottengono ottimi risultati di alto prestigionon solo nell’ambito della ricerca di base, maanche per le ricadute di tipo applicativo molto ri-levanti per la nostra società. L’attività svolta el’alta qualità dei risultati collocano l’INFN al più altolivello nel campo della fisica nucleare tra gli istitutidi ricerca in ambito internazionale e permettono,grazie allo stretto legame con l’Università, la for-mazione di studenti e di giovani ricercatori in unsettore strategico per lo sviluppo del Paese.La tabella 3.3 mostra la composizione, riferita al2011, del personale che svolge le attività di fisicanucleare e le risorse finanziarie utilizzate neltriennio 2009-2011.
La struttura e la dinamica degli adroniLa teoria che descrive i quark e le loro interazioni
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
36
Fig. 3.11: La carta dei nuclei con indicati i diversi modelli e le loro regionidi applicazione, a partire dalla struttura del nucleone fino alla strutturadei nuclei più complessi.
nia, concretizza un investimento decennale diR&D effettuato dall’Istituto e offre una impor-tante occasione di leadership europea nel set-tore dell’astronomia neutrinica
HIGHLIGHT del 2011• ICARUS, presso i Laboratori del Gran Sasso,ha per la prima volta prodotto uno spettrodi neutrini interamente misurato nell’Ar-gon liquido, una milestone fondamentaleraggiunta per la prima volta al mondonello sviluppo di questa tecnologia digrande interesse per futuri esperimenti.
• BOREXINO, presso i Laboratori del GranSasso, ha misurato con precisione il flussodi neutrini solari della sequenza del 7Bee ha posto un limite sull’asimmetria gior-no/notte;
• OPERA, presso i Laboratori del Gran Sasso,ha presentato una misura preliminaredella velocità dei neutrini inviati dal CERNai Laboratori del Gran Sasso ;
• T2K, in Giappone ha osservato i primieventi di oscillazione νμ→ νe, e fornito leprime indicazioni sul valore dell’angolo dimescolamento θ13;
• FERMI ha esteso la misura del rapporto trapositroni ed elettroni fino a 250 GeV con-fermando ed estendendo la misura di PAMELA;
• PAMELA ha osservato un notevole flussodi antiprotoni nelle fasce di Van Allen edeterminato un inatteso cambio di pen-denza dello spettro di protoni ed elionella regione di energia sopra i 200 GeV;
• AMS-02 è stato lanciato con il penultimovolo dello Shuttle ed installato sulla ISSdove prenderà dati per almeno 10 anni.
MILESTONE del periodo 2012-2014• Pubblicazione primi risultati di AMS-02sulle misure di precisione della composizione dei raggi cosmici;
• Pubblicazioni risultati dell’ esperimentoGERDA presso i Laboratori del Gran Sassoper la ricerca del decadimento doppiobeta e la verifica della teoria del neutrinodi Majorana;
• Completamento (2012) della presa dati edella relativa analisi (2012-14) dell’espe-rimento OPERA presso i Laboratori delGran Sasso utilizzando il fascio di neutriniprovenienti dal CERN per misurare iltasso di trasmutazione tra neutrino mue neutrino tau;
• Verifica della misura della velocità deineutrini nel fascio CNGS (esperimentiOPERA, BOREXINO, LVD, ICARUS) (2012);
• Lancio di LISA Pathfinder (2013), il dimo-stratore tecnologico dell’ interferometrospaziale LISA per la ricerca delle ondegravitazionali;
• Costruzione (2012-2014) del rivelatore CUORE che migliorerà di un ordine digrandezza la sensibilità nella ricerca deldecadimento doppio beta ed il test dellateoria del neutrino di Majorana:
• Completamento (2012-2014) del rivela-tore XENON1t presso i Laboratori delGran Sasso, per lo studio della materiaoscura con metodi diretti;
• Costruzione (2012-2014) dell’osservatoriosottomarino di neutrini KM3NET cheprevede la realizzazione di una grandematrice di rivelatori sottomarini al largodella Sicilia meridionale;
• Misura dell’effetto Lense-Thirring con ilsatellite geodetico LARES
Risorse addizionali (2012-2114)Settore Spaziale: provenienza ASI, mediamente1,5 m€/anno (Pamela, Fermi, AMS-02, Lisa Pa-thfinder)KM3NET: mediamente 2 M€/anno, provenienzaMIUR (dal 2010) e EU (2010-2012). PON Sicilia,20,7 M€ (2012-14)Progetti ERC: mediamente 1,5 M€/anno (nonnel bilancio della CSN2) . Junior RARENOISE, Se-nior LUCIFER Progetto AdV. Mediamente 2 M€/anno (sia nelbilancio della CSN2, che nel bilancio dell’ INFN),(2009-2011)
Infrastrutture per la ricerca (2011-2013)Potenziamento dei LNGS per ospitare la nuovagenerazione di rivelatori per lo studio della ma-teria oscura.Potenziamento del sito di Capo Passero per losviluppo del rivelatore sottomarino KM3NET.Potenziamento delle infrastrutture di Calcolo(CNAF) per l’analisi delle grandi quantità di datiprodotte dagli esperimenti a terra e nello spaziodalla CNS2.
Iniziative per la formazioneOgni anno vengono realizzate in media 5 confe-renze per le scuole dedicate ai temi della CNS2allo scopo di migliorare la conoscenza dei temi,scientifici e tecnologici, legati a queste ricerche.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
35
FTE INFN staff + art.23,15 (anno 2011) 158FTE Associati staff (anno 2011) 237Assegnisti, borsisti, dottorandi (anno 2011) 146Totale risorse finanziarie spese 2009-2011 (k€) 31,2
di cui spese per investimenti(inventario, apparati) 2008-2010 (M€) 9.8
Linea scientifica CNS3
Tab. 3.3: Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN3.

ALICE a LHC rappresenta una sfida sia come com-plessità tecnologica sia come dimensioni e am-piezza della collaborazione. La partecipazioneINFN in ALICE ha avuto e ha un ruolo centralenell’esperimento, dapprima nella costruzione del -l’apparato e attualmente nella conduzione dellasperimentazione e nell’analisi dei dati, come te-stimoniato dai vari ruoli di responsabilità. Sfrut-tando le collisioni protone-protone ALICE haottenuto nel 2011 numerosi risultati utili a carat-terizzare le collisioni e tra essi quelli sulla forma-zione di risonanze e di nuclei e anti nuclei (vedifigura 3.12).Va sottolineata l’importanza delle misure di mol-teplicità delle particelle cariche e del rapportoprotone antiprotone alle energie di 0.9 e 7 TeVnel centro di massa, che forniscono rilevanti ve-rifiche dei modelli teorici. Molti altri risultati sa-ranno disponibili a breve e in particolare anche
dalle collisioni tra Pb-Pb acquisite a fine anno aLHC. Nel loro complesso i risultati ottenuti mo-strano l’eccellente funzionamento dell’accelera-tore LHC e dell’apparato ALICE sia per la partestrumentale sia per l’analisi dati.
Struttura nucleare e meccanismi di reazioneIl problema centrale attualmente affrontato conparticolare vigore nei diversi laboratori (Europa,Usa e Giappone) è quello dell’evoluzione delleproprietà caratteristiche dei nuclei e/o della ma-teria nucleare asimmetrica (masse, interazioni,simmetrie, eccitazioni, gradi di libertà collettivi),in presenza cioè di un rapporto anomalo di neu-troni e protoni. L’ambizioso programma, che ri-chiede molte informazioni sperimentali, è infattiquello di comprendere i limiti della stabilità nu-cleare e ottenere in laboratorio nuclei non pre-senti sulla Terra ma che potrebbero invece
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
38
Fig. 3.12: Alcuni tra i risultati più interessanti ottenuti da ALICE nel 2011 in interazioni centrali Pb-Pb a 2.76 TeV/nucleone. A sinistra (in alto) è mostratala densità di particelle cariche in funzione della centralità (Phys. Rev. Lett. 106, 032301 (2011)); il grafico di sinistra (in basso) mostra i risultati dell’analisidelle correlazioni HBT: prodotto Rout*Rside*Rlong per kT=0.3 GeV/c (Phys. Lett. B 696 (2011) 328); In entrambi i grafici i risultati di ALICE sono paragonaticon misure a energie inferiori. A destra sono mostrate le misure del flusso di particelle cariche in termini di v2, v3, v4, e v5 in funzione del momentotrasverso per tre differenti intervalli di centralità.
(nota come Cromo Dinamica Quantistica, Quan-tum Chromo Dynamics o QCD) non è ancora ingrado di spiegare in modo esauriente la strut-tura dei nucleoni. Ad esempio, rimane ancorada chiarire come i quark e i gluoni si combininoper generare le proprietà del protone e del neu-trone, quali massa, spin e momento angolare, eanche a produrre lo spettro delle risonanze ba-rioniche.Lo studio della struttura degli adroni con sondeelettromagnetiche, che hanno la capacità di pe-netrare in profondità senza alterare sostanzial-mente il sistema, viene condotto in Germania,a Bonn, con fotoni di energia fino a 3 GeV (e -sperimento MAMBO) e al laboratorio americanoJLab, in Virginia, con fotoni ed elettroni di ener-gia fino a 6 GeV (esperimento JLAB12). In par-ticolare, sono in programma misure inclusive edesclusive di alta precisione con fasci e bersaglipolarizzati volte alla ricerca di risonanze bario-niche e di mesoni predetti dai modelli a quarkma non ancora identificati, ed allo studio dellecorrelazioni spin-moto orbitale nel nucleone. Sitratta di ricerche di grande interesse in fisicaadronica, che costituiscono la motivazione prin-cipale dell’innalzamento a 12 GeV dell’energiadei fasci del JLab. Inoltre l’elevata qualità del fascio di elettroni diJLAB ed in particolare l’elevato grado di polariz-zazione permette di controllare la produzioneall’interno del nucleo di adroni diversi dai nu-cleoni, in particolare particelle Lambda dotate disapore stranezza (quark “strano”) che interagi-scono con i nucleoni presenti formando i cosid-detti ipernuclei.Questo permette di comprendere in maggiordettaglio le diverse proprietà dell’interazioneforte in presenza di materia nucleare. Fra i vari adroni dotati di stranezza sono di par-ticolare interesse i kaoni che possono essere cat-turati da un nucleo formando atomi kaonici incui un kaone si muove su “orbite” con raggicirca 1000 volte minori di quelle tipicamenteelettroniche (esperimento SIDDARTHA). La spe-rimentazione con kaoni presso LNF ha portatoalla misura più precisa di sempre del sistemaprotone-kaone (idrogeno kaonico), alle primemisure al mondo di 3He kaonico e di 4He kao-nico con un bersaglio gassoso, grazie agli altivalori di luminosità ottenuti per il collisionatoreDAFNE e ad una maggiore precisione dei rivela-tori. I risultati di SIDDHARTA permettono di ot-tenere informazioni uniche sull'interazionekaone-nucleo/nucleone a bassa energia e sono
oggetto di notevole interesse da parte di un'am-pia comunità di fisici teorici che lavorano nelcampo della QCD in regime non-perturbativonel settore con stranezza.I risultati ottenuti sugli ipernuclei sia a JLab chepresso i LNF sono d’interesse per i modelli chedescrivono l’interno delle stelle di neutroni edhanno avuto un impatto importante nel deli-neare il programma scientifico al laboratoriogiapponese JPARC (Japan Proton AcceleratorResearch Complex).La collaborazione PANDA sta preparando la spe-rimentazione relativa allo studio molto detta-gliato della struttura degli adroni e delle diversefenomenologie prodotte dall’interazione forteutilizzando come sonda un fascio di antiprotoni(l’antiparticella del protone nel mondo specularedell’antimateria) presso il laboratorio internazio-nale FAIR (Facility for Antiproton and Ion Rese-arch) in costruzione a Darmstadt, Germania.Questo fascio avrà caratteristiche di intensità epurezza uniche al mondo. Attualmente i ricer-catori di PANDA sono impegnati in un’intensaattività di R&D per il rivelatore e di simulazioneper le prestazioni strumentali e per la fisica.Questa attività ha ottenuto come riconoscimentola scelta da parte della collaborazione internazio-nale di PANDA della tecnologia pro posta dai ri-cercatori italiani per il tracciatore, tecnologiabasata sugli “Straw Tubes” per la quale è giàstato scritto il Technical Design Report. Per i pro-grammi a più lungo termine a FAIR è in corsoun’attività per sviluppare una tecnica molto effi-cace per la polarizzazione di antiprotoni (PAX) perrealizzare in futuro studi sullo spin dei quark.
Transizioni di fase nella materia adronicaLa collisione tra ioni a energie ultrarelativisticheè caratterizzata da densità di energie sufficien-temente elevate da permettere una transizionedalla materia adronica ad uno stato de-confi-nato di quark e gluoni, la stessa che si presumeabbia avuto luogo nell’Universo primordiale, neiprimi dieci milionesimi di secondo dopo il BigBang. Lo studio del quark-gluon plasma è l’am-bizioso obiettivo scientifico dell’esperimentoALICE al collisionatore LHC al CERN di Ginevra.L’interazione di ioni Pb a energie di 5.5 TeV as-sicurerà la produzione di una miriade di parti-celle (adroni coi loro decadimenti in leptoni) e laloro misura permetterà di comprendere la ma-teria nucleare in condizioni estreme di tempera-tura e di densità di energia. In tutti i suoi diversi aspetti la sperimentazione di
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
37

danno luogo al flusso di neutroni che permettel’innesco dei processi s e la formazione degli ele-menti pesanti nelle stelle.Un diverso approccio è stato seguito da ERNA,che ha basato lo studio delle reazioni di catturaradiativa sull'uso di un bersaglio gassoso e unseparatore di massa per la rivelazione di ioni dirinculo. Sono state studiate le reazioni chiavedella combustione stellare dell’elio e del carbo-nio: 12C+12C, 12C(α,γ)16O e la 3He(α,γ)7Be, otte-nendo, negli ultimi due casi, per queste reazioniper la prima volta una misura diretta della se-zione d’urto totale e una precisione molto vicinaa quella richiesta dai modelli stellari. Una via alternativa, e in molti casi complemen-tare, alle misure dirette è fornita dai metodi in-diretti. In questo ambito, la collaborazioneASFIN ha sviluppato e utilizza con successo latecnica del “Cavallo di Troia”che consente dimisurare la sezione d’urto di nucleo nudo, senzaeffetti di schermatura. Sono di rilievo in questocontesto i dati relativi al problema della scarsitàdegli elementi Li, B e Be, utili ai modelli che de-scrivono i fenomeni che avvengono all’internodelle stelle, la produzione di neutrini solari in-clusa.Lo studio delle reazioni neutrone-nucleo sta at-tualmente ricevendo molta attenzione in moltilaboratori, non solo perché la cattura neutronicariveste grande importanza per la nucleo-sintesidegli elementi più pesanti del ferro ma ancheper contribuire alle tecnologie nucleari emer-genti. La collaborazione n-TOF al CERN è forte-mente impegnata in questi studi, ha ottenutorisultati di grande interesse e ha un programmaben delineato per i prossimi anni. In particolarefarà ricerca utile per gli sviluppi nel campo dellaproduzione di energia nucleare mediante fis-sione. Sono inoltre allo studio possibili attivitàcon nuove sorgenti di neutroni anche presso ilaboratori INFN.Nel campo della fisica fondamentale lo studiodell’antimateria fornisce una verifica stringentealle interazioni e simmetrie che stanno alla basedei modelli teorici. L’attività sulla spettroscopiadell’anti-idrogeno (l’atomo più semplice di anti-materia), sulle sezioni d’urto di antiprotoni aenergie di pochi keV e sulla verifica della sim-metria CPT e della validità del principio di equi-valenza per antimateria sono in corso al CERNda parte della collaborazione AEGIS.Sempre nel campo della fisica fondamentale, loscopo principale dell'esperimento VIP presso iLNGS è misurare gli effetti di possibili violazioni
del principio di esclusione di Pauli con una sen-sibilità migliore rispetto a quanto ottenuto fi-nora, rivelando eventuali transizioni di elettroniverso livelli energetici completamente occupati.
ProspettiveTutte e quattro le linee scientifiche della CSN3hanno prospettive, anche a lungo termine, cer-tamente di grande interesse. Per la dinamica dei quark ci si aspetta l’esten-sione del programma di fisica da 6 a 12 GeV aJLAB e la preparazione del nuovo esperimentoPANDA con un programma di fisica che si basasull’uso di antiprotoni alla facility internazionaleFAIR che appartiene alla lista ESFRI (EuropeanScienze Foundation Research Infrastructure).Queste attività sperimentali forniranno verifichemolto stringenti sull’interazione tra quark,gluoni e quark-gluoni (teoria QCD), sulla strut-tura interna del nucleone e sulle proprietà delleparticelle nella materia nucleare.L’esperimento JLAB12 dopo il completamentodella preparazione del nuovo tracciatore indi-spensabile per partire con la sperimentazionecon i fasci a 12 GeV, intende portare avanti larealizzazione del rivelatore per elettroni diffusi apiccoli angoli necessario per la ricerca di nuovimesoni.Per l’ambizioso studio del plasma di quark egluoni e quindi della materia dopo il Big Bang,è chiaro che l’esperimento ALICE a LHC avrà lapossibilità di produrre fisica nuova con alto po-tenziale di scoperta nei prossimi dieci anni. Atale scopo ALICE dovrà potenziare i centri di cal-colo GRID come previsto nei piani pluriennali epreparare l’upgrade dei rivelatori per la presadati a LHC dopo il 2016 che sarà fatta con fascidi più alta energia e maggiore intensità.Per lo studio della struttura e delle reazioni nu-cleari si è aperta un’era nuova con i fasci di nu-clei radioattivi. Ci si focalizzerà sui nuclei semprepiù lontani dalla valle di stabilità le cui proprietàsono determinanti per capire il cosmo, la vitadelle stelle, la nucleosintesi e la produzioned’energia. Questo programma è fortemente le-gato ai miglioramenti previsti agli acceleratoriesistenti ai LNL e LNS, all’avanzamento del pro-getto AGATA e, a più lungo termine, al progettoSPES. Queste attività, anche se incentrate pressoi nostri Laboratori Nazionali, sono in stretta col-laborazione internazionale e la realizzazione deiprogrammi scientifici necessita lo svolgimentodi attività comuni presso i laboratori esteri in Eu-ropa (incluso il CERN), Usa e Giappone. Sono
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
40
esistere in condizioni simili a quelle che si realiz-zano nel cosmo.
Le collaborazioni INFN impegnate in queste pro-blematiche sono molto attive e utilizzano pre-valentemente i fasci di ioni dei laboratori diLegnaro, LNL (esperimenti GAMMA, NUCL_EX,PRISMA, EXOTIC) e di Catania, LNS (esperimentiEXOCHIM, DREAMS, LNS_STREAM) ma anche ifasci di ioni radioattivi dei laboratori esteri, inparticolare, in Europa, GANIL in Francia e al GSIHelmholtz Centre for Heavy Ion Research (Dar-mstadt, Germania).L’argomento su cui la sperimentazione INFN siè focalizzata è quello dei nuclei lontano dallastabilità e in particolare di quelli ricchi di neu-troni, dei quali si studiano le diverse eccitazioni(particella singola e collettive) che portano in-formazioni sulle interazioni e sulla materia neu-tronica, attualmente di grande interesse ancheper l’astrofisica, in particolare per la nucleosin-tesi degli elementi pesanti e per le stelle di neu-troni. Esperimenti a LNL e GSI di responsabilitàdelle collaborazioni INFN hanno dato contributisignificativi per isolare interessanti effetti del si-stema a molti corpi tra cui gli accoppiamenti difononi di vibrazione alle particelle, effetti di pai-ring ed eccitazioni che coinvolgono vibrazionipuramente neutroniche. Esperimenti con l’ap-parato CHIMERA ai LNS hanno fornito risultatiparticolarmente interessanti sulla dipendenzadell’energia di simmetria (presente quando vi èun’asimmetria nel numero di protoni e neutroni)dalla densità barionica, rilevanti per la descri-zione delle stelle di neutroni. Questi esperimentisaranno successivamente estesi a energie piùalte con nuove misure in programma a GSI conla responsabilità INFN.Ai LNS si sta inoltre realizzando un programma dimisure di frammentazione, alcune d’interesse per
la cura dei tumori con fasci di particelle nucleari(adroterapia) e altri per creare nuclei nella regionedi instabilità protonica. A LNL si è conclusa nel di-cembre 2011 la prima serie di misure con il rive-latore AGATA (dimostratore AGATA vedi figura3.13) della collaborazione internazionale europeache è basato sulla tecnica del tracciamento del-l’interazione gamma con la materia.Questo metodo ha un forte potenziale applica-tivo nell’ambito della tecnologia dell’elabora-zione di immagini (imaging), oggi impiegatadiffusamente in ambito medico e nel settoredella sicurezza, per la rilevazione dei materiali il-legali attraverso la scansione gamma delle merciviaggianti. Le misure di fisica riguardano lo stu-dio di modi di eccitazioni in nuclei moderata-mente ricchi di neutroni, che sono d’interesse epreparatori anche in vista della sperimentazionecon fasci radioattivi di prossima generazione,come quelli di SPES o SPIRAL2. A LNS si utilizze-ranno sempre di più i fasci radioattivi di nucleileggeri prodotti sia da EXCYT che con la tecnicadella frammentazione in volo.
Astrofisica nucleare e ricerca interdisciplinarePoiché le stelle sono vere centrali di energia nu-cleare galattica, è importante, per capire la lorovita, realizzare in laboratorio misure di alta pre-cisione delle reazioni chiave coinvolte. Questereazioni nucleari giocano un ruolo essenziale perl’origine ed evoluzione delle nostre galassie, perle abbondanze degli elementi e per la fisica deineutrini, nonché ovviamente per la produzionedi energia nei diversi ambienti stellari. È propriograzie a uno studio sistematico di numerosimeccanismi e reazioni nucleari che oggi siamoin grado di fare passi avanti nella comprensionedel processo della nucleosintesi. L’esperimento LUNA3 al Laboratorio Nazionaledel Gran Sasso si è concentrato recentementesu reazioni nucleari riguardanti la combustionedell’idrogeno nel ciclo CNO che coinvolge i nu-clei di Carbonio, Azoto e Ossigeno ed è la prin-cipale sorgente d’energia nelle stelle più massivedel Sole.È inoltre iniziata una misura finalizzata a capireperché i modelli di nucleosintesi primordiale pre-vedano una quantità di 6Li che è 2-3 ordini digrandezza inferiore rispetto alle misure in stellepovere di metalli. I programmi a più lunga sca-denza richiedono invece un nuovo acceleratorecon tensione massima di terminale 3.5 MV concui studiare la reazione 12C(α,γ)16O e le reazioni(α,n) su 13C e 22Ne. Queste ultime reazioni
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
39
Fig. 3.13: Il dimostratore del rivelatore AGATA, che usa la tecnica deltracciamento dell’interazione gamma con la materia, montato ai La-boratori Nazionali di Legnaro.

3.5 LA FISICA TEORICA
L’attività descritta in questo paragrafo è coordi-nata dalla Commissione Scientifica Nazionale IV(CSN4). La descrizione dettagliata delle attivitàdella CSN4 è disponibile al sito web:web.infn.it/CSN4/
PremessaL'attività scientifica della CSN4 è organizzata insei settori (detti Linee Scientifiche) che copronoi campi più importanti della ricerca in fisica teo-rica, e cioè
1. Stringhe e teoria dei campi2. Fenomenologia delle particelle elementari3. Fisica nucleare e adronica4. Metodi matematici5. Fisica astroparticellare e cosmologia6. Meccanica statistica e teoria dei campiapplicata
Questa attività si sviluppa in stretta connessionesia con il mondo accademico sia con altri enti diricerca in Italia e all'estero. La varietà e la qualitàdella ricerca svolta dalla CSN4 sono dimostratedall'alto numero di pubblicazioni, citazioni e re-lazioni a conferenze internazionali. Molte dellericerche teoriche si svolgono in stretto collega-mento con le attività sperimentali dell'INFN in fi-sica delle particelle elementari, in fisica nuclearee in fisica astroparticellare coordinate dalle altreCSN dell'INFN. Le collaborazioni internazionalisono fortemente supportate dalla CSN4 che in-fatti utilizza gran parte del suo budget totale perscambi con istituzioni straniere. Inoltre, gli ac-cordi dell'INFN con ITEP, JINR, IHEP (Russia), MEC(Spagna), MIT (USA), ICTP e ECT* (Italia) ven-gono intensamente sfruttati dai fisici teoricidella CSN4 e forniscono ulteriori opportunitàper scambi e collaborazioni internazionali.Un'attività importante e tradizionale della CSN4è la formazione di giovani ricercatori e studenti.Ciò si riflette anche nell'elevato numero di pub-blicazioni con dottori di ricerca e dottorandi cherappresentano infatti oltre il 30% della produ-zione scientifica totale della CSN4.
Attività scientificaLo studio dei problemi fondamentali della fisicanucleare e delle particelle elementari è entratoin una fase di grande interesse a causa dello svi-luppo dei fronti sperimentali lungo le linee del-l’alta energia, dell’alta intensità e della fisicaastroparticellare.
Il cosiddetto "fronte dell'alta energia" consistenel cercare di produrre nuove particelle pesantiusando acceleratori ad alta energia e ad alta fre-quenza di collisioni come il Large Hadron Colli-der (LHC) del CERN di Ginevra. Il cosiddetto"fronte dell'alta intensità" consiste invece nellaricerca di nuovi fenomeni, di nuove particelle edi nuove proprietà usando acceleratori ad ener-gia medio-alta ma con un'altissima frequenza dicollisioni come la macchina Super B in fase dicostruzione. Infine, il cosiddetto "fronte astro-particellare" consiste nel considerare l'Universostesso come una macchina naturale per pro-durre particelle e per fornirci indicazioni sulleproprietà della materia ed energia oscura, deiraggi cosmici etc. In questo contesto il compitodella fisica teorica è quello di fornire metodi e mo-delli per interpretare le osservazioni sperimentalied in particolare formulare teorie per estendere ilModello Standard delle interazioni fondamentali,al fine di includere i nuovi fenomeni della fisicaelet trodebole e del sapore e di trovare candidatiparticellari di materia oscura.Esistono fondamentalmente due approcci perraggiungere questi obiettivi: uno detto "bot-tom-up", che partendo dai dati sperimentali edalla fenomenologia arriva all’elaborazione dimodelli e teorie di nuova fisica, e uno detto"top-down" che partendo invece da astratteteorie spesso basate su sofisticati strumenti ma-tematici giunge ad implicazioni fenomenologi-che da confrontare con i risultati sperimentali.Nell'approccio "bottom-up" molto importanteè lo studio degli aspetti fenomenologici delle in-terazioni forti alla scala di Fermi (esplorata dagliesperimenti di LHC) o lo studio dei meccanismidi rottura della simmetria elettrodebole per spie-gare l'origine della massa. Inoltre è fondamen-tale continuare l’analisi dei dati provenienti dagliesperimenti di astrofisica al fine di trovare cor-relazioni tra segnali diretti o indiretti di materiaoscura nei diversi esperimenti. La correlazionetra questi segnali e l'eventuale produzione dimateria oscura a LHC costituisce una delle sor-genti più interessanti per teorie di nuova fisicaoltre il Modello Standard. A questi studi si af-fianca l’attività di ricerca sulla fisica del sapore,sui meccanismi di leptogenesi nel contesto diteorie unificate, lo studio del mescolamentodelle diverse specie di fermioni in modelli con osenza supersimmetria alla scala debole o in mo-delli con "dimensioni extra", cioè con altre di-mensioni oltre quelle corrispondenti allo spazioe al tempo che conosciamo.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
42
particolarmente consolidate da molti anni le col-laborazioni con GANIL per SPIRAL2 e GSI-FAIRper NUSTAR. Con GANIL è in corso da anni unaccordo di collaborazione formalizzato tra INFNe IN2P3.Per l’astrofisica nucleare bisognerà portare avantil’upgrade di LUNA con un acceleratore da 3.5 MV.In quest’ambito si rafforzerà la collaborazione in-ternazionale. Il tema di punta è quello legato al-l’abbondanza di carbonio e ossigeno negliambienti stellari. Inoltre le misure in programmaconsentiranno di ottenere informazioni essenzialiper la nucleosintesi degli elementi in un ampio in-tervallo di masse.Le prospettive di ricerca in Fisica Nucleare sonosenza dubbio molto attraenti anche per le lorosempre maggiori ricadute applicative in settoristrategici come quello medico e dell’energia emeritano quindi d’essere perseguite con ade-guate risorse di personale e strumentazione.
HIGHLIGHT del 2011• Presso il JLAB è stata condotta l’esten-sione a grandi valori dell’impulso trasfe-rito della misura del fattore di forma ela-stico del protone mediante la polarizza-zione di rinculo. La misura di altissimaprecisione ha posto limiti stringenti suimodelli che descrivono la distribuzione dicarica elettrica nel protone;
• Nel 2011 l’attività di analisi di ALICE è ri-sultata particolarmente intensa e produt-tiva, portando risultati molto interessantialla comunità scientifica circa le caratte-ristiche degli eventi di collisione Pb-Pb ein collisioni pp. In particolare è stata ef-fettuata la misura:- della densità di particelle cariche per unità di pseudorapidità;
- del flusso ellittico di particelle cariche;- degli spettri di momento trasverso delle particelle cariche;
- delle correlazioni HBT;- della produzione di J/ψ�e di adroni charmati in interazioni Pb-Pb e pp;
• A Dicembre 2011 si è conclusa ai LNL lacampagna di misure con il dimostratoredi AGATA, utilizzato anche in accoppia-mento con lo spettrometro a grande ac-cettanza e risoluzione PRISMA. Di parti-colare rilevanza sono i risultati ottenutiin misure di vita media di livelli popolatimediante reazioni di trasferimento dinucleoni;
• Sia ai LNS, con l’apparato CHIMERA, cheai LNL, nell’ambito della collaborazioneNUCLEX, sono continuate misure atte adevidenziare effetti di isospin in reazionitra ioni pesanti, ottenendo informazionisull’energia di simmetria, importante perle stelle di neutroni;
• Presso i LNF è stata effettuata la primamisura mondiale di atomi kaonici di 3He;
• Gli esperimenti LUNA3, ERNA e ASFINhanno continuato lo studio sistematicodei meccanismi che regolano i processireazioni nucleari riguardanti la combu-stione dell’idrogeno in particolare nelciclo CNO che coinvolge i nuclei di Carbo-nio, Azoto e Ossigeno.
MILESTONE del periodo 2012-2014• Realizzazione dei nuovi rivelatori per ap-parato CLAS a JLab (USA) e inizio dellasperimentazione a 12 GeV per studiare lastruttura del nucleone e la dinamica deiquarks;
• Risultati finali relativi a misure sugli atomikaonici realizzate al LNF per verificare ilimiti a bassa energia del modello QCD;
• Misure con ALICE a LHC finalizzate a tro-vare effetti nuovi che caratterizzano ilquark-gluon plasma;
• Ampliamento delle strutture di calcolobasate sulla GRID per l’esperimento ALICEche richiede un’intensa attività d’analisi;
• Definizione dell’upgrade dei rivelatori diALICE, necessario per sfruttare al megliole prestazioni di più alta luminosità pre-vista da LHC, oltre che alla possibilità diampliare il programma di fisica dell’espe-rimento.
• Potenziamento ed upgrading degli appa-rati sperimentali del LNL in preparazionedei fasci potenziati del complesso PIAVE-ALPI e di SPES.
• Inizio di un’attività ai LNS con fasci radio-attivi prodotti da frammentazione ed uti-lizzando l’apparato CHIMERA ampliatocon un nuovo sistema di rivelazione;
• Completamento di una serie di misureper la descrizione della nucleosintesi diBig Bang con l’apparato LUNA al LNGS estudio di fattibilità per una serie di nuovemisure con un nuovo acceleratore perenergie di qualche MeV.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
41

zioni e gruppi collegati dell’INFN e da tre deiquattro laboratori nazionali (la CSN4 non è pre-sente ai laboratori di Legnaro). Le attività sonoattualmente organizzate in 52 progetti di ricercadenominati “Iniziative Specifiche”, che aggre-gano ricercatori di diverse sezioni per conseguirecomuni finalità scientifiche. Le Iniziative Specifi-che sono valutate ogni tre anni da refereeesterni (nella stragrande maggioranza stranieriappartenenti a prestigiose università ed enti diricerca) e le assegnazione dei fondi di ricerca di-pendono dai risultati di questa valutazione. I set-tori di ricerca di maggior investimento sono lalinea 1 (Stringhe e Teoria dei Campi), la linea 2(Fenomenologia delle Particelle) e la linea 5 (Fi-sica Astroparticellare e Cosmologia).La tabella 3.4 riassume la distribuzione percen-tuale di afferenza e il numero di Iniziative Speci-fiche nelle sei Linee Scientifiche della CSN4,mentre la composizione del personale e le ri-sorse finanziarie sono riportate nella tabella 3.5. La CSN4 ha svolto, e certamente svolgerà nelfuturo, un ruolo chiave nella ricerca in fisica teo-rica con contributi di grande rilievo ampiamentericonosciuti a livello internazionale, come dimo-strato dall'alto numero di citazioni e inviti allemaggiori conferenze internazionali.Molto sviluppata è inoltre la collaborazione conricercatori provenienti da prestigiosi istituti e la-boratori di tutto il mondo, nonché lo scambiodi giovani ricercatori mediante l’assegnazione diborse di dottorato o post-dottorali, finanziateattraverso progetti italiani o europei, o finanziatidirettamente da istituti di ricerca esteri. La pro-duzione scientifica annua ammonta a circa1200 lavori, pubblicati su riviste internazionalicon referee. La CSN4 rappresenta un organismostrategico per lo sviluppo della fisica teorica inItalia, con uno spettro di interessi molto piùampio di quello di stretta competenza INFN.Questo ruolo è stato possibile grazie a un’atti-tudine culturale aperta e al mantenimento diuna stretta collaborazione col mondo accade-mico, che se possibile deve essere ulteriormenteconsolidata e rafforzata. Molti dei risultati piùsignificativi sono il frutto di una fertilizzazioneincrociata dell’INFN con le università e con altrienti di ricerca italiani e stranieri.
PC Cluster di PisaPer i complessi calcoli numerici richiesti dalle attivitàdi ricerca specialmente nei campi dell’astrofisica,della fisica nucleare, della fisica agli acceleratori edella meccanica statistica, nel 2010 la CSN4 ha rea-lizzato un cluster di PC (1024 core per un potenzacomplessiva di circa 10 Teraflop, 1 GB di RAM percore) presso la sezione di Pisa dell’INFN.Tale cluster, chiamato CSN4CLUSTER, è entratoin funzione nell’estate 2010 a appena 6 mesidall’approvazione del progetto; esso è integratocon la infrastruttura EGI Grid e permette l'esecu-zione di calcoli paralleli, seriali e multithreaded.Questo servizio sarà fornito per tutto il 2012 mail cluster rimarrà operativo anche dopo il 2012;la CSN4 dovrà dunque considerare la possibilitàdi upgrade e/o espansioni dell'hardware.
Galileo Galilei Institute (GGI)Una delle iniziative di maggior successo dellaCSN4 è costituita dall’Istituto Galileo Galilei (GGI)di Arcetri. Il GGI si è oramai conquistato una famainternazionale e rappresenta una solida tradizionenell’organizzazione di workshop internazionali acui hanno partecipato e partecipano scienziatiprovenienti da tutto il mondo. I fondi necessari alfunzionamento del centro, forniti a questo scopodall’INFN, permettono di organizzare mediamentetre workshop ogni anno, di durata media di 8 set-timane, oltre ad alcune scuole post-dottorali, mi-niworkshop e meeting di varia natura. Maggioriinformazioni sul GGI e sulle sue attività sono for-nite nella sezione 3.10.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
44
FTE INFN staff + art.23,15 (anno 2011) 115FTE Associati staff (anno 2011) 480Assegnisti, borsisti, dottorandi (anno 2011) 450Totale risorse finanziarie spese 2009-2011 (M€) 9,9
di cui spese per investimenti(inv., c.a.) 2009-2011 (M€) 0.7
Linea scientifica CNS4
Tab. 3.5: Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN4.
% FTEnumero IS
Tab. 3.4: Distribuzione percentuale degli FTE e numero di Iniziative Specifiche nelle sei Linee Scientifiche della CSN4.
Linea 133%13
Linea 216%10
Linea 313%10
Linea 411%6
Linea 611%8
Linea 516%5
Un esempio tipico e molto importante dell'ap-proccio "top-down" della fisica teorica è rap-presentato dalla teoria delle superstringhe(“string theory”) che fornisce uno schema con-sistente per la unificazione a livello quantisticodi tutte le forze fondamentali, inclusa la gravità,nell’ambito del quale le particelle elementari e imediatori delle forze sono associati a diversimodi di vibrazione di oggetti estesi unidimen-sionali detti stringhe.Nel limite in cui la lunghezza delle stringhe di-venta trascurabile, questa teoria si riduce alla re-latività generale (ovvero alla sua estensionesupersimmetrica, la supergravità) unificata conle altre interazioni fondamentali descritte dallecosiddette teorie di gauge.Negli ultimi anni lo studio della teoria delle strin-ghe e delle loro generalizzazioni a più dimensioni,dette membrane o più concisamente “brane”, èstato uno degli argomenti di punta della ricercafondamentale in fisica teorica a livello mondialeportando alla formulazione dei cosiddetti modellidi "brane-world" per la descrizione della fisicadelle particelle elementari.Inoltre, lo studio delle brane e della geometria adesse associata ha aperto nuove prospettive per lacomprensione del settore non-perturbativo delleteorie di gauge portando alla formulazione divarie corrispondenze gauge/gravità il cui prototipoè la dualità AdS/CFT che oggi trova applicazioni esviluppi in numerosi e svariati settori, dalla idrodi-namica alla fisica della materia condensata.L’attività coordinata dalla CSN4 non si esauriscenei temi menzionati finora, ma ha importantiestensioni nello studio degli aspetti più formalidella teoria dei campi, nella fisica matematica,nella fisica statistica, nella biofisica, nella turbo-lenza o nell'applicazione di tecniche e modellifisici in ambito economico.
Settori di ricerca e composizioneCome detto in precedenza, l’attività della CSN4è organizzata in sei Linee Scientifiche i cui prin-cipali argomenti di ricerca sono qui di seguitobrevemente menzionati:
1. STRINGHE E TEORIA DEI CAMPI:superstringhe, supergravità, teorie supersimme-triche; dimensioni extra; gravità quantistica e co-smologia; dinamica non-perturbativa nelleteorie di gauge; QCD a grandi distanze, appli-cazioni alla meccanica statistica; fenomeni criticie gruppo di rinormalizzazione.
2. FENOMENOLOGIA DELLA PARTICELLE:fisica del neutrino, fisica dei sapori, fisica oltre ilmodello standard, materia oscura, QCD, fisicaadronica, rottura della simmetria elettrodebolee della supersimmetria.
3. FISICA ADRONICA E NUCLEARE:fisica degli ioni pesanti, materia adronica e mo-delli di QCD, struttura e reazioni nucleari, studinumerici delle fasi di QCD, plasma di quark egluoni, fenomeni di trasporto, distribuzioni par-toniche generalizzate.
4. METODI MATEMATICI:relatività generale e fisica gravitazionale, geo-metria non-commutativa e gruppi quantici,struttura algebrica in teorie di campo, stabilitàdinamica classica e quantistica, entanglement echaos, geometria di sistemi dinamici e sistemiintegrabili.
5. FISICA ASTROPARTICELLARE E COSMOLOGIA:fisica delle stelle di neutroni, supernovae, sor-genti di radiazione astrofisiche, neutrini in fisica,astrofisica e cosmologia, sorgenti di onde gra-vitazionali, buchi neri, modelli inflazionari, ma-teria oscura ed energia oscura, fenomenologiaalla scala di Planck, teorie di gravità.
6. TEORIA DEI CAMPI E MECCANICA STATISTICA:metodi non perturbativi della teoria quantisticadei campi applicati a sistemi statistici, sistemi dielettroni fortemente correlati, condensazione diBose-Einstein, meccanica statistica di non-equi-librio, biofisica quantitativa, protein folding, re-golazione genica, turbolenza, sistemi disordinati,vetri di spin, reti neurali.
Alle attività di ricerca della CSN4 contribuisconocirca 1000 scienziati provenienti da tutte le se-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
43
Fig.3.14 Rappresentazione schematica di un "brane-world", con stringhe(aperte o chiuse) e dimensioni extra (da un disegno del Cern Courier). Fig. 3.15: La sede del Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics ad
Arcetri (FI).

caratteristiche delle teorie di unificazionedelle interazioni fondamentali, il ruolodella supersimmetria e gli aspetti non-perturbativi delle teorie di campo;
• Realizzazione di un’infrastruttura di Su-percalcolo, con una potenza di almenoun Petaflop, per eseguire calcoli al reti-colo necessari nella fisica del sapore edessenziali per discriminare segnali dinuova fisica nelle misure a SuperB e LHC;
• Rafforzamento dell’internazionalizza-zione delle attività della CSN4 con un au-mento di periodi di collaborazione pas-sati dai nostri ricercatori in istituzionistraniere nel quadro di accordi o pro-grammi internazionali e, parallelamente,notevole enfasi ad inviti di maggiore du-rata rivolti a studiosi stranieri di alto livello.
3.6 LE RICERCHE TECNOLOGICHEE INTERDISCIPLINARI
L’attività descritta in questo paragrafo è coordi-nata dalla Commissione Scientifica Nazionale V(CSN5). La descrizione dettagliata delle attivitàdella CSN5 è disponibile al sito web:www.infn.it/csn5/
L’INFN, attraverso la Commissione Scientifica Na-zionale 5 (CSN5), promuove e sviluppa la ricercanel campo della fisica degli acceleratori, dei rive-latori di radiazione, dell’elettronica, dell’informa-tica e della fisica interdisciplinare. In quest’ambitoil ruolo svolto dall’Istituto è praticamente unico alivello nazionale: non solo svolge una funzione diguida e coordinamento fra ricercatori di differentidiscipline (Nucleare, Particellare, Astroparticellare,Struttura della Materia, Ingegneria Elettronica eInformatica, Biologia, Medicina, Chimica), ma raf-forza anche tra l’altro il raccordo dell’INFN conl’Università e gli altri enti nazionali di ricerca: CNR,INAF, IIT (Istituto Italiano di Tecnologia), ASI, INAF.Le nuove frontiere della ricerca sui rivelatori el’elettronica associata seguono i grandi progettisperimentali che impegnano l’INFN. Grande at-tenzione è rivolta ad esempio alla progettazionedi elettronica VLSI (Very Large Scale Integration)analogica e digitale, allo studio di nuovi processicostruttivi, all’analisi e sintesi di architetture digitaliad alte prestazioni per applicazioni di trigger, ac-quisizione dati e computing on-line.Tali attività, svolte nell’ambito delle grandi colla-borazioni internazionali, gia guardano alle richie-
ste del dopo LHC (SLHC) e agli esperimenti della“fisica del flavor” di alta precisione. Inoltre si porràgrande attenzione allo sviluppo di nuovi e piùavanzati sistemi di rivelazione di raggi X o gammaper radioastronomia su satellite e per esperimentidi fisica interdisciplinare basati sull’uso della radia-zione elettromagnetica dal lontano infrarosso airaggi X, ai raggi gamma delle future ComptonSource per la fotonica nucleare.Sul fronte delle ricerche interdisciplinari, moltedelle applicazioni delle tecniche sviluppate dal-l’INFN sono di grande impatto socio-economicoin vari settori.
1. BIOMEDICINA:le competenze dell’INFN nell’ambito degli accele-ratori, dei rivelatori e dello studio delle interazioniradiazione-materia hanno trovato applicazioni ri-levanti nell’imaging medico, nella terapia dei tumori(sviluppo di piani di trattamento in radioterapia confasci di protoni e ioni), nella dosimetria e nello stu-dio dell’evoluzione cellulare.
2. SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI.le stringenti richieste degli esperimenti di fisicafondamentale applicati allo studio degli eventi rarihanno portato allo sviluppo di tecnologie e me-todiche di misura estremamente avanzate e dielevatissimo livello di sensibilità. La sensibilità stru-mentale, le metodiche analitiche e le competenzesviluppate hanno ad oggi già prodotto importantirisultati e ricadute in molti ambiti, tecnologici/ap-plicativi o sociali: indagini ambientali, analisi di re-perti di interesse artistico, archeologico e storico.
Inoltre saranno incentivate le attività legate allo svi-luppo ed applicazione interdisciplinare della lucedi sincrotrone e alle sorgenti di radiazione di nuovagenerazione. Tali attività vedono l’INFN interagireattraverso gli esperimenti finanziati dalla CSN5 conle principali istituzioni di ricerca e di controllo na-zionali e regionali operanti nel settore sanitarioquali l’Istituto Superiore di Sanità, Ministero dellaSalute, Enti (ITT, CNR, INGV), Fondazioni edAziende Sanitarie nazionali e regionali. Sarà inco-raggiata l’attività di trasferimento tecnologicoanche attraverso lo sviluppo di appositi accordi dicollaborazione con le associazioni industriali di ca-tegoria (CONFINDUSTRIA e CONFAPI).
HIGHLIGHT del 2011
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
46
Training e altre attività educativeIn ambito CSN4 vengono date circa 300 tesiuniversitarie per anno (circa 120 triennali, 120specialistiche o magistrali, e 50 tesi di dotto-rato). Con propri fondi, la CSN4 finanzia alcunescuole nazionali e internazionali per studenti didottorato e borsisti post-dottorali (Scuola diParma, Scuola B. Touschek a Frascati, Scuola diOtranto, Laces al GGI, Scuola congiunta CSN1-CSN4 su LHC), e visite scientifiche per 150 gior-nate-uomo al GGI e per 400 giornate-uomoall’ICTP (International Center For Teoretical Phy-sics). A partire dal 2005 la CSN4 ha istituito ilPremio Sergio Fubini, divenuto nel 2007 un pre-mio ufficiale dell'INFN, come riconoscimento perle tre migliori tesi di dottorato dell'anno.
HIGHLIGHT del 2011Tra i principali risultati raggiunti si possonomenzionare:• I lavori di analisi dei dati provenienti da-gli esperimenti di LHC, lo sviluppo di al-goritmi per il calcolo degli effetti alNext-to-Leading-Order (NLO) per i jets diQCD, e in generale i calcoli di alta preci-sione;
• Lo studio di vari aspetti non-perturbativiin compattificazioni di teorie di superstringa, il calcolo delle funzioni di corre-lazione nel limite planare della teoria diSuper Yang-Mills N=4 e lo studio di varieapplicazioni e generalizzazioni della cor-rispondenza AdS/CFT;
• Lo studio dei risultati di PAMELA e FERMIsui positroni sia per un'eventuale rivela-zione indiretta di materia oscura sia perla caratterizzazione delle incertezze nelleosservazioni astrofisiche;
• Lo studio di diversi scenari di inflazionecosmologica e dei loro possibili test ba-sati sulla radiazione di fondo cosmica;
• L’interpretazione di segnali di violazionedi CP nei decadimenti del mesone B intermini di nuova fisica alla scala elettro-debole;
• Lo studio della asimmetria di spin nellaproduzione semi-inclusiva di pioni ekaoni che permette di stabilire nuoveequazioni di evoluzione per le sezionid'urto di potenziale interesse per gliesperimenti a RHIC di Brookhaven e aLHC.
MILESTONE del periodo 2012-2014Nella fisica teorica, come in tutta la ricerca dibase, non è molto significativo indicare unaprecisa “roadmap” per il raggiungimentodegli obiettivi di ricerca e stabilire precise"milestone".Tuttavia è ragionevole indicare come impor-tanti obiettivi da raggiungere nel prossimoperiodo i seguenti punti:• Sviluppo delle attività di ricerca nelle tremaggiori problematiche teoriche con-nesse con la ricerca sperimentale particel-lare di questo decennio:1) meccanismo sottostante la rotturaspontanea della simmetria che descrivele interazioni elettrodeboli (fisica al-l’LHC, connessa con la ricerca della par-ticella di Higgs);
2) spiegazione dei rapporti di massa e deimescolamenti con violazione di CP trai costituenti fondamentali della mate-ria (quarks e leptoni) e sviluppo dellafisica del sapore con i mesoni B da stu-diare alla macchina SuperB e nell’espe-rimento LHCb;
3) ricerca ed interpretazione dei costi-tuenti elementari della materia oscurain relazione anche agli esperimenticondotti ai Laboratori Nazionali delGran Sasso e a vari esperimenti spazialiquali PAMELA, FERMI e AMS/02;
• Rafforzamento della collaborazione conle componenti sperimentali dell’Enteoperanti principalmente nell’ambito del-le CSN1, CSN2 e CSN3 sui temi di ricercasopra menzionati. Al fine di favorire talecollaborazione teorico-sperimentale sicercherà di enfatizzare maggiormente ilruolo del Galileo Galilei Institute (GGI) or-ganizzando workshops congiuntamentecon le altre CSN dell'INFN, sull'esempio diquanto è stato fatto su argomenti di fi-sica astroparticellare insieme alla CSN2nell'ottobre 2011. Inoltre, a metà novem-bre 2012 presso i Laboratori Nazionalidel Sud verrà organizzato congiunta-mente alla CSN3 un incontro della comu-nità di fisica nucleare italiana, sia speri-mentale sia teorica, per valutare la situa-zione complessiva del campo e svilupparele sinergie utili per affrontare le nuovesfide;
• Sviluppo delle attività di ricerca di tipo"top-down" per comprendere meglio le
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
45
XDXL, un esperimento per lo sviluppo diSilicon Drift Detector di grande superficie(7x7 cm2) e la loro applicazione alla spet-
•

hanno importanti applicazioni nella spettrosco-pia di raggi X. Gli sviluppi tecnologici connessicon questa attività, sviluppati in collaborazionicon industrie italiane, permetteranno all’INFN dicollocarsi alla frontiera di questo campo di ri-cerca e sviluppo.Nel campo della fisica degli acceleratori si svi-lupperanno, nel medio termine, sorgenti di ionicon correnti molto maggiori di quelle disponibili;daranno risultati le linee di ricerca relative all’in-cremento della luminosità, alle tecniche innova-tive per minimizzare l’emittanza dei fasci, quelleper il miglioramento dell’accettanza delle strut-ture acceleranti e per la realizzazione di tecnichedi accelerazione a plasmi. Gli studi sulla produ-zione di fasci di raggi X monocromatici (otteni-bili per scattering da pacchetti di elettroni e lucelaser), da una parte promettono un innovativoimaging biomedico in vivo, dall’altra fanno na-scere studi teorici sulla possibilità di emissionedi raggi X coerenti, mediante processo FEL (FreeElectron Laser), sia in regime quantistico checlassico. Grazie alla tecnica dell’Inverse Com-pton Scattering (ICS) nel prossimo decennio saràpossibile realizzare sorgenti di raggi X quasi mo-nocromatiche realizzate facendo collidere un fa-scio di elettroni con impulsi dell’ordine deipicosecondi e di alta brillanza, con impulsi laserdi alta energia. Lo ICS permette di selezionarele energie dei raggi X e la risoluzione temporalein maniera estremamente accurata. Nella dia-gnostica medica questa disponibilità di sorgenti(quasi) monocromatiche, (parzialmente) coe-renti, e di piccole dimensioni spaziali (decine dimicrometri) permetterà l’utilizzo di tecniche in-novative non possibili con le sorgenti conven-zionali. Le sorgenti ICS saranno protagoniste neiprossimi anni dell'apertura dell'era della foto-nica nucleare, in cui fasci di fotoni a energie trai 2 e 20 MeV rappresenteranno la radiazione disincrotrone di 5a generazione per studi ed ap-plicazioni nucleari. A energie molto più elevate(fotoni> 50 MeV), sorgenti ICS possono essereusate come primo stadio per la produzione dipositroni polarizzati per collider lineari. Sorgentibasate su ICS sono in costruzione o in fase diprogetto in diversi laboratori. L’INFN, grazie alfascio di elettroni di SPARC e al laser FLAME delprogetto PLASMONX, ha realizzato una impor-tante infrastruttura (SPARC-LAB) ai LNF che lepermette di essere uno dei centri leader mondialiper lo studio delle interazioni elettroni fotoni esviluppare sistemi di accelerazione innovativi perapplicazioni in campo medico anche in collabo-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
48
Fig. 3.16: Immagine tomografica di un fantoccio ottenuta da PRIMA+.
troscopia X ad alta risoluzione in diversisettori. Ha ottenuto una risoluzione inenergia a temperatura ambiente che oggirappresenta il migliore risultato a livellointernazionale per rivelatori di queste di-mensioni.Tali rivelatori presentano grande interessein diversi cam pi: spettroscopia, rivelazionedi contaminanti radioattivi, diagnosticabio-medica, esperimenti di astrofisica X susatelliti; HELIOS, miglioramento della BEAM BRI-GHTNESS per le nuove generazioni di sor-genti di ioni. L’esperimento studia lepro blematiche legate alla dipendenza delplasma heating dai parametri di funziona-mento delle sorgenti MDIS (Microwave Di-scharge Ion Sources) e ECRIS (ElectronCyclotron Resonance Ion Sources).Ha spiegato la formazione di “hot elec-trons” nel plasma con fenomeni di turbo-lenza generati dai profili di densità delfascio; ha dimostrato la formazione diElectron Bernstein Waves in sorgenti diplasma di ridotte dimensioni, proponen-dole come strumento per superare i limitidi densità nelle sorgenti di ioni attuali.Questi risultati dimostrano che è possibileprodurre correnti di ioni monocarichi digran lunga maggiori di quelle attuali epotenzialmente anche di ioni multipli.Nel lungo periodo, l'applicazione dei risul-tati di questo esperimento potrà permet-tere l'upgrading di acceleratori esistenti ela minimizzazione dei costi delle futuremacchine acceleratrici;TELMA (Trace Element Measurementsand Analysis); ha ottenuto sensibilità dimisura per la ricerca di elementi radioat-tivi in tracce che non ha paragoni nelresto del mondo sviluppando inoltre varietecniche analitiche quali l’attivazioneneutronica (NAA), la spettrometria dimassa (ICP MS) e la spettroscopia gammacon rivelatori HPGe. La “low radioactivitylevel facility” del Gran Sasso, laboratorioindirizzato alla spettroscopia gamma conrivelatori HPGe, è considerato il migliorlaboratorio esistente per misure di radio-attività.Gli approcci sviluppati sono oggi conside-rati come punto di riferimento per la se-lezione dei materiali atti alla costruzionedi nuovi rivelatori a bassissimo fondo. Le
tecniche analitiche hanno avuto interes-santi applicazioni interdisciplinari, adesempio dimostrando che Napoleonenon è stato av velenato, come citato nellapiù importante rivista di Anatomia pato-logica (Adv. Anatomic Pathology, Vol 18,nr. 2, 2011);PRIMA+ (proton Computed Tomography)ha ottenuto la prima immagine tomogra-fica (figura 3.17) di un fantoccio, utiliz-zando il dispositivo di pCT. L'acquisizioneè stata fatta con il fascio di protoni da 62MeV utilizzato clinicamente presso i la-boratori Nazionali del SUD dell'INFN.L'immagine è stata ricostruita con algo-ritmo FBP corretto per tener conto delMCS. Questa è la prima tomografia spe-rimentale ottenuta con protoni in Europae anche negli Stati Uniti, a nostra cono-scenza, era stata ottenuta un'unica im-magine test nel 2007 (a cui per ora non èseguita nessuna altra pubblicazione).Il risultato porterà ad un ulteriore svi-luppo del sistema al fine di ottenere unapparato di tomografia per protoni real-mente innovativo, di grande funzionalitàe tecnologicamente al meglio dello statodell'arte, in grado di aumentare signifi-cativamente l'accuratezza nel tratta-mento adroterapico;TERASPARC, produzione, estrazione e usodi impulsi ultracorti di radiazione coerenteTHz nell’intervallo spettrale 75-1000 micron(200 GHz-5 THz). La radiazione viene pro-dotta attraverso l’interazione di un fascioultracorto di elettroni, compressi tramite“velocity bunching”, con una targhetta me-tallica nel Free Electron Laser SPARC pressoi laboratori nazionali INFN di Frascati.Tale radiazione è stata utilizzata comediagnostica per misurare con precisionela lunghezza longitudinale dei pacchettielettronici di SPARC. Nel contempo sonostati caratterizzati i fattori di merito dellaradiazione: potenza di picco, spectral co-verage e energia per impulso con lo scopodi utilizzarla, nel 2012, per esperimenti siadi spettroscopia risolta in tempo pump-probe che per la caratterizzazione di de-tector e sistemi di imaging THz.
•
•
•
•
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
47
ProspettiveNei prossimi tre anni in particolare, in una prospet-tiva temporale comunque proiettata anche oltreil triennio, verrà posta particolare attenzione allostudio e allo sviluppo di sistemi di rivelazione peri futuri esperimenti e del l’elettronica associata.Una linea di ricerca privilegiata sarà quella dei cir-cuiti integrati tridimensionali. Lo sviluppo dellatecnologia di integrazione verticale, sfruttando lepotenzialità offerte dall’evoluzione delle tecnolo-gie microelettroniche ad alta densità, potrà aprirela strada per la realizzazione di sistemi di traccia-tura che superino le attuali limitazioni intrinsechedei sensori a pixel ibridi e dei MAPS (MonolithicActive Pixel Sensors) CMOS, e per svi lup pare di-mostratori di tracciatori sottili a pixel. Infatti i futuriesperimenti di fisica delle alte energie (SuperB,SLHC, collider lineari) saranno caratterizzati dastringenti richieste per i sistemi di tracciatura chedovranno operare ad alto rate con una minimaquantità di materiale. In questo ambito sarannostudiate anche altre soluzioni basate sull’impiegodi silicio su substrato isolante e su diamanti sinte-tici policristallini. Grande rilievo nel prossimo de-cennio si darà anche allo sviluppo di tecniche ditrasmissione dati digitale ad alta velocità, di sen-sori, convertitori e strumentazione metrologica diinteresse per la fisica fondamentale, applicata einterdisciplinare, e alla riduzione del danno da ra-diazione attraverso lo studio di nuovi processi e diappropriate tecniche di progetto.Una linea di ricerca particolarmente rilevantesarà lo sviluppo tecnico di rivelatori bolometrici.Questi rivelatori, oltre ad avere grandissimo in-teresse per gli esperimenti di fisica fondamen-tale (double beta decay, dark matter search)

trarre giovamento dall’applicazione delle tecnolo-gie proprie del nostro ente. La tabella 3.6 riassume la composizione del per-sonale e le risorse finanziarie.
MILESTONE del periodo 2012-2014
3.7 IL CALCOLO E LE RETI
L’attività descritta in questo paragrafo è coordi-nata dalla Commissione Nazionale Calcolo eReti (CCR). La descrizione dettagliata delle atti-vità della CCR è disponibile al sito web:web.infn.it/CCR.
Attività 2011L’INFN ha potenziato notevolmente negli ultimianni i centri di calcolo presenti presso le suesedi, in risposta alle sempre crescenti esigenzedi risorse di calcolo necessarie per le proprie at-tività scientifiche, in particolare quelle derivantidalla sperimentazione a LHC. L’incremento dellerisorse riguarda sia il CNAF, che svolge il ruolocentrale di sede per l’elaborazione primaria didati scientifici e di archivio permanente di dati aservizio di tutto l’INFN, sia tutte le sedi dei Tier-2 della federazione WLCG (World Wide LHCComputing Grid), in cui viene svolta l’attività co-ordinata di analisi dati. Per sopperire alle neces-sità di calcolo della fisica teorica in varie linee diricerca, che riguardano interazioni fondamen-tali, astrofisica teorica, meccanica statistica, flui-dodinamica turbolenta, sorgenti di ondegravitazionali, ecc., e che richiedono oggi la di-sponibilità di risorse di decine di Teraflop, è statopotenziato nel 2011 il cluster per il calcolo pa-rallelo, basato sull’impiego di processori com-modity interconnessi attraverso una rete dicomunicazione a bassa latenza (Infiniband) edinstallato a Pisa per sfruttare in modo sinergicole esperienze già acquisite in tale sede nella ge-stione di grandi sistemi di calcolo e nell’utilizzodei servizi forniti dall’infrastruttura Grid INFN.Il consolidamento operato a livello di hardware,software e definizione di servizi prosegue anchein altre sedi in linea con la strategia generaledell’INFN tesa ad ottenere:
Con gli ultimi interventi effettuati nel 2011,l’INFN dispone oggi di un insieme unico in Italiadi centri dedicati al calcolo scientifico. Esso è co-stituito, oltre che dal CNAF, da una dozzina diinstallazioni particolarmente rilevanti, collocate
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
50
FTE INFN staff + art.23,15 (anno 2011) 89,8FTE Associati staff (anno 2011) 335,6Assegnisti, borsisti, dottorandi (anno 2011) 192,5Totale risorse finanziarie spese 2009-2011 (k€) 14,286
di cui spese per investimenti(inv., c.a.) 2008-2010 (M€) 4.394
Linea scientifica CNS5
Tab. 3.6: Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN5.
Commissioning Sorgente Thomson ai LNF(dic. 2012);Rivelatori a Silicio ad integrazione verti-cale (dic. 2012);Prime immagini con sorgente Thomson(giu. 2012);Prototipo di rivelatore a diamante sinte-tico a pixel (dic. 2012);Primo prototipo di sistema di piani ditrattamento con fasci di ioni carbonio(dic. 2012);Convertitore per la produzione di fasci dineutroni ai LNL (dic. 2012);Accelerazione di fasci di protoni in plasmigenerati da impulsi laser ad alta potenza(dic. 2012);Misure e modelli radiobiologici per l’in-terpretazione degli effetti di fasci di ionicon la materia vivente per applicazioni inadroterapia e per la radioprotezione neiviaggi umani spaziali (dic. 2012);Sistemi di diagnostica per radiazione Fel(dic. 2012);Esperimenti di pump and probe con lasorgente THz (giu. 2013);Rivelatori a pixel in silicio e diamante sin-tetico per esperimenti a collider ad altaluminosità (giu. 2013);Ricostruzione di immagini con SorgenteThomson ai LNF (dic. 2013);Sorgente ECR per adroterapia e per acce-leratori alta intensità (dic. 2013);Realizzazione di sistemi di imaging avan-zato (proton CT, PET online) (gen. 2014);Misure di frammentazione nucleare peradroterapia (dic. 2014);Realizzazione di rivelatori per spettrosco-pia X di altissima risoluzione (dic. 2014).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
razione con l’industria e/o con enti di ricerca dialtri paesi europei.Tra i progetti europei nei quali l’INFN, grazie allecompetenze sviluppate nell’ambito di SPARC-LAB, avrà un ruolo di guida ci sarà sicuramenteil progetto ELI (Extreme Light Infrastructure).L’applicazione della fisica fondamentale alla sa-lute dell’uomo e all’ambiente sta diventandoun’esigenza primaria e riconosciuta della ricercamoderna. Nel campo dell’adroterapia, oltre allegià citate attività di fisica degli acceleratori, cre-sceranno gli studi di modellistica e radiobiologia,che hanno inoltre ricadute anche sull’attivitàumana nello spazio. Argomenti portanti sarannoin questo campo gli studi di radiobiologia, le mi-sure di sezioni d’urto di frammentazione nuclearee le simulazioni connesse che permetteranno, nelcampo della radioterapia, la realizzazione di pianidi trattamento più mirati. Saranno inoltre studiatisistemi innovativi di imaging del tipo Proton Com-puted Tomography e PET-Online. Nel complesso, va sottolineato che la CSN5 pos-siede le conoscenze di base e le competenzespecialistiche nelle tecniche più avanzate per losviluppo di sensori e rivelatori di radiazione,nella costruzione di sofisticate macchine accele-ratrici e nelle tecniche di simulazione e analisidati. È quindi in grado di operare in modo effi-cace il loro trasferimento al mondo della medi-cina, in particolare al campo dell’imagingmedico e della Radioterapia. Tuttavia, affinchéquesto trasferimento abbia successo, sia da unpunto di vista scientifico che sociale, è necessa-rio che l’Istituto nel prossimo decennio operi instretta cooperazione e sinergia con la fisica me-dica operativa e con il mondo medico.Nel tracciare la prospettiva futura bisognerà pro-grammare investimenti su tecniche e tecnologieconsolidate da trasferire al mondo industriale,che a sua volta le sviluppi nei suoi aspetti di af-fidabilità e riproducibilità per l’utilizzo operativoin campo medico. In una prospettiva di piùlungo termine, sarà altresì necessario investiresu nuove idee che seppure ora alla frontieradella conoscenza potranno, se ben indirizzate ecoordinate, portare nel futuro a sviluppi strate-gici nella prevenzione, diagnosi e terapia. In par-ticolare, i campi di ricerca biomedica nei qualil’INFN si impegnerà, attraverso la CSN5 e i pro-getti speciali e strategici ad essa connessi, sa-ranno la lotta contro il cancro ed il trattamentodelle malattie degenerative del sistema nervoso.Nel campo della fisica ambientale è prevedibileun incremento di specifiche iniziative di ricerca,
come la realizzazione di un Laboratorio di Ra-dioattività Ambientale ai LNGS per le analisi diradionuclidi e le loro applicazioni nel campodella Fisica Terrestre, dell’Ambiente, e della nonproliferazione nucleare. Le attività saranno svoltein collaborazione con Istituti di Ricerca e Organiz-zazioni Internazionali quali l’IAEA (InternationalAtomic Energy Agency) e l’ICTP (InternationalCentre for Theoretical Physics). Sempre in temadi controlli ambientali, continuerà lo sviluppodelle metodologie di analisi con fasci ionici dellepolveri fini in atmosfera, e saranno messe apunto le analisi con spettroscopia di massa conacceleratore per la determinazione dello 129I,tracciante di eventuali perdite di impianti nu-cleari. Inoltre, utilizzando l’alta sensibilità dei ri-velatori HPGe sviluppati nei laboratori di MilanoBicocca ed essendo questi laboratori gli unici inItalia ad individuare gli isotopi del Cs (134, 136,137), è stato possibile effettuare il monitoraggiodella nube di Fukushima, dimostrando una po-tenzialità unica nel poter fornire supporto alleattività di misura delle ARPA. Continuerà infinel’attività interdisciplinare rivolta al mondo dellaconservazione dei beni culturali anche attraversola ricerca e sviluppo di strumentazione portatileper analisi non distruttive.
Il panorama di sviluppo mostrato ben evidenzia lavitalità della comunità dei ricercatori INFN nelcampo delle ricerche tecnologiche e interdiscipli-nari, l’elevato impatto di questa ricerca sulla fisicaparticellare, astroparticellare e nucleare e le rica-dute in altri settori scientifici e della società. Taleattività richiede nei prossimi anni un’adeguata va-lorizzazione sia in termini finanziari che di risorseumane. Inoltre la CSN5 si propone come incuba-tore privilegiato per lo sviluppo di programmi diricerca da svolgere in collaborazione sia con l’in-dustria italiana ed europea sia con l’Università econ altri Enti di ricerca, con strutture sanitarie direspiro nazionale e regionale, con i Ministeri dellaSalute e dell’Ambiente e dei Beni Culturali e piùin generale con tutte le istituzioni che possono
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
49
Un incremento sostanziale dell’affidabi-lità e una riduzione dei consumi elettricirealizzata attraverso l’impiego di im-pianti specificatamente progettati perutenze informatiche ad alta densità dipotenza dissipata e dotati di adeguati li-velli di ridondanza;Lo sfruttamento ottimale delle risorse dicalcolo tramite l’efficace condivisione in unambiente applicativo eterogeneo in gradodi gestire applicazioni scientifiche multi-di-sciplinari, in qualche caso originate anchein ambienti di ricerca industriale;L’ottimizzazione dell’impiego del perso-nale.
•
•
•

rimentali e teoriche che, in alcuni casi, già oradispongono di grandi moli di dati o li stanno ve-locemente accumulando.
Adeguamento alla reteCome evidenziato da studi e proiezioni messi adisposizione su iniziativa della CCR già da qual-che anno, la crescita delle esigenze di calcoloscientifico dell’INFN richiede, in particolare perla sperimentazione al LHC, un rapido adegua-mento della rete della ricerca italiana GARR aimoderni standard tecnologici già adottati daaltre analoghe reti in Europa e negli Stati Uniti.Il progetto di nuova rete GARR-X, basata sul no-leggio di fibre spente e la gestione di apparatitrasmissivi proprietari, risponde a tali esigenzeed in corso di realizzazione, con previsione di ar-rivare a compimento a fine 2012.Per l’INFN è prioritario poter trarne da subito ilmassimo vantaggio, per cui sono già state indi-viduate le risorse finanziarie necessarie per l’am-modernamento degli apparati di connessionealla rete geografica, soprattutto nei centri Tier2per LHC e successivamente in tutti i rimanentisiti, a seconda delle relative necessità. Oltre apermettere i trasferimenti di dati a velocità del-l’ordine di 10 Gbps, la rete GARR-X permetteràanche di sviluppare più elevati livelli di integra-zione fra i siti INFN. Un esempio in questo sensodi applicazione già da ora funzionante è il colle-gamento a 10 Gbps realizzato dall’INFN fra inodi di calcolo residenti presso la Sezione di Pa-dova e il sistema di storage ospitato presso i La-boratori Nazionali di Legnaro. Nell'attesadell'avvento di GARR-X, i trasferimenti di dati diLHC hanno raggiunto i limiti di banda dei colle-gamenti attuali e si è quindi effettuato al rad-doppio delle capacità di banda dei siti Tier1 eTier2 della federazione WLCG.
Potenziamento dei servizi a livello nazionaleProseguirà nei prossimi anni l’impegno dellaCCR per rafforzare gli strumenti e i servizi fornitia livello nazionale. In particolare si persegui-ranno i seguenti obiettivi:
3.8 I PROGETTI STRATEGICIE I PROGETTI SPECIALI
Attività di rilevanza determinante nella program-mazione scientifica dell’Istituto sono svoltecome Progetti Strategici, seguiti da appositi co-mitati scientifici.Attività relative allo sviluppo e alla realizzazione diinfrastrutture di ricerca di rilevanza nazionale o in-ternazionale sono svolte come Progetti Specialiseguiti da appositi comitati tecnico-scientifici.
In questo paragrafo saranno descritti i progettistrategici:
• INFN-E (Applicazioni all’Energia)• NTA (Nuove Tecniche di Accelerazione)
E i progetti speciali:
• APE• SPES• INFN-GRID• ELN
Progetto strategico INFN-EnergiaINFN-E è una nuova linea di ricerca dell’Ente,il cui fine è lo sviluppo di competenze e stru-mentazioni nel settore delle applicazioni dellafisica nucleare all’ambito dell’energia.L’instaurazione di collaborazioni con le indu-strie del settore (in particolare Ansaldo Nu-cleare, SOGIN), così come con altri Entinazionali e internazionali con attività specifi-che nel settore (quali ENEA, CNR, Politecnici,Euratom), costituisce una premessa essenziale.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
52
Ulteriore diffusione nei centri INFN degli stru-menti che facilitano la condivisione delle risorse,con particolare riferimento alle possibilità, of-ferte dalle tecnologie di virtualizzazione, di di-saccoppiare le applicazioni dalle specifichecaratteristiche dell’ambiente di esecuzione;Promozione di un piano per l’accertamentocontinuo dell’efficienza energetica dei centri
di calcolo INFN che fornisca la base per even-tuali interventi migliorativi, verificandone poil’eficacia di implementazione;Ampliamento degli strumenti collaborativimessi recentemente a disposizione degli utentisu base nazionale e adozione di tecnologieVoIP (Voice over IP) per l’integrazione dellevarie modalità di comunicazione utilizzatenell’Ente;Estensione dei contratti nazionali e semplifica-zione della gestione attraverso l’implementa-zione nel nuovo sistema informativo dell’INFNdi funzionalità ad hoc già inserite nel correntepiano di sviluppo del sistema stesso;Miglioramento della sicurezza di tutta la reteINFN, rispetto a possibili attacchi informatici.
•
•
•
•
•
presso i Laboratori Nazionali e le Sezioni.È importante sottolineare come, in riferimentoa tutto il ciclo di vita delle infrastrutture di cal-colo, l’INFN abbia cercato negli ultimi anni dicreare uno stretto livello di coordinamento na-zionale delle attività legate al calcolo. Ciò purgarantendo l’autonoma azione delle sedi che,giovandosi dell’iniziativa del proprio personale,possono riuscire a cogliere le opportunità di si-nergie con altre istituzioni e finanziatori localicome, ad esempio, le Università, i centri di ri-cerca e gli enti locali. Un caso esemplare di si-nergia è costituito dai centri di supercalcolorealizzati al Sud presso Università e Consorzi re-gionali (Napoli, Catania e Cagliari) nell’ambitodel PON Ricerca 2000-2006 e dalla partecipa-zione al progetto Re.Ca.S. (Rete di calcolo perSuperB e altre applicazioni), approvato nell’am-bito dei PON infrastruttura. La CommissioneCalcolo e Reti dell’INFN è il principale strumentodi cui si serve l’INFN per realizzare tale coordi-namento, sia attraverso il vaglio delle richiestedi finanziamento per gli apparati destinati ai ser-vizi centrali di ciascuna sede, sia attraverso pro-mozione di attività e progetti specifici.
Nel 2011 la Commissione ha proposto finanzia-menti per il potenziamento delle infrastrutturedei siti INFN sulla base delle seguenti priorità:
Nel corso del 2011 si è completato il dispiega-mento del sistema di autenticazione e autoriz-zazione nazionale (progetto AAI) che permettenon solo di accedere ai servizi e alle risorse dicalcolo dell’INFN con un’unica credenziale, maanche di integrarsi con analoghi sistemi di altreistituzioni nazionali e internazionali. L’adozionedi tale infrastruttura consentirà un’interazionepiù efficiente degli utenti con i servizi, una sem-plificazione nella gestione degli stessi e beneficisignificativi sul fronte della sicurezza. Il primonucleo del nuovo sistema di AAI è operativo dal-l'estate e viene al momento utilizzato per l'au-tenticazione di accesso ai servizi centrali didipendenti ed associati. Inoltre AAI è stato inte-grato come Identity Provider e come fornitore diservizi nell'ambito della federazione IDEM, ge-stita dal GARR. Infine è stato consolidato il sup-porto delle tecnologie wireless basate sullostandard IEEE 802.1x (progetto TRIP), con la suaintegrazione con il Servizio EduROAM per laMobility.Da rilevare anche il consolidamento del sistemaridondato di server per la gestione di licenzesoftware su base nazionale. Il servizio di auditingper la sicurezza, effettuato da un nucleo diesperti dell’Ente attraverso controlli sistematicie finalizzato a valutare il livello di vulnerabilitàdei principali servizi informatici operanti nellesedi INFN, ha prodotto il primo rapporto. Infine,nel 2011 il piano per la formazione del perso-nale in campo informatico, strumento recente-mente introdotto dalla CCR per coordinare leiniziative promosse a livello nazionale ha com-preso attività formative rispondenti alle esigenzesia dei gruppi di ricerca, che del personale deiservizi e degli utenti dei servizi informatici, at-traverso varie tipologie di corsi fra cui una nuovaScuola Internazionale dedicata allo sviluppo diapplicazioni scientifiche su larga scala.
ProspettiveLa sfida principale che il sistema di calcolo distri-buito dell’INFN dovrà affrontare nei prossimianni, sarà rappresentata dalla prevista rapidacrescita delle attività di elaborazione ed analisidei dati prodotti dai quattro esperimenti a LHC.Ormai terminata la fase di adeguamento degliimpianti tecnologici, i centri INFN coinvolti do-vranno aumentare considerevolmente le propriecapacità e fornire agli esperimenti servizi ope-ranti in condizioni di funzionamento a regime.Ciò dovrà avvenire garantendo la piena dispo-nibilità delle risorse anche per altre attività spe-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
51
Favorire la costituzione di infrastrutturenazionali e di soluzioni esportabili; Implementare soluzioni che portino adun migliore impiego del personale deiservizi; Perseguire una razionalizzazione dell’uti-lizzo delle macchine utilizzate per i ser-vizi centrali; Consolidare le risorse di calcolo delleunità operative in un’ottica di infrastrut-tura condivisa.
•
•
•
•
Fig. 3.17: La rete planetaria GRID unisce e utilizza contemporaneamente la potenza di calcolo e la memoria di decine di migliaia di computer.

cherà, tra l’altro, una collaborazione in atto traINFN-E e l’Institute for civil security del JRC aIspra su quella parte del programma che ri-guarda l’uso di tecniche nucleari per problemidi sicurezza civile.
ADS, reattori veloci, bruciamento e trasmu-tazione scorie:nell’ambito della sperimentazione e progetta-zione di reattori a fissione di nuova generazione(Gen IV) e reattori guidati da acceleratori (ADS,Accelerator Driven Systems), sono operativi inEuropa vari progetti di R&D volti a definire le ca-ratteristiche di questi nuovi sistemi. In partico-lare, una delle configurazioni studiate prevededi utilizzare Piombo o Piombo/Bismuto comefluido refrigerante. L’Italia, con Ansaldo Nu-cleare, è leader in questo settore, che in Europaè portato avanti con i progetti GUINEVERE,MYRRHA, LEADER/ALFRED. Per progettare im-pianti di nuova concezione (critici o sottocritici),è di fondamentale importanza la disponibilità diinfrastrutture di ricerca dove i calcoli teorici sulcomportamento di questi sistemi innovativi pos-sano essere testati sperimentalmente. Di parti-colare importanza è la possibilità di misurareparametri di sistema come il coefficiente di mol-tiplicazione (keff), la distribuzione di flusso deineutroni e altri legati alla cinetica e dinamica delsistema, al fine di validare i codici di calcolo usatiper progettare gli impianti. Questo aspetto è diparticolare rilevanza nel caso di sistemi sottocri-tici tipo ADS. INFN-E contribuisce all’avanza-mento delle conoscenze in questo settore con iprogetti di:
In questo contesto, alcuni partecipanti a INFN-Ehanno ottenuto un finanziamento nell’ambitodel progetto UE FP7 “FREYA” per partecipare amisure di flusso neutronico nel reattore Guine-vere disponibile presso il centro di ricerche SCK-CEN di Mol (Belgio), pure basato su una matricedi Piombo solido. Le misure prevedono di carat-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
54
•
di combustibile immersi in una matrice diPiombo solido, controllato dal fascio di pro-toni del ciclotrone da 70 MeV e 50 kW incorso di acquisizione da parte dei LaboratoriNazionali di Legnaro.Al momento si sta anche studiando una ver-sione rimodulata, a ridotto o nullo contenutodi combustibile fissile, pensata per acceleratoripiù potenti quali IFMIF, che potrebbe essereutilizzata come dimostratore del bruciamentodelle scorie. Per ovviare alla scarsità di dati esi-stenti, all’interno di INFN-E la resa di neutroniin funzione dell’angolo e dell’energia è statamisurata nel caso di un convertitore di Beril-lio, utilizzando i protoni da 62 MeV prodottidal ciclotrone dei LNS (ADS: Sez. Ge, LNS, Ba,LNL). Questa parte di misure è pressoché con-clusa, mentre il progetto di ADS verrà docu-mentato in un CDR (Conceptual DesignReport) in base al quale si potranno verificarele possibilità concrete di finanziamento e rea-lizzazione di un’infrastruttura di questo genere;Un esperimento a zero potenza (NUC-SMILE:Sez. Pv, Mib, Polit. Mi), basato su di un pic-colo sistema sottocritico contenente Uranionaturale e acqua, disponibile presso il LENAdi Pavia, in cui si programma di sostituire l’ac-qua con pallini di Piombo ottenendo così unospettro di fissione non moderato. L’inserzionedi una sorgente di neutroni esterna permet-terà di studiare la cinetica del sistema. Sonostate effettuate simulazioni della configura-zione col Piombo e si stanno verificando lenecessarie pratiche autorizzative;Un apparato per simulare sperimentalmentelo spettro di neutroni veloci di un reattore(FARETRA: LNL). Il progetto prevede di utiliz-zare il ciclotrone in via di acquisizione pressoi LNL per produrre neutroni da un bersagliodi Tungsteno, utilizzando poi una opportunacombinazione di materiali per rimodulare lospettro primario e renderlo simile allo spettroveloce di un reattore. Sono state effettuatevarie simulazioni per dimostrare la fattibilitàe i proponenti sono alla ricerca di un finan-ziamento dedicato, dati i costi elevati.
Un Centro di formazione e ricerca, pensatosia per l’addestramento di giovani ingegneri,fisici e tecnici e la promozione culturale nelsettore (master, stage, dottorati, ecc.) in col-laborazione con Università e Industria, sia perlo studio della trasmutazione delle scorie ra-dioattive a vita lunga tramite fissione veloce.Tale Centro dovrà essere attrezzato con infra-strutture di interesse scientifico, ma dotatedella massima sicurezza e sostenibilità.La proposta iniziale di INFN-E, studiata appro-fonditamente in collaborazione con AnsaldoNucleare, Politecnici di Milano e Torino,ENEA, LENA di Pavia e altre Università, pre-vedeva che il Centro si costruisse intorno aun generatore di neutroni di bassa potenza(< 1 MW) basato su un piccolo reattore ve-loce sottocritico del tipo ADS, con elementi
•
•
•
Tale collaborazione fornisce da un lato le com-petenze complementari necessarie, dall’altroserve a indirizzare, sempre nell’ambito diun’ampia autonomia e libertà di idee, le pro-poste e gli sviluppi verso possibili utilizzi con-creti. INFN-E si articola su tematiche generali di co-mune interesse nelle quali l’Ente, nell’ambitodelle sue attività istituzionali, ha sviluppatoampie competenze e ottenuto importanti ri-sultati, quali:
Nel corso dei suoi tre anni di vita, INFN-E si è an-data costruendo intorno ai temi che ad oggi ap-paiono di maggiore interesse nell’industrianucleare, ovvero:
Di seguito riportiamo sinteticamente le attivitàsvolte per linee specifiche.
Trasferimento tecnologico:applicazione di nuove tecnologie, sviluppatedall’Istituto nel corso delle ricerche di base, aproblematiche tipiche dei programmi sull’Ener-gia Nucleare. Fanno parte di questa linea:
Tutti questi progetti erano stati approvati nel-l’ambito di Convenzioni dell’Ente con industrienazionali che ancora ne seguono realizzazioni esviluppi. Esiste inoltre una Convenzione tra ilJRC (Joint Research Centre) e l’INFN che ratifi-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
53
Rivelatori di nuclei, particelle e radiazione; Applicazioni di acceleratori di ioni e particellea problematiche nell’ambito dell’energia nu-cleare; Formazione superiore e professionale.
•
•
•
• Smantellamento degli impianti (decommis-sioning) e trattamento delle scorie;Controllo dei materiali radiologicamente rile-vanti (sicurezza ai varchi); Studio di nuove tipologie di impianti per lafissione nucleare, con caratteristiche di sicu-rezza avanzate (ADS, reattori veloci Genera-tion IV) e sviluppo di nuove metodologie ditest;Sviluppo di impianti per la fusione nucleare;Monitoraggio ambientale;Formazione e divulgazione;
•
•
•
•
•
zione da parte di Ansaldo Nucleare e SOGIN.È stato recentemente effettuato un test sufusti reali presso l’ex centrale nucleare del Ga-rigliano a Sessa Aurunca. Conclusa la faseINFN-E, sono in corso contatti con l’Eura-tom per l'eventuale formulazione di unbando di interesse per questo tipo di tec-nologia. Inoltre è in fase di elaborazioneun protocollo d’intesa con SOGIN relati-vamente alla sperimentazione per lo svi-luppo industriale di questa tecnologia;Un altro progetto, ora concluso (SPECTX:Sez.Ts), ha riguardato lo sviluppo di nuovi ri-velatori silicon drift per il monitoraggio adelevata risoluzione e angolo solido di raggi X; Progetti per la rivelazione non invasiva di sor-genti radioattive e materiali strategici nei con-tainers ai porti e ai varchi. Due prototipi,realizzati con tecnologie diverse quali la to-mografia con muoni cosmici mediante ca-mere a deriva (MUSTEEL: Sez. Pd, Sez. Ge,Tecnogamma, Acciaierie Beltrame) o la rive-lazione diretta di fotoni o neutroni con scin-tillatori a grande area caricati al gadolinio(PIC: Sez. Ge, JRC-Ispra, Ansaldo Nucleare)sono in fase avanzata di costruzione e test.La fase INFN-E è quindi da considerarsiconclusa. Entrambi i progetti hanno ot-tenuto, rispettivamente nel 2010 e nel2011, un finanziamento dall’UE nell’am-bito del FP7. Un nuovo progetto innovativobasato sulla rivelazione di neutroni tramitecattura in un recipiente d’acqua (WANDA:Sez. Ge) ha effettuato alcune prove dimo-strando la validità del concetto;Un progetto di nuovi rivelatori per il monito-raggio esterno della potenza e del burn-upnei reattori di potenza tramite la rivelazionedei flussi di antineutrini emessi dal nocciolo.Nell’ambito di INFN-E (CORMORAD: Sez. Ge,Ansaldo Nucleare) è stato costruito un proto-tipo, testato presso i reattori di Cernavoda(Romania), col quale si è potuto misurare ifondi e valutare la sensibilità. La parte INFN-E è conclusa, mentre, per le elevate dimen-sioni e costi, la costruzione dello strumentoeffettivo richiederà la partecipazione di orga-nismi internazionali (IAEA, UE, etc.)
Progetti per il controllo della contaminazioneambientale e delle fughe di radiazioni nei de-positi di scorie radioattive. Tra questi è in faseavanzata la realizzazione (DNMR: LNS, Sez.Mi, www.lns.infn.it/link/DMNR) di una rete difibre scintillanti per il monitoraggio on-linedell'attività di fusti contenitori di sostanze ra-dioattive nei depositi e la segnalazione dieventuali perdite, con interesse e collabora-
•
•

tari a ITER - l’INFN (Laboratori Nazionali di Le-gnaro, Sezioni di Padova, Torino, Bologna) haassunto un’importante responsabilità nella pro-gettazione e realizzazione dei RFQ di alta po-tenza per il primo stadio di IFMIF, un doppioacceleratore lineare di deutoni ad altissima in-tensità (40 MeV, 130 mA) dedicato alla produ-zione di fasci di neutroni (circa 1017n/sec), perlo studio dei materiali da utilizzare nei reattori.La parte del progetto sino ad ora finanziata(EVEDA) corrisponde ad un acceleratore di 9MeV e piena corrente, che verrà costruito dauna collaborazione europea (oltre all’INFN, prin-cipalmente CEA, Francia e CIEMAT, Spagna) einstallato in un’infrastruttura specifica costruitadal JAEA (Japan Atomic Energy Agency) pressoRokkasho nel nord del Giappone. Il primo stadioda 5 MeV che l’INFN sta costruendo rappresentail quadrupolo a radiofrequenza più potente almondo. Dopo la brasatura del primo prototipoa LNL fine ottobre 2010, è cominciata la parterealizzativa con la costruzione dei 18 moduli checostituiscono la struttura dei quali uno è giàstato completato. Parte importante del progettoè costituita dallo sviluppo di tutti i sottosistemi,vuoto, raffreddamento e controllo della fre-quenza, integrazione meccanica e funzionalenell’acceleratore. Sono previsti dei test parzialiin Europa seguiti dall’installazione e test con ilfascio in Giappone (presso il laboratorio di Rok-kasho) a partire dal 2013.L’INFN contribuisce con proprio personale alprogramma di integrazione delle varie compo-nenti dell’acceleratore in Giappone.
Progetto strategico ntaIl Progetto Strategico NTA (Nuove Tecniche di Ac-celerazione) ha l’obiettivo di sostenere e svilupparericerche, anche attraverso collaborazioni interna-zionali, nel campo della scienza degli acceleratorie, con più alta priorità, nel settore delle tecnologiead essi correlate.La realizzazione di nuovi acceleratori di particelleinfluenza (e, a sua volta, è influenzata da) unlargo spettro di attività scientifiche e tecnologi-che. Per questo la ricerca avanzata di tecnologieper nuovi acceleratori è vitale non solo per la fi-sica delle particelle elementari, ma anche per fa-vorire l’affermarsi di tecnologie innovative inmolti campi.Le tante applicazioni presenti e future delle mac-chine acceleratrici vanno dalle utilizzazioni pro-priamente scientifiche (schematizzate nella tabella3.6) al loro uso medicale ed industriale.
Nel triennio 2012-2014 attraverso il Progetto Stra-tegico NTA, saranno sviluppate ricerche nei settoriidentificati dalla comunità scientifica di riferimentoa livello internazionale come quelli di maggior in-teresse scientifico e tecnologico. Le attività di ri-cerca saranno portate avanti presso i LaboratoriNazionali di Frascati, di Legnaro e del Sud e pressole Unità Operative di Bologna, Catania, Ferrara,Genova, Milano, Milano Bicocca, Napoli, Pavia,Pisa, Roma, Roma Tor Vergata, Roma Tre e Trieste.La tabella 3.7 riassume le ricerche in corso di svol-gimento e che si concluderanno nel triennio 2012-2014: nella prima colonna è riportata l’area diricerca, nella seconda lo scopo della ricerca stessae nella terza colonna la sigla utilizzata all’internodel Progetto Strategico NTA. I risultati fin qui otte-nuti in queste attività hanno permesso all’INFN diconsolidare il suo ruolo di primo piano in campointernazionale nello sviluppo di concetti e di tec-nologie per i futuri acceleratori. A medio e lungotermine la sfida per le attività di Ricerca e Sviluppoconsisterà nel produrre fasci di vari tipi di particelle(elettroni, protoni, neutroni, muoni, ioni) a più alteenergie, con più alta intensità, con più alta bril-lanza e, per i collisori, con più alta luminosità. Que-sti obiettivi dovranno essere raggiunti con spesesocialmente sostenibili per quanto riguarda sia icosti di produzione, sia le spese di funzionamento,sia l’ammontare di potenza elettrica necessaria.Nella tabella 3.8 sono riportati i principali problemiche dovranno essere risolti al fine di progettare erealizzare i principali acceleratori (indicati nellaprima riga della tabella stessa) all’attenzione dellacomunità scientifica internazionale. Su tali temil’INFN, attraverso il Progetto Strategico NTA, è giàoggi operante e tali temi saranno anche al centrodelle sue attività a medio termine.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
56
Fig. 3.18: Schema di IFMIF-EVEDA, il prototipo di acceleratore di deutoniad altissima intensità per lo studio dei materiali per la produzione di energiada fusione nucleare.
terizzare il reattore in configurazione critica esottocritica, ove quest’ultima prevede di operareil sistema come ADS usando un acceleratore ela reazione Deuterio + Trizio per generare neu-troni veloci monocromatici.
Tecniche di produzione e monitoraggio dineutroni veloci:Lo studio di sistemi a fissione innovativi, critici esottocritici, così come la sperimentazione sui re-attori a fusione, può avere grande beneficio dallosviluppo di rivelatori in grado di misurare non soloil flusso di neutroni veloci ma anche la loro distri-buzione energetica. In questo contesto è stato av-viato il progetto RILF, volto a sviluppare rivelatoriinnovativi per neutroni energetici, adatti ad am-bienti con campi misti (neutroni/gamma) e con altiflussi di neutroni quali ADS, reattori veloci di bassapotenza e reattori a fusione sperimentali. RILF siarticola in due linee di ricerca:
Fisica del reattore:consiste nel rilancio, nell’ambito delle attività diFisica teorica dell’Istituto, delle ricerche sulla Fi-sica dei neutroni e sulle teorie di trasporto, siacoagulando le pochissime competenze rimastenel settore, sia contribuendo a formarne dellenuove tra i ricercatori delle nuove generazioni.Una attività teorica di questo tipo costituisce unpresupposto necessario per lo sviluppo di pro-getti sulla produzione di Energia Nucleare siaper fissione che per fusione. Il programmaFISNE, partito presso la sezione di Genova in col-laborazione coi Politecnici di Torino e di Milano,
sullo studio del comportamento cinetico e dina-mico (dipendenza dalla temperatura) dei reattoridi nuova generazione, fornirà elementi impor-tanti per la comprensione del funzionamento diADS in corso di realizzazione in Europa qualiGUINEVERE e MYRRHA.
Fusione nucleare:le attività in corso si articolano su due linee pro-grammatiche distinte e complementari:
ITER:il contributo dell’INFN a ITER consiste essenzial-mente nel progetto e nella costruzione, nell’am-bito del Consorzio RFX con ENEA, CNR, Universitàdi Padova e Acciaierie Venete, di una test facilityper il sistema di Iniezione a Atomi Neutri (NBI), checostituirà uno dei principali metodi di riscalda-mento ausiliare del plasma e verrà realizzato dalConsorzio presso il centro di ricerca CNR di Pa-dova. Nel 2010 è stato completato il progettodella sorgente di ioni negativi che dovrà esseremontata ai LNL e lo studio della dinamica del fa-scio di ioni. Il 2011 si è concluso con l’approva-zione definitiva da parte dell’organismo Europeo“Fusion for Energy” della test facility da costruirepresso il CNR di Padova. Il Laboratorio di Legnarosupporta il progetto contribuendo allo studiodella dinamica dei fasci e sviluppando il progettocriogenico di raffreddamento delle varie com-ponenti del sistema. Compito del laboratorio èanche lo studio delle alte tensioni in vuoto.
IFMIF (International Fusion Materials Irra-diation Facility):nell’ambito del Broader Approach - un accordotra il Giappone e alcuni Paesi Europei per la rea-lizzazione di sistemi e infrastrutture complemen-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
55
•
•
La prima linea (Sez. Ge, To) riguarda rivelatoribasati su cristalli di diamante, caratterizzatida segnali molto veloci e alta resistenza allaradiazione. Rivelatori commerciali sono statitestati con varie sorgenti e attualmente si stalavorando con l’Università di Tor Vergata el’ENEA di Frascati alla realizzazione di un ri-velatore a sandwich. In futuro si prevede ditestare questi rivelatori nell’ambito del pro-getto UE “FREYA”;La seconda linea (LNL) riguarda lo sviluppo diun rivelatore a fibre ottiche al quarzo. L'obiet-tivo è di usare questi rivelatori per misure pra-ticamente puntuali (spazialmente) di alti flussi(all'interno della facility FARETRA, vedi sopra)dove altri tipi di rivelatori sarebbero accecati.Attualmente sono stati realizzati e testati al-cuni rivelatori e si sta verificando la possibilitàdi testarli al CN dei LNL.
Tab. 3.7: Applicazioni delle macchine acceleratrici a uso scientifico.
Campo di interesse
Fisica atomica
Fisica della materiacondensata
Fisica della materiacondensata
Scienza deimateriali
Chimica ebiologiamateriali
Acceleratore
Fasci di ioni a bassa energia
Sorgenti di Radiazione diSincrotone
Sorgenti di neutroni daspallazioni
Fasci di ioni
Sorgenti di Radiazione diSincrotone
Temi di studio
Processi di collisione atomica,studio di stati eccitati,collisioni elettrone-ione,potere frenante degli elettroninei solidi
Studi di strutture cristallinecon i raggi X
Studi di scattering di neutronisu metalli, cristalli., liquidi emateriali amorfi
Analisi di materiali dopoattivazione con protoni eraggi X;Studi di emissione di raggi X; Spettrometria di massa conacceleratore
Studi del legame chimico;Dinamiche e cinematichebiologiche;Cristallografia di proteine e divirus

Progetto speciale APEIl Supercalcolo in ambito INFN: stato e pro-spettiveLa simulazione numerica rappresenta uno stru-mento fondamentale per le ricerche di base deigruppi teorici e sperimentali. In ambito INFN sonotradizionalmente attive comunità scientifiche cheutilizzano supercalcolatori per lo studio numericodelle interazioni forti (LQCD, Lattice QuantumChromo Dynamics, capace di spiegare con metodistatistici ed algoritmi numerici le proprietà dellamateria subnucleare), di problemi di MeccanicaStatistica, della dinamica dei fluidi in regime tur-bolento e della biologia computazionale. Le esigenze di calcolo nel settore della fisica adro-nica e del flavour sul reticolo sono state oggettonel corso degli ultimi anni di studi quantitativi edettagliati, effettuati in particolare in ambito INFNin previsione dello sviluppo della SuperB factory.Alla luce di queste analisi siamo in grado di quan-tificare in un PetaFlops nel 2013 e in 10 PetaFolpsnel triennio successivo, quelle che sono le esi-genze di calcolo dei gruppi teorici INFN dettate inprimo luogo dalla necessità di mantenere l'accu-ratezza delle previsioni teoriche al livello richiestodalla precisione delle esperimenti presenti e futuriin questo settore, in particolare LHC(b) e SuperB. Da un punto di vista tecnologico i sistemi di cal-colo data la loro scala dovranno essere caratteriz-zati da elevata efficienza computazionale, bassoconsumo elettrico ed alta integrazione.Nel corso degli ultimi venti anni, l’INFN ha svilup-pato macchine di calcolo parallelo attraverso ilprogetto speciale APE/APE100/APEMille/apeNEXT;ciò ha permesso alla comunità scientifica italiana(e, più generalmente, europea) di tenere il passocon il progresso della ricerca nel campo delle in-terazioni forti in regime non-perturbativo (LatticeGauge Theory). Nelle diverse fasi di evoluzione delprogetto, le macchine APE sono sempre state for-temente connotate da caratteristiche architetturaliche hanno, di fatto, costituito un vero e proprioparadigma, rivelatosi vincente nel campo del cal-colo parallelo a elevate prestazioni, e che oggi sitrovano implementate nei supercomputer com-merciali di ultima generazione. In particolare: ilprocessore elementare di calcolo VLSI custom (chegarantisce straordinaria efficienza computazionalesulle applicazioni d’interesse), la rete di comuni-cazione interprocessore con connettività punto-punto a primo vicino a griglia tridimensionale (adalte prestazioni e bassa latenza), un eccellenterapporto potenza dissipata/prestazioni che garan-tisce alta integrazione e ridotti costi realizzativi e
di esercizio. L’ultima realizzazione, apeNEXT, è co-stituita da un insieme di supercomputer installatiall’Università di Roma “La Sapienza” capaci dicomplessivi 12 TeraFlops e utilizzati da vari gruppiteorici inseriti in più ampie collaborazioni interna-zionali.Sempre nello stesso ambito, l’apertura di una se-conda linea di ricerca, apeNET, ha permesso direalizzare sistemi di calcolo basati su PC Clusterscommerciali equipaggiati da reti dedicate 3Di-mensionali di derivazione APE ed implementatesu componenti programmabili (FPGA).Tali sviluppi hanno portato all’installazione di duesistemi da 96 e 128 nodi di calcolo (rispettiva-mente presso la Sezione INFN di Tor Vergata epresso l’ECT* di Trento) interconnessi dalla reteapeNET e caratterizzati, contrariamente ai clusterinterconnessi da network commerciali, da scala-bilità (quasi lineare) delle performance con il nu-mero dei processori.Il progetto APE, nelle sue varie evoluzioni, haanche consentito all’Italia di presidiare le attivitàdi ricerca sul calcolo parallelo e le relative tecno-logie di sviluppo (software e hardware) e di gene-rare rilevanti risultati di trasferimento tecnologico,ad esempio nel settore del computing dedicatoad alte prestazioni (Quadrics, società di Finmec-canica, nella metà degli anni ‘90 e più recente-mente EUROTECH) e dell’elettronica per sistemiembedded (ATMEL Roma). Si tratta di tecnologiee competenze strategiche per l’Italia e l’Europa edinfatti membri del gruppo APE coordinano e par-tecipano con ruoli di leadership ad importanti pro-getti europei (progetti FP6 SHAPES ed HARTES eprogetto FP7 EURETILE) nel settore delle ”Advan-ced Computing Architectures” e degli ”Embed-ded Systems” derivati dal know-how sviluppatonegli anni in ambito APE.Non bisogna inoltre dimenticare come questainiziativa abbia permesso la formazione di alcunedecine di ricercatori e tecnologi specializzati nellaprogettazione di sistemi su silicio e software disistema, un’esperienza unica e strategica per ilpanorama italiano e di grande valore scientificoe tecnologico a livello europeo.Al fine di conservare la posizione competitivaraggiunta a livello internazionale, la collabora-zione ha intrapreso iniziative di ricerca e sviluppoper arrivare alla realizzazione di supercomputernella fascia del PetaFlops utilizzando tecnologiestate-of-the-art.La roadmap di breve/medio periodo, nell’oriz-zonte temporale del piano triennale, prevede larealizzazione di sistemi ibridi “cpu commerciali -
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
58
Applicazioni delle macchine acceleratrici ad usomedico e industriale:
HIGHLIGHT del 2011
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
57
Diagnostica medica con radioisotopi prodotticon fasci accelerati;Terapie antitumorali con radiazioni, utiliz-zando: protoni, ioni pesanti, pioni, raggi X daLinac ad elettroni, neutroni da Linac a pro-toni;Individuazione di pozzi petroliferi con sor-genti di neutroni;Impiantazione ionica con fasci di ioni positivi;Polimerizzazione, vulcanizzazione, sterilizza-zione di cibo, produzione di membrane mi-croporose etc;Datazione archeologica per mezzo di spettro-scopia di massa con acceleratori.
•
•
•
•
•
Area di ricerca
Teoria degliacceleratori
Simulazionicomputerizzate
Cavità a RFsuperconduttrici
Criogenia
Sorgenti
Diagnostica deifasci e relativastrumentazione
Magneti
Acceleratori alaser-plasma
Tecnologie edinfrastrutturedi sostegno alleattività di Ricerca&Sviluppo
Obiettivi
Studi su “Crab-waist” e “Crab-crossing”per massimizzare la luminosità dimacchina
Damping Ring per ILC: definizione dellattice e valutazione dell’effetto di nuvolaelettronica sui positroni
Realizzazione di cavità super conduttricicon tecniche di spinning(a); R&S dimateriali sc con temperatura criticamaggiore del Niobio per cavità ad alto beta(a); “sputtering” di Niobio con Magnetron(a); cavità sc in terza armonica (b)
Progettazione e realizzazione di criomoduliper X-Fel (Desy, in costruzione) e ILC (inprogettazione)
Sorgenti di ioni, per fasci ad alta brillanza;fotocatodi per “cannoni” ad alta brillanza(a); generazione di fasci di raggi X, 20-500keV ad alta cromaticità, rapidità e brillanzadi picco (b)
Rimozione della “e-cloud” con film sottilidi materiali innovativi
Modifica dei poli di magnete wiggler perottimizzazione dei campi
Accelazione sfruttando alti gradientigenerati nella interazione laser –plasmacon auto iniezione o iniezione esterna
Kickers rapidi per iniezione/estrazione inanelli di accumulazione (a); Deflettori a RF,Monitor a RF della posizione dei fasci.Partecipazione alla progettazione erealizzazione della Clic Test Facility (CTF3al CERN) (b)
Sigla dell’attivitàdi ricerca
Super-B/LNF
ILC/LNF
a) Shamash/LNL b) ILC/Mi
ILC/Mi
a) ILC/Mib) SparcLab:LNF-Bo-Mi-Na-Pi
Imca/LNF
ILC/LNF
SparcLab:LNF-Bo-Ct-Pi-Mi-Na-RmI
a) ILC/LNFb) CLIC/LNF
Tab. 3.8: Classificazione delle ricerche svolte nel progetto strategico NTA
Argomenti R&D
Nuvola di elettroni (e-cloud) x x x x x xFondo di ioni (Ion effect) x x x x xRadiazione coerente di sincrotone x xEffetti di carica spaziale x x x x x x xScie di pacchetti corti (Short bunch wakes) x xSimulazioni al computer x x x x x x xTeoria x x x x x x xStrumentazione x x x x x xAlti gradienti nc1 x x xAlti gradienti sc2 x x x x x xRaffreddamento elettronicoRaffreddamento stocastico3 xRaffreddamento per ionizzazione x xHOM damping x x xEmittanza ultra-basse x x xSorgenti ultra-brillanti4 x xSorgenti di positroni xTarghette per alte potenze x x x xMagneti sc5 x x x xFixed Field Alt Grad x x xAccelerazione con laser6 x xCampo-scia dei fasci xImpianti e attrezzature per test x x x x
Tab. 3.9: Problematiche e possibili applicazioni studiate in NTA
n Factory
Muon Collider
e+e-Collider
VLHC+SLHC
Sorgenti di luce da LINAC
Medicina, Fusione, Industria
Sorgenti di Neutroni
1Cavità e amplificatori implementazionedi potenzialità ed efficienza2Cavità, processi e materiali3Microonde e ottiche4Sorgenti di fotoni ncrf, scrf e dc5struttura dei magneti, processi e materiali6Laser plasma, linac
Sono continuati gli studi sui DampingRing, che i relativi test su DAFNE hannoportato ad una esperienza riconosciuta intutto il mondo;I magneti dipolari superconduttivi curvi,ritenuti improponibili fino al progetto esperimentazione lanciato in NTA, sonoora una soluzione di riferimento: il pro-totipo messo a punto da DISCORAP (conla collaborazione di Ansaldo) nel 2011sarà sottoposto a test risolutivi per poterproporre la loro realizzazione su scala in-dustriale;Nel 2010, presso i LNF, sono state ottenutele prime accelerazioni mediante intera-zione laserplasma. L’attività del complessoFlame (laser di alta potenza) – SPARC(iniettore a RF di alta brillanza) entrerà neiprossimi tre anni nella piena fase speri-mentale. L’utilizzazione di questa stru-mentazione integrata, iniettore RF-laser(di assoluto interesse internazionale), con-sentirà di produrre altissimi gradienti di ac-celerazione, e ci si attende che possa aprirela strada ad una nuova era nell’accelara-zione di particelle elementari;Gli studi sul progetto SuperB stanno pro-cedendo speditamente, a conferma delfatto che il progetto SuperB rappresentaun’attività di importanza strategica perl’INFN e per la sua collocazione in campointernazionale.
•
•
•
•

pliche del prototipo di QUonG attualmente infase di integrazione sarà quindi possibile realizzareuna installazione di classe PetaFlop (peak singolaprecisione) con circa 15 armadi e un volume dioccupazione simile all’attuale installazione diapeNEXT di Roma.Nella tabella 3.10 è inoltre riportata una previ-sione degli indici di performance di costo e pre-stazioni per singolo armadio basata sullo scalingtecnologico aspettato per le unità GPGPU. Leprossime generazioni di GPU (Nvidia Kepler di in-troduzione attesa nel 2012) raggiungeranno
performance dell’ordine dei 5 TeraFlop per de-vice permettendo la realizzazione un’installa-zione molto compatta di classe multi-PetaFlopad un costo di poco superiore a 1 MEuro/Peta-Flop con annessa una sensibile riduzione deicosti operativi dovuti ad un più basso consumoed ad una più alta integrazione.Il progetto QUonG fa leva sul co-finanziamentodell’UE, realizzato attraverso la partecipazionedell'Ente a progetti Europei FP7 in questa parti-colare area di ricerca, e la collaborazione di sele-zionati partner internazionali accademici edindustriali. Nell'ambito del progetto Europeo EU-RETILE, coordinato dall'INFN, sarà infatti possibileproseguire in maniera sinergica lo sviluppo delnetwork processor ottimizzato per l'architetturaQUonG e lo studio di nuovi modelli di program-mazione efficiente per le architetture many-core.
Strutture INFN e altre istituzioni parteci-pantiAl progetto APE collaborano ad oggi ricercatorie tecnologi afferenti alle sezioni INFN di Roma eRoma Tor Vergata, mentre le sezioni di Ferrara,Milano Bicocca ed il gruppo collegato di Parmasono coinvolte nel progetto AURORA. In aggiunta presso le sezioni di Roma, Roma TorVergata, Ferrara, Milano Bicocca, Parma, Pisa,Bari sono presenti gruppi di fisici teorici che uti-lizzano i sistemi APE per ricerche in LGT, biologia
computazionale, fluidodinamica. I principali par-tner tecnologici, accademici, nazionali ed inter-nazionali che collaborano con l’INFN in questaarea di ricerca grazie a collaborazioni stabiliteanche in sede di progetti europei sono riportatinel seguente elenco non esaustivo:
• Università di Pisa, Dipartimentodi Ingegneria dell’Informazione
• Università di Roma Sapienza,Dipartimento di Ingegneria Elettronica
• Università di Padova, Dipartimentodi Elettronica e Informatica
• RWTH AAchen University, ISS• Swiss Federal Institute of TechnologyZurich, CH
• Università di Julich e Wuppertal • Tima e Université Joseph FourierGrenoble I
Principali partner industriali:
• NVidia• Atmel • Eurotech spa • Sky Technology • Seco• Finmeccanca-Quadrics, nel passato
Sorgenti di finanziamento e ammontareLe principali fonti di finanziamento per le attivitàcollegate al progetto APE sono, oltre al budgetordinario INFN, il contributo per la partecipazionea progetti Europei FP6 ed FP7 e per il progettoAURORA il co-finanziamento della Provincia Au-tonoma di Trento (PAT).Come evidenziato nella tabella 3.11 nel periodo2006-2013 la partecipazione del gruppo ai pro-getti Europei FP6 ed FP7 ha generato un cofi-nanziamento pari a 2900 KEuro utilizzato prin-cipalmente per il reclutamento di giovani ricer-catori e tecnologi da impiegare nelle attività diricerca e sviluppo.Nella tabella 3.11 sono inoltre indicate leprevisioni di spesa per la realizzazione dell’in-stallazione di classe PetaFlop la cui roadmapprevede nel 2012 l’integrazione di un prototipodi armadio completo da 70 TeraFlop per uncosto pari a 300 KEuro e nei 2 anni successiviun investimento pari a circa 2 MEuro per la co-struzione del sistema finale nell’ambito del pro-getto premiale di supercalcolo INFN SUMA.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
60
reti dedicate” secondo le seguenti molteplicilinee di sviluppo:
Progetto apeNET+:nell’arco del 2011 la collaborazione ha terminatolo sviluppo della nuova generazione di apeNETdenominata apeNET+ con l'obiettivo di realizzarel'infrastruttura di network efficente per i clusterdi PC da impiegare nel calcolo scientifico.L'hardware di apeNET+ impiega una FPGA ad alteprestazioni con una capacità di trasferimentocomplessiva pari a 500 Gbit/s per nodo di calcolograzie all’integrazione del network processor dinuova generazione sviluppato dalla collabora-zione nell’ambito dei progetti europei a cui par-tecipa.Nel 2011 la collaborazione ha assemblato unmini-cluster da 4 nodi che scalerà ad 8 entro lametà del 2012. apeNET+ sarà utilizzata comebackbone di connessione per i sistemi ibridiQUonG attualmente in fase di realizzazione (vediparagrafi successivi). La flessibilità dell’architetturadi apeNET+ ha permesso di realizzare una networkinterface che, unica al mondo, supporta la tecno-logia peer-to-peer presente nelle GPU (Graphic-Processing Unit) Nvidia di ultima generazione chegarantisce una sostanziale riduzione delle latenzed’accesso e permette l’offloading della CPU perquanto riguarda l’onerosa gestione dei trasferi-menti remoti da/verso la GPU.
Progetto AURORA:coordinato dalla EUROTECH spa e cofinanziatodalla Provincia Autonoma di Trento, si prefiggedi realizzare macchine di calcolo basate su pro-cessori commerciali INTEL interconnessi da unarete toroidale 3Dimensionale (contributo origi-nale dell’INFN al progetto) con elevata densitàdi processori per volume (pari a circa 4 volte uncluster di PC standard).In funzione della generazione di processori in-tegrata le prestazioni scalano da 10 a 50 Tera-Flops per armadio.
PC Cluster accelerati con GPU (Graphic Proces-sing Unit): progetto QUonG:l’emergere di nuove architetture di calcolo perla grafica ad alte prestazioni (Graphic ProcessingUnit, GPU), spinte da un mercato dei videogio-chi valutato in 10 miliardi di $ per anno, carat-terizzate da elevate potenze di calcolo (>1TeraFlop per singolo chip), notevole rapportoFlop/Watt e Flop/$ e con caratteristiche architet-turali estremamente favorevoli per il calcoloscientifico, permette di progettare sistemi ibridiCPU+GPU in grado di scalare alle centinaia diTeraFlops per armadio. In questo ambito l’INFNha intrapreso la realizzazione del sistemaQUonG, una piattaforma parallela scalabile alPetaFlops, basata su meccanica commerciale eprocessori commodities Intel, accelerata attra-verso GPU di ultima generazione ed intercon-nessa dal network apeNET+.L'interesse applicativo per questa nuova architet-tura di calcolo permette all'INFN di coagulare, in-torno al progetto, un gruppo composto daricercatori esperti in molteplici ambiti di ricerca:tra questi si evidenziano gruppi INFN attivi in am-bito teorie di campo su reticolo, bio-computing,gravitational waves analysis, progettazione di si-stemi di trigger ai colliders ma anche fisici com-putazionali, internazionalmente riconosciuti,esperti di fluidodinamica applicata alla medicina,sistemi complessi, genomica computazionale,neural network. L'adozione della piattaforma dicalcolo QUonG in tali molteplici aree di ricercagarantisce l'applicazionedi un modello già speri-mentato, con le passategenerazioni di sistemi APE,che ha portato rilevanti ri-sultati scientifici e note-vole visibilità nazionale edinternazionale.Dalla tabella 3.10 si eviden-zia che già nel 2012 è pos-sibile installare sistemi ar-madio di dimensione stan-dard composti da nodi dicalcolo multiprocessore eacceleratori GPU-based alcosto di circa 300 kEuroper armadio e con una po-tenza di calcolo di picco di~75 TeraFlop in singola pre-cisione e ~37 TeraFlop indoppia precisione. Di con-seguenza a partire da re-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
59
Fig. 3.19: Schede apeNEXT+
Fig. 3.20: ProgettoQUOnG: CPU+GPU conapeNET+
2011-20122013-2014
Tab. 3.10: Caratteristiche dei sistemi multi-processore.
SingolaPrecisione
75300*
Peak Perf/rack (TeraFlops)
Sistema ibrido “multi processore-GPU” con apeNET+
Note:* performances previste con adozione di GPU di ultima generazione con introduzioneprevista per 2H/2012
** costo previsto con adozione di GPU di ultima generazione e re-scaling dei costiin produzione delle apeNET+
Costo perRack(KEuro)Singola
Precisione37150*
~300~280**
# armadiper sistemaPetaFlop
154

Sistema di front-end ISOL:si sono eseguiti esperimenti sotto fascio di ca-ratterizzazione del materiale del bersaglio pressoORNL (Oak Ridge, USA) e sono stati pubblicati irisultati delle misure precedenti.È stata messa in funzione la sorgente al plasmaper la produzione di fasci di alogeni ed è iniziatala sperimentazione con la sorgente laser.
Ri-acceleratore:si è concluso lo studio per la definizione del si-stema di pre-accelerazione adottando lo svi-luppo di un sistema a RFQ calda che utilizza latecnologia già sviluppata per IFMIF a LNL-Pd-To-Bo. É stata abbandonata la soluzione con piat-taforma a 250kV la cui operatività è consideratapoco affidabile nell’ambiente ad alta radiazionedel bersaglio ISOL.
Scuola SPES:è stata organizzata una Scuola internazionaledi formazione in tecniche sperimentali confasci radioattivi ("First SPES School on Experi-mental Tecniques with Radioactive Beams",Laboratori Nazionali del Sud, 8-11 novembre2011).La scuola ha avuto un ottimo successo con lapresenza di molti giovani laureandi, laureati ePhD, ricercatori junior e senior, e un ampiocontesto internazionale.Sono stati affrontate alcune delle problemati-che più rilevanti nel campo della fisica con ifasci radioattivi, dando rilievo alle tecniche dirivelazione, e mostrando l'attività sviluppataed in corso in molti laboratori nel mondo.
Progetto premiale:Il progetto SPES è stato presentato al MIURcome Progetto Premiale 2011.
Progetto di rilevanza scientificaSPES-ISOL:l’attività principale del Progetto SPES è lo svi-luppo della Fisica Nucleare fondamentale perlo studio dei nuclei lontani dalla valle della sta-bilità con fasci instabili. Il Progetto SPES pre-vede l’uso del metodo ISOL per la produzionedei fasci instabili utilizzando una potenza sulbersaglio primario di circa 10 KW.I fasci saranno prodotti utilizzando la reazionedi fissione dell’Uranio indotta da protoni.Come driver di protoni si utilizzerà un ciclo-trone da 35-70 MeV ad alta intensità (fino a500 micro A). Il rate di fissioni previsto nel ber-
saglio di produzione è di 1013 fissioni al se-condo e permetterà di ottenere fasci di inten-sità uno-due ordini di grandezza superiori aquanto attualmente disponibile. I fasci pro-dotti saranno pre-accelerati e iniettati nell’ac-celeratore lineare superconduttivo ALPI deiLNL. Il progetto è in fase di realizzazione.Compete a livello internazionale con SPIRAL2in Francia, HIE-ISOLDE al CERN, up-grade diHRIBF in USA (Oak Ridge National Lab), ISACin Canada (TRIUMF).
Progetti di rilevanza applicativaI progetti applicativi sono attualmente a livellodi studio di fattibilità:si sono creati due gruppi di studio per l’uso delfascio del ciclotrone in attività applicative.
Progetti basati sull’uso del fascio di protoni delCICLOTRONE:
LINCE: Legnaro Italian Neutron CEnterIl fascio di protoni del ciclotrone permette digenerare neutroni con uno spettro energeticonon disponibile ai reattori nucleari e con carat-teristiche spettrali che possono essere calibratecon moderatori opportuni o agendo diretta-mente sul fascio di protoni. SPES partecipa a UCANS (Union for CompactAccelerator-driven Neutron Sources). L’Unioneper le sorgenti compatte di neutroni basate suacceleratori è nata nel 2010 ed ha lo scopo didare supporto e coordinamento ad una comu-nità in via di rapida espansione soprattutto inUSA, Cina e Giappone. Sono stati presentati, da una collaborazione diricercatori di vari enti (INFN, CNR, Uni Roma2,Padova, Camerino), due progetti che utiliz-zano il ciclotrone come “driver” per la produ-zione di neutroni:
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
62
Principali linee di attivitàNell’ambito del progetto SPES è stata valutatala realizzazione di tre aree per attività sia appli-cative che di Fisica fondamentale:
1. Area ISOL con produzione di fasci di ioni eso-tici e selezione isotopica ad alta risoluzione.
2. Laboratorio per l’uso del secondo fascio diprotoni del ciclotrone, per la produzione di ra-dioisotopi innovativi per applicazioni medichenel campo della diagnostica e della terapia.
3. Laboratorio per la produzione di neutroni uti-lizzando il fascio del ciclotrone e bersagli di varimateriali (Litio, Berillio, Tungsteno, ecc.) per lostudio dei reattori nucleari di IV generazione eapplicazioni nel campo dei materiali, dell’indu-stria, della medicina e dell’astrofisica.
Il progetto è stato suddiviso in fasi successive direalizzazione e finanziamento. Ogni fase per-mette l’utilizzo della struttura con un gradomaggiore di funzionalità come riassunto nellatabella 3.12.
Principali risultati conseguiti nel 2011Ciclotrone: nel 2011 è iniziata la realizzazione del ciclotronepresso la ditta BEST (Canada) che ha presentatoil progetto realizzativo nel Giugno 2011, in ac-cordo con il piano di lavoro sottoscritto con ilcontratto per l’acquisizione del ciclotrone fir-mato nell’Ottobre 2010. Il progetto è stato ana-lizzato e valutato positivamente dal gruppo diesperti che fa riferimento alla task5 del progettoSPES.La consegna del progetto è la prima milestoneper l’inizio del pagamento. Sono stati versati allaBEST 3 Meuro, secondo quanto previsto nelcontratto, nel Luglio 2011.A Gennaio 2012 è stato forgiato il ferro del ma-gnete che è in fase di spedizione dalla ditta co-struttrice in Giappone alla BEST in Canada. Ilpiano di lavoro segue la tempistica programmata.
Edilizia: è stato ridefinito il layout della zona di trasferi-mento e selezione del fascio ottimizzando il per-corso delle linee e la disposizione delleapparecchiature. Questo processo ha portato al-l’ottimizzazione dell’edilizia ed è entrato nella faseconclusiva il progetto esecutivo dell’edilizia e degliimpianti.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
61
Progetto speciale SPESSelective Production of Exotic Species (Produ-zione Selettiva di Specie esotiche)Il progetto SPES è inserito in una rete di colla-borazioni che è mostrata in figura 3.21.
Obiettivi1. Realizzare un sistema ISOL di seconda gene-razione che fornisca fasci di ioni ricchi di neu-troni per lo studio della fisica nucleare fuori dallavalle di stabilità.2. Fornire una struttura di ricerca in grado disoddisfare, oltre agli obiettivi scientifici, esigenzeapplicative di interesse nazionale e internazio-nale.Ecco alcune delle caratteristiche tecniche prin-cipali del progetto:
Metodo di produzione di fasci esotici:fissione dell’uranio indotta da fascio di protonisu bersaglio diretto di UCx. Estrazione del fasciocon tecnica ISOL.
Fissioni in bersaglio:1013 fissioni al secondo.
Riacceleratore:sistema PIAVE-ALPI, energie di fascio 5-10 MeVper nucleone. Caratteristiche di fascio attual-mente non disponibili nel panorama internazio-nale.
Facility della stessa classe:HIE-ISOLDE e SPIRAL2 (in fase di realizzazione).
APE: fondi ordinari in KEuro
201020112012
(2013-2014) Progetto premiale supercalcolo APE: Fondi esterni in KEuro EU FP6/FP7)
2006-2009 (SHAPES)2010-2013 (EURETILE)
AURORA: fondi ordinari in KEuro2009-2011 (Fase 1)2012-2013 (Fase 2)
AURORA: fondi esterni in KEuro (PAT)2009-2011 (Fase 1)2012-2013 (Fase 2)
Finanziamento
1201503002000*
Finanziamento8002100
Finanziamento300600**
Finanziamento 1500600***
Tab. 3.11: Finanziamenti del progetto APE.
Note:* Finanziamenti richiesti per fasi successive del progetto** Richiesta finanziaria all’INFN per AURORA Fase 2 attualmente in fase di discussione*** Quota legata all’eventuale finanziamento INFN di AURORA fase 2.
FARETRA (FAst REactor simulator for TRAn-smutation studies) per l’uso di neutroni in ap-plicazioni energetiche. Ha lo scopo diprodurre un fascio di neutroni con caratteri-stiche spettrali simili a quelle previste per i re-attori di IV generazione (da qualche KeV aqualche MeV).Tale fascio sarà utilizzato per misure integralidi sezioni d’urto di fissione e di cattura su at-tinidi e frammenti di fissione a breve vitamedia, o per misure di attivazione di partistrutturali e materiali per raffreddamento peri reattori veloci di IV Generazione;
•

Risorse finanziarieIl progetto utilizza risorse finanziarie INFN. Per le attività applicative sono in corso contatticon Università e ASL sul territorio veneto per illoro coinvolgimento nella realizzazione di partidi interesse specifico.
HIGHLIGHT 2010-2011
MILESTONE 2012
Prospettive a medio termineIl ciclotrone, con due fasci di protoni estratticontemporaneamente, permette di soddisfaredue utenze senza sensibili interferenze: la facilityISOL ed una facility applicativa possono essereoperate contemporaneamente. A medio termine SPES si presenta come un pro-getto in grado di fornire fasci di nuclei esotici digrande interesse per la comunità internazionaledi Fisica Nucleare. Un’utenza applicativa può essere installata, inuna prima fase, nel secondo bunker ISOL. Tra leutenze applicative basate sul ciclotrone, quellecon il maggior grado di realizzabilità a mediotermine sono: facility per neutroni e produzionedi radioisotopi per la medicina.
Strategia a lungo terminePer la fisica dei fasci esotici SPES rappresentauna facility di riferimento per EURISOL. Può mi-gliorare le caratteristiche di intensità dei fasci se-condari con due vie alternative: progettando unbersaglio diretto che utilizzi tutta la potenza di-sponibile dal fascio di protoni, sviluppando unbersaglio a due step per produrre in modo pri-vilegiato nuclei molto ricchi di neutroni (vediprogetto di upgrade di ORNL-HRIBF, USA). Può
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
64
LARAMED: LAboratorio Radioisotopi per la ME-DicinaIl progetto LARAMED ha come obiettivo l’usodei fasci di protoni del ciclotrone di SPES per losviluppo di un laboratorio per la produzione diradioisotopi innovativi per la ricerca e le appli-cazioni in medicina. Il ciclotrone di Legnaro co-stituisce il secondo esempio al mondo dimacchina costruita per accelerare i protoni concorrenti di 0,3-0,5 mA fino a un’energia di 70MeV (il primo esempio è il ciclotrone ARRONAX,Nantes, Francia).Questa energia permette di aprire canali di rea-zione per la produzione di radionuclidi innovativiper la medicina mentre l’alta corrente permettela produzione di elevate quantità di radioisotopi(fino a 10 volte più di un ciclotrone standard).Questa facility raggiunge un grado di eccellenzanell’ambito della produzione di radioisotopi perla medicina e consente alla medicina nucleare disperimentare radionuclidi attualmente non di-sponibili e, quindi, di continuare nella ricerca diinnovative soluzioni diagnostiche e terapeutiche.Il nuovo ciclotrone permetterà anche di pro-durre, con rese più elevate, alcuni radionuclidiche sono già impiegati in medicina nucleare efungere da centro di distribuzione per officinefarmaceutiche che producono radiofarmaci.Il progetto è stato presentato al Ministro dellasalute alla Regione Veneto e alla comunità scin-tifica di riferimento in un incontro organizzatoda INFN, Facoltà di Medicina - Università di Pa-dova e Associazione Italiana Medicina Nucleareil 29 Novembre 2010.
GENERATORE di Neutroni ADSIl fascio di protoni può essere di interesse per so-stenere un ADS (Accelerator Driven System) diricerca (proposta INFN-Ansaldo).Questa attività è in fase di studio in una colla-
borazione ANSALDO- INFN- ENEA- PolitecnicoMilano- Politecnico Torino-SOGIN.
Collaborazioni internazionali e interazionicon altre componenti della rete di ricerca
SPES Collaboration
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
63
LIFAN (Legnaro Intense FAst Neutron facility)per la produzione di fasci di neutroni per ir-raggiamento di dispositivi elettronici con larealizzazione di un fascio per SEE (SingleEvent Effect) e per irraggiamenti diretti confasci di protoni da 70 MeV. La facility produceun fascio simile allo spettro atmosferico (limi-tato a 70 MeV) e permette di studiare il com-portamento di sistemi complessi sottoposti adanneggiamento neutronico. Queste misuresono di estremo interesse per l’avionica, lastrumentazione nucleare e in generale per lacomponentistica elettronica.
•
Fig. 3.21: Collaborazione SPES
FASE ALFA
FASE BETA
FASE DELTA
FASEGAMMA
PROGETTOSPES:
Costo stimanto globale
Fase Ciclotrone:sitema ISOL per fasci esotici non dafissione e non riaccelerati. Produzione di neutroni con fasciodel ciclotrone
Fase riaccelerazione:produzione, trasporto,selezione ad alta risoluzionee riaccelerazione di fasci esoticida fissione.Messa in funzione del secondobersaglio ISOL.
Fase sorgente di neutroni:progetto e realizzazione diuna facility di neutroni che utilizzail fascio di protoni del ciclotrone.
Fase laboratorio per produzioneradioisotopi per scopi medicie ricerca applicata con fasci diprotoni e neutroni del ciclotrone
~ 70-100 Meuro
30 Meuro
25 Meuro
10 Meuro perla realizzazionedi due strutturedi msura conneutroni(progetto LINCE)
10-30 Meuroa seconda dellivello diproduzione deiradioisotopi(progettoLARAMED)
Finanziamento2010-2012
Finanziamento2013-2015
Finanziamento2012-2015in collaborazionecon altri enti.
F inanziamento2012-2015in collaborazionecon altri enti.
Facility ISOL: fasci di ioni ricchi di neutroni, 1013 f/s, A= 60-160, 10AmeV.Driver protoni: Ciclotrone con due uscite indipendenti.Energia= 35-70 MeV, corrente interna 0,750 mA distribuita su due uscite(corrente massima su una uscita 0,5 mA).Fasci di neutroni prodotti per conversione dei fasci di protoni delCiclotrone.Uso diretto del fascio di protoni per produzine radioisotopi.
Tab. 3.12: Costo complessivo delle fasi di realizzazione del progettoSPES
SPES ISOLLINCELARAMED
PROGETTOSPES:costiprevistiin Milionidi €
20121400
20131115
201414312
Facility ISOL: fasci di ioni ricchi di neutroni, 1013 f/s, A= 60-160, 10 AmeVriaccelerati con RFQ e Linac-ALPI.Driver protoni: Ciclotrone con due uscite indipendenti. Energia= 35-70MeV, corrente interna 0,750 mA distribuita su due uscite (corrente massimasu una uscita 0,5 mA).Fasci di neutroni prodotti per conversione dei fasci di protoni del Ciclotrone.Uso diretto del fascio di protoni per produzine radioisotopi.
Tab. 3.13 Costo annuo previsto per la realizzazione di ciascun pro-getto nel triennio 2012-2014
Le attività previste come milestone per il2010-2011 sono state tutte completate:Definizione del progetto esecutivo perl’edilizia e le infrastrutture;Completamento della gara di acquisto delciclotrone e inizio costruzione;Operazione del Front-End ISOL completodi bersaglio, sorgente a ionizzazione su-perficiale e a plasma, estrazione del fascioa 30 keV. Inizio attività con ionizzazionevia laser;Test sotto fascio di nuovi materiali per ber-sagli ISOL con la produzione di pasticchedi carburo di uranio con nano tubi e testsotto fascio a ISOLDE e ORNL;È iniziata la realizzazione del sistema ISOLdi test sotto fascio a LNS;Scuola Internazionale SPES (LNS, 8-11 No-vembre 2011);Convegno Internazionale “SPES 2010 In-ternational Workshop”, Legnaro, 15-17Novembre 2010;
Per il prossimo anno sono previsti i se-guenti obiettivi:Inizio della realizzazione edilizia e delleinfrastrutture;Avanzamento nella costruzione del ciclo-trone;Installazione filtro di wien e analisi fasciosorgente ISOL;Installazione di un sistema ISOL per misuredi produzione sotto fascio a LNS;
Studio di nuovi materiali per bersagli ISOLcon la produzione di pasticche di carburodi uranio a diverse densità;Preparazione di un TDR aggiornato per lafacility ISOL e dei TDR per i progetti appli-cativi LINCE e LARAMED.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tab. 3.14: Obiettivi generali (milestones) realizzabili nel triennio peri progetti più rilevanti
Tab. 3.7: Applicazioni delle macchine acceleratrici a uso scientifico.
SPES ISOL
LINCE
LARAMED
2014
Completamentoedilizia.Trasferimento delciclotrone e inizioinstallazione.Avanzamento nellarealizzazione delsistema di trasportoe selezione dei fasciesotici. Avanzamentonella realizzazione delpreacceleratore a RFQe del Charge Breeder.Installazione dei sistemi dicontrollo per gli accessi.
Costruzione bersaglidi conversione. Acquisizionestrumentazione dimisura e radioprotezione.Implementazione edilizia
Acquisizione linea ditrasporto fascio protoni.Impiantistica di sicurezza.Acquisizione celledi manipolazione.Realizzazione prototipibersagli.
2013
Realizzazione edilizia.Completamentociclotrone in sede dittacostruttrice.Inizio costruzioneSeparatore ad altarisoluzione.Inizio costruzionepreacceleratore.Sviluppo Charge Breeder.Progetto Beam Cooler.Sviluppo del sistema dicontrollo e sicurezza perl’operazione del ciclotrone
Progetto e realizzazioneprototipi di bersagli diconversioneProgetto linea di trasportofascio protoni.Sviluppo sistemi controllo
Implementazione edilizia.Progettazione facility.Progetto linea di trasportofascio protoni e bersagli diproduzione.
2012
Gara edilizia eassegnazione lavori.Monitoraggioavanzamento lavoriciclotrone.Progettazione sistemadi trasporto fascio.Progettazione sistemadi preaccelerazione.Misure di produzionesotto fascio a LNS.Implementazione delsistema di Sicurezza
Preparazione TDR
Preparazione TDR

passato di pertinenza di INFN-GRID, in partico-lare quelle connesse ai progetti europei IGI-In-SPIRE ed EMI. La distinzione logica assegna a IGIi progetti con ruolo infrastrutturale, per il man-tenimento dei servizi e del middleware GRID diinteresse generale e per i loro sviluppi sempre diinteresse generale. Spettano per contro a INFN-GRID le attività di specifico interesse INFN.Un chiaro esempio di interesse primario INFN èdato dal progetto WLCG e attività connesse; iprogetti di cooperazione internazionale basatasu GRID, come EU-India-Infra e CHAIN2, sonostati per quest’anno inclusi in INFN-GRID, la lorocollocazione potrà essere ridiscussa in futuro, aseguito del consolidamento di IGI.Nel 2011 si è sviluppata impetuosamente l’ana-lisi degli esperimenti a LHC, che ha portato unavasta messe di risultati di fisica e dimostrato de-finitivamente la funzionalità, efficienza e robu-stezza dell’infrastruttura di calcolo basata suGRID. Nell’ambito di WLCG è intanto iniziata lafase preparatoria dell’upgrade del sistema di cal-colo che si metterà in atto dopo il lungo stop diLHC. Gli altri progetti finanziati da EU e attivi inINFN-GRID sono stati EGI-InSPIRE, EMI, EU-India,EPIKH, CHAIN, LIBI, We-NMR, a cui si aggiungel’infrastruttura di training nazionale per GRID,GILDA.
Finanziamenti 2011Nel 2011 il finanziamento a INFN-GRID è statodi 700 kE, per coprire le attività correnti dei pro-getti in corso (missioni, consumi e circa 200 kEhardware) .Da notare che nello stesso periodo le attività dicalcolo di LHC sono state finanziate con 1,5 MEai Tier2, tramite gli esperimenti, mentre il finan-ziamento al Tier1 è stato > 2.5 ME.Il finanziamento a INFN per il 2012 è stato di400 kE, non includendo più le attività di EGI-In-SPIRE e EMI, assunte da IGI. I progetti nonWLCG che iniziano nel 2012 sono il soloCHAIN2, mentre Eu-India-Infra era iniziato ametà 2011.
Prospettive per il 2012 e a medio e lungo ter-mineLe prospettive per INFN-GRID vengono descrittenell’assunzione che IGI si consolidi e svolga ilruolo di mantenere e sviluppare l’infrastrutturaGRID di interesse generale, intraprendendoanche gli opportuni progetti Europei e Nazio-nali, che dovranno fornire il finanziamento alleattività di innovazione connesse con GRID e
CLOUD. Assumiamo anche che le competenzeattualmente presenti nell’INFN su GRID non ven-gano disperse ma restino disponibili, in partetramite IGI, anche quando IGI avrà acquisito au-tonomia dall’INFN.La coordinazione fra i 2 pro-getti speciali e con il Tier1 e la CommissioneCalcolo è assicurata da un Management Boarddel calcolo, che include i responsabili nazionalidei 2 progetti, il direttore del CNAF e il Presi-dente della Commissione Calcolo. Per il 2012INFN-GRID continua le attività già trattate per il2011, e tiene riunioni mensili del suo ExecutiveBoard allargato (EBL). EBL è include i coordina-tori nazionali calcolo degli esperimenti LHC, CDFe BaBar/SuperB, i rappresentati delle Commis-sioni Scientifiche Nazionali, ed esperti dei servizisia Tier1 che GRID-IGI, è presieduto dal respon-sabile nazionale di INFN-GRID e agisce fra l’altrocome forum di discussione per preparare la pro-posta di un nuovo assetto per il calcolo scienti-fico INFN. In questo assetto le attività coperteoggi da INFN-GRID potranno essere assunte daun organismo stabile, con struttura simile aduna commissione nazionale piuttosto che conquella di un progetto speciale, per sua naturatemporaneo.L’organismo dovrà comunque assicurare le fun-zioni principali che restano ad INFN-GRID unavolta scorporate le attività proprie di IGI: il coordi-namento e promozione dei progetti di calcolo diinteresse specifico INFN (incluso WLCG) e il finan-ziamento di quella parte dei progetti che nonpassa naturalmente attraverso gli esperimenti.Il finanziamento della partecipazione a WLCGdel personale dei servizi calcolo e del CNAF nonafferenti agli esperimenti è a carico di INFN-GRID, come pure le partecipazioni a conferenzee workshop Grid per il personale che non ren-diconta nei progetti specifici che organizzano glieventi.Per questi progetti sono decisive le competenzedei servizi calcolo la cui rappresentanza è oggiassicurata tramite la commissione calcolo e reti.L’iniziativa per i progetti però fin qui è general-mente nata al di fuori dei servizi calcolo, conpersonale in parte diverso, e l’integrazione fraservizi calcolo e progetti di calcolo è fra gli obiet-tivi ancora da realizzare.
Progetto speciale IGI(italian Grid Infrastructure)Attività 2011Alla fine del 2010 il MIUR ha erogato all’INFN,per l’avvio di IGI, un contributo di 2 M€. Que-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
66
estendere la produzione di fasci esotici a isotopia breve vita-media sviluppando un sistema IGI-SOL che estrae direttamente gli ioni generatinella fissione dell’Uranio irraggiato con il fasciodi protoni. Questi sviluppi permetterebbero di mantenereuna rilevanza scientifica di piena concorrenzacon SPIRAL2 e HIE-ISOLDE.Le tre facility europee potrebbero formare unarete per la Fisica Nucleare specializzandosi infasci e tematiche specifiche. Un PAC Europeopotrebbe distribuire l’utenza in relazione al tipodi fascio richiesto e alla strumentazione dispo-nibile nei vari laboratori.Il progetto SPES si presta in modo particolareall’attivazione di collaborazioni tra vari enti in re-lazione alle competenze specifiche che il pro-getto sviluppa e ai campi applicativi che apre:
Il progetto SPES permette rilevanti attività appli-cative senza sacrificare la ricerca di base.Rappresenta bene le capacità di ricaduta dellaricerca dell’INFN in aree cruciali per il Paesecome la Sanità e l’innovazione tecnologica. Ri-sorse esterne, sia finanziarie che di personale,concordate con altri enti quali ENEA, CNR, uni-versità, regioni e/o realtà industriali, sono neces-sarie per attivare questo programma.La figura 3.22 e la figura 3.23a mostrano unoschema del laboratorio ciclotrone e il sistemaISOL installato e in operazione a LNL.La figura 3.23b mostra il ferro del magnetedopo la lavorazione di forgiatura in Giappone.
Progetti speciali GRIDLe attività che fino al 2010 rientravano in INFN-GRID, dal 2011 sono suddivise fra 2 progettispeciali: INFN-GRID e IGI che saranno descritti indettaglio in questo capitolo.
INFN-GRIDAttività 2011Il progetto speciale INFN-GRID ha continuato afornire la struttura unitaria di coordinamento efinanziamento ai progetti basate su tecnologieGRID e relative attività delle sezioni, laboratoried esperimenti dell’INFN, tramite l’appositoINFN-GRID Executive Board. Il progetto specialeIGI, che ha iniziato in questo anno la sua attività(vedi infra) copre dal 2012 parte delle attività in
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
65
Sviluppo di carburi e tecniche di caratterizza-zione di materiali a 2000°C.; Competenze nello sviluppo di bersagli di con-versione per neutroni;Possibilità di dotare il Paese di una facility perneutroni alternativa ai reattori nucleari (con-sorzio tra enti di ricerca - INFN, ENEA, CNR -e industria); Sviluppo di nuovi radiofarmaci. Collabora-zione scientifica tra SPES e ARRONAX in Fran-cia, unico laboratorio per la ricerca di nuoviradioisotopi a scopo medico prodotti conprotoni di energia superiore a 30 MeV.L’INFN potrebbe partecipare ad una collabo-razione con università e ditte farmaceutichefornendo infrastrutture e fascio di protoni.
•
•
•
•
Fig. 3.22: Isometrico laboratorio Ciclotrone e layout di trasferimentoe selezione del fascio esotico.
Fig. 3.23a: Sistema ISOL installato a LNL
Fig. 3.23b: Ferro del magnete dopo la forgiatura

Il Progetto Speciale è gestito dal Comitato diCoordinamento della JRU IGI, che comprende irappresentanti di tutti i partner (enti di ricerca,università e consorzi) della JRU IGI e agisce comeAssemblea dei Soci, e da un Comitato Esecutivoda questo nominato che agisce come un CdA.Su mandato del Ministero (MIUR) la JRU IGIrappresenta la National GRID Initiative (NGI)italiana nel Council e nelle attività tecnichedell’European Grid Initiative (EGI) che coordinala gestione dell’infrastruttura grid europea.Particolare cura è stata posta durante la primaparte del 2011 nel chiarire con l’INFN e gli altripartner le responsabilità di IGI nella gestionedei servizi grid necessari per il calcolo di LHCo di altri progetti INFN.Si è seguito il modello di funzionamento ge-neralmente adottato a livello Europeo, asse-gnando a IGI la responsabilità dei progetti conruolo infrastrutturale o che hanno come obiet-tivo il mantenimento e lo sviluppo dei servizi edel middleware GRID di interesse generale, ein particolare i progetti EGI-InSPIRE e EMI,mentre sono rimaste di pertinenza del pro-getto speciale INFN-Grid le attività di specificointeresse INFN come quelle relative a WLCG.Le attività programmate e realizzate all’internodel Progetto Speciale IGI hanno dovuto tenereconto di un finanziamento ridotto rispetto aquanto programmato con la conseguenza chenon è stato possibile assumere su fondi MIURtutto il personale previsto. Si è quindi datapriorità in questo primo anno alla selezionedelle persone dei partner coinvolte nelle atti-vità e nei servizi di base e solo all’inizio del2012 si è cominciato con fondi residui a co-prire le necessità di supporto a nuove comu-nità di utenti e di formazione.
Prospettive per il 2012 e a medio e lungo ter-mineNel 2012 e negli anni seguenti IGI si deve conso-lidare e svolgere il ruolo di sviluppare, manteneree mettere a disposizione di tutti nell’infrastrutturaGRID nazionale i servizi di interesse generale, par-tecipando anche a opportuni progetti Europei eNazionali, che dovranno fornire il finanziamentoalle attività di innovazione connesse con GRID esoprattutto CLOUD. L’obiettivo è aumentare inmodo significativo le comunità e gruppi accade-mici e di ricerca che accedono ai servizi di IGI, checostituisce la missione principale di IGI. Questoobiettivo sarà perseguito in collaborazione conEGI e altre iniziative internazionali sia facendo
evolvere i servizi GRID esistenti sia introducendonuovi servizi che rispondano alle esigenze dinuove comunità di utenti, come quelle legatealle infrastrutture di ricerca incluse nella road-map ESFRI. Parallelamente IGI svilupperà gli stru-menti opportuni per abbattere le barriered’ingresso all’uso delle risorse distribuite e que-sto si potrà realizzare anche mediante lo svi-luppo di un’offerta CLOUD basata su softwareopen che consenta ai team di ricerca di ottenerein modo elastico e flessibile le risorse e gli am-bienti virtuali di cui hanno bisogno.
Progetto speciale ELN (Eloisatron)Descrizione generale del ProgettoL’obiettivo del progetto è dimostrare che, par-tendo da tecnologie esistenti è possibile, conuna serie di R&D tecnologicamente in grado diessere realizzate nel giro di pochi anni, dimo-strare la fattibilità di un collider a protoni conparametri di energia e luminosità superiori dialmeno un ordine di grandezza a quelli di LHC.In parallelo con queste attività di ricerca e svi-luppo scientifico-tecnologiche, il progetto ELNdedica notevole attenzione alle ricerche pura-mente teoriche legate ai limiti estremi di ener-gia e luminosità che è possibile ottenere. Lafisica, sia online sia offline, legata alle massimeenergie ottenibili e i rivelatori in grado di ot-tenere risultati analizzabili fanno parte inte-grante del progetto. Lo studio di fattibilità diun futuro protosincrotrone superconduttore,con parametri di energia e luminosità superioria quelli di LHC di almeno un ordine di gran-dezza, è stato portato vanti da parecchi anninell’INFN grazie al Progetto Speciale ELN (Eloi-satron). A tale studio si affianca anche, nel-l’ambito del Progetto stesso, quello dellemolteplici implicazioni fisiche e tecnologichedi una simile impresa.
Strutture INFN e altre Istituzioni parteci-pantiIl Progetto ELN si avvale di una vasta collabo-razione internazionale che ha come sede cen-trale Bologna (Università e INFN). Le attivitàdella collaborazione internazionale si artico-lano su gruppi di lavoro localizzati a: Amburgo(DESY), Berkeley (LBNL), Ginevra (CERN), Hou-ston (HARC, Texas A&M Univ.), Los Angeles(UCLA), Mosca (ITEP, NPI-State Univ.), NewYork (Columbia Univ.), Salerno (Università eINFN), San Pietroburgo (PNPI), Twente (Univ.)e Vilnius (Univ.).
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
68
sto è stato utilizzato assieme al contributo di 1M€ circa della Commissione Europea per la par-tecipazione ai progetti EGI-InSPIRE e EMI perdare l’avvio nel 2011 ad un progetto speciale
INFN, denominato IGI, sotto cui raccogliere tuttele attività grid di valenza generale e il personalea queste dedicato, prima finanziato diretta-mente dall’INFN o da altri partner.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
67
Tab. 3.15: Tabella riassuntiva progetto Spes
PROGETTO SPES
PRINCIPALI LINEEDI ATTIVITÀ
Ricerca in fisica nucleare con fasci di ioni instabili.Applicazioni di fasci di neutroniProduzione di radioisotopi di interesse medico
Definito il progetto esecutivo per l’edilizia e gli impianti..Avviata costruzione ciclotrone dalla ditta BEST.Operativo front-end ISOL e produzione fasci stabili in laboratorio.Organizzazione Scuola internazionale su tecniche sperimentali con fasci radioattivi.
PRINCIPALI RISULTATICONSEGUITI NEL 2011
SPES_ISOL:Realizzazione di un sistema ISOL di seconda generazione che fornisca fasci riaccelerati di ioni ricchi di neutroni per lostudio della fisica nucleare fuori dalla valle di stabilità.
PROGETTI DIRILEVANZA SCIENTIFICA
Il progetto utilizza risorse finanziarie INFN. Per le attività applicative sono in corso contatti con Università e ASL sul territorio veneto per il loro coinvolgimentonella realizzazione di parti di interesse specifico.
RISORSE FINANZIARIE
SPES coinvolge in ambito nazionale varie sezioni INFN e i Laboratori Nazionali di Legnaro e del SUD.Ha una forte collaborazione con l’Università di Padova e con Ingegneria Nucleare dell’Università di Palermo.Per i progetti applicativi sono in corso contatti con Università, ENEA, CNR ed enti locali per promuovere lapartecipazione e la sinergia.In ambito internazionale SPES è inserito in una rete di collaborazioni scientifiche con CERN, paesi europei, USA,Canada, Giappone.
COLLABORAZIONIINTERNAZIONALIE INTERAZIONI CONALTRE COMPONENTIDELLA RETE DIRICERCA
Per il raggiungimento degli obiettivi proposti devono essere acquite le seguenti infrastrutture di ricerca: Ciclotrone da 70MeV ad alta intensità, infrastruttura di maneggiamento e selezione ad alta risoluzione del fascio di ioni (beam handling), preacceleratore per iniezione in acceleratore Lineare ALPI,sistema di bersagli per irraggiamento ad alta potenza (35kW sul bersaglio)sistema di maneggiamento di bersagli in Camera calda.
INFRASTRUTTUREDI RICERCA DAACQUISIRE
LINCEProduzione di neutroni con uno spettro energetico non disponibile ai reattori nucleari e con caratteristiche spettralicalibrate con moderatori opportuni o agendo direttamente sul fascio di protoni. Applicazioni allo studio di sezionid’urto per reattori di IV Generazione, studio di danneggiamento di dispositivi elettronici.
LARAMEDuso dei fasci di protoni del ciclotrone di SPES per lo sviluppo di un laboratorio per la produzione di radioisotopi inno-vativi per la ricerca e le applicazioni in medicina.
GENERATORE di Neutroni ADSIl fascio di protoni può essere di interesse per sostenere un ADS (Accelerator Driven System) di ricerca (proposta INFN-Ansaldo). Questa attività è in fase di studio in una collaborazione INFN-ENEA-SOGIN.
PROGETTI DIRILEVANZA APPLICATIVA
COSTO ANNUOPREVISTO PERLA REALIZZAZIONEDI CIASCUN PROGETTONEL TRIENNIO2011-2013
ISOL
14
2012>14M€
2012
LINCE
Gara edilizia e assegnazione lavori.Monitoraggio avanzamentolavori ciclotrone.Progettazione sistemadi trasporto fascio.Progettazione sistemadi preaccelerazione.Misure di produzione sottofascio a LNS.Implementazione del sistemadi Sicurezza
Realizzazione edilizia.Completamento ciclotronein sede ditta costruttrice.Inizio costruzione Separatoread alta risoluzione.Inizio costruzione preacceleratore.Sviluppo Charge Breeder.Progetto Beam Cooler.Sviluppo del sistema di controllo e sicurezza per l’operazionedel ciclotrone
Completamento edilizia.Trasferimento del ciclotronee inizio dei test di accettazione.Avanzamento nella realizzazionedel sistema di trasportoe selezione dei fasci esotici.Avanzamento nella realizzazionedel preacceleratore a RFQe del Charge Breeder.Installazione dei sistemidi controllo per gli accessi.
Preparazione TDR Progetto e realizzazione prototipidi bersagli di conversioneProgetto linea di trasportofascio protoni.Sviluppo sistemi controllo
Costruzione bersagli di conversione. Acquisizione strumentazionedi misura e radioprotezione.Implementazione edilizia
Preparazione TDR Implementazione edilizia.Progettazione facility.Progetto linea di trasporto fascioprotoni e bersagli di produzione.
Acquisizione linea di trasportofascio protoni.Impiantistica di sicurezza.Acquisizione celle di manipolazione.Realizzazione prototipi bersagli.
LARAMED ISOL
11
2013>17M€
2013
LINCE
1
LARAMED
5
ISOL
14
2014>31M€
2014
LINCE
5
LARAMED
12
OBIETTIVI GENERALISPES_ISOL
OBIETTIVI GENERALILINCE
OBIETTIVI GENERALILARAMED

dro) dell’Unione Europea e l’inizio di altrettantiprogetti del VII.La partecipazione dell’INFN al VI PQ è statamolto attiva e fruttuosa; il tasso di successodei progetti presentati è stato superiore al70% ed il finanziamento totale della Commis-sione Europea è stato di circa 30 MEuro.Anche nell’ambito dei primi bandi del VII pro-gramma quadro l’INFN ha presentato svariatiprogetti di successo.Il VII programma quadro della commissioneeuropea (2007-2013) presenta delle novità im-portanti rispetto al precedente: la durata, 7anni, il budget di circa 50 miliardi, aumentatodel 74%/anno, ma sopratutto si nota un cam-biamento rispetto alla ricerca.Per la prima volta infatti è stato stanziato unbudget specifico per la ricerca di base, il pro-gramma IDEAS con uno stanziamento di 1.06GEuro/anno. Ancora più importante per l’INFNè il finanziamento dedicato alla fase preparatoriaed alla costruzione di infrastrutture di ricerca divalenza europea incluse nella roadmap dell’Eu-ropean Strategy Forum on Research Infrastruc-tures (ESFRI). La roadmap di ESFRI, alla formazionedella quale hanno contribuito esperti dell’INFN,è revisionata periodicamente.Una prima revisione della roadmap si è con-clusa nel 2008 ed una seconda nel 2010.Di particolare rilevanza nell’ambito del VII FP èla creazione dello Spazio Europeo della Ricerca(European Research Area, ERA), il cui scopoprincipale è quello di favorire l’integrazione edil coordinamento delle attività e delle politichenazionali nel settore della ricerca.La costruzione di nuove infrastrutture il miglio-ramento e l’integrazione di quelle esistenti as-sumono notevole rilevanza nella realizzazionedi ERA. È proprio tramite l’accesso alle infra-strutture esistenti e tramite la creazione diconsorzi per la costruzione di nuove infrastrut-ture che si possono superare le frammenta-zioni esistenti sulle pratiche e sulle politichenazionali nel settore della ricerca.Recentemente, a questo scopo, la Commis-sione Europea ha anche messo a punto unostrumento che facilita la costituzione di con-sorzi per le infrastrutture europee di ricerca(European Research Infrastructure Consortium- ERIC).L’INFN è un attore importante nella costru-zione di ERA partecipando attivamente e pro-movendo, come si vedrà in seguito, numerosiprogetti sulle infrastrutture di ricerca.
Sfruttando l’esperienza acquisita nella parteci-pazione ad importanti progetti del VI PQ e gra-zie anche ad un miglior coordinamento, l’INFNha partecipato attivamente e con successo giàalle prime call for proposal del VII PQ in tutti iprogrammi. Degli oltre 140 progetti presentatinei primi bandi, più di 30 sono stati approvati,in particolare nell’ambito delle infrastrutture diricerca, dove l’INFN ha una consolidata espe-rienza e know-how nel campo delle cosiddettee-infrastrutture grazie alla pluriennale espe-rienza nelle tecnologie del calcolo intensivo di-stribuito GRID (Grid computing), e neiprogrammi IDEE e Marie Curie dedicati ai gio-vani ricercatori. Il tasso di successo in questeprime call è stato di circa il 30% da confron-tare con il 15% della media italiana. Il finan-ziamento complessivo della commissioneeuropea per l’INFN relativamente a questiprimi progetti approvati è di circa 19 MEuro.Vedi figure 3.31 e 3.32. La partecipazione dell’INFN al programmaCOOPERAZIONE(COOPERATION), il cui scopoè incentivare la cooperazione e rafforzare i le-gami tra l’industria e la ricerca in un quadrotransnazionale, è limitata: fra le 11 priorità,quella relativa all’ICT (Information and Com-munication Technology) riguarda direttamentele attività INFN, mentre le tecniche nucleari ele applicazioni degli acceleratori di particellesono trasversali a diverse aree tematiche(Health, Environment, Food, Nanoscience, Ener-gy, Security).
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
70
Partecipano inoltre al Progetto ELN: la Fonda-zione “Ettore Majorana” e Centro di CulturaScientifica (FEMCCS), la World Federation ofScientists-World Laboratory (WFSWorldLab) eil MIUR.
Attività svolte nel 2011Le attività del Progetto ELN sono proseguitesecondo le sue quattro linee guida: 1) studiteorici e fenomenologici sulla fisica a moltecentinaia di TeV, a partire dai livelli di energiaaccessibili adesso o nell’immediato futuro(LHC); 2) studi teorici sul collider adronico aimassimi livelli di energia (√s = 200 TeV-1 PeV)e luminosità (1034-1036 cm-2s-1); 3) R&S sucavità rf e magneti superconduttori di nuovagenerazione; 4) R&S su rivelatori di particellecapaci di operare in condizioni estreme di ri-soluzione spaziale e temporale, oltre che diresistenza alle radiazioni.
HIGHLIGHT 2011Nel 2011 sono stati studiati, in particolare,temi e obiettivi di fisica (interazioni pro-tone-protone, protone-nucleo e nucleo-nu-cleo ad altissima energia, fisica “leading” aLHC, dinamica di QCD a piccolo x, fisica diuna nuova forma di materia adronica de-confinata fatta di quark e gluoni) e tecnichesperimentali di rivelazione e di accelera-zione di particelle, con particolare riguardoal problema della collimazione dei fasciadronici e a quello delle loro possibili appli-cazioni in altri campi. Per quanto riguardale attività di R&S, è da segnalare lo sviluppodegli studi relativi al prototipo di rivelatoreMRPC (Multigap Resistive Plate Chamber)con il quale era stata ottenuta una risolu-zione temporale di soli 20 ps: un recordmondiale.
Prospettive a medio termine Con l’avvio di LHC si aprono nuovi orizzontiper la fisica nucleare e subnucleare. È dunquepiù che mai opportuno che l’INFN, attraversouna collaborazione internazionale che si arti-coli su scala mondiale (e non solo europea), ri-volga la propria attenzione al futuro della fisicaadronica nell’era post-LHC, con grande anti-cipo rispetto alle eventuali scoperte di LHC.Nel triennio 2012-2014, nel quadro del Pro-getto ELN, dovranno dunque essere poten-ziate le attività di ricerca e sviluppo chepuntano alle più moderne tecniche di rivela-
zione di particelle e di accelerazione, anchealla luce delle linee strategiche già emerse inambito europeo (CERN, ECFA, ESFRI, FALC,etc.) e nazionale (INFN).
Prospettive a lungo termine L’upgrade di LHC in un futuro relativamenteprossimo, sia in termini di luminosità sia in ter-mini di energia, sarà di grande valore per glistudi già fatti nell’ambito del progetto ELN.La realizzazione di un supercollider adronicoha bisogno della realizzazione di nuovi proto-tipi di dipoli magnetici con grandi dimensionied elevate intensità di campo (anche tramitel’utilizzo di materiali superconduttori innova-tivi), nonché di nuovi prototipi di cavità rf(radio-frequenza).Dovranno proseguire dettagliate simulazioniMonte Carlo che consentano di indagare sullepotenzialità fisiche del supercollider. Se i finan-ziamenti lo permetteranno, sarà anche studiatala possibile realizzazione di un futuro colliderelettrone–protone. Per quanto riguarda i rivela-tori di particelle, saranno di cruciale importanza,da un lato, la costruzione di nuovi prototipi checostituiscano tappe consolidate per nuove ricer-che e sviluppi tecnologici, dall’altro, la verificadella loro possibile realizzazione su larga scala.Di particolare rilevanza sarà l’attività di R&D perquanto riguarda la risposta in risoluzione tem-porale dei rivelatori. Sarà necessaria una intensaattività di R&D per la costruzione di rivelatori diparticelle i cui prototipi possano essere sottopo-sti a test al CERN in modo da verificare quali pa-rametri migliorare per ottenere risoluzionitemporali ancora più potenti di quelle finora ot-tenute. Uno degli obiettivi principali del progettoELN riguarda infatti lo studio dei rivelatori di par-ticelle per far fronte alle enormi difficoltà legatealla molteplicità delle particelle prodotte in ogniinterazione e alla luminosità della macchina chedeve essere progettata in modo da ottenere va-lori massimi di questo cruciale parametro.Parametro che viene subito dopo quello del li-vello di energia. La redazione di un ELN TDR (Te-chnical Design Report) dovrà essere parteeffettiva della pianificazione operativa.
3.9 I PROGETTI EUROPEI
Attività 2009-2011Il 2008 ha visto la conclusione di molti progettidi ricerca iniziati nel VI PQ (Programma Qua-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
69

Nell’ambito del programma CAPACITÀ (CAPACI-TIES) - Infrastrutture di Ricerca, l’INFN partecipa,e in molti casi coordina, diversi progetti che coin-volgono decine di istituti europei e centinaia di ri-cercatori, in molti dei cosiddetti “strumenti” delprogramma (tabella3.15). Questi progetti vedonola partecipazione di molte sezioni e laboratoriINFN. In particolare lo strumento “Design Stu-dies” è appunto dedicato allo studio di fattibilitàdi infrastrutture di interesse europeo e costitui-scono la base per le revisioni della roadmap diESFRI. In questo contesto l’INFN ha presentato 5progetti legati alle nuove tecniche di accelera-zione, alla fisica nucleare, particellare ed astropar-ticellare. Due di questi sono stati recentementeapprovati, nei quali l’INFN ricopre ruoli primari co-ordinando importanti work package:
Lo strumento Preparatory Phase di nuove infra-strutture è, invece, una tipologia di finanziamentoriservata alle infrastrutture già presenti nelle road-map di ESFRI. Lo scopo è portare il progetto allamaturità legale, finanziaria e tecnica per essererealizzato. Nella prima call dedicata a 34 infra-strutture di tutte le discipline, l’INFN partecipa a 9progetti, ed in un caso ne è anche coordinatore:
Per quanto riguarda lo strumento Attività Inte-grate (Integrated Activities) per le infrastrutturedi ricerca sono stati presentati diversi progettinel campo della fisica particellare, nucleare,astroparticellare e sulle nuove tecniche di acce-lerazione. Molti di questi progetti mirano adestendere, consolidare e migliorare i risultati ot-tenuti nei progetti del VI PQ, coinvolgono decinedi istituzioni europee, comunità di migliaia di ri-cercatori ed hanno un budget totale di circa 10milioni di euro. Recentemente sono stati appro-vati 4 grandi progetti:
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
72
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
71
Fig. 3.25: Tasso di successo nelle varie tipologie
Fig. 3.24: Progetti presentati nelle varie tipologie
Tab. 3.16: Progetti INFN nelle infrastrutture di ricerca
Strumento Numero progetti
Design studies 2
Preparatory phase 9
Attività integrate 7
e-infrastructures 14
Contributo UE per l’INFN 26 MEuro
HadronPhysics2 è un progetto sulla fisica adro-nica ed è coordinato dall’INFN; ha come scopolo studio della strongly interacting matter cheinclude la struttura degli adroni, la QCD, ecc.
ET (Einstein gravitational-wave Telescope) sipropone lo studio di rivelatori per onde gravi-tazionali di terza generazione, rivelatori conuna sensitività più di 100 volte migliore diquella degli attuali rivelatori;EURONU è dedicato allo studio di fattibilità diuna neutrino-factory europea;
KM3Net-PP è un progetto dedicato alla realiz-zazione di una facility sottomarina per la neu-trino astronomy ed in generale per la fisicaastro particellare. Questo progetto è coordi-nato dall’INFN (LNS) e coinvolge più di 20 isti-tuti ed università europee;SLHC-PP è dedicato all’upgrade di LHC, è co-ordinato dal CERN e vede la partecipazione didecine di istituti europei; l’INFN partecipa adun importante work package del progetto;FAIR è dedicato alla costruzione della nuova fa-
cility FAIR (Facility for Antiproton and Ion Rese-arch) e coinvolge decine di istituti europei;SPIRAL2PP è dedicato alla facility SPIRAL2, ècoordinato dal laboratorio francese GANIL(Grand Accélérateur National d’Ions Lourds),partecipano 25 istituzioni europee, l’INFN par-tecipa e/o coordina work packages rilevanti;ILC-HiGrade (International Linear Collider andHigh Gradient Superconducting RF-Cavities) èdedicato all’International Linear Collider ed inparticolare allo studio ad alla ingegnerizzazionedelle cavità RF superconduttrici ad alto gra-diente. Il progetto è coordinato dal laboratoriotedesco DESY (Deutsches Elektronen-Synchro-tron) e vi partecipano 6 istituzioni europee.L’INFN partecipa e coordina work packages ri-levanti;PRE-XFEL è relativo alle attività preparatorie perl’implementazione dell’ X-ray Free ElectronLaser europeo. Il coordinamento è di DESY;ELI-PP (Extreme Light Infrastructure) sarà laprima infrastruttura dedicata allo studio dell’in-terazione laser-materia con intensità laser nelregime ad alta intensità (I>1023 W/cm2). Il pro-getto è coordinato dal francesce CNRS (CentreNational de la Recherche Scientifique) e vi par-tecipano 15 istituti; l’INFN coordina la parteci-pazione italiana al progetto;TIARA coordinato dal CERN ha come scopol’integrazione dell’R&D sulla fisica degli accele-ratori integrando le infrastrutture nazionali inuna singola infrastruttura europea;HiPER (High Power laser Energy Research) èuna facility dedicata allo studio di fattibilitàdella laser driven fusion come fonte di energia.L’INFN partecipa se pur marginalmente, allafase preparatoria del progetto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grants”) l’INFN ha ottenuto ottimi risultati. Nellaprima call sono stati presentati più di 3000 pro-getti in tutte le discipline di cui 997 per la fisicae l’ingegneria. Un progetto che ha come nodoprincipale l’INFN ed in particolare i LaboratoriNazionali di Frascati è stato selezionato: il pro-getto ha come titolo “Supersymmetry, Quan-tum Gravity and Gauge Fields”, e si propone distudiare una serie di aspetti fondamentali dellafisica dei buchi neri, della teoria delle stringhe edella teoria dei campi di spin elevato. Nella se-conda call sono state presentate circa 800 propo-ste nel pannello relativo alla fisica e all’ingegneria.Per la Fisica fondamentale sono state selezionate9 proposte, tre delle quali vedono come principalinvestigator ricercatori italiani. Uno di questi pro-getti, che ha scelto l’INFN come host institution,ha come scopo principale lo studio della massadel neutrino; il progetto è stato finanziato con unbudget di circa 3,3 MEuro e verrà effettuato neiLaboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN.Mettendo a frutto l’esperienza dei passati PQ,l’INFN ha migliorato l’organizzazione interna, ilsupporto informativo e amministrativo ai re-sponsabili dei progetti e la diffusione delle op-portunità offerte dal VII PQ. La Commissione peri Rapporti con l’Unione Europea (CRUE), istituitadall’INFN nel 2003, ha tenuto diversi seminarinelle cinque commissioni scientifiche nazionalie ha organizzato un ciclo dedicato di corsi di for-mazione per il personale amministrativo.
ProspettivePer quanto riguarda i programmi futuri, l’INFN in-tende sfruttare al meglio gli ultimi bandi del VIIPQ e si sta preparando al nuovo programma Ho-rizon2020 che inizierà nel 2014.Forte è l’interesse ed il coinvolgimento dell’INFNper le infrastrutture di ricerca. Molti progetti disuccesso per la fisica nucleare, particellare, astro-particellare e per le nuove tecniche di accelera-zione sono nati all’interno di organismi europeiquali ApPEC (Astroparticle Physics European Co-ordination), NuPECC (Nuclear Physics EuropeanCollaboration Committee) e ESGARD (EuropeanSteering Group on Accelerator R&D) e prevedonola creazione di vere e proprie reti di infrastrutturedi ricerca di valenza europea. Molti tra questi pro-getti iniziati nell’ambito del VI PQ vedono la pro-pria prosecuzione, estensione e consolidamentodei risultati nel VII PQ. Poche risorse restano an-cora da allocare nel VII PQ, mentre nella bozza diHorizon2020 il finanziamento per le infrastrutturedi ricerca è al momento ridimensionato. Tuttavia
il programma è ancora in corso di discussionepresso le istituzioni europee ed il managementdell’INFN sta seguendo con attenzione i suoi svi-luppi. Anche nel settore delle e-infrastrutture edell’ICT l’INFN ha molti progetti in preparazione,soprattutto nel campo dell’estensione e dellosfruttamento del supercalcolo reso possibiledalle tecnologie di Grid computing. Numeroseopportunità di estensione e applicazione di que-ste tecnologie sembrano emergere anche in Ho-rizon2020.Inoltre l’INFN prevede di partecipare ai nuovischemi delle azioni Marie Curie per il cofinanzia-mento di programmi regionali, nazionali ed inter-nazionali relativi alla mobilità dei ricercatori e dicontinuare a partecipare ai programmi di trainingper i giovani ricercatori. Anche i prossimi bandiIDEE, sia per giovani che per ricercatori esperti, ve-dranno un’ampia e qualificata partecipazione deiricercatori INFN. Grande entusiasmo ha suscitatonella comunità INFN il primo bando ERC SinergyGrant, che si propone di finanziare progetti inno-vativi di dimensione molto maggiore rispetto aglialtri grant ERC e che quindi meglio si adattano amolte delle attività di ricerca dell’INFN. Numeroseproposte sono state preparate, e certamenteanche le prossime edizioni di questo bando sa-ranno accolte con estremo interesse.Infine i ricercatori dell’INFN resteranno attenti acogliere le opportunità offerte dal programmaCOOPERAZIONE in tutti quei casi in cui le tecnichenucleari e con acceleratori sono rilevanti. Nel pro-gramma Horizon2020 grande rilevanza sarà dataall’innovazione, sia nei suoi aspetti più legati allosviluppo industriale che i quelli mirati a dare rispo-ste ai cambiamenti sociali. L’INFN con la linea diricerca 5 è da sempre attento a questi temi e nonmancherà di partecipare ai bandi che permette-ranno di utilizzare le tecnologie studiate e svilup-pate nell’Ente.L’INFN continuerà a migliorare anche la strutturadi supporto scientifico e logistico- amministrativoai progetti.
3.10 I PROGETTI CONGIUNTI CON ALTRIENTI NAZIONALI E REGIONALI
Numerose e significative sono le attività con-giunte con altri enti ed Istituzioni, oltre a quellegià descritte nell’ambito dei progetti strategici especiali nei paragrafi 3.8, soprattutto in ambitoapplicativo nei settori Medicina, Beni Culturali,Grid-ICT, formazione e diffusione della cultura
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
74
Nell’ambito dello strumento “ICT based e-infra-structures”, l’INFN ha presentato ben 15 pro-getti molti dei quali sono stati approvati. Alcunidi questi progetti sono coordinati dall’INFN (vedianche paragrafo 3.8 (progetto speciale INFN-GRID):
Per quanto riguarda invece l’aspetto delle risorseumane e della mobilità, nell’ambito del pro-gramma PERSONE (PEOPLE) del VII PQ, il cuiscopo è favorire la mobilità e la progressione dicarriera dei ricercatori, sono stati presentati sva-riati progetti dello strumento Research and Trai-ning Network che coinvolgono ampie comunitàinternazionali intorno a programmi di forma-zione e scambi di giovani ricercatori. Ben 6 pro-getti di questo tipo sono stati approvati nei duebandi fino ad ora conclusi.I ricercatori INFN hanno anche ottenuto notevolirisultati nel programma IDEE (IDEAS), il cuiscopo fondamentale è favorire l’emergere diidee innovative investendo su progetti di eccel-lenza di ricercatori brillanti, sia giovani cheesperti, e offrendo al ricercatore possibilità di co-struirsi un proprio gruppo di ricerca. La primacall, dedicata ai giovani ricercatori (strumentoERC Starting Grants), ha ricevuto più di 9000proposte in tutte le discipline con la possibilitàdi finanziarne circa 200; il 50% dei progetti sicolloca nel campo della fisica e dell’ingegneria.Un progetto presentato da una ricercatrice INFNè stato finanziato. Il progetto, di durata quin-quennale, ha come scopo l’applicazione di re-centi tecniche della meccanica statistica airivelatori di onde gravitazionali (http://www.ra-renoise.lnl.infn.it/). Nel quarto bando per ERCstarting grant è stato invece finanziato il pro-getto NPFlavour, presentato da un ricercatoreINFN, che si propone di sviluppare gli strumentiteorici per sfruttare la grande mole di risultatisperimentali disponibili in fisica del sapore, percercare di determinare la struttura del modellosottostante (http://npflavour.roma1.infn.it/).
Nei primi due prestigiosi bandi IDEAS dedicati airicercatori senior (strumento “ERC Advanced
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
73
Questa iniziativa integrata è iniziata con suc-cesso nel VI programma quadro e coinvolgepraticamente l’intera comunità europea checonduce attività di ricerca in questi campi. Il fi-nanziamento totale è di circa 10 MEuro di cui3 MEuro per l’INFN;HadronPhysics3 prosegue le attività di ricercae networking dei suoi due predecessori. È statoapprovato nel 2011 ed inizia nel 2012 con unbudget di 9 MEuro di cui 2.8 all’INFN;EUCARD è un progetto sulle nuove tecniche diaccelerazione ed è l’estensione e prosecuzionedel progetto CARE finanziato nel VI PQ. EU-CARD ha come scopo primario la creazione inEuropa di laboratori con acceleratori contri-buendo così alla costruzione della EuropeanResearch Area nella scienza degli acceleratori.Il progetto ha un finanziamento per l’INFN dicirca 1 MEuro;ELISA è un progetto dedicato al free electronlaser ed alla luce di sincrotrone; ULICE è un progetto che sfrutta le tecniche nu-cleari e degli acceleratori per la cura dei tumori;AIDA è un progetto che si occupa delle infra-strutture di ricerca necessarie allo sviluppo dinuovi rivelatori per i futuri acceleratori di parti-celle, come SLHC, i linear colliders ILC e CLIC,le future neutrino-factories, la SuperB e il pre-visto up-grade in lumunosità di LHC. Ha un fi-nanziamento totale di 9.9 MEuro, dei quali 0.9vanno all’INFN;ENSAR coinvolge le principali infrastrutture eu-ropee per la fisica nucleare, sostenendo attivitàdi ricerca nel campo della struttura nucleare,dell’astrofisica nucleare e delle applicazioni difisica nucleare. Il finanziamento totale del pro-getto è di 8 Meuro, dei quali 1 MEuro va al-l’INFN;
EGEEIII e EMI sono progetti tesi a consolidaree a migliorare l’infrastruttura Grid europea edil middleware;EELA-2, GISELA, EuAsiaGrid, EuIndiaGrid eCHAIN intendono estendere l’infrastruttura e-Science all’America Latina e all’Asia; EGI (European Grid Initiative), OGF-EU e EGI-INSPIRE sono progetti il cui scopo è definire la
struttura per la sostenibilità a lungo terminedella Grid europea; SIENA è un progetto che si propone di definireuna roadmap per le e-Infrastructure avendocome obiettivo di massimizzare l’interoperabi-lità e l’adozione di standard;e-NMR, e la sua continuazione We-NMR,hanno lo scopo di diffondere e unificare l’e-in-fratstruttura NMR per i sistemi biologici;EURETILE è un progetto coordinato dall’INFNnel settore delle ”Advanced Computing Archi-tectures” e degli ”Embedded Systems” sullabase del know-how sviluppato negli anni nel-l’ambito del progetto APE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sagli per effettuarne ad esempio una sorta di “ra-diografia” con particelle. Grazie ad alcune di que-ste realizzazioni, presso il LABEC si svolge ancheuna intensa attività di supporto per esperimentidi fisica nucleare basati in altri e più grandi labo-ratori sia nazionali che all’estero, ad esempio testpreliminari di rivelatori e misure di danno da ra-diazione.Va sottolineato infine il ruolo che il LABEC svolge– grazie al fatto di essere inserito in una strutturalocale dell’INFN, a stretto contatto col Diparti-mento di Fisica e Astronomia - sia per la didatticauniversitaria nell’ambito di laboratori per studenti,che per l’addestramento alla ricerca e la forma-zione di competenze superiori (in diversi ambiti:impiantistica, elettronica, vuoto, rivelatori, acqui-sizione e analisi dati) a livello di tesi di laurea, lau-rea specialistica e dottorato.Le elevate competenze e il prestigio del LABECsono ampiamente riconosciuti a livello internazio-nale. Nel 2009 la rivista del NuPECC Nuclear Phy-sics News International ha dedicato al LABEC unarticolo nella serie dei Laboratory portraits.Le attività del LABEC portano da un lato a unacontinua rilevante produzione di lavori scientifici,su riviste ISI e libri; dall’altro alla partecipazione inprogetti pubblici finalizzati (campagne di studiodi manufatti storico-artistici, campagne di moni-toraggio dell’ambiente in ambito regionale, na-zionale e mondiale). In particolare, nel corso degliultimi tre anni, il LABEC si è inserito in una reteregionale di collaborazioni per la ricerca e i servizi,insieme ad altri enti pubblici come università, isti-tuti del CNR, la Sovrintendenza regionale toscana,l’Opificio delle Pietre Dure, ricevendo finanzia-menti dalla Regione Toscana per il pagamento dipersonale a tempo determinato per un totale dicirca seicentomila euro. Il LABEC ha partecipato epartecipa inoltre a progetti regionali e internazio-nali nel campo del monitoraggio dell’inquina-mento atmosferico (ad esempio i progetti PATOS– PArticolato in TOScana - e il suo seguitoPATOS2) e dei cambiamenti climatici, quali la co-laborazione EPICA (European Project for Ice Co-ring in Antarctica).Recentemente, uno sviluppo molto importante alLABEC ha riguardato l’uso dell’AMS in problemiambientali, in particolare la misura della concen-trazione di 14C nel particolato atmosferico. Sitratta di un argomento estremamente innovativoe di grande rilevanza. La misura della concentra-zione di 14C nel particolato, infatti, consente diricavare informazioni decisive per determinarel’origine della componente carboniosa delle pol-
veri fini, che spesso è quella maggioritaria: dallamisura della quantità di 14C si può capire se lafonte di questa componente dell’inquinamento ènaturale o antropica, causata ad esempio dallacombustione di petrolio e derivati. La sfida speri-mentale è legata – in aggiunta al fatto che la con-centrazione da misurare è dell’ordine o inferiorea un atomo ogni mille miliardi - all’esiguità dellamassa del materiale su cui effettuare l’analisi (lepoche centinaia di microgrammi che si raccolgonosui filtri del particolato). Queste attività rappresen-tano la frontiera della ricerca tecnologica in que-sto settore, che vede nel mondo impegnati solodue o tre laboratori. Al LABEC, le tecniche di pre-parazione e di misura con l’acceleratore che si èiniziato a sviluppare hanno dimostrato che questasfida tecnologica si può affrontare, e si vuolequindi proseguire in questa direzione. Oltre alle attività portate avanti usando le tecnicheche usano l’acceleratore, di recente all’interno delLABEC si sono sviluppate anche strumentazioniportatili altamente competitive per la diagnosticadei Beni Culturali, per venire incontro all’esigenzache spesso si presenta di analizzare opere inamo-vibili, ad esempio gli affreschi. Sfruttando le ampiecompetenze sviluppate con le tecniche di accele-ratore, si sono “trasferite” alcune soluzioni appli-cative anche alla strumentazione portatile. Si èrealizzato ad esempio un innovativo sistema perle analisi di fluorescenza X con strumentazioneportatile, che supera le tradizionali limitazioni diquesto tipo di strumentazioni riuscendo a esten-derne la capacità analitica nelle misure di compo-sizione dei materiali anche agli elementi a numeroatomico basso, fino al sodio. Grazie a questa stru-mentazione innovativa, già nel corso del 2010 ilgruppo del LABEC è stato chiamato dalle Sovrin-tendenze e dall’Opificio delle Pietre Dure a svol-gere numerose campagne di analisi in situ, inpreparazione a interventi conservativi. Sono statianalizzati ad esempio affreschi di Giotto in SantaCroce a Firenze, il grande crocifisso ligneo delMaestro di Figline, nella stessa chiesa, l’affrescodella Resurrezione di Piero della Francesca alMuseo Civico di Sansepolcro, una Madonna conbambino di Raffaello, e molte altre opere impor-tanti, Anche questo nuovo filone di sviluppo ditecniche con strumentazione portatile appare per-ciò molto promettente e fecondo.Le prospettive di attività per il prossimo triennioe quelle a più lungo termine dipendono tuttaviadrasticamente da quello che potrà essere lo svi-luppo del personale. In effetti, mentre la strumen-tazione disponibile è tuttora ai massimi livelli,
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
76
scientifica. Di seguito si illustrano solo alcuni casiesemplari di attività svolte in collaborazione; perl’elenco completo si rimanda al successivo para-grafo 5.1:
1. Il Laboratorio LABEC di Sesto Fiorentino(Firenze)
2. Il Centro Nazionale di AdroterapiaOncologica (CNAO)
3. Il Galileo Galilei Institute forTheoretical Physics (GGI)
4. Il Centro Enrico Fermi5. La Fondazione Ettore Maiorana (FEMCCS)6. La Fondazione Bruno Kessler (FBK)7. Il Consortium GARR
Il Laboratorio LABECIl laboratorio LABEC è una grande struttura dellasezione di Firenze, che occupa locali del Dipar-timento di Fisica e Astronomia dell’Università dicomplessivamente oltre 1500 m2. È basatacome strumento principale su un acceleratore diparticelle di tipo Tandem, da 3 milioni di Volt ditensione massima di terminale, col quale si ef-fettuano numerose importanti applicazioni in-terdisciplinari di tecniche della fisica nucleare, dinotevole impatto sociale e culturale.
Nato inizialmente per applicazioni nel campodei Beni Culturali, grazie alla versatilità delle at-
trezzature e all’originalità delle tecniche svilup-pate, ha progressivamente esteso il campo diapplicazioni anche al settore dei problemi am-bientali (di particolare importanza e attualità ilcontrollo della qualità dell’aria con la misuradella composizione delle polveri fini in atmo-sfera), alla geochimica, alla scienza dei materialiin generale.L’acceleratore Tandem del LABEC consente siamisure di Accelerator Mass Spectrometry (AMS)– in particolare datazioni archeologiche col me-todo del 14C – che di Ion Beam Analysis (IBA)per sofisticate determinazioni non distruttive dicomposizione di materiali.La caratteristica peculiare del LABEC è quella disvolgere un’estesa attività di ricerca e sviluppodi nuove tecnologie nucleari applicative (finan-ziata dall’INFN attraverso la Commissione Scien-tifica Nazionale 5), grazie alla quale si possonomantenere costantemente ai massimi livelli le at-tività più standard “di servizio” svolte a favoredi dipartimenti universitari e altri Enti pubblicinel campo delle scienze umane, Sovrinten-denze, Enti di tutela del patrimonio culturale,Enti di tutela della salute e dell’ambiente.Per quanto concerne queste attività “di servi-zio”, il LABEC continua a produrre annualmenteoltre duecento datazioni 14C di reperti archeo-logici o storici, nell’ambito di collaborazioni congruppi di studiosi del settore ed enti di tutela;partecipa a campagne di indagini diagnostichepreliminari al restauro di opere d’arte di ogni ti-pologia; effettua migliaia di misure di composi-zione delle polveri fini in atmosfera, nel’ambitodi campagne di monitoraggio della qualità del-l’aria in collaborazione con Agenzie di prote-zione ambientale, in Italia e all’estero.Riguardo alle attività di ricerca e sviluppo, in-vece, al LABEC si sono realizzati negli ultimi anninumerosi canali di fascio e nuovi set-up di mi-sura, taluni con caratteristiche pionieristiche etuttora uniche nel panorama mondiale: sonocorrentemente usati fasci estratti in atmosfera(una tecnica introdotta proprio dai ricercatori delLABEC, poi divenuta uno standard a livello in-ternazionale in particolare per le analisi sui BeniCulturali), anche con dimensioni micrometrichee sistemi di scansione, per ricavare non distrut-tivamente non solo la composizione di un cam-pione ma anche la distribuzione spaziale dellesue componenti; sistemi di fasci a impulsi bre-vissimi, un centinaio di ps (pico-secondi); sistemidi microfasci estratti di intensità controllata fino apoche particelle al secondo, con scansione su ber-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
75
Fig. 3.26: Analisi di composizione dei pigmenti su una tela del Man-tegna alla facility di microfascio esterno a scansione del Laboratorioper i Beni Culturali di Firenze (LABEC).

Nazionali di Frascati, i Laboratori Nazionali di Le-gnaro, i Laboratori Nazionali del Sud (Catania),nonché le Sezioni di Milano, di Torino, di Genovae Pavia. Ciascuna unità è stata coinvolta nel rag-giungimento di uno o più obiettivi specifici benindividuati e con precise responsabilità che vannodalla progettazione alla costruzione, alla misura everifica delle caratteristiche di progetto, alla instal-lazione e messa in funzione delle apparecchiaturescientifiche o parti del complesso di acceleratori.In questa impresa hanno contribuito diversi istitutied enti pubblici e privati; tra questi si ricordano:la Fondazione Policlinico Ospedale Maggiore (Mi),la Fondazione Istituto Neurologico C. Besta (Mi),la Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori (Mi),l’Istituto Europeo di Oncologia (Mi), la FondazionePoliclinico San Matteo (Pv), la Fondazione TERA(No) e, oltre l’INFN, il CERN di Ginevra, il GSI (Dar-mstadt), il LPSC (Grenoble), il NIRS (Chiba, Giap-pone), l’Università di Milano, il Politecnico diMilano, l’Università di Pavia, il Comune di Pavia,la Fondazione Cariplo. Tra questi, principalmentel’INFN e il CERN hanno curato gli aspetti tecnolo-gici, ossia le fasi di progettazione, costruzione, in-stallazione e messa in funzione degli acceleratori.Attualmente il CNAO sta completando la fase dicommissioning. Completata la progettazione, co-struzione ed installazione, già da oltre un anno èterminato il processo di caratterizzazione dei fascidi ioni idrogeno e ora ci si accinge a caratterizzareil funzionamento della macchina con gli ioni car-bonio. Tutto il sistema di trasporto e controllo deifasci fino alle sale di trattamento è stato messo apunto.Nel 2011 è iniziata la fase di sperimentazione cli-nica richiesta dal Ministero della Salute. Anche aquesta fase l'INFN sta collaborando con i suoigruppi di esperti per quanto riguarda la parte diradiobiologia, ovvero del misure di efficacia del fa-scio con l'irradiazione di cellule in vitro e di cavie.In parallelo, dopo una prima fase in cui dei “fan-tocci” sono stati esposti al fine di caratterizzare ifasci stessi di particelle, è iniziato anche il tratta-mento di un campione selezionato di pazienti. At-tualmente sono in corso trattamenti con i fasci diprotoni. Una volta completato il commissioningcon gli ioni carbonio, e le relative misure di carat-terizzazione radiobiologica, inizieranno anche itrattamenti con questo tipo di fasci. La sperimen-tazione clinica è prevista durare 18 mesi e si pre-vede di trattare in totale circa 230 pazienti. Allafine di questo periodo i protocolli clinici per i trat-tamenti dovrebbero essere stati completamentedefiniti e si potrà iniziare il trattamento sistematico
dei pazienti affetti da tumore. A regime il CNAOeffettuerà circa 20.000 sedute all’anno e sarannotrattati 3.000/3.500 pazienti. Le patologie clinicheche potranno essere trattate includono: sarcomidell’osso e delle parti molli, tumori del sistemanervoso centrale e paraspinale, tumori del di-stretto cervico cefalico, melanomi dell’occhio edelle mucose, tumori non a piccole cellule del pol-mone, tumori primitivi del fegato, neoplasie del-l’età pediatrica, tumori ginecologici, tumori delpancreas.Le attività a medio termine proseguiranno conl’installazione della linea sperimentale dedicataalla ricerca. Si tratta di una ulteriore linea che tra-sporterà i fasci estratti dal sincrotrone in una op-portuna sala, già realizzata, dove potrà essereeffettuata ricerca clinica, radiobiologia e fisica. Perquest’ultima, come si è detto, nel 2009 è stato fir-mato un accordo quadro di collaborazione traINFN e CNAO. I due enti si stanno impegnandoper reperire i finanziamenti necessari alla sua rea-lizzazione.Questa area di ricerca al CNAO riguarderà sia laradiobiologia che altre attività di test per apparatie dispositivi di interesse dell'INFN. Più a lungo termine, è prevista una fase di espan-sione del CNAO con la realizzazione di ulterioridue sale di trattamento dove poter alloggiaredelle “teste” rotanti che permetteranno di poterirraggiare i pazienti da qualsiasi direzione, mentre,allo stato attuale, due sale di trattamento preve-dono l’irraggiamento con un fascio fisso orizzon-tale ed una sala è predisposta per l’irraggiamentocon fascio fisso, sia orizzontale che verticale (fi-gura 3.77).L'esperienza che l'INFN sta maturando insieme alCNAO per questo tipo di attività consentirà anchel'attuazione di processi di trasferimento tecnolo-gico vantaggiosi per l'ente. In particolare si staconsiderando la richiesta da parte di MEDAU-STRON, il centro di adroterapia in costruzione inAustria, della realizzazione del sistema di monito-raggio e distribuzione del fascio terapeutico, cheal CNAO è stato sviluppato con il sostanziale ap-porto di gruppi INFN.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
78
grazie all’investimento di strumentazione (valuta-bile intorno ai 5 milioni di euro) che l’INFN ha ef-fettuato nel LABEC nel corso degli ultimi anni, unagrave criticità per il laboratorio è la precarietà dibuona parte del personale che vi afferisce. Moltodel lavoro continua ad essere portato avanti daassegnisti di ricerca o studenti di dottorato, e peruna struttura delle dimensioni e delle potenzialitàdel LABEC, lo staff permanente è largamente sot-todimensionato sia per il supporto tecnico di ma-nutenzione delle impegnative attrezzature che perla conduzione delle attività di ricerca e di servizio(ad esempio l’acceleratore puo solo saltuaria-mente essere utilizzato in turni notturni).Se sarà possibile nel prossimo triennio stabilizzarealmeno una parte del personale precario, attual-mente presente grazie ai finanziamenti esterni, re-centemente ottenuti dalla Regione Toscana,saranno possibili una serie di sviluppi metodolo-gici, quali quelli sopra accennati, oltre al poten-ziamento dei sistemi di microfascio esterno ascansione, al miglioramento dei livelli di sensibilitàe precisione delle datazioni col 14C e all’allesti-mento delle procedure per la misura in AMS di unaltro radioisotopo, lo 129I, che riveste grande im-portanza, tra l’altro, per il monitoraggio dei pos-sibili livelli di contaminazione legati direttamenteo indirettamente alle attività delle centrali nucleari.
LA FONDAZIONE CNAO La Fondazione CNAO (Centro Nazionale di Adro-terapia Oncologica), in stretta collaborazione conl’INFN, ha completato la realizzazione del primocentro italiano (figura 3.38), secondo in Europa,dedicato alla cura dei tumori con l’utilizzo di ioniidrogeno e ioni carbonio. Il trattamento dei tumoriattraverso l’utilizzo di fasci di particelle di altaenergia è in continuo aumento presso i centri stra-nieri, soprattutto americani e giapponesi. In Italiaè già da anni in funzione, presso i Laboratori Na-zionali del Sud dell’INFN, a Catania, un laboratoriodenominato CATANA che, in collaborazione conl’università di Catania, permette la cura del mela-noma dell’occhio con l’irraggiamento di ioni idro-geno prodotti dall’acceleratore dei LNS.Il numero dei pazienti trattati e delle indicazionicliniche è in costante crescita. L’azione delle par-ticelle sulle celle tumorali provoca la rottura delladoppia elica nella struttura del DNA e porta allamorte delle cellule tumorali. In particolare, i pro-toni e gli ioni leggeri hanno il vantaggio di pene-trare nel corpo fino ad una profondità, correlataalla loro energia iniziale, rilasciando poca energiadurante il tragitto e concentrandone il rilascio alla
fine del loro percorso.Questo comportamento è comunemente indi-cato come picco di Bragg. Il rilascio di energiaad una profondità controllabile e la facilità di pe-netrazione, rendono questa tecnica estrema-mente precisa ed attraente rispetto al piùdiffuso irraggiamento effettuato con elettroni oraggi X che rilasciano la loro energia negli stratisuperficiali diminuendo man mano con la pro-fondità.La tecnologia necessaria alla generazione, tra-sporto, raggiungimento della necessaria energiadelle particelle per il trattamento specifico ed in-fine, loro trasporto fino al paziente, è quella ba-sata sull’utilizzo di un acceleratore di particelle ditipo circolare, denominato sincrotrone, aventecirca 25 m di diametro.Le particelle, gli ioni, generati da un plasma con-finato in una sorgente dedicata, subiscono unaprima accelerazione e manipolazione e quindivengono immessi nell’anello circolare, il vero eproprio sincrotrone, che ne innalza l’energia finoa quella necessaria per l’irraggiamento. A questopunto un sistema di estrazione permette diestrarre gli ioni dall’anello e li indirizza, tramiteuna opportuna linea di trasporto, in una delle tresale di trattamento dove il paziente attende di es-sere “trattato” (figura 3.27).L’INFN è l’unico istituto in Italia dotato di un labo-ratorio, i Laboratori Nazionali di Frascati, dove giàdagli anni ’60 del secolo scorso esiste una tradi-zione nella realizzazione di acceleratori circolari,oltre ad avere nel Laboratori Nazionali di Legnaroe nei Laboratori Nazionali del Sud, Catania, di piùrecente realizzazione, acceleratori lineari che pro-ducono e lavorano con ioni dedicati ad esperi-menti di fisica fondamentale. Questa tradizioneed esperienza è stata messa a disposizione dellaFondazione CNAO, appositamente istituita perprogettare e costruire il CNAO a Pavia.Nel Novembre del 2003 l’INFN ha firmato un ac-cordo di collaborazione con il CNAO, attraversoil quale l’INFN è divenuto co-responsabile con ilCNAO nella costruzione del complesso di acce-leratori. La collaborazione ha coperto il periodo2003-2009 ovvero tutta la fase di progetta-zione, costruzione, installazione e messa in fun-zione del CNAO. Nel 2009 è stato firmato unnuovo accordo di collaborazione tra INFN eCNAO finalizzato all’utilizzo per scopi scientificidell’acceleratore ed in particolare per studi avan-zati nel campo della radiobiologia.L’accordo di collaborazione ha coinvolto vari la-boratori e Sezione dell’INFN, tra cui i Laboratori
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
77

Il Galileo Galilei Institute for TheoreticalPhysics (GGI) di Arcetri (Firenze)Il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics(GGI) è stato fondato dall’INFN nel 2005 ed èsostenuto finanziariamente dall’INFN e dall’Uni-versità di Firenze. Il GGI organizza e ospita wor-kshop avanzati di fisica teorica (tipicamente treogni anno) soprattutto ma non esclusivamentenel settore della fisica delle particelle; ciascunworkshop è dedicato a un tema specifico, duramediamente 8 settimane e vede la partecipa-zione di circa 20-30 ricercatori al giorno, sele-zionati all’interno della comunità internazionaledai comitati organizzatori dei workshop.
I workshop che si terranno al GGI nel 2012sono:
I workshop che si terranno al GGI nel 2013sono:
La commissione scientifica nazionale di fisica teo-rica dell’INFN (CSN4) ne è stata promotrice e tut-tora costituisce il riferimento principale del GGIdal punto di vista scientifico. Il presidente dellaCSN4 presiede anche le riunioni del ComitatoScientifico (Scientific Committee) per la selezionedei programmi da sottoporre all'approvazione fi-nale del Comitato di Consulenza (Advisory Com-mittee). Entrambi i comitati sono formati dascienziati di chiara fama nei diversi settori della fi-sica teorica.Maggiori informazioni sulle attività del GGI sipossono trovare sul sito web:http://www.ggi.fi.infn.it/.Si veda anche il paragrafo 3.5.
IL Centro Enrico Fermi per il Progetto EEE L’obiettivo del Progetto “La Scienza nelle Scuole:Extreme Energy Events (EEE)” è quello di portarela Scienza nel cuore dei giovani attraversoun’azione di incentivazione culturale diretta, chenasce quando gli studenti sentono di essere di-ventati protagonisti nella costruzione di uno stru-mento e nella elaborazione di dati, che sono allafrontiera del pensiero scientifico.Il Progetto EEE è frutto di una collaborazione traINFN, CERN, MIUR, FEMCCS (Fondazione EttoreMajorana e Centro di Cultura Scientifica), Cen-tro Fermi (Museo Storico della Fisica e CentroStudi e Ricerche Enrico Fermi) e gli Istituti Scola-stici coinvolti, distribuiti su tutto il territorio na-zionale. Agli Istituti Scolastici viene reso dispo-nibile un “Laboratorio Avanzato”, particolar-mente potente per lo studio dei Raggi Cosmicie in particolare per lo studio degli sciami di par-ticelle prodotte dai Raggi Cosmici di altissimaenergia, di cui non si conoscono ancora le ori-gini. Questi sciami possono produrre coinci-denze tra stazioni di rivelazione anche moltolontane tra loro ed è proprio sulla grande di-stanza tra le stazioni che punta il Progetto. Stu-denti ed Insegnanti costruiscono con le loromani, al CERN a Ginevra, i loro rivelatori inmodo da partecipare personalmente alla realiz-zazione del Progetto. Come rivelatore si è sceltauna terna di MRPC (Multigap Resistive PlateChamber). Questo rivelatore, inventato da An-tonino Zichichi e collaboratori, detiene il recordmondiale nella misura dei tempi di volo delleparticelle subnucleari. La terna di MRPC per-mette di identificare la direzione dei muoni dellosciame cosmico. Quindi, tramite la misura delledirezioni e dei tempi di arrivo, è possibile iden-tificare la direzione del primario e rigettare coin-cidenze accidentali, indipendentemente dalladistanza relativa tra le stazioni. Attualmente gliIstituti Scolastici coinvolti sono 33, distribuiti sututto il territorio nazionale e prossimi a sezioniINFN, che li supportano per quanto riguarda lamanutenzione e l’analisi dei dati. Tuttavia, inprospettiva studenti e docenti saranno auto-nomi, sia per quanto riguarda la raccolta dei datisia per la loro interpretazione. L’obiettivo finaledel prossimo triennio è il coinvolgimento dicento Scuole e l’estensione della ricerca di coin-cidenze, attese e non, non solo tra questi siti,ma anche tra loro e siti lontani, in sinergia conanaloghe stazioni installate in Cina. Russia, USAe Australia.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
80
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
79
Fig. 3.27: Controllo dei tumori radio resistenti con ioni di carbonio.Fig. 3.28: Schema del complesso di acceleratori del CNAO e dellelinee di trattamento.
Fig. 3.29: Vista del sincrotrone.Fig. 3.30: Sala di trattamento (in allestimento).Fig. 3.31: Vista aerea del centro CNAO a Pavia.
New Quantum States of Matter (data di inizioaprile 2012);What is nu? From New Experimental Neu-trino Results To A Deeper Understanding OfTheoretical Physics And Cosmology (data diinizio giugno 2012);New Frontiers In Lattice Gauge Theories (datadi inizio agosto 2012);Understanding the TeV Scale Through LHCData, Dark Matter And Other Experiments(data di inizio ottobre 2012).
•
•
•
•
Higher Spins, Strings and Duality (data di ini-zio marzo 2013);Beyond the Standard Model after the first runof LHC (data di inizio maggio 2013);Geometry of strings and fields (data di inizioagosto 2013).
•
•
•

IL Consortium GARRNelle sue attività di ricerca, l’INFN fa largo usodi applicazioni avanzate, che presentano requi-siti di rete molto elevati e che richiedono solu-zioni specifiche; fra questi LHC, Computing Gridè l’esempio più eclatante in termini di molti datitrasmesse e di estensione intercontinentale dellasua operatività. I servizi relativi ad una efficiente connessione te-lematica tra le proprie sedi (laboratori e sezioni)e da e verso i laboratori internazionali sono oggiassicurati dal Consortium GARR (www.garr.it),un’associazione senza fini di lucro fondata nel2001 di cui l’INFN è socio fondatore, insieme aCNR, ENEA e Fondazione CRUI. Questa esterna-lizzazione di servizi non core-business garantisceun servizio ad oggi adeguato ed è effettuatacon 49 collegamenti per un totale di 48 gigabital secondo di banda. Le statistiche 2010 e 2011dimostrano l’affidabilità del servizio e, soprat-tutto, il grande utilizzo che l’INFN fa della rete,soprattutto nel trasferimento dei dati da e versoil CERN e da e verso i laboratori nazionali ed ilCNAF. Il progetto GARR-X del GARR, già con-cretamente avviato, consentirà di mantenersi alpasso con gli altri enti di ricerca europei, soprat-tutto per quanto riguarda il trasferimento dellegrandi moli di dati connesse al grid computing,e più in particolare ai Tier1- Tier2 di LHC e, ci siauspica, di SuperB. Tra i servizi gestiti dal GARR, vi è anche il serviziodi videoconferenza (http://vconf.garr.it/), centra-lizzato e multipunto (nel corso del triennio inevoluzione verso l’alta definizione), ed il serviziodi certification authority (ca.garr. it), necessarioper l’accesso alle griglie computazionali. Nelcorso del triennio 2012-2014, una particolareattenzione verrà posta allo sviluppo e al sup-porto delle tecnologie wireless e della Mobilityche rappresentano sempre di più uno strumentodi base del lavoro di ricerca e di formazione. Diparticolare rilievo è il servizio GARR AAI IDEMper la gestione dell’identità federata, finalizzataal controllo degli accessi a risorse e servizi appli-cativi accessibili via web (repository di dati, ri-sorse di calcolo, riviste elettroniche, piattaformedi e-learning, Videoconfernza, ecc), nell’ambitodella quale è prevista un’attività di collabora-zione a livello internazionale, che attraverso ilmeccanismo del Confederazioni, possa esten-dere i benefici dell’autenticazione e autorizza-zione degli utenti anche fuori dall’Italia,allargandone quindi le potenzialità.
3.11 I PROGETTI FIRB, PRIN
Progetti FIRBL’Istituto ha applicato e ricevuto finanziamentia valere sul programma FIRB (Fondo per gli In-vestimenti della Ricerca di Base) del MIUR.
Progetti PRINTradizionalmente ricercatori dell’INFN e i colleghiuniversitari associati partecipano ai Progetti diRicerca di Interesse Nazionale (PRIN) in strettacollaborazione con le università su tematiche diinteresse dell’Istituto. Tenuto conto della dimen-sione complessivamente limitata delle parteci-pazioni, della crescente onerosità amministrativaper la rendicontazione e soprattutto della ridu-zione progressiva delle risorse disponibili, l’Isti-tuto ha deciso di escludere ogni tipo difinanziamento diretto in aggiunta alla disponi-bilità di personale e di attrezzature comunquegià presenti presso le proprie strutture. Va comunque sottolineata la grande rilevanzache questi progetti rivestono in un sinergicosforzo INFN-Università nell’accedere a fonti di fi-nanziamento preziose per lo sviluppo e il raffor-zamento di progetti di ricerca di area INFN.
3.12 I PROGETTI REGIONALIE I PROGETTI LOCALI
L’Istituto, attraverso le sue strutture (Sezioni e La-boratori nazionali) ha avanzato proposte e ha ri-cevuto finanziamenti su programmi regionali olocali. In particolare si segnalano i seguenti pro-getti regionali, attivi nel 2011 e la cui scadenzarientra nel piano triennale 2012-14.
STRUTTURA: SEZIONE DI TORINOTITOLO DEL PROGETTO: NEU_ART
Note (ricadute sulla società, rapporti con l’Indu-stria, trasferimento tecnologico, ecc.): Presenza salone DNA - in progress.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
82
La Fondazione Ettore Majorana (FEMCCS) La Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cul-tura Scientifica non è una Accademia né unaUniversità come quelle a tutti note. È una Istitu-zione nata nel cuore della Scienza di Frontieraper opera di Bell, Blackett, Rabi, Weisskopf e Zi-chichi. Lo scopo della Fondazione a livello na-zionale ed internazionale è stato quello prima dicreare e poi di mantenere in Italia una piatta-forma culturale di alto livello scientifico, chepossa permettere ai giovani ricercatori di cono-scere quali sono le problematiche di maggioreattualità ed interesse nei vari campi della ricercascientifica, ai ricercatori più esperti di studiare ediscutere con i loro colleghi più qualificati i risul-tati delle loro ricerche. Poiché le varie discipline scientifiche su cui si ar-ticola l’attività della Fondazione hanno diversi li-velli di interesse e di profondità nell’ambito delletematiche scientifiche, l’attività delle varieScuole si adegua a queste esigenze le quali im-plicano anche una funzione di incentivazioneper quelle discipline poco coltivate in Italia, madi grande interesse scientifico. L’attività dellaFondazione non si limita tuttavia alla program-mazione e allo studio delle problematiche di in-teresse rigorosamente scientifico: essa è estesaanche allo studio e all’approfondimento delleproblematiche provenienti dalle discipline uma-nistiche, allo scopo di legare la cultura rigorosa-mente scientifica a proficui scambi di idee sutemi di grande attualità per impostare lo studiodi problemi interdisciplinari e per promuovereaggiornamenti sui risultati ottenuti e sui pro-gressi fatti. Quello che distingue Erice è lo spiritoche anima tutti i partecipanti: studenti e do-centi. L’obiettivo primo è imparare. Non si rila-sciano diplomi né titoli di alcun tipo. Comenovecento anni fa. Lo studente ascolta la le-zione e dopo l’interruzione per la colazione siapre la parte più divertente. Lo studente può ri-volgere al professore qualsiasi domanda. Anchela più banale. Non sarà punito.È interesse di tutti conoscere i pensieri dei gio-vani cervelli esposti alle novità scientifiche dellequali avevano, forse, immaginato tanti dettagli,ma difficilmente quelli che frullano nella testadel docente. Dato un problema, i modi di af-frontarlo sono diversi. L’originalità della Fonda-zione Ettore Majorana è nell’essere riuscita acreare un “ponte” tra l’insegnamento universi-tario e i laboratori scientifici. Questo “ponte” hale sue radici nei periodi in cui un docente puòstare vicino a uno studente. E questo avviene
proprio dando a studenti e docenti le stessestrutture logistiche, creando così un’atmosferadi interazione culturale che l’Università non puòdare. Dal 1963 la Fondazione Ettore Majoranae Centro di Cultura Scientifica di Erice, Sicilia,costituisce un polo di attrazione per tutta la co-munità scientifica internazionale grazie alle sue123 scuole post-universitarie avanzate (la piùantica è quella di Fisica Subnucleare), a cuihanno contribuito i maggiori esperti mondialinei più svariati campi del sapere, cercando di ab-battere le barriere ideologiche, politiche, razziali,inventate non dalla Scienza, ma dai suoi peg-giori nemici. Ogni anno dal 1963 autori di sco-perte ed invenzioni, tra i quali ben 125 PremiNobel (di cui 76 hanno avuto il Nobel dopo laloro partecipazione a Erice, e 49 erano già premiNobel quando hanno cominciato a parteciparealle attività del Centro), insegnano a studentiprovenienti da tutto il mondo i più recenti risul-tati raggiunti sulla frontiera della Scienza.In 49 anni di attività hanno partecipato alleScuole post universitarie e ai Workshops di Ericeoltre centomila ricercatori, provenienti da 140 di-verse nazioni. Notizie più dettagliate sulle strut-ture della Fondazione FEMCCS, sulle attività e suipartecipanti sono reperibili alla pagina web:www.ccsem.infn.it
La Fondazione Bruno Kessler (FBK)La Fondazione Bruno Kessler (FBK) è promossae sostenuta dalla provincia di Trento ha unaforte vocazione per la ricerca scientifica le tec-nologie correlate e le relative applicazioni. Da al-cuni anni l’INFN ha rapporti privilegiati dicollaborazione sia nello sviluppo di sensori di si-licio (per i quali FBK ha un centro di produzionetra i più avanzati in Europa ed ha già lanciato di-versi spin-off anche motivati dalla collabora-zione con L’INFN), sia per quanto riguarda letecniche di calcolo avanzato. Entrambe le lineestanno dando ottimi risultati.Un esempio significativo dei risultati della colla-borazione con l’INFN, sono i fotomoltiplicatoridi silicio (SiPm), questi interessantissimi sensoristanno conoscendo, a solo tre anni dall’iniziodello sviluppo, un successo internazionale. L’av-vio di uno spin-off da cui l’INFN trarrà proventisotto forma di royalty ha avuto luogo nel corsodel 2010. La convenzione tra i due enti è statarecentemente rinnovata. Entrambi i partner,INFN ed FBK sostengono con entusiasmo la col-laborazione.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
81
Durata: 1/12/2009 - 30/11/2012;Finanziamento alla struttura/finanziamentocomplessivo del progetto: 283k€/675k€;Ente/i finanziatore/i: Regione Piemonte;Partner: Dip. Fis. Sper. Univ di Torino e CentroConservazione e Restauro (CCR) di VenariaReale;Ente resp. del progetto: INFN Sezione di Torino;Risorse della struttura impegnate nel pro-getto: laboratorio tecnologico e in piccola mi-sura CdC.
•
•
•
•
•
•

STRUTTURA: LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSOA) TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO SPECIALE MUL-TIASSE GRAN SASSO IN RETE. Ambito: ProgrammaOperativo FSE Abruzzo 2007-2013, obiettivo CRO- protocollo d’intesa tra INFN e Regione Abruzzo.
La Regione Abruzzo ha autorizzato la realizza-zione delle seguenti attività a valere su economieprodotte durante la realizzazione del Progetto"Gran Sasso in rete":
B) TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO SPECIALE MUL-TIASSE LA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA IN ABRUZZO.Ambito: Programma Operativo FSE Abruzzo2007-2013, Obiettivo CRO – Piano Operativo2009-2010-2011.
Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Re-gione Abruzzo e INFN, avvenuta in data 2 settembre2011, è stata avviata la realizzazione del Progetto“La Società della Conoscenza in Abruzzo”.Il Progetto complessivo validato dal competenteorganismo in data 17 febbraio 2012, si inserisceall’interno della collaborazione tra Regione Abruzzoed INFN Laboratori Nazionali del Gran Sasso,avviata con gli strumenti attuativi della fase con-clusiva del P.O.R. Ob 3 - 2000/2006 e ripropostacon il Piano operativo FSE Abruzzo 2007/2008.
L’obiettivo del Progetto è quello di contribuireallo sviluppo di una Società della conoscenza chefonda la propria crescita e competitività sul sapere,la ricerca e l´innovazione attraverso la realizzazionedi attività di alta formazione e di formazione con-tinua specialistiche in grado di garantire il trasfe-rimento di conoscenze avanzate al tessuto pro-duttivo regionale e contribuire alla crescita dellacompetitività del territorio regionale e alla valo-rizzazione del capitale umano.Il carattere innovativo della formazione propostadai Laboratori Nazionali del Gran Sasso è l’adozionedel modello formativo “one to one” per borse distudio e assegni di ricerca. Ed inoltre, il modellodelle “comunità di pratica” e l’utilizzo degli stru-menti del web 2.0 per i corsi online ha offerto giài suoi frutti tra le Imprese della Regione; la forma-zione su strumentazione altamente tecnologica el’istituzione del Centro di Eccellenza Formativaed Informativa in Fisica Astroparticellare (C.F.A.)hanno contribuito a mantenere molto alto il livellodi formazione erogato.La nuova strategia per la relazione col territorio èquella del largo coinvolgimento dei rappresentantidell’economia abruzzese sin dai primi passi dellaprogettazione allo scopo di accogliere le istanzedi alta formazione provenienti dal tessuto im-prenditoriale. Le caratteristiche peculiari dei L.N.G.S.e le modalità organizzative attribuiscono valenzaintrinsecamente prototipale a tutti gli interventi.Il Progetto con risorse complessive pari a €2.650.000,00 prevede la realizzazione delleseguenti azioni:L’intervento a) “Promozione della conoscenza”prevede la formazione di giovani che soddisfi lenecessità della ricerca e le esigenze delle Impreseattraverso il "training-on-the-job", presso i LNGSe il trasferimento in azienda (o in altri centri di ri-cerca italiani o esteri) delle conoscenze acquisiteattraverso uno stage che va da minimo 4 a mas-simo 6 mesi. L'idea fondamentale è di creare deiruoli di 'boundary spanner', persone che agiscanonell'intersezione tra il mondo produttivo e ilmondo della ricerca, contribuendo ad espanderei confini di entrambi i settori e in qualche caso cre-ando essi stessi nuove interfacce.Si prevede l’erogazione di:
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
84
STRUTTURA: SEZIONE DI PISATITOLO DEL PROGETTO: ISOLATORI SISMICI PER ADVAN-CED VIRGO (ISAV)
Note (ricadute sulla società, rapporti con l’Indu-stria, trasferimento tecnologico, ecc.):
Il progetto si inserisce in modo complementarenel programma di ricerca INFN “Advanced Virgo”implementando una collaborazione con ScienziaMachinale, partner del presente progetto,di elevatoimpatto professionale. La collaborazione riguardal’area di sviluppo della sensoristica per spostamentimicrometrici e la progettazione, nonché la realiz-zazione,realizzazione di particolari meccatroniciavanzati, mediante attività di co-design effettuatapresso i locali della ditta, dove i giovani ricercatoripotranno usufruire delle strutture e dei softwaretools che SM metterà a disposizione congiunta-mente all’esperienza del proprio personale seniorprogettista meccatronico.
STRUTTURA: SEZIONE DI GENOVATITOLO DEL PROGETTO: MAGNETIC IRON DETECTOR 2(MID2)Il Consiglio Direttivo del 27 Febbraio 2009 ha ap-provato la Convenzione MID2 tra l’INFN, gli Ospe-dali Galliera e l’Associazione Ligure Talassemiciper la definizione e lo sviluppo di un nuovo mo -dello Magnetic Iron Detectoravente per oggettodella presente convenzione è la definizione deirapporti di collaborazione per il perfezionamentoe la realizzazione di un modello di MID (nel se -gui to MID2) con caratteristiche tali da consentirnel’im piego routinario in attività clinico mediche dapar te di personale ospedaliero.
Note (ricadute sulla società, rapporti con l’Industria,trasferimento tecnologico, ecc.):Il suscettometro MID 1 (EU 1 644 739 and US7,412,275 B2 patents) è utilizzato dal 2005 dal-l’Ospedale Galliera, ha misurato un migliaio dipazienti evitando centinaia di biopsie epatiche.Nel 2009, il consorzio UNI.T.I. tra l’Università diGenova e Sviluppo Italia ha giudicato il progettoMID idoneo a diventare uno spin-off universitario. Inoltre: è stata proposta una borsa di dottorato.Per una descrizione del problema medico e delMID fatta dal dott. Forni, responsabile del Centrodella Microcitemia e delle Anemie Congenite equalche immagine del MID vedere:http://mdwebtv.videoplaza.it/player.asp?idpal=6591.È stato presentato un poster dall’INFN alla PrimaConferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, or-ganizzata nel 2010 a Cernobbio dal Ministerodella Salute.
STRUTTURA: SEZIONE DI FIRENZETITOLO DEL PROGETTO: TEMART - TECNICHE AVANZATEPER LA CONOSCENZA MATERICA E LA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO STORICOARTISTICO
Si tratta di un progetto molto articolato. TemArtmira da una lato a mettere a disposizione di So-vrintendenze e altri Enti di tutela le grandi poten-zialità degli Enti di ricerca, tra cui l’INFN, nelleapplicazioni ai beni culturali; dall’altro intende tra-sferire alcune delle competenze createsi all’in-terno degli Enti di ricerca al mondo produttivo.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
83
dali Galliera;Partner: INFN; Associazione Ligure Talassemici,E.O. Ospedali Galliera;Ente resp. del progetto: INFN Sezione di Genova;Risorse della struttura impegnate nel progetto:Personale tecnico ed amministrativo.Strumentazione. Locali
•
•
•
Durata: 2009-2011. La collaborazione con gliospedali Galliera è attiva per tutto il 2012;Finanziamento alla struttura / finanziamentocomplessivo del progetto: 100 k€/500 k€;Ente finanziatore: Associazione Ligure Talas-semici, Fondazione CARIGE, INFN, E.O. Ospe-
•
•
•
Durata: febbraio 2010 – gennaio 2012;Finanziamento alla struttura/finanziamentocomplessivo del progetto: 343 k€/3.240 k€;Ente finanziatore: Regione Toscana (POR-FESR2007-2013);Partner: 13, di cui 5 pubblici (Università di Fi-renze e Siena, CNR, INFN, MIBAC [Opificio Pie-tre Dure]) e 8 privati (sia grandi che piccoleimprese toscane);Ente resp. del progetto: CNR-IFAC [Istituto diFisica Applicata “Nello Carrara”];Risorse della struttura impegnate nel progetto:Laboratorio LABEC; Note (ricadute sulla società, rapporti con l’In-dustria, trasferimento tecnologico, ecc.):
•
•
•
•
•
•
•
Durata: 1/11/2010 – 31/10/2013;Finanziamento alla struttura/finanziamentocomplessivo del progetto: 450k€/589k€;Ente finanziatore: Regione Toscana - PORCREO FSE 2007-2013;Partner: INFN; “Scienzia Machinale s.r.l” (sedein Navacchio, Comune di Cascina - Pisa);Ente resp. del progetto: INFN Sezione di Pisa;Risorse della struttura impegnate nel progetto:1 tecnologo, 2 tecnici, 3 borsisti, disponibilitàdi laboratori del servizio di Alte Tecnologie,supporto amministrativo.
•
•
•
•
•
•
20 borse regionali (per giovani residenti in A -bruz zo) di formazione per:
- 7 annualità Diplomati (6 temi)- 15 annualità Laureati (14 temi)
2 Assegni di Ricerca regionali (per giovani re-sidenti in Abruzzo) di durata biennale.
•
•
Assegno di Ricerca nell'ambito della RicercaTecnologica, durata biennale con tema "Rea-lizzazione di uno Science Center: percorsi di-dattici e comunicativi" La Comunicazioneisti tuzionale per un Ente di Ricerca: realizza-zione di uno Science Center è una attività di ri-cerca che gode di particolare vivacità grazieall'elevata internazionalità dell'utenza scienti-fica dei Laboratori ed anche al contributo dialtri partner istituzionali. Conclusione percorsoformativo: luglio 2013; Assegno di Ricerca nell'ambito della RicercaScientifica, durata annuale. Tema: Studio deglieventi di interazione di neutrini del fascio diCNGS in OPERA" Conclusione percorso forma-tivo: giugno 2012; Follow up e valutazione finale Progetto com-plessivo "Gran Sasso in rete": come previstodal Protocollo di Intesa stipulato in data 20 no-vembre 2008 si procederà a una valutazionedegli esiti degli interventi realizzati che con-senta di definire modelli di intervento e stru-menti operativi tesi a diffondere con continuitàla cultura tecnico-scientifica. A questa azionefarà seguito la valutazione finale congiunta diimpatto del Progetto.
•
•
•

PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
86
L’intervento b) ”Formazione online per leaziende” reitera e perfeziona le precedenti espe-rienze del Progetto Speciale Multiasse “GranSasso in rete” (http://gransassoinrete.lngs.infn.it/)che ha consentito all’INFN-LNGS di elaborare esperimentare un modello di formazione in moda-lità e-learning per l’alta formazione di imprendi-tori, dirigenti e tecnici di imprese abruzzesi. Incollaborazione con il Consortium GARR (per gliaspetti tecnologici di piattaforma) saranno realiz-zati ed erogati:
4 corsi in modalità blended:
L’intervento c)”Innovazione Tecnologica” si pre-figge l’obiettivo di sviluppare interventi formativiper l’acquisizione di peculiari competenze tecnico-specialistiche nel settore della prototipizzazionerapida mediante Stereolitografia. Si prevede:
L’intervento d)”Lab_GS_Orienta” trova fonda-mento nella lunga esperienza dei LNGS nelladiffusione della cultura scientifica, indirizzataprevalentemente a studenti provenienti da scuoledi ogni ordine e grado. Iniziative rivolte adallievi abruzzesi:
L’intervento e)”Centro di fisica astro particellare”prevede, la realizzazione di percorsi di Alta For-mazione (Assegni di ricerca, borsa di dottorato eminiborse) e di aggiornamento a contenuto se-minariale presso il Centro di Eccellenza formativaed informativa nel campo della Fisica Astroparti-cellare (C.F.A.). Nodi della rete: Laboratori Nazio-nali del Gran Sasso quale capofila, Universitàdell’Aquila, Università di Roma Tor Vergata, Se-zioni INFN di Bari, Ferrara, Roma e Torino, INAFOsservatorio Astrofisico di Arcetri.
L’intervento f) “Attività divulgative ad elevatocontenuto scientifico-culturale” contribuisce allarealizzazione della nona edizione della ScuolaEstiva Gran Sasso – South Dakota – Princeton per20 studenti del IV anno delle scuole superioriabruzzesi.
STRUTTURA: LABORATORI NAZIONALI DEL SUDTITOLO DEL PROGETTO: APPLICAZIONI BIOMEDICHE DIFASCI DI PROTONI
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANOPROGRAMMATICODIATTIV
ITÀSCIEN
TIFICA
85
Durata: triennio 2008 - 2011 prorogata peril triennio 2011-2013;Finanziamento alla struttura/finanziamentocomplessivo del progetto: circa 50.000 Eu -ro/anno in media per l’INFN;Ente/i finanziatore/i: AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA POLICLINICO “GASPARE RO-DOLICO” DI CATANIA;Partner: INFN, Azienda Policlinico GaspareRodolico, UNICT, Centro Siciliano di Fisica Nu-cleare e Struttura della Materia;Ente resp. del progetto: LNS + Azienda Ospe-
daliera Gaspare Rodolico;Risorse della struttura impegnate nel pro-getto : circa 25 BTU/anno di fascio di protonidel CS (1 BTU = 8 ore);Altre informazioni significative (ricadute sullasocietà, rapporti con l’Industria, trasferimentotecnologico, ecc.): pazienti trattati finora conun follow up positivo intorno al 90%. In as-senza di questa convenzione sarebbero an-dati all’estero, in altri centri di trattamento,con ovvio e pesante aggravio della spesa daparte del sistema sanitario.
“Scuola estiva” per 25 allievi del terzo annodella scuola secondaria superiore;Attività di formazione ed aggiornamento perInsegnanti; Attività presso il Museo della Fisica e dell’Astro-fisica di Teramo, "Galileium".
“Incontri con la Scienza” (previsti circa 20 in-contri per max 24 studenti/giorno);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AcademicTraining effettuati da eminenti per-sonalità scientifiche;2 corsi per allievi di corsi Dottorato delle Uni-versità della rete CFA; 2 Assegni di Ricerca biennali (di cui 1 riservatoai residenti della Regione Abruzzo);Contributo per una borsa di Dottorato pressol’Università degli Studi dell’Aquila;“mini-borse” per brevi periodi di formazionee training;Seminari per promozione della cultura scien-tifica.
•
•
•
•
•
•
Acquisizione in leasing di una macchina distereolitografia (SLA) ad elevata precisione(oggetto delle attività di formazione);3 Borse di studio (per giovani residenti inAbruzzo) di cui 2 per diplomati ed 1 borsa distudio per un neo-laureato della durata di12 mesi;Formazione rivolta a 10 tecnici di aziendeabruzzesi dei settori automotive, aerospazio,industria alimentare, industria biomedica edeventualmente altre.
•
•
•
Applicazioni di metodi avanzati di spettrome-tria gamma ad alta risoluzione in campo me-dico, farmacologico, alimentare e ambientale;Progettazione, realizzazione e gestione di unarete aziendale wirelessdi cui 2 corsi in II edizione:- Affidabilità dei servizi informatici aziendali - Applicazione delle macchine Stirling nei pro-cessi con fonti rinnovabili
di cui 2 corsi in autoapprendimento:- E-tutor: le competenze per la formazione on-line
- Utilizzo dei sistemi SCADA per il controllo delterritorio
•
•

4. I LABORATORI NAZIONALI, IL CNAFE LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA
I LABORATORI NAZIONALI, IL CNAF E LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA

principali risultati scientifici conseguiti nel2011Il complesso degli acceleratori di DAFNE ed il la-boratorio SPARC-LAB rappresentano le infra-strutture intorno alle quali si svolge gran partedelle attività sperimentali nel campo della fisicadelle particelle, della fisica nucleare ed in nume-rosi ambiti multidisciplinari ed applicativi. Lo shut-down previsto su DAFNE nel 2011 perinstallare la nuova regione di interazione diKLOE-2 è stato prolungato per consentire inter-venti di riparazione e di manutenzione in diverseparti dell’acceleratore, in particolare sul sistemadi iniezione; inoltre sono stati effettuati degli in-terventi sui magneti di DAFNE al fine di ridurreed ottimizzare il consumo energetico.Il commissioning di DAFNE iniziato in novembre
ha mostrato un rapido aumento della luminositàdi picco con valori confrontabili con i miglior va-lori ottenuti durante il run di KLOE-1. Le collisioni sono state ottimizzate correggendol’accoppiamento di betatrone e minimizzandole dimensioni convolute dei fasci collidenti alpunto d’interazione e caratterizzate misurandola luminosità specifica.Il miglior accoppiamento misurato in singolo fa-scio, a corrente intermedia con 60 pacchetti diparticelle, è pari al 0.14%, valore da confrontarecon il miglior valore ottenuto durante il passatorun di KLOE quando il minimo accoppiamentoera nell’intervallo 0.2 ÷ 0.3 % .Le minime dimensioni dei fasci collidenti nelpiano trasverso verticale sono σy = 3 μm, valoreinferiore al minimo misurato durante il run de-dicato all’esperimento SIDDHARTA.La luminosità specifica misurata a bassa cor-rente, definita come la luminosità di singolopacchetto normalizata per la corrente dei pac-chetti collidenti, è pari a 4.5 1028 cm-2 s-1 . Que-sto valore è quattro volte più alto di quellomisurato durante l’ultimo run di KLOE(2004÷2006) ed è comparabile con il miglior ri-sultato ottenuto durante la presa dati dell’espe-rimento SIDDHARTA..I valori della luminosità specifica e di σy sono en-trambi confrontabili con quelli misurati durantei test sul Crab-Waist senza il solenoide di KLOEe successivamente ad un lungo periodo di otti-mizzazione. Il commissioning sta continuandoper consolidare i risultati ottenuti e per miglio-rare la luminosità ad alte correnti.Parallelamente alle attività di DAFNE si è svoltauna intensa sperimentazione con le tre linee diluce di sincrotrone attive (vedi fig. 4.1). Tutte leproposte di esperimento pervenute tramite ilprogetto europeo E.Li.S.A. (European LightSources Activities- Novembre 2009/Agosto2011), a causa dell’ upgrade di DAFNE iniziatoa fine 2009, sono state soddisfatte nel periodogennaio- aprile 2011 con circa 600 ore di tempomacchina. La linea che ha fornito i maggiori risultati scien-tifici è stata quella di radiazione IR nota comeSINBAD-IR. Tra i risultati più significativi si pos-sono citare quelli riguardanti la caratterizzazionedel tipo di collagene presente nella matrice ex-tracellulare delle cellule endoteliali che si tro-vano nelle immediate vicinanze dei capillarisanguigni dei tumori gliali (o gliomi). Questotipo di studio riveste un ruolo fondamentalenella comprensione delle correlazioni tra lo svi-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ L’ISTITUTO
NAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
90
Fig.4.1: Complesso degli acceleratori DAFNE e dei laboratori di luce disincrotrone.
Fig. 4.2: Sala sperimentale dell’acceleratore SPARC. Sono visibili, inprimo piano, gli ondulatori.
4.1 I LABORATORI NAZIONALI:LNF, LNGS, LNL, LNS
In questo paragrafo saranno descritte le attivitàe le prospettive dei quattro Laboratori Nazionali:
LNF: Laboratori Nazionali di FrascatiLNGS: Laboratori Nazionali del Gran SassoLNL: Laboratori Nazionali di LegnaroLNS: Laboratori Nazionali del Sud
I Laboratori Nazionali di Frascati (LNF)Il Laboratorio (sito web: http://www.lnf.infn.it/)
Nei Laboratori Nazionali di Frascati lavoranocirca 400 persone, divise nella Divisione Ricerca,la Divisione Acceleratori, la Divisione Tecnica el’Amministrazione.La caratteristica principale dei Laboratori Nazio-nali di Frascati è quella di saper costruire acce-leratori di particelle. Attualmente sono infunzione a Frascati due acceleratori, DAFNE (fi-gura 4.1), un acceleratore materia-antimateriacon elettroni e positroni, che detiene il recordmondiale di Luminosità a bassa energia e l’ac-celeratore lineare SPARC (figura 4.2), usato perprodurre luce LASER con elettroni oscillanti incampo magnetico, detto FEL (Free ElectronLASER). I LNF sono tra i quattro laboratori nel mondoche hanno realizzato la luce LASER con questatecnica e gli unici nel mondo ad avere un anellodi accumulazione elettroni-positroni con alta lu-minosità. Le competenze tecniche e scientifichedella Divisione Acceleratori e della Divisione Tec-nica, che contano oggi circa 120 dipendenti,sono uniche in Italia, e rare in Europa: una verae propria ricchezza dell’INFN messa al serviziodella società.In questo momento, infatti, la Divisione Accele-ratori e la Divisione Tecnica, oltre a fare ricercascientifica di base, sono state impegnate nellacostruzione ed attualmente nella messa a puntodi un acceleratore di protoni e ioni carbonio perla terapia medica al Centro Nazionale per laAdroterapia Oncologica (CNAO) in un nuovoospedale a Pavia ed hanno completato il dise-gno costruttivo di un LASER ad elettroni liberiper raggi X (SPARX), utilizzabile per studi distruttura della materia, biologia, scienze dei ma-teriali ecc, nell’area di ricerca romana e nel cam-pus dell’Università di Tor Vergata. La Divisione Ricerca, con i suoi circa 200 ricer-catori, ingegneri e tecnici, è impegnata in atti-
vità di ricerca a Frascati e in collaborazioni inter-nazionali, con programmi sperimentali in corsoal CERN di Ginevra con particolare presenzasugli esperimenti a LHC, nel laboratorio Nazio-nale Americano “FERMI” (FNAL) a Chicago, neiLaboratori di SLAC a Stanford, in California, alJefferson National Laboratory (JLAB) in Virginia,all’European Syncrotron Radiation Facility (ESFR)a Grenoble oltre che nei laboratori italiani di Le-gnaro, del Gran Sasso e del Sud, a Catania.La stretta collaborazione con gli altri centri di ri-cerca porta ad un confronto continuo dei ricer-catori e dei tecnici con i loro colleghi, confrontoche è necessario ed è alla base del manteni-mento dell’elevata qualità della ricerca in Italia.La ricchezza culturale che ne deriva ha permessodi far crescere attività complementari alla ricercain fisica delle particelle: tra queste, l’uso dellaluce di sincrotrone emessa dagli elettroni diDAFNE, l’uso dei fasci di elettroni, di positroni edi fotoni, estratti dall’iniettore di DAFNE, la ri-cerca in scienza dei materiali, le applicazioni me-diche e spaziali, lo sviluppo di nuovi rivelatori, letecniche di elaborazione dell’immagine, lo svi-luppo di ottiche di raggi X, la dosimetria delleradiazioni ed il controllo ambientale, la gestionedi reti informatiche, la costruzione di centri dicalcolo avanzato, la fisica teorica. Una nuova sala sperimentale, dedicata allo stu-dio dell’accelerazione di particelle cariche cononde di plasma generate in un gas rarefatto daun impulso di luce LASER infrarosso molto in-tenso, è entrata in funzione nei LNF.Si tratta di una nuova tecnica che ha anche in-teressanti applicazioni come la generazione diimpulsi di raggi X molto intensi e, quindi, po-tenziali applicazioni mediche. La presenza di una grande officina meccanica,di un Servizio di Elettronica, di un potente e mo-derno Centro di Calcolo, di un Servizio di FisicaSanitaria, anch’esso unico nell’INFN, grandi areesperimentali con annessi laboratori in ambientedi pulizia controllata, ma soprattutto il suo per-sonale, abituato alla realizzazione di grandi pro-getti, fanno dei Laboratori Nazionali di Frascatiuna risorsa disponibile per altri laboratori, na-zionali ed esteri, e dalle Università. La presenza di un programma di ricerca scienti-fica e tecnologica di alta qualità tiene insiemequesti scienziati e tecnici, permettendo al labo-ratorio di crescere culturalmente, di attirare eaddestrare le nuove generazioni alla ricerca.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ L’ISTITUTO
NAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
89

a punto del laser in grado ora di produrre im-pulsi corti (<30 fs) con potenze di oltre 200 TW.Si è completata anche la costruzione della lineadi trasporto del fascio laser di potenza fino allasala sperimentale di SPARC dove sarà possibilefar collidere fasci intensi di fotoni con fasci adalta brillanza di elettroni e produrre radiazioneX mediante backscattering Thomson. Sul piano dello sviluppo tecnologico è stato con-dotto con successo il primo test di potenza suun prototipo delle nuove strutture acceleranti inbanda C (6 GHz) progettate a LNF e realizzatein collaborazione con l’industria italiana nell’am-bito del progetto SPARX. Il prototipo è stato pro-vato a KEK, dove era disponibile la stazione dimisura, e, alimentato con oltre 70 MW di po-tenza incidente, ha sostenuto un campo di circa50 MV/m senza RF breakdown. È stato ancheprogettato ed è in corso di realizzazione il nuovogun in banda S per SPARC/SPARX. Significativirisultati sono stati anche ottenuti con le strut-ture in banda X (12 GHZ) realizzate a LNF e pro-vate ad alta potenza a SLAC, ottenendo campiacceleranti comparabili con lo stato dell’arte inbanda X: 100 MV/m. Ulteriori studi sono in corsosu metodi di brasatura alternativi finalizzati adaumentare i gradienti del campo accelerante nelquadro della collaborazione INFN/SLAC/KEK.Inoltre è stata completata la costruzione a LNFdi un RF gun compatto di nuova concezione,combinazione di configurazione RF ad onda sta-zionaria e viaggiante, in collaborazione conUCLA e La Sapienza, per applicazioni medicali.
La Collaborazione KLOE ha implementato il ri-velatore installando 2 coppie di rivelatori (LETLow Energy Tagger e HET High Energy Tagger)per rivelare i leptoni associati ai processi γ−γ.Inoltre ha finalizzato nel 2011 numerose analisitra le più significative ricordiamo:
Nel 2011 la collaborazione SIDDHARTA ha fina-lizzato l'analisi dati per la misura dell'idrogenokaonico, ottenendo i migliori valori al mondo perlo spostamento e l'allargamento del livello fon-damentale, 1s, dovuti all'interazione forte. I risul-tati pubblicati hanno goduto di una notevoleattenzione dalla parte della comunità scientifica.Ne sono la prova sia l'articolo su questa misurasul CERN Courier:(http://cerncourier.com/cws/article/cern/47489),che gli articoli pubblicati da vari gruppi teoriciche lavorano nel campo della QCD a bassa ener-gia. Sempre nel 2011 sono stati pubblicati i ri-sultati sull'elio 3 kaonico. Per la prima volta almondo lo spostamento del livello 2p, generatodell'interazione forte, è stato ottenuto con unerrore di pochi eV. Tale misura è fondamentaleper capire la dinamica dell'interazione forte insistemi con più nucleoni e la possibile forma-zione di stati del tipo nuclei kaonici fortementelegati. Da sottolineare il fatto che la misura del-l'elio 3 kaonico, per cui a JPARC è stata presen-tata una proposta di esperimento dedicato, èstata realizzata a DAFNE in soli tre giorni di presadati. Dopo un’attività di R&D di alcuni anni, nel2011 è entrato in funzione a LNF un nuovo la-boratorio, lo SCF_LAB, che esegue la caratteriz-zazione in condizioni spaziali realistiche diretroriflettori laser usati per il tracciamento diprecisione dei satelliti e della Luna (tramite la mi-sura del tempo di volo d’impulsi laser corti).Questo laboratorio consiste di una camera pulitadedicata e prende il nome dalla “Satellite/lunarlaser ranging Characterization Facility” (SCF). LaSCF è unica al mondo ed è usata da progettiINFN in collaborazione con la NASA per il testdella relatività generale con l’orbita lunare (espe-rimento MoonLIGHT), e da ASI ed ESA per mi-gliorare fino al mm il posizionamento dellacostellazione di navigazione satellitare Europea,Galileo (progetto ETRUSCO-2). Lo SCF_LAB haprodotto pubblicazioni innovative sui seguentiargomenti: a) nuovo standard industriale per iltest spaziale dei retroriflettori laser b) test di re-troriflettori installati sui primi due satelliti di Ga-lileo lanciati il 21 Ottobre 2011; c) test delretroriflettore di nuova generazione, Moon-LIGHT, sviluppato da University of Maryland(USA) e LNF.Dal 2010 si è sviluppato un nuovo laboratorio
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
92
•
•
•
•
La misura di precisione della vita media delKS;L’ulteriore determinazione con un metodo al-ternativo del contributo adronico al g-2 delmuone. Il nuovo risultato è in perfetto ac-cordo con i precedenti e conferma la discre-panza a più di 3 sigma tra il valore misurato(da BNL) del g-2 muonico con quello calco-lato nell'ambito dello SM usando il risultatodi KLOE come input;Prima osservazione del decadimento raro del-l'eta in 2e+2e-;Limite sull'esistenza di un bosone vettore non
SM previsto da alcune teorie recenti sulladark matter (il cosiddetto “dark photon”) nelrange di massa 200-500 MeV.
luppo di cellule endoteliali vascolari e l’angioge-nesi nei gliomi maligni.Sempre nel 2011 è stata completata la realizza-zione di una camera pulita dedicata al tratta-mento dei campioni biologici, da caratterizzareutilizzando la radiazione di sincrotrone, in cuisono stati installati sistemi criogenici per la con-servazione delle cellule, microscopi ottici ed unmicrotomo. L’utilizzo di questo laboratorio per icampioni biologici e dell’alto flusso di radiazioneIR prodotto da DAFNE, pemetterà la realizzazionedi misure di imaging su cellule “in vivo” che rap-presenta uno dei goal primari per gli studi di in-teresse biologico. È stato inoltre quasi completatol’upgrade della linea UV e la costruzione delledue nuove linee XUV di radiazione di sincrotroneil cui commissioning è previsto nel 2012.La Beam Test Facility di DAFNE, pur essendoprincipalmente dedicata a test e calibrazioni dirivelatori, per le sue caratteristiche di fascio intermini di range in energia e di intensità rappre-senta una facility unica per alcuni specifici espe-rimenti rivolti allo studio dell’interazioneelettromagnetica con la materia. Durante gli ul-timi due anni ha ospitato collaborazioni da tuttaEuropa interessate a misure di channeling e diinterazioni di elettroni/positroni in cristalli. Taliesperimenti utilizzano infatti fasci di alta inten-sità (1010 particelle/s) con piccole dimensioni edivergenze angolari, la versatilità della BTF con-sente di soddisfare le esigenze di diversi utenti. Sono proseguiti gli esperimenti con il Laser adElettroni Liberi (FEL) di SPARC che già aveva di-mostrato di aver raggiunto la saturazione a 500nm in regime di emissione spontanea autoam-plificata (SASE) nel 2009 e di amplificazione disegnale esterno (Seeded) nel 2010. Particolar-mente significativa nel 2011 è stata la dimostra-zione del regime di Singola Spike, investigatoper la prima volta a SPARC, (Fig. 4.3). Infatti lapossibilità di produrre pacchetti di elettroni corti,con la tecnica originale del Velocity Bunching(2010), unita alla possibilità di variare spazial-mente l’intensità del campo magnetico dell’on-dulatore (Tapering), ha permesso di produrrepacchetti di radiazione coerente con un’am-piezza spettrale ridotta rispetto al regime SASE.Solo una Spike dello spettro caotico del regimeSASE è stata infatti cosi’ amplificata. La stabilitàe l’alta brillanza raggiunta dal fascio di elettronihanno inoltre permesso di osservare la genera-zione di armoniche fino a 45 nm. Sono iniziatianche test preliminari riguardanti schemi FEL più“esotici”, quali la Cascata Superradiante, che
verranno ulteriormente approfonditi nel corsodel 2012. Gli studi sulla dinamica dei fasci adalta brillanza prodotti dall’iniettore di SPARChanno portato ad un ulteriore contributo inno-vativo. Sono stati infatti prodotti treni di 2 e 4pacchetti di elettroni corti (<200 fs) con distanzavariabile fino ad 1 ps, mediante una tecnica ori-ginale denominata Laser Comb, (Fig. 4.4). Contale struttura temporale è stato possibile pro-durre per la prima volta 2 impulsi di radiazioneFEL ad alta ripetizione e generare radiazione THza banda stretta. Ulteriori applicazioni sono pre-viste nel 2013 quali l’eccitazione risonante diun’onda di plasma per l’accelerazione ad altogradiente.
Nella sala sperimentale per l’accelerazione dielettroni con il laser di potenza FLAME sono giàstati ottenuti elettroni fino a 100 MeV in 4 mmdi lunghezza accelerante con un plasma in re-gime di auto iniezione eccitato dal laser. Nel2012 si punterà ad ottenere energie dell’ordinedel GeV. Questo ambizioso obiettivo è reso pos-sibile dal completamento nel 2011 della messa
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ L’ISTITUTO
NAZIO
NALEDIFISIC
ANUCLEA
RE: STA
TOEPROSPETTIV
E
91 Fig. 4.3 - Tipica misura dello spettro FEL in regime di Singola Spike (a)e confronto con le simulazioni (b).
Fig. 4.4 – Immagine del treno di impulsi prodotto con la tecnica LaserComb. Sono visibili 4 impulsi da 200 pC in 200 fs di lunghezza rms, se-parati da 1 ps.

zione di una nuova sala attrezzata dedicata allelinee per gli utenti delle sorgenti di radiazionedi SPARC_LAB ampliando lo spazio attualmentedisponibile nel bunker.Per quanto riguarda l’attività di sviluppo tecno-logico di cavità in banda X si continueranno lemisure di resistività a RF del film di molibdenodepositato su campioni; si continueranno leprove dell’Electron Beam Welding; la realizza-zione di una sezione ad onda stazionaria rive-stita con Molibdeno e la realizzazione dellasezione di tipo ‘triple-choke cavity’. Nel 2013 verrà completata l’installazione dellelinee dedicate agli esperimenti di accelerazionea plasma, con iniezione esterna di elettroni, pi-lotato dal laser FLAME o dal treno di impulsi dielettroni Comb. L’obiettivo del 2014 sarà quellodi dimostrare non solo l’alto gradiente ottenibilein queste configurazioni ma anche la capacitàdi preservare l’alta qualità dei fasci accelerati aduso dei futuri Linear Colliders o Sorgenti di Ra-diazione Compatte.Inoltre la successiva realizzazione di una sorgentedi radiazione FEL a corta lunghezza d’onda in-novativa (V generazione), pilotata da un accele-razione a plasma, potrà essere il contributod’eccellenza del programma di SPARC_LABnell’ambito del quadro internazionale.Nel periodo 2012-2014 la collaborazione SID-DHARTA-2 lavorerà all'upgrade dell'apparatosperimentale per la prima misura al mondo deldeuterio kaonico. Un nuovo sistema di veto,nuova criogenia e shielding verranno eseguitiper migliorare di un fattore circa 20 il rapportosegnale fondo. La collaborazione SIDDHARTA-2è impegnata nella costruzione, test e assem-blaggio del nuovo setup, con l'obiettivo di rea-lizzare entro il 2014 la misura delle transizioni Xdel deuterio kaonico. SIDDHARTA-2 prevedenella sua campagna di misure anche altre misuredi atomi esotici.Continueranno le attività di luce di sincrotronee l’uso dei fasci estratti dall’iniettore di DAFNE,elettroni, positroni e fotoni, secondo le richiestedegli utenti esterni. Queste attività “di servizio”sono importanti perché mettono a disposizione,dei ricercatori italiani e stranieri, sorgenti di par-ticelle che esistono solo in pochissimi laboratorinel mondo e, per alcuni aspetti, solo a Frascati. Dal 2012 lo SCF_LAB si arricchirà di una se-conda facility, la SCF-G, ottimizzata per il test diretroriflettori laser delle costellazioni mondiali dinavigazione satellitare (GPS-3/USA, Galileo/EU,GLONASS/Russia, COMPASS/Cina, IRNSS/India,
QZSS/Giappone) .Il laboratorio X Lab Frascati prevede lo sviluppodi una nuova tecnica di imaging applicata allasorgente Thomson di SPARC_LAB, lo studio diuna tecnica innovativa per applicazione dei ca-pillari alla accelerazione laser di plasma ed inol-tre l’ applicazione di ottica di raggi X e neutronitermici in nanostrutture.L’antenna gravitazionale “NAUTILUS” conti-nuerà il suo funzionamento nei prossimi anni.Infine l’attività legata al progetto SuperB (vediparagrafi... ) permetterà ai LNF di mantenereuna leadership mondiale nel campo degli acce-leratori di particelle di alta energia e di alta in-tensità.
MILESTONE del periodo 2012-2014
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
94
Completamento del commisioning diDAFNE per l’aumento di luminosità richie-sta per l’esperimento KLOE;Installazione calorimetri e tracciatori perupgrade esperimento KLOE;Completamento presa dati dell’esperi-mento KLOE per raggiungere la lumino-sità di progetto;Studio di fattibilità per ulteriori misure diprecisione di atomi kaonici e della fisica dibassa energia kaone-nucleo per SID-DHARTA2;Completamento realizzazione parti espe-rimento NA62;Presa dati esperimenti all’LHC e partecipa-zione ad analisi;Completamento presa dati esperimentoOpera e partecipazione ad analisi;Completamento del progetto ETRUSCO-2e della qualifica dei retroriflettori laser diGalileo nell’ambito del SCF_LAB;Completamento dello sviluppo e qualificadel retroriflettore lunare Italo-Americanodi nuova generazione nell’ambito diSCF_LAB;Avvio della fase preparatoria per la realiz-zazione del progetto SuperB;Operazione con il laser FLAME alla mas-sima potenza ed ottimizzazione della qua-lità degli elettroni accelerati in regime diauto-iniezione (2012); Sperimentazione di nuove tecniche di dia-gnostica della coerenza della radiazioneFEL mediante speckle e di misure di impulsidi radiazione ultracorti (2012);Sperimentazione di nuovi schemi per laproduzione di radiazione a corta lun-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
di ottica di raggi X, lo X LabFrascati, (policapil-lary optics e compound refrective optics) dedi-cato alla ricerca di base di diverse nuove otticheed alle loro possibili applicazioni in campo multi-disciplinare. Sono stati implementati diversi appa-rati sperimentali per lo studio della fluorescenzadi raggi X, e diverse soluzione per nuovi rivelatoria raggi X basati su combinazioni ottica-GEM, ot-tica-LiF. Inoltre sono state proposte e realizzate di-verse nuove tecniche di microscopia con altogrado di contrasto per lo studio di reazioni biolo-giche veloci.Nel 2011 è stata realizzata una stazione pereffettuare micro-tomografie su campioni bio-logici utilizzando la combinazione di tubi araggi X con ottica dedicata; questa è una tec-nica innovativa e alternativa alla sperimenta-zione con luce di sincrotrone. Il vantaggio ditale tecnica consiste nella semplicità di appli-cazione, nella rapidità, risultando inoltremeno invasiva rispetto alle tomografie con-venzionali. Nella figura 4.5 è mostrata una mi-crotomografia computerizzata di una parte diformica realizzata con tale tecnica in circaventi minuti. Parallelamente è stato imple-mentato lo studio della teoria di channelingdi X-ray e neutroni termici in diverse micro- enano-strutture.
Attività nei prossimi tre anniNei prossimi tre anni continuerà la sperimenta-zione a DAFNE con l’esperimento KLOE2. La col-laborazione KLOE2 prenderà dati nell’ attualeconfigurazione fino alla seconda metà 2012quando saranno installati i nuovi rivelatori di ver-tice e la nuova calorimetria in avanti con l’obiet-tivo di raccogliere un campione di eventi tra le5 e le 10 volte più copioso di quello ottenuto inprecedenza. L'uso dei nuovi detector, inoltre, èvolto a migliorare le prestazioni del rivelatore, inparticolare per quegli eventi di "interferometriaquantistica" che rappresentano la peculiaritàdella fisica a DAFNE.All’inizio del 2012 è stato avviato il laboratorioSPARC_LAB (Sources for Plasma Accelerators andRadiation Compton with Lasers and Beams), natodalla fusione delle infrastrutture già operative diSPARC e FLAME, allo scopo di coordinare ed ar-monizzare le attività in corso con i fasci di elet-troni e fotoni di alta intensità e potenzialmentein continua evoluzione, Fig. 4.6. Sarà un labora-torio interdisciplinare dedicato allo studio dinuove tecniche di accelerazione di particelle (elet-troni, protoni, ioni) ed allo sviluppo ed applica-zione di sorgenti di radiazione avanzate (FEL, THz,Compton-Thomson), in perfetta armonia con iprogrammi europei ELI ed EUROFEL.
Il primo obiettivo da raggiungere sarà la messain funzione della sorgente Thomson, prima sor-gente europea dedicata di raggi X monocroma-tici da Thomson back-scattering, che avrà unprogramma per gli utenti dedicato ad applica-zioni di imaging radiologico avanzato (mammo-grafia, lung CT, etc). Il completamento dellalinea di trasporto degli elettroni è previsto entrola Primavera 2012. I fasci di elettroni e fotoni sa-ranno inoltre sincronizzati sulla scala delle de-cine di fs con un sistema pilotato da un OpticalMaster Oscillator in corso di implementazione.Il programma futuro prevede anche la realizza-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
93
Fig.4.5 Microtomografia computerizzata realizzata a X Lab Frascati.
Fig. 4.6 - Schema delle linee sperimentali di SPARC_LAB

presente nella roccia di tipo calcareo che costi-tuisce la montagna.L’assorbimento della radiazione cosmica dovutoalla copertura di roccia, le grandi dimensioni ele notevoli infrastrutture di base ne fanno unluogo unico al mondo per la rivelazione di se-gnali deboli o rari, d’interesse per la fisica astro-particellare, subnucleare e nucleare.All’esterno, in prossimità dell’uscita di Assergidell’autostrada A24, su un’area di 9,5 ettari al-l’interno di un Parco Nazionale di eccezionalevalore ambientale e naturalistico alle pendici delGran Sasso, sono situati i laboratori di chimica,elettronica, progettazione meccanica e officine,il Centro di Calcolo, la Direzione del Laboratorioe gli uffici.Il successo internazionale dei LNGS e l’indiscussoprimato nel panorama mondiale dei Laboratorisotterranei destinati alla fisica astroparticellare,sono testimoniati oltre che dalle numerose pub-blicazioni, dalla vasta comunità scientifica inter-nazionale costituita da circa 950 scienziati chepartecipa alle attività di ricerca che si svolgono nellaboratorio. Circa il 60% di loro sono stranieriprovenienti da ventinove paesi diversi in Europa,Stati Uniti e Asia, il rimanente 40% sono italianiappartenenti alle varie sedi dell’INFN e alle prin-cipali Università. Al momento gli esperimenti deiLaboratori sono 21 in diverse fasi di realizza-zione, gestiti in stragrande maggioranza da Col-laborazioni internazionali mediante organi diautogoverno scientifico e di gestione delle ri-sorse, regolati nell’ambito di Memorandum ofUnderstanding sottoscritti da tutti gli Istituti fi-nanziatori. Gli esperimenti dedicati alla fisicadella terra o alle scienze ambientali o alla biolo-gia vengono svolti anche in collaborazione conaltri Istituti di ricerca quali l’INGV o l’Istituto Su-periore di Sanità attraverso la stipula di specifi-che convenzioni.
Principali risultati scientifici ottenuti nel 2010Ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso si cercadi capire come è fatto l’ Universo attraverso lostudio dei messaggeri che esso ci invia e allostesso tempo si studiano le caratteristiche ultimedelle particelle elementari.Le linee di attivitàprincipali dei LNGS coprono la fisica del neu-trino, la ricerca di materia oscura e la fisica nu-cleare di interesse astro-particellare.Il progetto CNGS, iniziato nel 2006 e operativocon regolarità dal 2008, consiste di un fascio ar-tificiale di neutrini, tutti di tipo muonico, pro-dotto dall’acceleratore di protoni SPS del CERNe indirizzato verso i LNGS attraverso la crostaterrestre per una distanza di 732 km. Dentro iLaboratori del Gran Sasso, l’esperimento OPERAè specificatamente dedicato alla rivelazione deineutrini del CNGS. L’ apparato con i suoi cen-tocinquantamila “mattoni” costituiti da strati dipiombo e speciali emulsioni nucleari, può esseredefinito un’enorme macchina fotografica ingrado di registrare con straordinaria precisionespaziale l’avvenuta trasformazione di alcunineutrini dal tipo muonico al tipo tau (ντ ) du-rante il percorso dal CERN al Gran Sasso. La co-struzione e la gestione di questo complessoapparato hanno richiesto l’uso di avanzate tec-nologie sviluppate anche in collaborazione conle imprese italiane operanti nel campo della ro-botica, della meccanica di precisione, ottica edelettronica.OPERA, dopo aver pubblicato la prima evidenzaal mondo di rivelazione diretta dell’oscillazioneνμ→ντ , ha continuato a raccogliere dati per for-nire maggiore significanza statistica alla misura.Nel corso del 2011 ha registrato 4210 eventi dainterazioni di neutrino contenuti nell’apparato,corrispondenti a una luminosità integrata nel-l’anno di 4.79×1019 POT, che si aggiungono ai9349 raccolti negli scorsi anni. È proseguital’analisi e lo scanning degli eventi registrati nelleemulsioni sia ai LNGS che nei laboratori europeie giapponese.Nel corso del 2011 OPERA ha riportato la misuradi un’evidenza di neutrini superluminali. Tuttaviasuccessive accurate verifiche da parte dell’espe-rimento stesso hanno masso in luce l’evidenzadi due anomalie strumentali delle quali una (di-fettosa connessione di una fibra ottica) può ren-dere conto dei 60ns di anticipo nell’arrivo deineutrini al Gran Sasso. Inoltre gli esperimentiEWD e OPERA hanno persentato un risultatodella velocità dei muoni cosmici evidenziando lapossibile sorgente di errore nella precedente mi-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
96
Fig.4.9: Gallerie sotterranee dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS)Il Laboratorio (sito web: http://www.lngs.infn.it/)
I Laboratori (figura 4.7) del Gran Sasso (LNGS)dell’INFN sono un’infrastruttura di ricerca perla fisica astro-particellare unica al mondo inquanto a estensione, complessità e comple-tezza di impianti, La fisica astro-particellare,parola coniata per descrivere un campo di ri-cerca alla congiunzione tra la fisica delle par-ticelle elementari, l’astrofisica e la cosmologia,ha avuto un enorme sviluppo negli ultimi duedecenni: l’INFN con i Laboratori del Gran Sassonon solo ha anticipato questo sviluppo, macontinua ad avere un posto di primo piano nelpanorama mondiale.
Situate tra le città dell’Aquila e Teramo, a circa120 km da Roma, le strutture sotterranee delLaboratorio sono collocate su un lato del tunnelautostradale, lungo circa dieci chilometri, cheattraversa il Gran Sasso, direzione Roma, e con-sistono di tre grandi sale sperimentali, (ognunadelle quali misura circa 100 m di lunghezza, 20m di larghezza e 18 m di altezza) e tunnel di ser-vizio, per un volume totale di circa 180.000 m3
e una superficie di circa 18.000 m2. Le sale sonoservite dagli impianti tecnici e di sicurezza ne-cessari alle complesse attività sperimentali chevi si svolgono e garantiscono adeguate condi-zioni di lavoro al personale che vi opera.La facilità di accesso al Laboratorio dall’auto-strada consente il trasporto all’interno delle saledi parti di apparati pesanti e di grandi dimen-sioni, il continuo approvvigionamento di quantonecessario al funzionamento sia del Laboratoriosia degli esperimenti e un facile ricambio delpersonale operante al suo interno.
I 1400 m di roccia che sovrastano i Laboratoricostituiscono una copertura tale da ridurre ilflusso dei raggi cosmici di un fattore un milione;inoltre, il flusso di neutroni in galleria è un mi-gliaio di volte inferiore rispetto alla superficiegrazie alla minima percentuale di uranio e torio
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
95
ghezza d’onda, Cascata Superradiante(2012);Caratterizzazione di treni di impulsi di ra-diazione FEL mediante la tecnica del LaserComb (2012);Attività sperimentale con la sorgente THzcon esperimenti di pump and probe (2012-2013);Commissioning del nuovo sistema di Sin-cronizzazione (2012);Commissioning finale della linea Thomsone produzione radiazione X ed attivitàutenti (2012);Attività utenti linea Thomson (2012-2013);Accelerazione e caratterizzazione di fascidi protoni in plasmi generati da impulsilaser di potenza su bersaglio solido (2012-2013);Test con nuovo ondulatore a corto periodo(2013);Upgrade dell’energia di SPARC medianteinstallazione di nuove cavità acceleranti inbanda C ed installazione del nuovo RF gun(2013);Commissioning della linea per accelera-zione a plasma con iniezione esterna(2013);Prove ad alta potenza a SLAC delle sezioniad onda stazionaria in banda X di tipostandard e “triple-choke-cavity”. Realizza-zione del gun ibrido a 12 GHz per le provead alta potenza a SLAC (2013);Caratterizzazione di fasci di elettroni pro-dotti da acceleratore a plasma (2013-2014).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fig.4.7: Veduta dei Laboratori esterni del Gran Sasso.
Fig.4.8: layout dei laboratori sotterranei

isotopi chiamato “doppio decadimento betasenza neutrini”. Tale fenomeno nucleare è legatoall’esistenza di una massa dei neutrini e alla loronatura di particelle di Majorana (ovvero con par-ticella e antiparticella coincidenti). Il programma dei LNGS nel campo della ricercadei decadimenti 0ννββ si�sviluppa attraverso l’usodi differenti isotopi e di differenti tecniche di rive-lazione.L’esperimento GERDA usa cristalli di germanio ar-ricchiti con 76Ge, immersi in argon liquido e ulte-riormente schermati da acqua ultrapura. Nel 2011GERDA ha completato la fase di commissioningdell’apparato utilizzando prima cristalli di germa-nio naturale e successivamente anche tre cristalliarricchiti con 76Ge. Questo ha consentito di valu-tare in modo molto approfondito tutte le sorgentidel fondo per la misura nell’apparato, in partico-lare sono stati studiati tutti gli accorgimenti per ri-durre al minimo la linea a 1525 KeV da 42K (42Ar).I risultati preliminari ottenuti utilizzando i primigermani arricchiti hanno mostrato chiaramente ilsegnale prodotto dai decadimenti 2ννββ.�Alla�fine�del�2011 con l’immissione nell’appa-rato di 8 germani arricchiti (massa totale 17.7Kg) è iniziata ufficialmente la presa dati dellaprima fase dell’esperimento.In parallelo prosegue la preparazione di ulteriori26 rivelatori BEGe (20 Kg) che saranno utilizzatinella fase 2 del programma sperimentale del-l’esperimento.In parallelo prosegue la preparazione di ulteriori26 rivelatori BEGe (20 Kg) che saranno utilizzatinella fase 2 del programma sperimentale del-l’esperimento.L’esperimento CUORE si prefigge di rivelare i de-cadimenti 0ννββ nel �130Te e rappresenta il più re-cente e ambizioso sviluppo della tecnica dei“bolometri” di biossido di tellurio, sulla qualel’INFN detiene un’esperienza più che ventennale. L’esperimento attualmente in fase di costruzioneai LNGS, utilizzerà quasi mille cristalli (741 kg) diTeO2 con una abbondanza isotopica del 34.17%. Nel corso del 2011 la produzione dei cristallidi TeO2, presso lo Shanghai Institute of Ceramics,ha raggiunto circa l’80% del totale. Sono paral-lelamente proseguiti presso i LNGS i test a cam-pione della produzione, effettuati tramite testbolometrici che hanno confermato la conformitàdei cristalli prodotti alle specifiche contrattuali diradiopulizia. È proseguita la produzione delle partiin rame che compongono il rivelatore ed è iniziatapresso i Laboratori Nazionali di Legnaro la puliziadegli stessi pezzi tramite un processo a quattro
stadi (tumbling, electro-polishing, chemical et-ching e plasma cleaning).Ai LNGS è stata installata nella camera pulita lalinea di assemblaggio che permetterà di realiz-zare i rivelatori di CUORE in atmosfera inerte.Nella preparazione di CUORE-Ø, la prima delle19 torri dell’apparato, sono stati però riscontratialcuni problemi sui componenti di rame dovutiad una errata lavorazione meccanica ed a unaridotta rigidità del rame stesso, problemi chesono in via di soluzione. Sono stati completatigli schermi a 40 e 4 Kelvin del criostato diCUORE, mentre quello a 300 Kelvin è ancora infase di lavorazione.È stato testato con successo presso la LeidenCryogenics il refrigeratore a diluizione destinato araffreddare l'esperimento che ha dimostrato pre-stazioni anche superiori alle specifiche richieste.
È continuata nel 2011 nei LNGS l’attività di LUCI-FER, un programma di R&D che si prefigge di stu-diare le potenzialità di bolometri scintillanti diZnMoO4 come rivelatori di terza generazione perla ricerca di decadimenti 0ννββ del 100Mo.Gli studi hanno riguardato la capacità di discrimi-nazione dal fondo, la risoluzione energetica e unavalutazione del fondo aspettato in un futuro rive-latore.La collaborazione COBRA nel corso del 2011 hatrasferito i rivelatori in un laboratorio più grandeassegnato dai LNGS, dove può continuare le sueattività di Ricerca e Sviluppo in migliori condizionisperimentali.Lo studio della composizione dell’Universo è unodei temi più affascinanti della ricerca attuale. AiLNGS sono attualmente presenti diversi esperi-menti dedicati alla rivelazione diretta di candidatidi materia oscura, ciascuno dei quali usa tecnolo-gie diverse. La ricchezza di esperimenti competitiviconsente al Gran Sasso di essere un laboratorio as-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
98
Fig.4.11: Il sistema di criogenia dell’esperimento ICARUS per la rivela-zione dei neutrini, ai Laboratori del Gran Sasso.
sura della velocità dei neutrini di OPERA. Nelmaggio 2012 è prevista un’ulteriore e definitivamisura della velocità dei neutrini dal CERN daparte di ben quattro esperimenti ai Laboratoridel Gran Sasso: OPERA, ICARUS, LWD, BORE-XINE. Anche l’esperimento MINOS negli StatiUniti, dopo le necessarie migliorie si appresta aripetere la misura della velocità dei neutrini.L’altro esperimento dedicato al CNGS è ICARUS(figura 4.11), un innovativo apparato che con-siste di circa 600 tonnellate di Argon liquefatto,alla temperatura di –186 °C. in grado di combi-nare la spettacolare ricostruzione in 3D di qua-lunque interazione o spostamento di particellecariche all’interno del suo volume, con una ot-tima misura calorimetrica dell’ energia delle par-ticelle. ICARUS nel 2011 ha continuato adaccumulare eventi di interazione di neutrini delfascio CNGS ed ha mostrato i primi risultati sullaricostruzione degli eventi. Infine la Collabora-zione sta implementando e migliorando il triggerassociato all’apparato, allo scopo di poter esten-dere gli studi anche ad altri campi di interessedella fisica astroparticellare. La capacità di ope-rare in sotterranea un apparato così complessocostituisce inoltre un decisivo passo avanti versola costruzione di futuri esperimenti di migliaia ditonnellate di Argon liquido.L’esperienza e il Know-how acquisiti dai LNGSnella gestione degli apparati criogenici e in parti-colare a servizio del rivelatore ICARUS sono diven-tati materia di insegnamento in uno dei corsi die-learning erogati in modalità web 2.0, organiz-zati dai LNGS nell’ambito del POR Abruzzo, cheha visto una grande partecipazione di imprendi-tori locali interessati all’utilizzazione di tali tecno-logie anche in processi con fonti rinnovabili.
La rivelazione dei neutrini provenienti dal Sole èlo scopo principale dell’esperimento BOREXINO(figura 4.10) che misura in tempo reale le compo-nenti di bassa energia dello spettro solare. Ciò
consente al contempo di studiare le reazioni di fu-sione nucleare all’interno della stella a noi più vi-cina e lo studio delle proprietà dei neutrini. Grazie alla estrema radiopurezza del rivelatore (unvero record mondiale) Borexino si è rivelato un ap-parato sensibile anche ai geoneutrini prodotti neldecadimento di Uranio e Torio presenti all’internodella terra. Il loro studio ci consentirà di capirel’origine del calore prodotto dal nostro pianeta, lasua composizione e la sua origine. Osservatori digeoneutrini in diversi parti del globo potrebberosvelare i meccanismi che governano i moti con-vettivi di trasporto del calore all’interno della terrache sono alla base dei fenomeni vulcanici e deimovimenti tettonici. La misura ha suscitato anchel’interesse di una vasta comunità di geofisici.Nel corso del 2011 Borexino dopo aver eseguitouna campagna di ri-calibrazione del rivelatore, hapubblicato una misura di alta precisione (4.3% )del flusso dei neutrini monocromatici da 7Be mi-gliorando quindi quanto già misurato nel 2007 enel 2008. Ha inoltre dimostrato, con l’1% di pre-cisione, l’assenza di una asimmetria notte/giornodel flusso di neutrini da 7Be. Questi risultati hannoconsentito di confermare la soluzione LMA-MSWe di escludere definitivamente la soluzione LOW,nello spazio dei parametri che descrivono l’oscil-lazione dei neutrini, senza utilizzare i dati di KAM-LAND e quindi senza la necessità di assumere CPTnel settore dei neutrini. È da sottolineare inoltreche è la prima volta che nello stesso esperimentosi misura la probabilità di oscillazione dei neutrinisia nella regione dominata dall’effetto materia chenella zona di transizione e vicina alle oscillazioninel vuoto. Di estrema rilevanza infine è stata la misura, perla prima volta in questo campo, di neutrini solarinell’intervallo 1.0-1.5 MeV e quindi della primaevidenza di rivelazione diretta del flusso di neutrinipep. Assumendo per essi quanto previsto dal mo-dello solare standard, è stato inoltre possibileporre il limite superiore di 7.9 conteggi/(giorno x100ton) al 95% di C.L. al flusso di neutrini dalciclo CNO nel sole.Questi risultati sono stati ottenuti utilizzando unanuova tecnica di analisi per la discriminazione deisegnali dal fondo prodotto da 11C.L’esperimento LVD ha continuato la sua attività diosservatorio per eventi di supernova, facendoparte della rete mondiale SNEWS. L’apparato haanche rivelato i neutrini del CNGS.Ai LNGS infine lo studio delle proprietà del neu-trino avviene in esperimenti che si prefiggono dirivelare un raro processo di decadimento di alcuni
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
97
Fig. 4.10: L’esperimento Borexino per la rivelazione dei neutrini, aiLaboratori Nazionali del Gran Sasso.

CNO di combustione dell’idrogeno e regola laproduzione degli isotopi di ossigeno e fluoro inmoltissimi ambienti stellari quali le novae, le gi-ganti rosse, le stelle massive e le stelle AGB. Inoltre si è lavorato alla finalizzazione del progettorelativo alla installazione nei laboratori sotterraneidel Gran Sasso di un acceleratore con tensione diterminale 3.5 MV che consentirebbe di studiarereazioni chiave del ciclo di combustione dell'elioe reazioni che producono le sorgenti di neutroniper il processo s. In particolare è stato definito ecompletato il progetto tecnico di bonifica del sitodell'interferometro (pavimentazione, impianti-stica, sicurezze ed altro) e delle schermature ne-cessarie per l’installazione del nuovo acceleratoreda 3.5 MV a stadio singolo. Nel peculiare contesto sperimentale dei Laboratoridel Gran Sasso dedicati alla fisica astro-particellaree alla ricerca di eventi rari, è di fondamentale im-portanza per molti esperimenti selezionare e uti-lizzare i materiali a bassissimo contenuto diradioattività naturale e realizzare condizioni dicontaminazione estremamente bassa da parte dielementi più o meno comuni nell’ambiente (ades. potassio, piombo, torio, uranio, le terre rare,etc... ).È quindi per questo che i LNGS si sono dotati diun Laboratorio specializzato in spettrometriagamma tra i più grandi e con le migliori presta-zioni al mondo. I rivelatori al germanio iperpurooperanti nel laboratorio sotterraneo consentonomisure di valori di radioattività naturale estrema-mente basse, non possibili in superficie. Parimenteimportante è il Servizio di Chimica e Impianti chi-mici che gestisce due spettrometri di massa conanalizzatore di massa quadrupolare, di cui l’ultimoacquisito, il Finnigan ELEMENT 2 commercializ-zato dall’azienda Thermo Electron presenta spe-cifiche tecniche e prestazioni uniche a livellomondiale.L’analisi tramite spettrometria di massa è comple-mentare alla tecnica che utilizza la spettrometriagamma, le potenzialità dell’una e dell’altra com-binate insieme permettono di ampliare notevol-mente il campo delle applicazioni e migliorare laqualità delle misure.Le due tecniche trovano numerose applicazioni,al di là dalle specifiche necessità degli esperimentioperanti nei LNGS, in campo geologico e idrogeo-logico, nelle scienze ambientali tramite lo studiodell’atmosfera e degli oceani, nella scienza dellospazio (misure di meteoriti, campioni prelevati suMarte o da comete), produzione industriale (p.e.per la selezione dei materiali impiegati nella pro-
duzioni di circuiti integrati per computer ed elet-tronica per evitare malfunzionamenti a causa dicontaminanti radioattivi), analisi e datazioni dicampioni archeologici.I LNGS hanno implementato, nell’ambito del PORAbruzzo, specifici programmi di formazione perl’utilizzazione di queste strumentazioni di alta tec-nologia.L’esperimento ERMES studia radionuclidi cosmo-genici e primordiali in matrici solide e fluide all’in-terno dei LNGS mediante spettrometria gammaHPGe ed a scintillazione liquida per la caratteriz-zazione del fondo di neutroni. Nel corso del 2011sono proseguiti le analisi e gli studi sui campionidi acqua prelevati nei vari siti del laboratorio sot-terraneo allo scopo di indagare e caratterizzare ul-teriormente le variazioni di fondo di neutroni nellaboratorio e le variazioni anomale della concen-trazione di attività di uranio in acqua, osservatenel corso del 2009 e associabili con i processi geo-dinamici dell’evento sismico aquilano. Il Laboratorio ospita inoltre esperimenti di in-teresse geofisico, quali GIGS costituito da uninterferometro di tipo Michelson-Morley, e l’e -sperimento PULEX2 di interesse biologico.È infine da sottolineare che la peculiarità e com-plessità degli esperimenti operanti nei 180000 m3
del Laboratorio sotterraneo, in stretta intercon-nessione con il tunnel autostradale, la necessitàdi assicurare la massima sicurezza anche dalpunto di vista ambientale, implicano l’installa-zione e l’utilizzazione di rilevanti impianti tecno-logici, avanzati sistemi di gestione e controllofunzionale anche a distanza, uso di reti ultravelocie affidabili di trasmissione di dati, robusti servizidi sicurezza e monitor ambientale.Le elevate competenze specialistiche acquisite intali ambiti dal personale dei LNGS sono oggettodi programmi di formazione rivolti al territorio ealla sua realtà produttiva.
Le attività del Laboratorio sull’orizzonte del PianoTriennale 2011-2013 saranno governate da unaparte dagli esperimenti già presenti, in costru-zione o appena approvati, dall’altra dall’auspica-bile partenza di nuovi esperimenti e attività giàsottoposti all’esame dei LNGS e in attesa della ap-provazione finale e di finanziamenti. Gli esperimenti in questo momento in presa datie che hanno già prodotto risultati di fisica conti-nueranno nel prossimo triennio a essere operativifino al pieno raggiungimento del loro obiettivo diricerca: BOREXINO continuerà nello studio dei neutrini so-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
100
solutamente all’avanguardia in tale classe di studi.L’esperimento DAMA/LIBRA che utilizza cristaliiscintallanti (NaI) estremamente radiopuri, avevagià recentemente confermato con una signifi-canza statistica di 8.9 σ una modulazione annualedei segnali di bassa energia, del tutto compatibilecon quanto aspettato da una interazione di par-ticelle di Dark Matter. Nel corso del 2011 la colla-borazione ha completato la caratterizzazione eottimizzazione dei nuovi fotomoltiplicatori instal-lati alla fine del 2010. L’esperimentato ha quindiripreso ad accumulare nuovi dati con una sogliain energia minore e con accresciuta sensibilità perla ricerca di possibili candidati di DM.Nel corso del 2011 la pubblicazione da partedell’esperimento CoGeNT di analoga modula-zione annuale, ancorché con bassa significanzastatistica, ha suscitato grande interesse nella co-munità scientifica. Un confronto comparativotra i due esperimenti sembra indicare una com-patibilità dei risultati nell’ipotesi di interazioneelastica coerente di neutralini leggeri, di massanon incompatibile con i recenti risultati degliesperimenti LHC.È tuttavia da notare che tale ipotesi risulta in-compatibile con i limiti più recenti pubblicati daXENON 100l e CDMS. Questa situazione ha sti-molato una grande messe di pubblicazioni volteda una parte a tentare una conciliazione di tuttii risultati, dall’altra a mettere in evidenza possi-bili incertezze e limiti nella sensibilità dei vari ap-parati.La ricerca di candidati di DM ai LNGS si avvaleinoltre della tecnica che utilizza TPC riempite di li-quidi criogenici (Argon e Xenon) a doppia fase (li-quida e gas) che è stata iniziata nei LNGS grazieal lavoro pionieristico dell’esperimento WARP conArgon. Il progetto XENON ai LNGS si propone la ricercadi DM attraverso la rivelazione di scattering diWIMPs sui nuclei di XENON. Dopo il successo delprimo rivelatore XENON 10, attualmente è in fun-zione ai LNGS il rivelatore XENON 100l, una TPCa doppia fase contenente una massa sensibile di62 kg di Xenon ultrapuro, in grado di stabilire conprecisione millimetrica il vertice dell’interazione.Nel corso del 2011 la Collaborazione ha pubbli-cato i risultati relativi a 100.9 giorni di acquisizionetra Gennaio e Giugno 2010. Sono stati identificatitre candidati con un fondo aspettato di 1.8 eventinella regione dove è atteso il segnale di intera-zione da WIMPs,. Ciò ha consentito di fissare ilmiglior limite superiore alla sezione d’urto di in-terazione elastica spin-indipendente per WIMPs a
50 Gev. L’esperimento ha poi continuato ad ac-cumulare dati in condizioni migliori di fondo e asoglia più bassa per incrementare ulteriormentela sua sensibilità. Il prossimo passo nel programmadella Collaborazione XENON sarà la costruzionedi un apparato di terza generazione (XENON1T)contenete una tonnellata di volume fiduciale diXENON, che si prefigge di guadagnare due ulte-riori ordini di grandezza in sensibilità. Nel corsodel 2011 XENON1T ha ricevuto la definitiva ap-provazione da parte dei LNGS e del Consiglio Di-rettivo INFN.Nel 2011 il Comitato Scientifico Internazionale delGran Sasso ha esaminato e approvato una nuovaproposta, DarkSide 50, che si inserisce nella lineadi ricerca di DM con la tecnica di TPC a doppiafase in Argon. L’esperimento che si propone diusare Argon depleto e uno schermo attivo in scin-tillatore liquido, farà uso della Counting Test faci-lity (CTF) di Borexino.Nel 2011 è stato installato nella sala C dei LNGSun piccolo protipo di 10 l dell’apparato.Dark Side 50 è al momento all’esame del Comi-tato Tecnico Scientifico INFN prima della decisionefinale da parte del Consiglio Direttivo dell’INFN.Il rivelatore di CRESST infine si basa sulla tecnicabolometrica con cristalli scintillanti di CaWO4operati a temperatura di 10 mK. Nel corso del2011 la Collaborazione CRESST ha mostrato i ri-sultati ottenuti dopo un lungo run con 8 cristalli,corrispondente ad una esposizione di 730 Kggiorno. È stato evidenziato un eccesso di eventinella regione dove è aspettato il segnale da scat-tering di WIMPs. Successivamente è ripartito unnuovo run in cui ulteriori accorgimenti sono statiimplementati sui rivelatori volti ad una ulteriore ri-duzione del fondo. Prosegue inoltre in un crio-stato ad hoc l’attività di ricerca e sviluppo volta almiglioramento delle prestazioni dei rivelatori dautilizzare. Le misure dirette di sezioni d’urto di interazioninucleari di interesse astrofisico ottenute dall’espe-rimento LUNA nel laboratorio sotterraneo delGran Sasso sono di grande interesse per capire imeccanismi che generano l’energia e produconogli elementi all’interno delle stelle. Nel corso del 2011 la collaborazione è stata im-pegnata nella misura delle reazioni 2H(α,γ)6Li e17O(p,γ)18F. La prima è fondamentale per la pro-duzione di 6Li durante la nucleosintesi primordiale(BBN) ed una sua più accurata conoscenza po-trebbe permettere di risolvere la discrepanza tra6Li osservato in stelle molto antiche e 6Li previstodalla BBN. La reazione 17O(p,γ)18F fa parte del ciclo
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
99

arrivi a una proposta definitiva di esperimento.Inoltre proseguirà l’attività R&D di LUCIFER che sipropone di realizzare un rivelatore a cristalli di se-leniuro di zinco (ZnSe) che accoppi la tecnica bo-lometrica usata nell’esperimento CUORE allarivelazione della luce di scintillazione tipica dei ri-velatori di materia oscura.Infine i prossimi anni saranno importanti per la rea-lizzazione, nell’ambito dell’esperimento ERMES, diun laboratorio da installare tra la sala a e la salaB dei laboratori sotterranei, dedicato alla ricercanel campo delle scienze ambientali e dei mate-riali, mediante misure di bassissimi livelli di trac-cianti radioattivi cosmogenici, antropogenici eprimordiali. Il progetto che è in attesa di finan-ziamenti, si avvarrà della collaborazione dellaIAEA-EL e JRC-ITU.
Conclusioni e prospettiveIl panorama a lungo termine che copre il prossimodecennio è chiaramente più difficile da tracciare,anche perché alcune scelte discenderanno inevi-tabilmente dai risultati scientifici ottenuti dalla co-munità, sia al Gran Sasso sia in altri laboratori, edai risultati di LHC.È anche da considerare che i LNGS, data la loroposizione all’interno di un parco nazionale, dif-ficilmente si potranno espandere nell’attualesito e quindi il volume dei futuri esperimenti sarànecessariamente limitato dalla capacità dellesale esistenti. Questo aspetto è rilevante per al-cuni programmi scientifici, quali lo studio delleviolazioni di parità nel settore dei neutrini o laricerca del decadimento del protone che potreb-bero richiedere masse e volumi enormi, non rea-lizzabili al Gran Sasso, a meno di realizzare nuoviscavi in zone non vincolate.La comunità scientifica internazionale si sta inter-rogando sui possibili scenari aperti dalle prime in-dicazioni di un angolo di mescolamento deineutrini θ13 relativamente grande. Gli anni delpresente piano triennale saranno decisivi per chia-rire quali fasci di neutrino, rivelatori e quali labo-ratori rappresentano le migliori scelte perprocedere nella comprensione delle proprietà deineutrini.Inoltre il Gran Sasso possiede una leadership negliesperimenti con altissime prestazioni dal punto divista del basso livello di radioattività. Si tratta diun vantaggio competitivo rispetto ad altri labora-tori che andrà mantenuto e sfruttato, cercando dimassimizzare il potenziale di scoperta nelle ricer-che sul doppio decadimento beta e sulla materiaoscura. Queste ricerche saranno quindi sicura-
mente le linee principali di sviluppo dell’attivitàscientifica del Laboratorio nel prossimo decennio.È da sottolineare che gli esperimenti già approvatiper il doppio beta coprono un lungo arco tempo-rale e l’eventuale estensione di GERDA a una fasetre, in sinergia con altri analoghi esperimenti, e larealizzazione di CUORE II che possa utilizzare tel-lurio arricchito per un incremento ulteriore di sen-sibilità, danno al programma del Laboratorio inquesto campo una prospettiva di lungo respiro.Anche per gli esperimenti di materia oscura, larealizzazione nel presente Piano Triennale di nuoviesperimenti appena approvati quali XENON 1t oin attesa dell’approvazione finale, garantiranno alLaboratorio una continuità nella leadership attual-mente tenuta dai LNGS nel campo anche al di làdel presente piano triennale.Le misure di sezioni d’urto, di processi di fusionedi interesse astrofisico, costituiranno inoltre unalinea di ricerca unica nel panorama internazionalee di grande impatto scientifico. Inoltre, vanno incoraggiate le nuove proposteconcernenti questioni aperte in fisica che potreb-bero giovarsi dell’ambiente sotterraneo.Misure legate alla sismicità del territorio e postein correlazione con misure di radioattività in unambiente di bassissimo fondo radioattivo, l’utiliz-zazione della spettrometria gamma e spettrome-tria di massa per applicazioni in discipline diversequali le scienze ambientali e dei materiali, conti-nueranno ad allargare l’orizzonte scientifico delLaboratorio verso aspetti di grande impatto am-bientale e sociale.L’attività scientifica dei LNGS è in questo mo-mento al suo apice per numero e competitività diesperimenti, i numerosi e importanti risultatiscientifici raggiunti nei LNGS ne sono la testimo-nianza, a conferma dell’unicità nel panoramamondiale di questa infrastruttura di ricerca capacedi attirare ricercatori da ogni parte del pianeta.Tuttavia a fronte dell’incremento del numero ecomplessità degli esperimenti al Laboratorio delGran Sasso, non è stato possibile un proporzio-nale aumento delle risorse finanziarie e umanenecessarie a operare e gestire una così rilevanteattività di ricerca. Al contrario le possibilità di re-clutamento di personale stanno riducendosi sem-pre di più superando il livello di guardia; inoltrel’assottigliamento delle risorse destinate alle infra-strutture e all’impiantistica contrasta con le neces-sità di funzionalità e sicurezza del Laboratorio edegli esperimenti installati e operanti al suo in-terno.Va inoltre sottolineato che un laboratorio di ec-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
102
lari avvalendosi di un’ulteriore diminuzione deifondi a seguito della campagna di purificazionedello scintillatore in corso. L’obiettivo è di miglio-rare la misura delle componenti di energia piùbassa dello spettro di neutrini emessi, quali PEP eCNO; l’esperimento inoltre contribuirà a fornire,attraverso la misura di geoneutrini, importanti in-formazioni sul nostro pianeta.OPERA continuerà la presa dati accumulandoeventi da neutrini del CNGS per tutto il 2012 eproseguirà nell’analisi dei dati per confermare eaumentare la significanza statistica del risultatoottenuto nel corso del 2010 sulla prima evidenzadiretta delle oscillazioni di neutrini.ICARUS continuerà la presa dati sul fascio CNGSper tutto il 2012 e continuerà nell’analisi e nellaricostruzione degli eventi raccolti e prodotti ancheda interazioni di neutrini atmosferici, nell’intentodi dimostrare sperimentalmente tutte le potenzia-lità dell’apparato. Continueranno la presa dati e gli sviluppi contutti gli apparati di DAMA. In particolare, perDAMA/LIBRA ci si aspetta i risultati dell’analisidati accumulati a soglia più bassa. Prosegui-ranno inoltre le attività di R&D sia per esperi-menti di nuova generazione per la Dark matter,sia nel campo dei decadimenti 0ννββ.LVD continuerà a operare come osservatorio deineutrini da collassi. LUNA negli anni futuri (2012-2014) studierà altrecatture protoniche radiative quali la 22Ne(p,γ)23Na,la 18O(p,γ)19F e la 23Na(p,γ)24Mg. Tali reazioni, ap-partenenti al ciclo NeNa o CNO, sono essenzialiper la produzione degli elementi in moltissimi am-bienti stellari. Inoltre il prossimo triennio sarà decisivo per l’avviodel progetto LUNA-MV. Tale progetto prevede l’in-stallazione di un acceleratore con tensione mas-sima di terminale 3.5 MV presso i LNGS al fine distudiare reazioni chiave appartenenti al ciclo dicombustione dell’He quali la 12C(α,γ)16O che re-gola il rapporto tra carbonio ed ossigeno e le rea-zioni (α,n) su 13C e 22Ne che danno luogo al flussodi neutroni necessario al processo s per la forma-zione degli elementi con numero di massa mag-giore di 60. L’esperimento XENON-100 continuerà la presadati e al contempo ci si aspetta nel 2012 la pub-blicazione dei risultati dell’analisi dei dati già rac-colti nel 2011. Nella sconda metà del 2012 èprevista l’inizio delle attività di costruzione e in-stallazione nella sala B dei LNGS del nuovo appa-rato XENON 1t che si prefigge di aumentare didue ordini di grandezza la sensibilità nella rivela-
zione di candidati di materia oscura.Ci si aspetta inoltre nel 2012 la decisione finalesulla approvazione dell’esperimento Dark Side 50e l’inizio della costruzione del rivelatore che pre-vede il rifacimento della CTF di Borexino.L’esperimento CRESST continuerà la presa dati el’analisi volta alla piena comprensione dei segnalidi fondo, contemporaneamente continuerà lafase di ricerca e sviluppo sui cristalli .Per quello che attiene la ricerca di candidati di ma-teria oscura, è da rilevare la posizione di assolutofavore dei LNGS per merito della presenza in con-temporanea nel Laboratorio di esperimenti contecniche diverse e che utilizzano nuclei diversi.Questo non solo aumenta le potenzialità di unascoperta nel Laboratorio o comunque consentiràdi porre dei limiti sempre più stringenti, ma i risul-tati degli attuali esperimenti, in termini di sensibi-lità raggiunta e capacità di reiezione dal fondo,costituiranno la base indispensabile per la sceltadella tecnica migliore da utilizzare per raggiungeresensibilità ancora maggiore negli esperimenti delprossimo decennio. In tale ambito i LNGS parte-cipano anche al programma di Ricerca e SviluppoDARWIN finanziato dalla comunità europea sullafattibilità di apparati con liquidi criogenici digrande massa e bassissimo fondo radioattivo.Tra gli esperimenti che hanno come scopo la ri-cerca di eventi di decadimento doppio beta senzaneutrini, GERDA ha iniziato a raccogliere dati con8 rivelatori e ci si aspetta che in meno di due anniabbia completato questa prima fase dell’esperi-mento che ha come primo obiettivo la verifica deicontroversi risultati pubblicati da una parte dellacollaborazione HdMo. In una seconda fase nuovicristalli che sono in via di produzione, saranno in-seriti nel criostato allo scopo di raggiungere unasensibilità molto superiore. Il programma e l’oriz-zonte temporale dell’esperimento eccedonoquindi il presente piano triennale.L’esperimento CUORE, dopo il successo di CUO-RICINO, è già un esperimento di seconda gene-razione, con i suoi circa 1000 bolometri di TeO2 euna massa di 740 kg. È ancora in fase di costru-zione e ci si aspetta il completamento della co-struzione entro il presente piano triennale per il2014. In particolare nel corso del 2012 dovrebbeentrare in funzione la prima torre CUORE-0 checonsentirà un attento studio del fondo previstoper l’intero apparato. Il programma e l’orizzontetemporale di CUORE vanno quindi ben al di làdal presente piano triennale.Per COBRA, ci si aspetta che nel prossimo trienniocompleti il suo programma di ricerca e sviluppo e
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
101

(fra cui GASP, EUROBALL, CLARA) ed è stato com-pletato il prototipo denominato Dimostratore diAGATA. Quest’ultimo, inaugurato nella primavera2010, è stato utilizzato ai LNL anche in accoppia-mento con lo spettrometro magnetico a grandeaccettanza e risoluzione PRISMA per una campa-gna di misure fino al 31 dicembre 2011. Di parti-colare interesse sono i rivelatori al silicio per ionipesanti (progetto FAZIA) e quelli per neutroni(progetto NEDA) sviluppati in collaborazione conil laboratorio di Ganil nell’ambito del progetto eu-ropeo “SPIRAL2 preparatory phase” per applica-zioni nei futuri progetti Spes e Spiral2. L’eccellenza nella tecnologia degli acceleratori ètestimoniata dalla realizzazione del LINAC super-conduttivo ALPI-PIAVE, dai contributi portati allarealizzazione di acceleratori per il CNAO, il CERNe TRIUMF e dalla partecipazione a progetti inter-nazionali per acceleratori dedicati a programmi difusione nucleare (sviluppo dell’acceleratore RFQper IFMIF-EFVEDA, della NBTF per RFX). Attivo da cinquant’anni, LNL opera in stretta col-laborazione con gli altri laboratori nazionali del-l’INFN, fra cui in particolare il LaboratorioNazionale del Sud (LNS), e con i più importanti la-boratori esteri di livello internazionale, attivi nelcampo delle ricerche in fisica nucleare. Tali attivitàsi svolgono nell’ambito di accordi internazionalicome quello con ISOLDE-CERN e con Spiral2-GANIL, nell’ambito di un Laboratorio Europeo As-sociato costituito con lo scopo di condivideresviluppi tecnologici e finalità scientifiche nelcampo della Fisica Nucleare con Fasci di ioni stabilied esotici. A livello europeo, LNL è riconosciutocome “Large Scale Facility”.Il futuro del laboratorio ruota attorno al progettospeciale SPES (Selective Production of Exotic Nu-clear Species), descritto più in dettaglio nella Se-zione riguardante i Progetti Speciali. SPES èdedicato primariamente allo studio di nuove spe-cie nucleari ricche di neutroni. Al tempo stessotale progetto permette sviluppi applicativi relativialla produzione di radio-farmaci di tipo sperimen-tale ed innovativo (ma anche convenzionale) e allafisica dei neutroni, con particolare riguardo ai temidell’ energia, scienza dei materiali e salute.
Recenti risultati salienti (highlight) del La-boratorioNel corso del 2011 i LNL hanno fornito comples-sivamente circa 7500 ore di fascio all’utenza, permisure effettuate utilizzando gli apparati speri-mentali dei laboratori. L’attività sperimentale più rilevante è stata la cam-
pagna di sperimentazione con il nuovo rivelatoregamma ad alta risoluzione, il cosiddetto Dimostra-tore di AGATA (vedi cap. 3 figura 3.13). Questorivelatore, realizzato da un consorzio di numerosilaboratori europei e con capacità di “tracking”diraggi gamma, ha caratteristiche di efficienza, lo-calizzazione dell’interazione e potere risolvente digran lunga superiori a quelle degli apparati di pre-cedente generazione. La campagna di misura hautilizzato anche lo spettrometro a grande angolosolido PRISMA. Il complesso AGATA-PRISMA co-stituisce un potente strumento di indagine ingrado di richiamare la presenza di molti sperimen-tatori da tutta l’Europa. Nell’ambito del progetto Fazia (figura 4.13) sonostati condotti con successo i test dei primi proto-tipi di rivelatori al silicio “neutron doped” in gradodi fornire una discriminazione in massa degli ionisulla base della forma dei segnali. Tale progetto,parte della “preparatory phase” di Spiral2, hacome obiettivo studi di termodinamica nuclearein reazioni con fasci esotici.Per il progetto SPES, è iniziata nell’autunno 2011la costruzione del ciclotrone da 70 MeV ed altaintensità ed è stata completata la progettazionedell’edificio che dovrà contenere la macchina,mentre è stato installato il Front-End della facilityISOL (figure 4.14, 4.15) completo di bersaglio,sorgente a ionizzazione superficiale, estrattore eprima parte di trasferimento del fascio a 30 keV.Nell’ambito della fisica degli acceleratori, si è pro-ceduto con l’incremento in potenza delle cavitàdi basso beta di Alpi e si sono aggiunte quattroulteriori cavità acceleranti al sistema. Si è inoltreproceduto all’upgrade delle cavità dell’iniettorePIAVE e allo sviluppo di nuovi fasci pesanti con lasorgente ECR. Nell’ambito del progetto IFMIF, è in costruzione unRFQ di altissima intensità che verrà installato nel2015 nella sede giapponese di Rokkasho, insiemeagli altre componenti dell’acceleratore realizzateda una collaborazione europea guidata da F4E. È stato definitivamente approvato il programmaNBTF, che prevede la realizzazione di un com-plesso accelerante per lo studio e l’ottimizzazionedi un fascio di deutoni da iniettare nel reattore delprogetto internazionale ITER per la fusione. Ilcomplesso vede come attore principale il consor-zio RFX, cui partecipa l’INFN e che si avvale dellecompetenze presenti nel laboratorio.Nell’ambito dello sviluppo di tecnologie nucleariapplicate alla salvaguardia ambientale, i LNLhanno contribuito alla realizzazione della Cartadella Radioattività della Regione Toscana, che è
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
104
cellenza come i LNGS costituisce un centrounico al mondo di alta formazione per i giovaniricercatori operanti nel campo della fisica astro-particellare ed è importante poter continuare amantenere questa posizione di preminenza in-ternazionale mediante un flusso continuo e pro-grammato di menti giovani e brillanti.
MILESTONE del periodo 2012-2014I Laboratori Nazionali di LegnaroIl laboratorio (sito web: http://www.lnl.infn.it/)
Legnaro oggiLa missione principale dei LNL è lo sviluppo delleconoscenze nella fisica e astrofisica nucleare dibase assieme alle applicazioni delle tecnologie nu-cleari connesse. I laboratori (figura 4.12), situato nelle vicinanze diPadova ed in prossimità di svincoli autostradali edaeroporti nazionali ed internazionali, si estendonosu una superficie di circa 200.000 mq, sulla qualesono edificati circa 120.000 mc, con possibilità dicostruire ulteriori 170.000 mc per lo sviluppo dinuovi progetti. I Laboratori sono allacciati ad unalinea di alta tensione a 132 KV con disponibilitàdi fonti di energia elettrica primarie pari a 120MVA.Dispone di uno staff di 110 dipendenti a tempoindeterminato, una quindicina di dipendenti atempo determinato e si avvale di circa 150 asso-ciati (dottorandi, borsisti e personale universitario);circa il 60% del personale dipendente ed asso-ciato è laureato o dottore di ricerca.Si è dotato nel tempo di cinque macchine accele-ratrici, tutte utilizzate con continuità dalla comu-nità scientifica nazionale ed internazionale perstudi in fisica nucleare degli ioni pesanti (TAN-DEM-XTU, ALPI e PIAVE), e per applicazioni volteallo studio dei materiali, alla fisica dei neutroni eper ricerche interdisciplinari (AN2000 e CN). Nel-l’ambito della fisica nucleare ed astrofisica nu-cleare il laboratorio fa riferimento ad un ampiobacino di utenza di circa 600 ricercatori, più dellametà non italiani e di provenienza europea. Accanto alle attività di Fisica Nucleare, il laborato-rio ospita l’antenna gravitazionale ad altissimasensibilità Auriga per la rivelazione delle onde gra-vitazionali. Dispone di un centro di calcolo di pri-mordine con un ruolo significativo nell’analisidegli eventi prodotti alla grande macchina LHCdel CERN. Attività di eccellenza sono individuabili nel campodei rivelatori per raggi gamma e di particelle cari-che. In particolare, sono stati realizzati nel conte-sto di collaborazioni europee importanti apparatidi ampio utilizzo nella comunità internazionale
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
103
Completamento della purificazione delloscintillatore liquido di BOREXINO, presadati con fondo ancora più basso per misu-rare in modo diretto le componenti dibassa energia dello spettro dei neutrini so-lari e incrementare la statistica della misuradei geoneutrini;Completamento della presa dati dell’espe-rimento OPERA nel 2012 coi neutrini CNGSe proseguimento dell’analisi;Completamento della presa dati dell’espe-rimento ICARUS nel 2012 con il fascio CNGSe dimostrazione delle potenzialità del rive-latore per altre sorgenti di neutrini e versoapparati di centinaia di kt (kilotonnellate); Pubblicazione di nuovi dati a soglia piùbassa e eventuale conferma del segnale dimodulazione annuale dell’esperimentoDAMA per la ricerca della materia oscura; Completamento della presa dati di XENON100 per la ricerca della materia oscura;Costruzione del rivelatore XENON 1t e ini-zio del commissioning dell’apparato;Continuazione della linea di ricerca di ma-teria oscura con TPC ad Argon liquido;Continuazione della presa dati dell’espe-rimento CRESST, miglioramento dellacomprensione del fondo dell’apparato edefinitivo giudizio delle potenzialità dellatecnica che accoppia rivelazione di fononie luce di scintillazione;Completamento della prima fase dell’espe-rimento GERDA e verifica dei controversirisultati pubblicati da una parte della col-laborazione HdMo; Messa in funzione e analisi dati di CUORE-0 e costruzione dell’apparato CUORE;Continuazione del programma di R&D Lu-cifer verso un rivelatore di 1 t di isotopo perla ricerca del decadimento doppio betasenza neutrini;Completamento delle misure di LUNA dellesezioni d’urto nucleari di interesse astrofisicoe inizio del programma con un acceleratoreda 3.5 MV nella zona dell’interferometro del
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
laboratorio sotterraneo;Prosecuzione degli studi di interesse geofi-sico all’interno del laboratorio sotterraneo.Realizzazione del laboratorio dedicato allescienze ambientali medianti traccianti ra-dioattivi.
•
•

plicate all’ambiente.Si predisporranno azioni mirate per mantenereil funzionamento ottimale degli acceleratoriCN e AN2000 e della loro strumentazione ana-litica per consentire agli attuali utenti la conti-nuazione delle proprie ricerche in ambitointerdisciplinare, e per ampliare l’utenza a li-vello europeo specialmente nel campo dellenanotecnologie e dei microsistemi.
Il Laboratorio dell’INFN di Legnaro, assieme aquello di Catania, va considerato come presidionazionale delle conoscenze di base in Fisica Nu-cleare e delle competenze nel campo delle tecno-logie nucleari. I Laboratori di Legnaro e Catania,in sinergia fra di loro, sono ricchezze da mante-nere e potenziare al servizio del paese. Va mantenuta la duplice missione dei LNL, per losviluppo delle conoscenze nella fisica e astrofisicanucleare di base assieme alle applicazioni delle tec-nologie nucleari connesse, avendo presente che idue filoni sono inscindibili: la ricerca di base privadi applicazioni appare sterile, mentre un laborato-rio di moderne tecnologie, avulse dall’apporto dinuove conoscenze, è destinato ad invecchiare ra-
pidamente. Nel campo delle applicazioni di tecno-logie nucleari, va rafforzata la collaborazione congli enti territoriali e nazionali, ma va anche perse-guito ogni sforzo per incrementare la coopera-zione con le Aziende.In questo quadro, Legnaro ha tre principali linee disviluppo, corrispondenti ad altrettante diramazionidel progetto SPES (vedi anche par. 3.8):
SPES-beta:consiste nella riaccelerazione degli ioni esoticiprodotti dal bersaglio di UCx nel complessoALPI-PIAVE ad energie tra 5 e 10 MeV/nucleoneper impiegarli, mediante vari tipi di reazioni nu-cleari, nella formazione ed esplorazione di nucleiricchi di neutroni in condizioni estreme. Il pro-getto, assieme alla “facility” francese Spiral2 diGANIL attualmente in costruzione, permetteràuna ricerca di assoluta frontiera nel campo dellafisica nucleare, da realizzarsi in sinergia e in col-laborazione con le strutture dell’INFN, in parti-colare con i LNS, con il laboratorio francese econ altri laboratori europei. Per questa fase, nonancora approvata dall’INFN, è previsto un costodi 20-30 Meuro, a seconda delle opzioni. SPES-beta è stato presentato nell’ambito dei progettipremiali 2011 del MIUR.
SPES-gamma:consiste nella realizzazione di un centro per laproduzione e distribuzione di radio farmaci ditipo innovativo e sperimentale - oltreché di tipoconvenzionale - basato sulla seconda uscita delCiclotrone da 70 MeV. Un centro di tale tipo sa-rebbe unico nel Paese, e sostanzialmente ge-mello del progetto francese ARRONAX attual-mente in fase di completamento.Potrà fornire alla comunità della medicina e far-macologia nucleare una sorgente continua e ric-chissima di nuovi isotopi per la sperimentazioneclinica e contribuirebbe a garantire l’approvvi-gionamento di radio-farmaci convenzionali nelNord Est del paese.Già adesso sono in fase di definizione progettipreliminari: i costi sono previsti in circa 15 Meuroed i tempi di realizzazione in tre anni dall’appro-vazione. Per il finanziamento ed il successo del-l’iniziativa sono necessari il sostegno di Entiterritoriali e la partecipazione di Aziende e Istitu-zioni del settore sanitario, assieme alla collabora-zione con Università.Questa fase del progetto (LARAMED) è stata pre-sentata nell’ambito dei progetti premiali 2011 delMIUR.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
106
Fig. 4.14: Front-end del bersaglio ISOL.
Fig. 4.15: Il modello in alluminio, scala 1:1 dell’acceleratore RFQ perIFMIF.
stata consegnata nel 2011 al termine del progettoRad_Nat, co-finanziato dall’INFN. Nel biennio2009-2011 gli spettrometri gamma MCA_Rad,Za_NaI e AGRS_16 ideati e realizzati presso i LNLhanno permesso di misurare la radioattivitàgamma di 1913 campioni di suolo e roccia e direalizzare un survey airborne del 20% del territo-rio toscano.
Il laboratorio si è dotato di una cabina di trasfor-mazione elettrica da 132 kV e potenza erogabilefino a 40 kVA:
LNL nel prossimo triennioSPES-alpha, la prima fase del progetto SPES, giàapprovata e finanziata dall’INFN, si realizzeràentro il 2014, mediante l’acquisizione, l’installa-zione ed il collaudo di un ciclotrone a protoni(energie da 30 a 70MeV e correnti fino a quasi1mA) e la costruzione dell’edificio per ospitare lamacchina ed i laboratori ad essa annessi. Il progetto prevede nel triennio l’utilizzo di un ber-saglio in Carburo di Uranio (UCx) capace di fornire1013 fissioni al secondo sotto l’azione del fascio diprotoni del ciclotrone.
Con il contributo di molte Sezioni e Laboratoridell’INFN, ed in particolare dei LNS, proseguiràl’intensa attività di progettazione e di simulazionedelle parti da realizzare, nonché di costruzione diprototipi per poter passare velocemente alla in-stallazione delle apparecchiature necessarie allesuccessive fasi del progetto SPES. Nell’ambito della strumentazione per la fisica nu-cleare di base, impegno primario del laboratorioè la realizzazione del rivelatore per raggi gammaGalileo. Tale progetto, svolto in collaborazionecon le Università e sezioni INFN di Padova, Milanoe Firenze nel contesto di una collaborazione inter-nazionale, ha come obiettivo quello di dotare iLNL di un innovativo spettrometro di moderna ge-nerazione per studi di spettroscopia gamma. In-terventi di “up-grading” sono in programma peraltri apparati di eccellenza quale lo Spettrometroa grande accettanza PRISMA o il complesso diodoscopi per ioni pesanti - esperimento Nuclex -,per i quali nel corso del triennio sono previstecampagne sperimentali.
Nel campo del nucleare da fusione, due sono iprincipali impegni del laboratorio:
Proseguiranno le attività nelle quali il labora-torio ha raggiunto livelli di eccellenza, in par-ticolare per quanto riguarda la microbiologiae la microdosimetria. Per queste attività il La-boratorio dispone già di un’ottima strumenta-zione come il micro-fascio installato pressol’acceleratore CN. Saranno potenziate le attività nel settore dellaGeofisica Nucleare, dedicate alla creazione dicarte tematiche della radioattività nelle rocce,nei suoli e nell’ambiente. In particolare, grazieal sostegno di una fondazione privata, saràcompletata la carta della Radioattività della Re-gione Veneto. Al termine di questa esperienza,i LNL avranno contribuito al monitoraggiodella radioattività di circa il 15% del territorionazionale, con un ulteriore rafforzamento delproprio knowhow nelle tecnologie nucleari ap-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
105
Fig. 4.12: Vista aerea dei Laboratori Nazionali di Legnaro.
Fig. 4.13: Risultati recenti di FAZIA.
•
•
A realizzazione dell’acceleratore RFQ ad alta in-tensità del progetto IFMIF, parte essenzialedella macchina per la studio dei materiali dautilizzare nei reattori a fusione;La collaborazione alla realizzazione della Neu-tral Beam Test Facility, il laboratorio per lo stu-dio dell’iniettore di potenza nel plasmanell’ambito del progetto ITER e come sup-porto al consorzio RFX.

tecnologica collegate. A tale scopo i LNS si sonodotati di due acceleratori di ioni pesanti, un acce-leratore elettrostatico Tandem ed un ciclotronebasato su tecnologie superconduttive (CS). Neltempo gli argomenti di ricerca affrontati nei LNSsi sono estesi anche ad altri campi in cui l’INFNsvolge la sua funzione istituzionale ed in partico-lare alla fisica astroparticelllare con l’avvio del pro-getto di osservatorio sottomarino di neutrinicosmici denominato progetto NEMO.
L’edificio principale dei LNS, che comprende uffici,laboratori, sale acceleratori e sale misura, è situatoall’interno del campus dell’Università di Catania epresenta una superficie coperta utilizzabile di circa17.800 m2. Fa parte dei Laboratori anche una se-conda costruzione di recente ultimazione, collo-cata anch’essa all’interno del campus con unasuperficie coperta utilizzabile di circa 2.200 m2,supporto logistico di mensa per il personale e re-sidenza per gli ospiti. Inoltre, parallelamente allosviluppo delle ricerche di fisica astroparticellare, iLNS hanno acquisito e ristrutturato, negli scorsianni, due costruzioni situate nelle aree portuali diCatania e di Portopalo di Capo Passero, che co-stituiscono le stazioni a terra di riferimento per i
due siti sottomarini, rispettivamente di test e didestinazione dell’osservatorio di neutrini cosmici,e che hanno superfici coperte utilizzabili di circa750 m2 e 1.000 m2 rispettivamente.Il personale dei LNS comprende attualmente pocopiù di 100 dipendenti INFN a tempo indetermi-nato, una quindicina circa di dipendenti INFN concontratti a termine e altrettanti docenti universitariassociati con incarico di ricerca. A questi si aggiun-gono alcuni dipendenti di altri enti associati alleattività dell’INFN ed un numero periodicamente
variabile di titolari di assegni di ricerca e borsisti,sia dell’INFN che di altri enti, che si attesta media-mente intorno alle 30 unità. Ci sono poi, in media, una trentina di studenti lau-reandi, specializzandi e dottorandi, associati alleattività dell’INFN, che studiano e lavorano alle ri-spettive tesi. In totale quindi operano all’internodei LNS oltre 210 persone.
Principali risultati scientifici raggiunti nel 2011 Nel 2011 i LNS sono stati impegnati nel consoli-damento scientifico delle attività nel campo dellaFisica Nucleare con fasci radioattivi sia in terminidi offerta di fasci all’utenza ottenuti con la tecnicadella frammentazione in volo con l’upgrading
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
108
Fig. 4.18: Laboratori Nazionali del Sud
Fig. 4.19: L’acceleratore Tandem Van De Graaff da 15 MV dei Labora-tori Nazionali del Sud.
Fig. 4.20: Il Ciclotrone Superconduttore K800 (vista dell’esterno).
Fig. 4.21: Il Ciclotrone Superconduttore K800 (vista dell’interno).
SPES-delta:riguarda lo sviluppo di una sorgente di neutroniad alta intensità , per applicazioni nel campodella salute (BNCT), ma anche del nucleare ener-getico (classificazione di scorie nucleari) e del-l’astrofisica (determinazione delle probabilità diassorbimento di neutroni in ambiti astrofisici).La realizzazione di una “Multidisciplinary neu-tron source” (MUNES) è stata presentata nel-l’ambito dei progetti premiali del MIUR 2011.Riguardo alle piccole macchine, si punterà afarne un polo di eccellenza per la fisica interdi-sciplinare, con particolare attenzione agli aspettiapplicativi e al mondo dell’imprenditoria, inun’ottica anche di finanziamento o di cofinan-ziamento esterno prevedendo in quest’ottica sial’ampliamento delle potenzialità analitiche e diirraggiamento che l’allargamento e diversifica-zione della utenza a livello europeo.Si provvederà inoltre a soddisfare gli impegni as-sunti nell’ambito del programma IFMIF (figura4.16) e a fornire supporto adeguato al progettoNBTF (figura 4.17) in collaborazione con il con-sorzio RFX.
MILESTONE del periodo 2012-2014
I Laboratori Nazionali del Sud (LNS)Il Laboratorio (sito web: http://www.lns.infn.it/)
I LNS (figura 4.18) sono nati come laboratorio de-dicato alla ricerca di base nel dominio della fisicanucleare e alle attività multidisciplinari e di ricerca
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
107
Fig. 4.16: La nuova sorgente ECR.
Fig. 4.17: Schema di NBTF.
Avvio delle campagne di misura colnuovo rivelatore GALILEO agli accelera-tori TANDEM-ALPI-PIAVE;Potenziamento ed upgrading degli appa-rati sperimentali delle collaborazioni PRI-SMA e NUCLEX in preparazione dei fascipotenziati del complesso PIAVE-ALPI eanche di SPES fase beta; Completamento della fase Alpha del pro-getto SPES: edilizia ed impiantistica per ilnuovo ciclotrone, installazione e commis-sioning del ciclotrone;Sviluppo della fase Beta di SPES, per laproduzione di fasci di ioni radioattivi:adeguamento degli acceleratori esistentie dell'impiantistica criogenica per le ne-cessità del progetto, realizzazione delbersaglio di UCX e del charge breeder eprogettazione definitiva delle altre com-ponenti e della strumentazione speri-mentale;Completamento dell'acceleratore RFQper il progetto IFMIF-EVEDA nell'ambitodel Broader Approach, riguardante lostudio degli effetti di irraggiamento neu-tronico sui materiali dei futuri reattori afusione nucleare;Completamento della campagna di mi-sure della radioattività di rocce e suolidella regione Veneto e possibile;Ove siano finanziati i progetti premialipresentati dall’INFN al MIUR per il 2011potranno essere realizzate le seguentiiniziative : - estensione al territorio nazionale dellamappa della radioattività di rocce esuoli (programma ITAL RAD);
- Realizzazione di un centro per la pro-duzione di radionuclidi di interesse me-dico e a carattere innovativo e speri-mentale (progetto LARAMED), basatosul nuovo ciclotrone;
- Sviluppo di una sorgente neutronica,ad alta intensità per applicazioni inter-disciplinari (progetto MUNES).
•
•
•
•
•
•
•

Attività nei prossimi tre anniNel prossimo triennio continuerà l’impegno deiLNS nelle attività che mirano alla realizzazione diun telescopio per neutrini cosmici di alta energiacon dimensioni dell’ordine del km3 a profonditàabissali nel Mar Mediterraneo. Nell’ambito delprogetto i LNS hanno già realizzato l’infrastrutturasottomarina di Portopalo di Capo Passero, costi-tuita dalla stazione di terra (on-shore) collegata aun cavo elettro/ottico che termina a 80 km off-shore in un vasto plateau a 3500 m di profondità,sito ideale per l’installazione del telescopio. La sta-zione di terra di Capo Passero è collegata con la
rete GARR a 10 Gbit/s. La collaborazione italianaguidata dai LNS, partecipa al consorzio europeoKM3NeT, inserito nella roadmap europea per legrandi infrastrutture di ricerca elaborata dall’Eu-ropean Strategy Forum on Research Infrastructu-res. La Preparatory Phase di KM3NeT, coordinatada INFN-LNS si è appena conclusa con la proget-tazione dei vari elementi del telescopio quali glielementi base del telescopio (DOM, DU), la cui va-lidazione in acque profonde è prevista entro fine2012. Grazie al finanziamento ottenuto nel 2011attraverso il PON Ricerca e Competitività 2007-2013, nel prossimo triennio si avvierà la costru-zione di una prima parte (circa 28 torri) del nodoKM3NeT-Italia, espandibile in futuro come previ-sto nel precedente piano triennale dell’INFN finoa 100 torri e da realizzare nel framework della col-laborazione internazionale KM3NeT.Nel 2011 i LNS hanno partecipato all’avvio dellabaseline progettuale dell’acceleratore per la Euro-pean Spallation Source, una delle infrastrutture diricerca più ambiziose della ESFRI; in particolarel’INFN, attraverso i LNS, ha la responsabilità delNormal Conducting Linac, ovvero la sezione del-l’acceleratore che porta il fascio di protoni da 50mA fino all’energia di 50 MeV. I LNS stanno cu-
rando inoltre il progetto della Sorgente di Ioni eLEBT mentre i LNL curano il progetto del DriftTube Linac. La lavorazione di componenti proto-tipali partirà già nel secondo semestre del 2012,al fine di potere garantire il rispetto dei tempi del-l’intero progetto, che dovrà essere completato nel2019. Nel prossimo triennio I LNS saranno impe-gnati nel progetto della sorgente di protoni adalta intensità, utilizzando le competenze scientifi-che e tecnologiche già elaborate nell’ambito delprogetto TRASCO negli anni passati e quelle svi-luppate nell’ambito del Progetto Strategico NTA-HELIOS recentemente. Infatti i LNS, hanno giàconfermato con esperimenti dedicati, la capacitàdi centrare gli obiettivi di ESS per quanto riguardal’emittanza di fasci con le caratteristiche richiestedal progetto (90 mA, pulse length 2-3 ms, repe-tition rate 10-40 Hz). Sarà così consolidata la lea-dership internazionale dei LNS nel campo dellaproduzione di fasci intensi di protoni e ioni.
Conclusioni e prospettiveNei LNS si svolgono molteplici attività di ricercanucleare, astroparticellare e di applicazione ditecniche nucleari ad altri domini disciplinari, chevengono generalmente condotte nell’ambito dicollaborazioni internazionali. Nell’arco di tempodi riferimento del presente Piano Triennale il pro-gramma di sviluppo dei LNS comprende, da unlato, l’ampliamento delle intensità e della varietàdei fasci ionici, stabili e radioattivi, producibilicon gli acceleratori esistenti, obiettivo che ne-cessita di impegni finanziari complessivamentecontenuti. In questo ambito si inserisce anche lafase di studio della menzionata possibilità di ac-celerare frammenti di fissione da sorgenti radio-attive. Dall’altro lato, di più ampio respiro e dimaggiore impegno appare la realizzazione del-l’osservatorio di neutrini cosmici, il cui avvio ècomunque subordinato all’intervento finanziariodi enti esterni all’INFN. I presupposti perché le at-tuali attività continuino a essere svolte efficiente-mente e le nuove iniziative possano decollare conalta probabilità di successo ci sono e si fondanosaldamente sulla maturità acquisita dal personalee sulle sue capacità di adeguamento ai nuovi pro-grammi di sviluppo dei LNS. È importante potercontinuare a contare sulle professionalità alta-mente specializzate maturate durante questi anni. Dal punto di vista delle strutture esistenti, c’è unacrescente preoccupazione per l’invecchiamentodegli acceleratori che necessitano di importanti in-terventi volti a prevenire guasti irreparabili che,dopo quasi trenta anni di funzionamento del Tan-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
110
Fig. 4.24: Particolare della linea di fascio CATANA (LNS) per la terapiadel melanoma oculare.
della facility FRIBS, sia con il completamento dallospettrometro Magnex.Infatti sono state completate, nei tempi previsti,le operazioni di installazione dei nuovi elementimagnetici e di diagnostica studiati per l’incre-mento nella resa di produzione e trasporto di fasciesotici prodotti in volo con reazioni di frammen-tazione grazie al sistema FRIBS ai Laboratori Na-zionali del Sud. È stata migliorata la focalizzazionedel fascio sul bersaglio di produzione che è statocompletamente rinnovato così da poter soppor-tare intensità di fasci di produzione con potenzedi varie centinaia di watt. Tra fine Febbraio eMarzo 2011 il nuovo sistema è stato collaudatopositivamente con fasci primari di 18O e 36Ar, per-mettendo la produzione di ioni esotici come l’Ar-gon 34, il Carbonio 16 e 17, il Boro 13, gli isotopidel Berillio dal 10 al 12, il Litio 8 e 9 nonché gliisotopi 6 ed 8 dell’Elio ad energie tra 25 e 50AMeV. Dal confronto con le rese prodotte con ilfascio di 18O in esperimenti effettuati con il pre-cedente sistema, si è verificato l’ottenimento delguadagno di circa un ordine di grandezza nellerese. Ulteriori aumenti di intensità potranno essereottenuti grazie alla maggiore intensità possibilesul bersaglio e sfruttando a pieno le possibilità difocalizzazione offerte dal sistema. I fasci prodottisono stati utilizzati, sul rivelatore CHIMERA, in al-cuni esperimenti per lo studio dei sistemi con
alone di neutrone in nuclei esotici ricchi in neu-troni e per la misura della dipendenza dall’isospindelle rese delle reazioni nucleari. Sono in pro-gramma vari altri esperimenti con fasci esotici di68Ni e 8He. Le maggiori intensità disponibili aprononuove prospettive di utilizzo per questi fasci, col-locando i LNS in posizione molto favorevole nelpanorama internazionale. I LNS saranno nell’immediato futuro gli unici inEuropa a poter contare su fasci esotici di buonaintensità ed energia attorno alle energie di Fermi,
indispensabili ad esempio per lo studio dei limitidella stabilità del sistema nucleare ad alta energiadi eccitazione. Potranno inoltre sfruttare la possi-bilità, unica al mondo per i fasci di frammenta-zione, di trasportare i fasci prodotti su tutte lelinee sperimentali disponibili, permettendo unaeccezionale flessibilità di utilizzo. L’installazione aiLaboratori Nazionali del Sud del multi-rivelatoreEDEN, 36 moduli di scintillatori liquidi tipo NE213,nella sala sperimentale dello spettrometro magne-tico MAGNEX ha rappresentato l’evento qualifi-cante di una ambiziosa collaborazione scientificafra il gruppo dei LNS, che lavora con il suddettospettrometro, ed i colleghi dell’IPN-Orsay. L’elet-tronica di read-out del rivelatore EDEN è stata to-talmente rinnovata ed il commissioning dellanuova facility, installata presso i LNS, è risultatoassai più che positivo. La facility è pronta per ilprogramma sperimentale che prevede in primoluogo la rivelazione dei neutroni emessi dal deca-dimento delle risonanze osservate negli spettri dienergia misurati con MAGNEX, in particolare nellereazioni (18O,16O). Grazie all’ampia accettanza edall’elevata risoluzione in massa ed in energia diMAGNEX e alla capacità di EDEN di identificarecon una buona efficienza i neutroni e misurarnel’energia, con tale facility si aprono nuove pro-spettive in molti campi di spettroscopia nuclearee negli studi dei meccanismi di reazione. PIA
NOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
109
Fig.4.22 a) e b): Vista esterna e vista interna del rivelatore di particelle cariche CHIMERA ai Laboratori Nazionali del Sud.
Fig. 4.23: Lo spettrometro magnetico MAGNEX , Laboratori Nazionali del Sud

2011 2012
RISORSE CNAF
2013
CPU DISK TAPEHS06 TB-N TB
CPU DISK TAPEHS06 TB-N TB
ALICE
ATLAS
CMS
LHCB
TOTAL LHCB TIER1
BaBar
SuperB (dal 2011)
CDF
KLOE
LHCB TIER2
TOTALE GRUPPO I
AMS2
ARGO
AUGER
FERMI/GLAST
MAGIC
PAMELA
Virgo
TOTALE GRUPPO II
TOTALE CNAF
EXPERIMENT
25890 1749 3098
25900 2700 3600
18850 2860 6630
16950 1425 930
87590 8734 14258
2360 350 0
2500 200 0
8000 467 15
0 33 625
7200 0 0
20060 1050 640
5400 384 220
1200 224 986
1600 160 0
1400 60 40
500 45 70
600 70 96
3500 469 660
14200 1412 2072
104430 10371 1697
29830 1653 5377
27300 3000 4000
18850 3510 7670
16500 1665 1200
92480 9828 18247
2360 350 0
2500 200 0
8000 467 15
0 33 625
7200 0 0
20060 1050 640
5400 384 220
1200 224 986
1600 160 0
1400 60 40
500 45 70
600 70 96
3500 469 660
14200 1412 2072
109320 11465 20959
22200 1501 2400
22600 2480 3000
18300 2400 6500
9750 525 520
72850 6906 12420
2360 350 0
2500 100 0
7000 300 15
5400 0 0
17260 750 15
2457 143 50
800 160 752
1200 110 0
1400 60 40
450 30 50
600 60 80
7500 469 348
14407 1032 1320
87098 7898 13755
CPU DISK TAPEHS06 TB-N TB
ai dati (file system parallelo), ha permesso di farfronte a esigenze di prestazioni molto elevate,come ad es. di far fronte ad una richiesta di accessoai dati particolarmente impegnativa da parte di unodegli esperimenti (CMS) che invece ha messo incrisi tutti gli altri centri omologhi di WLCG: in taleoccasione il CNAF ha prodotto da solo la grandemaggioranza dei 150 milioni di eventi simulati dai7 Tier-1. Il Tier1 è collegato, tramite la rete della ri-cerca italiana GARR (con un accesso a 10 Gbps),alle reti della ricerca europee e mondiali; è dotatodi un collegamento dedicato a 20 Gbps (reteLHCOPN) con il CERN e gli altri Tier1 che fannoparte dell’infrastruttura mondiale Grid a servizio diLHC (Worldwilde LHC Computing Grid, WLCG). Il Tier1 gestisce anche il servizio di trasferimento deidati per i siti WLCG italiani.La potenza di calcolo e la capacità dello storageverrano ulteriormente incrementate durante il2012 e gli impianti sono dimensionati per ospi-
tarle mantenendo completa ridondanza di tuttele componenti dell’infrastruttura e garantendoquindi la massima affidabilità e disponibilità deiservizi, anche in caso di guasti.La disponibilità del servizi informatici forniti agliesperimenti LHC, misurata da WLCG, è risultata nel2011 superiore al 99%, posizionandosi oltre lamedia degli analoghi centri Tier1. La tabella 4.1mostra le risorse di calcolo e storage installate nel2011 e quelle pianificate per gli anni successivi peri vari esperimenti.Nel corso del 2011 si sono inoltre aggiunti comeutenti del Tier1 nuovi esperimenti (Borexino,Gerda, Icarus e Kloe), portando il numero totale aoltre 20. La pianificazione dei bisogni per gli annifuturi viene aggiornata di anno in anno seguendoi risultati della presa dati. Le stime attuali prevedonouna crescita quasi lineare delle necessità di CPU estorage nel Tier1 e Tier2, in linea con l’aumentoprevisto della quantità di dati da analizzare. L’uti-lizzo delle risorse di calcolo è stato continuo pertutto il 2011, ottenendo condizioni di pieno utilizzodella CPU disponibile per più del 95% del tempo.La figura 4.25 mostra l’utilizzo della CPU al CNAFdurante il 2011; l’area rossa indica la potenza diCPU effettivamente utilizzata mentre l’area verdetiene conto anche dei tempi morti della CPU tipi-camente dovuti alla latenza introdotta alle opera-zioni di accesso ai dati. Il loro rapporto, che è unamisura dell’efficienza delle applicazioni e delle pre-stazioni del sistema di accesso ai dati, ha raggiunto
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
112
Tab. 4.1: Il piano di sviluppo delle risorse al Tier1.
dem e oltre quindici del CS, divengono giornodopo giorno più probabili. Meriterebbe un inve-stimento anche tutto il sistema di impianti e di ser-vizi di base dei LNS, anch’essi ininterrottamenteoperativi da oltre trenta anni, la cui affidabilità èpresupposto indispensabile per continuare a svol-gere le attività di ricerca attuali ed intraprenderele imprese future.
MILESTONES del periodo 2012-2014
4.2 IL CNAF
IL CNAF è il centro nazionale dell’INFN dedicatoalla ricerca e allo sviluppo nel campo delle disci-pline informatiche e telematiche e alla gestionedei relativi servizi per le attività di ricerca dell’Isti-tuto.Contribuisce, come centro di riferimento nazio-nale, sia allo sviluppo software, sia alla realizza-zione dell’infrastruttura generale di calcoloscientifico distribuito, basata sulle tecnologie diGRID dispiegate sulla rete geografica. Inoltre ge-stisce vari servizi nazionali che nel tempo sonostati gradualmente potenziati, contribuendo intal modo ad accrescere l'efficienza globale e ri-durre i costi complessivi.Dal 2003 il CNAF ospita il centro nazionale dicalcolo dell’INFN Tier1, completamente rinno-vato nella dotazione di impianti tecnologici nel2007. Costituito per gli esperimenti ad LHC, ilcentro è divenuto rapidamente un punto di ri-ferimento per il calcolo di una ventina di esperi-menti dell’INFN ed in particolare per CDF,BABAR, VIRGO, e, più recentemente, SuperB. Gli impianti tecnologici realizzati per ospitare leapparecchiature informatiche del centro Tier1possono erogare una potenza elettrica comples-siva fino a 5 MWatt. Il calore prodotto dalle ap-parecchiature informatiche può essere dissipatofino a 2 MWatt.L’impianto tecnologico è stato realizzato congruppi di nuova generazione che integrano inuna sola macchina tutte le funzioni normal-mente richieste ai gruppi elettrogeni e ai tradi-zionali gruppi di continuità in grado di erogarefino a 3,4 MWatt di energia elettrica in conti-nuità assoluta. L’impianto è affiancato anche daun gruppo elettrogeno tradizionale per ulteriori1,2 MWatt di potenza elettrica erogabile.
Attività 2011Nel 2011, con il raggiungimento di condizioni difunzionamento a regime degli esperimenti a LHC,il Tier1 ha potuto non solo garantire agli esperi-menti le risorse di calcolo aspettate, ma anche ospi-tare elaborazioni su larga scala per l’analisi dei datiinizialmente non previste fra i compiti del centro.La potenza di calcolo installata è stata pari a circa110 KHS06 per un numero di job simultanei pari a~ 8300 e con una banda passante aggregata perl’accesso allo storage (9 PB su disco e 10 PB sutape) superiore ai 30 GB/s. L’infrastruttura di sto-rage, basata su standard industriali sia a livello diconnessioni (Storage Area Network) che di accesso
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
111
Campagna di esperimenti con i fasci ra-dioattivi prodotti per frammentazione econ il multirivelatore per particelle cari-che CHIMERA;Campagna di esperimenti sulla struttura deinuclei leggeri ricchi di neutroni, utilizzandol'accoppiamento dello spettrometro ma-gnetico MAGNEX con il multirivelatore perneutroni EDEN dell'IPNO;Misura di sezioni d’urto di interesse astro-fisico con il metodo del “Cavallo di Troia”;Sviluppo di un fascio post-accelerato di15O e campagna di esperimenti di astro-fisica nucleare e di struttura nucleare;Completamento dei due laboratori mul-tidisciplinari sottomarini al largo dellacosta orientale e sud orientale siciliana eloro utilizzo in misure di interesse ocea-nografico e geofisico.Realizzazione prima parte del Rivelatoresottomarino per il progetto KM3NET;Misure sistematiche di sezioni d’urto diframmentazione nucleare e simulazioniconnesse finalizzate alla formulazionedei piani di trattamento di adroterapia;Progettazione della sorgente MISHA dadedicare all’adroterapia e costruzione diuna sorgente ECR a 24 MHz che permet-terà di estendere le potenzialità del Ci-clotrone Superconduttore dei LNS;Partecipazione al progetto europeo ESS,con la progettazione e realizzazione diuna sorgente di protoni ad alta intensità;Studio e progettazione di una linea di fa-scio di protoni accelerati in plasmi nel-l’ambito del progetto europeo ELI; Potenziamento dei sistemi di analisi nondistruttiva per la caratterizzazione di re-perti di interesse storico ed artistico e svi-luppo delle tecniche relative;Sviluppo di sistemi di monitoraggio discorie radioattive ad alta efficienza ebasso costo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fig. 4.25: Utilizzo delle risorse di calcolo del Tier1

Proseguiranno nel prossimo futuro tutte le atti-vità già in corso nel 2011.
4.3 LE NUOVE INFRASTRUTTUREDI RICERCA: SUPERB, KM3NET, GRID
L’Istituto partecipa attivamente alla costituzionedelle infrastrutture europee per la ricerca, sia conproprie iniziative specifiche sia attraverso i pro-grammi europei (Design Study, Preparatory Phase,ICT-Infrastructure) anche in coerenza con la pro-pria roadmap (vedi paragrafo 2.10) e con la road-map dell’European Strategy Forum on ResearchInfrastructures ESFRI (vedi paragrafo 3.9).Tra le infrastrutture più significative, citiamo:SuperBKM3NeTGRID
Il progetto SuperBL’INFN ha approvato nel 2009 il Progetto Spe-ciale SuperB-TDR finalizzato alla preparazionedel Technical Design Report del progetto Su-perB, che è stato approvato come progetto ban-diera nel 2010.
Si tratta di un progetto integrato che com-prende la realizzazione di un collisore elettrone-positrone di nuova generazione, denominatoSuperB, dell’apparato sperimentale e dell’orga-nizzazione delle strutture di calcolo necessariea soddisfare le esigenze del programma scien-tifico. Il programma scientifico si propone di investi-gare la fisica al di là del modello standard conlo scopo di rispondere alle domande irrisolte suimeccanismi alla base del funzionamento dellamateria a livello microscopico, responsabili del-l’evoluzione dell’universo immediatamentedopo il Big Bang. Questo obiettivo può essere raggiunto se-guendo la via dell’altissima energia, metodo uti-lizzato ad LHC, e dunque attraverso laproduzione di nuove particelle e lo studio dellaloro dinamica. SuperB utilizza un metodo com-plementare che consiste nella ricerca di piccolis-simi effetti non previsti dalle teorie oggiuniversalmente accettate aumentando a bassaenergia il numero di reazioni prodotte in labo-ratorio. L’investigazione sperimentale con que-sto secondo metodo può essere realizzata acosti decisamente inferiori al primo, grazie allenuove tecniche di accelerazione sviluppate in
ambito INFN e che permetteranno di ottenereluminosità maggiori di 1036 cm2 s-1. Inoltre saràpossibile polarizzare il fascio di elettroni a livellodell’80%, aprendo la strada a misure altrimentinon accessibili. Il programma di fisica della SuperB consiste nellostudio delle piccole deviazioni dalle previsionidel modello standard nei decadimenti di charm,beauty e leptoni tau prodotti nelle annichilazionie+ e-. Questo programma scientifico è così som-marizzato:
La polarizzazione, caratterista unica di questamacchina, costituisce uno strumento essenzialenelle misure sul tau in quanto consente:
Questa macchina può essere anche essere operataad una energia appena superiore alla soglia di pro-duzione dei mesoni con charm che permette di ef-fettuare misure sulle fasi coinvolte nel meccanismodi violazione CP nel settore del charm.
Per raggiungere la sensibilità sperimentale neces-saria per la scoperta di nuova fisica è necessarioraccogliere un numero di eventi circa 100 voltesuperiore a quelli raccolti in BABAR e BELLE.Le caratteristiche dell’acceleratore SuperB ren-dono possibile realizzare tali misure in meno di
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
114
•
•
•
•
•
•
•
Sottoporre il paradigma CKM a un test al li-vello del 1%, attraverso un ampio insieme dimisure sui decadimenti di mesoni con b, mi-gliorando di almeno un ordine di grandezzala precisione ottenuta dagli esperimentiBABAR e BELLE;Migliorare di un fattore fra 10 e 100 la sensi-bilità alla violazione del sapore leptonico (LFV)nei decadimenti di leptoni tau (τ), con possi-bilità di scoperta, che rappresenterebbe unsegnale non ambiguo della presenza dinuova fisica. Queste misure sono comple-mentari a esperimenti dedicati sui muoni epossono permettere di distinguere fra modellidiversi di violazione;Esplorare la violazione di CP nei decadimentidel charm;Studio con alta statistica della spettroscopia,alla scoperta di nuovi stati;
Il controllo dei fondi fisici irriducibili nei deca-dimenti LFV del τ;Esplorare la violazione di T nella fisica del τ; Esplorare una possibile struttura magneticadel τ.
valori molto soddisfacenti (84%). Il Servizio Ope-rativo di Grid del CNAF, in collaborazione conl’unità Gestione Operativa del progetto specialeIGI, ha poi fornito i servizi Grid necessari permantenere stabile ed efficiente l’infrastrutturaGrid sia a livello nazionale che internazionale esoddisfare le esigenze operative e delle comu-nità di utenti.In particolare si è occupata di garantire un buonlivello di funzionalità dell’infrastruttura nazio-nale in collaborazione con i gestori dei siti, for-nendo supporto specialistico di primo e secondolivello agli utenti degli esperimenti e agli ammi-nistratori di sito. Il servizio gestisce i servizi Gridcentrali per autenticazione, sottomissione di job,monitoraggio e accounting nell’NGI e partecipaad attività di sperimentazione e certificazionedel middleware Grid contribuendo ad attività disviluppo di tool operativi per monitoring e ac-counting. Nel 2011, il servizio Ricerca e Svi-luppo, in collaborazione l’Unità di Ricerca,Progettazione e Mantenimento del Middlewaredi IGI, ha proseguito le attività di sviluppo man-tenendo costantemente aggiornati alcuni com-ponenti software fondamentali in uso in tuttal’infrastruttura GRID: VOMS, WMS, CREAM,StoRM, ARGUS, DGAS.Inoltre sono proseguite le attività di sviluppo incollaborazione con il Tier1, riguardanti l’utilizzodella virtualizzazione su larga scala (progettoWnoDes), sia con sottomissione di job dallaGrid, con la possibilità di selezionare specificiambienti virtuali, sia attraverso una nuova inter-faccia di tipo “Cloud”.All’attività di supporto degli esperimenti, svoltada uno gruppo di giovani con competenze spe-cifiche nelle applicazioni utilizzate in ambitoscientifico, che ha provveduto a manteneresempre aggiornati i relativi complessi ambientispecifici di esecuzione, si è affiancata nel 2011una attività di sviluppo software orientata allarealizzazione dei moderni framework di elabo-razione dei dati di cui si servono oggi gli esperi-menti, in particolare quelli che produconograndi moli di dati. Tale attività, che necessitaoggi di specifiche competenze informatiche, siè indirizzata inizialmente allo studio dell’evolu-zione dei framework attuali per lo sfruttamentodelle moderne CPU a molti core in particolareper l’esperimento SuperB.Oltre ai compiti in ambito scientifico, il CNAF hainoltre la responsabilità di garantire il funziona-mento di diversi servizi informatici nazionalidell’Istituto che, nel corso del 2011 sono stati
sfruttati in modo sempre più esteso. Ad esem-pio, i server web di esperimenti e progetti INFNinstallati su server dedicati al CNAF sono arrivatia oltre una quarantina, mentre diverse centinaiasono le mailing list gestite per l’ambito INFN. Il gruppo multimediale del CNAF ha continuatola sua attività sia come produzione video, checome streaming. Il Centro gestisce inoltre levideo e fono-conferenze per tutto l’INFN checomplessivamente utilizzano il sistema per circa55.000 ore al mese. Il CNAF istruisce e gestisce contratti nazionaliper manutenzioni hardware di apparati installatiin tutte le sedi ed acquisti e manutenzioni disoftware distribuito a livello nazionale per quasi1 M€ l’anno. Infine, dall’aprile del 2011, è col-locato e gestito presso il CNAF il cluster cheospita il sistema informatico dell’INFN. Il pas-saggio dalla piattaforma precedente, a quellaattuale, basata su moderni elaboratori e sistemaoperativo Linux, ha prodotto una diminuzionedrastica dei tempi di risposta delle applicazioni.Il servizio offerto dal centro si è ampliato note-volmente nel corso del 2011 dall’iniziale incaricodi gestione sistemistica del cluster a compren-dere vari altri compiti correlati con la gestionedelle applicazioni e dell’assistenza agli utenti.
Piani di sviluppo per i prossimi anniIl Tier1 del CNAF è in grado di ospitare le risorseper gli esperimenti a LHC per tutto il loro ciclodi vita, secondo quanto attualmente previsto neipiani per il calcolo approvati. Nell’aprile del2012 verranno installati nuovi server per unapotenza di calcolo complessiva di circa 40KHS06 aggiuntiva e sistemi di storage su discoper ulteriori 3 PB per far fronte alle esigenzedegli esperimenti, in particolare di quelli al LHC.Nel corso dell’anno avrà luogo anche un poten-ziamento della libreria di cassette magnetichecon nuovi drive in grado di quintuplicare la ca-pacità della stessa fino a 50 PB di dati disponibilionline.Nel corso del 2012 diventerà anche operativaGARR-X, l’evoluzione della rete della ricerca ba-sata sull'utilizzo di fibre spente. Il CNAF che ospitanelle sale del Tier1 un nodo centrale di GARR-X,potrà quindi ampliare secondo le esigenze di tra-sferimento dati degli esperimenti il numero di col-legamenti a 10 Gbps con il CERN e con altri centriTier1 attraverso LHCOPN, e con i Tier2 tramiteuna seconda rete dedicata, LHCONE. È previsto che a fine 2012 il CNAF sia collegatocon il CERN a 100 Gbps.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
113

rantire uno sforzo ben coordinato sia in personaleche in componenti strumentali, senza sprechi osovrapposizioni. Questo può essere ottenuto,oltre che con MOU bilaterali, anche con la possi-bile costituzione di una ERIC (European ResearchInfrastructure Consortium) come previsto dallenorme europee. Nel 2011 si è sviluppato ulterior-mente il TDR, in particolare l’analisi della competi-tività del programma sperimentale confrontatocon quello dell’esperimento LHCb, di futura gene-razione. Ne è risultato rafforzato il ruolo di “mac-china da scoperta” che potrà avere SuperB anchein questo scenario competitivo.Nella tarda primavera 2011 è stata presa la deci-sione, appurata l’idoneità del sito, di prevedere lacostruzione dell’acceleratore sul campus dell’Uni-versità Roma Tor Vergata, rispondendo positiva-mente alla disponibilità offerta dall’Università conuna lettera del suo Rettore pro tempore. Nel Luglio2011 è stata varato dall’INFN lo statuto del costi-tuendo consorzio “laboratorio Nicola Cabibbo”costituito in fase di fondazione dall’Università diRoma Tor Vergata e dall’INFN con lo scopo di co-struire e successivamente operare l’infrastruttura diricerca e con il mandato, ove possibile, di costituirela prima parte di un percorso mirante alla costitu-zione di una infrastruttura di ricerca europea (ERIC).Tale statuto è stato approvato dal MIUR e il 7 otto-bre 2011 il consorzio è stato costituito. Tale costi-tuzione, assieme alla erogazione di cassa del primocontributo 2010 pari a 19 Milioni di euro creano lecondizioni per la vera partenza della fase di costru-zione. Nel 2012 sono previste la costituzione dellastruttura amministrativa del consorzio e il comple-tamento della governance del progetto e del teamche lo realizzerà. Inoltre saranno stipulati accordiinternazionali per l’utilizzo di componenti dell’ac-celeratore di Slac, per la partecipazione di espertistranieri alla costruzione e per la realizzazione dispecifiche componenti dell’acceleratore. Le offerteeventuali riguardanti la fornitura esterna dellecomponenti sarà vagliata da apposite commissionidi esperti che dovranno accertare la rispondenzadelle specifiche a quelle del progetto,Entro l’estate, come da statuto, il laboratorio redi-gerà une relazione sui costi del progetto che saràsottoposta all’approvazione del comitato finanzepreposto a vigilare sulla congruità delle risorse conle finalità preposte. In autunno si pensa di “con-gelare” i parametri della macchina per permetterdi procedere alla stesura del progetto edilizio ese-cutivo senza che questo subisca successivamentevariazioni onerose sia dal punto di vista economicoche temporale. Per la fine del 2012 si prevede di
essere in grado di lanciare gli ordini per quellecomponenti che sono in affidamento “esterno” enei primi mesi del 2013 di essere in grado, termi-nato il progetto esecutivo edilizio, di lanciare legare edilizie. Lo sviluppo dell’alta tecnologia e degliordini associati, delle procedure di trasferimentodelle componenti riutilizzate di SLAC e il comple-tamento della infrastruttura edilizia dell’accelera-tore nella prima metà del 2014 consentirannonella seconda metà del 2014 di procedere conl’inizio dell’installazione di alcune componenti del-l’acceleratore tra le quali probabilmente il Linacper il quale si prevede il funzionamento in anticiposul resto dell’acceleratore per permetterne lamessa a punto prima dell’attivazione delle sezionicircolari.Dal punto di vista del personale, si prevede di cre-scere da una ventina di dipendenti nel 2012 ameno di una quarantina a regime verso il 2014,tenuto conto delle unità esterne che verrannomesse a disposizione del progetto dall’INFN edaltre istituzioni italiane e straniere. La realizzazionedel rivelatore mostrato in Fig. 4.26b, anche esso inlarga parte basato sul riutilizzo di parti dell’appa-rato dell’esperimento BABAR di SLAC, anche essida trasferire in Italia, implica comunque un pro-gramma aggressivo di R&S su parti cruciali come ilrivelatore di vertice, il sistema di identificazione diparticelle, parte del calorimetro elettromagnetico,una camera a deriva ad alta accettanza ed il rifaci-mento dei rivelatori di muoni. Infine sarà necessa-rio sviluppare l’infrastruttura di calcolo capace diimmagazzinare ed analizzare la grande mole didati che verranno raccolti a SuperB. Essa si baseràsulla infrastruttura distribuita GRID, incentrandosisu alcuni grandi centri di calcolo localizzati princi-palmente nel sud Italia.
Per tale realizzazione si conta di potersi avvaleredi finanziamenti derivanti dall’approvazione diprogetti PON.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
116
Fig. 4.27: Schema del collisore elettrone-positrone Super-B.
5 anni con i seguenti parametri:
• Energia nel CM aggiustabile: dalla soglia diproduzione di τ fino alla produzione di Υ(4s);
• Boost di Lorentz βγ~0.238 (~4.18x6.7GeV); • Luminosità >1036 cm2 s-1 @ Υ(4s) -1; • Luminosità integrata > 75 ab-1 in 5 anni(stima basata sul comportamento delle B-Fac-tories PEPII e KEKB);
• Polarizzazione (65-85%) di uno dei due fasci; • Potenza dissipata in totale < 30 MW.
Questi parametri sono stati esaminati dal comi-tato di valutazione della macchina (MiniMac)che li ha giudicati compatibili con il progetto diacceleratore sotto studio e che è basato sull’im-piego di nano-fasci, ottenibili grazie agli sviluppiportati avanti con successo presso i LaboratoriNazionali di Frascati.Dopo il Conceptual Design Report (CDR) pub-blicato nel 2007, un documento preliminare alTDR, ma già contenente larga parte delle infor-mazioni tecniche e costituito dalle tre sezioni:
• programma di fisica • acceleratore • rivelatore
Nel 2010 sono stati pubblicati tre documenti in-termedi (Progress Report), già citati nel cap. 3. Il completamento del Technical Design Report èatteso per la fine 2011. Il collisore ad alta luminosità SuperB, oltre all’im-piego discusso brevemente sopra, con il fine,
attraverso misure di precisione, di studiare pro-cessi che consentano di capire le caratteristichedella nuova fisica al di là della teoria standard,
si presta in modo naturale ad impieghi multidi-sciplinari con importanti ricadute nello sviluppodi nuove tecnologie. A questo proposito è evi-dente il ruolo importante che riveste la sinergiacon i programmi dell’IIT che caratterizza inmodo determinante le ricadute applicative diSuperB; infatti è possibile ad esempio uno sfrut-tamento ottimale dell’acceleratore come sor-gente di luce pulsata ad alta brillanza. Lecaratteristiche di tale sorgente sono competitiverispetto alle macchine esistenti, come mostratoin Fig 4.26. In proposito è importante sottoli-neare che la realizzazione di varie linee di lucerende l’infrastruttura la prima al mondo checombini ricerche di frontiera nell’indagine delleforze fondamentali del Cosmo con una facilityinterdisciplinare per lo sviluppo di nuove tecno-logie di Imaging, Life-Nanoscience e Analisi finedella materia organica, inorganica e biologica. Ipiani dettagliati della parte relativa all’IIT sonodescritti nel Piano Scientifico di quell’istituto. Gliimpieghi in scienza della materia e per applica-zioni biotecnologiche permetteranno un pe-riodo di impiego di SuperB per alcune decadi,ben al di là del tempo di vita di un acceleratoreper fisica fondamentale che solitamente è del-l’ordine di un decennio.Nella fase di preparazione e costruzione dell’ac-celeratore e del rivelatore sarà dedicata una par-ticolare attenzione a tutti gli sviluppi capaci diricaduta tecnologica su altre discipline e sulletecnologie ad esse correlate.Vista la natura internazionale del progetto conuna larga partecipazione di fisici e di esperti di
acceleratori da vari paesi dell’Unione Europea,ma anche dalla Russia, dagli USA, e dal Canada,è necessaria una organizzazione efficiente per ga-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
115
Fig. 4.26 a e b: Caratteristiche spettrali della luce di sinctrotrone prodotta in SuperB nei magneti di piegatura e negli ondulatori.

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda,Regno Unito, Romania e Spagna. Nel progettosono coinvolte nove tra laboratori e sezioni del-l’INFN e le Università ad esse collegate: Bari, Bo-logna, Catania, Genova, Napoli, Pisa, Roma 1,LNF e LNS, con una partecipazione di circa 80ricercatori e tecnologi.Il consorzio KM3NeT è stato finanziato dallaCommissione Europea con due progetti. Un De-sign Study, sviluppato dal 2006 al 2009 nell’am-bito del VI Programma Quadro che ha usufruitodi un contributo di 9 M€. Un progetto di Pre-paratory Phase, iniziato nel 2008 e che si con-cluderà nel 2012, finanziato nell’ambito del VIIProgramma Quadro con un contributo di 5 M€.Il coordinamento di quest’ultimo progetto è af-fidato all’INFN.Il Design Study ha studiato le soluzioni tecnolo-giche proposte dai membri del consorzio e de-finito un disegno tecnico, con alcune opzionialternative di backup, illustrato in un TechnicalDesign Report.Un’infrastruttura di ricerca come KM3NeT avràbisogno di una struttura internazionale di go-vernance che permetta ai paesi finanziatori distabilire un’adeguata entità legale, di coordinarelo sviluppo del progetto e di prendere le deci-sioni strategiche e finanziarie necessarie.L’esatta definizione di questa struttura è unodegli obiettivi principali del progetto di Prepara-tory Phase. Un candidato naturale per la strut-tura legale può essere l’European ResearchInfrastructure Consortium (ERIC) recentementeapprovato dalla EC. Tra gli obiettivi del progettovi è anche l’esplorazione di potenziali sorgentidi risorse finanziarie su scala regionale, europeaed internazionale.Per l’installazione del telescopio KM3NeT sonostati candidati tre siti: uno al largo di Tolone(Francia), dove è installato l’esperimento ANTA-RES, uno al largo di Pylos (Grecia), studiato dallacollaborazione NESTOR, ed uno al largo di CapoPassero (Italia), proposto dalla collaborazioneNEMO dell’INFN. Su questi siti sono già presentidelle infrastrutture. Sono in corso analisi tecni-che e valutazioni sulle performance del telesco-pio per considerare la possibilità di costruirlo inpiù blocchi indipendenti. Pertanto l’infrastrut-tura potrà essere installata in un singolo sito odistribuita su più siti. L’INFN ha avviato un’attività di Ricerca & Svi-luppo in questo settore attraverso la collabora-zione NEMO, finanziando, nel corso degli ultimitredici anni, lo studio e la caratterizzazione del
sito sottomarino di Capo Passero, l’ideazionedell’architettura generale del telescopio, lo svi-luppo di tecnologie innovative per il progetto ela realizzazione di prototipi. Alcune di queste at-tività sono state cofinanziate dal MIUR e dallaRegione Sicilia attraverso il progetto LAMS sulPON 2001- 2006, il progetto SIRENA su fondiMIUR e il progetto PEGASO sul POR Sicilia 2000-2006. Le competenze acquisite sono confluitenel consorzio KM3NeT consentendo alla colla-borazione italiana di assumere all’interno delconsorzio un ruolo di grande visibilità. Da partedell’INFN un importante investimento è statofatto nella realizzazione delle infrastrutture sot-tomarine.Una è stata realizzata al largo di Catania a 2000m di profondità per attività di test di prototipi eapplicazioni multidisciplinari, ed una sul sito diCapo Passero a 3500 m di profondità. Ciascunadi queste infrastrutture comprende una stazionedi terra, un cavo elettro-ottico sottomarino e leinfrastrutture di profondità per la connessionedegli apparati sperimentali.Entrambe sono oggi operative. Presso il Test Sitedi Catania è stato installato ed operato nel 2007l’apparato pilota NEMO Fase-1. La stazioneospita esperimenti di carattere multidisciplinaretra cui l’osservatorio SN-1 dell’INGV (Istituto Na-zionale di Geofisica e Vulcanologia), dotato distrumenti per il monitoraggio sismico ed ambien-tale. In parallelo con le attività mirate alla costru-zione del telescopio per neutrini, grandeattenzione è stata posta nello sviluppo delle ricer-che multidisciplinari, in collaborazione con altrienti ed istituti di ricerca nazionali e stranieri.Nell’ambito del progetto ESONET, che ha comeobiettivo la realizzazione di una rete di osserva-tori permanenti multidisciplinari lungo le costeeuropee, è stato lanciato un programma miratoalla realizzazione di una stazione di monitorag-gio acustico per lo studio del rumore di fondoacustico ed il monitoraggio di segnali di originebiologica, da installare presso il Test Site dei LNSal largo di Catania e che sarà operata in comuneda ricercatori INFN, INGV, CNR e CSIC (Spagna).Negli anni recenti l’INFN si è dotato di una in-frastruttura sottomarina sul sito candidato diCapo Passero (figura 4.29).Il sito, a 3500 m di profondità e a circa 80 kmdalla costa, è connesso a terra con un cavo elet-tro-ottico di 100 km di lunghezza. L’infrastrut-tura sottomarina alloggia un convertitore dipotenza DC/DC da 10 kW realizzato da Alcatelsulla base di un progetto innovativo specifica-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
118
L’infrastruttura KM3NeT KM3NeT è un’infrastruttura di ricerca multidi-sciplinare il cui principale obiettivo è l’osserva-zione di neutrini di alta energia di originecosmica. I neutrini sono particelle prive di caricae interagiscono così debolmente con la materiache possono raggiungere la Terra dal cuoredenso dei più potenti acceleratori cosmici e daiconfini più remoti del cosmo preservando la di-rezione di origine. Rappresentano quindi unasonda ideale per la comprensione dell’originedei raggi cosmici e dei meccanismi che gover-nano gli ambienti astrofisici più estremi, in cuile particelle cariche vengono accelerate fino aenergie milioni di volte più elevate delle energieraggiungibili con i più potenti acceleratori oggiesistenti, come LHC. L’avvio dell’astronomia conneutrini aprirà una nuova finestra di osserva-zione che consentirà di estendere la nostra co-noscenza dell’Universo “violento” in cui lampidi luce gamma brillano per brevi istanti con in-tensità pari a miliardi di miliardi di Soli, NucleiGalattici Attivi emettono enormi quantità dienergia, stelle massicce esplodono e buchi neriinghiottono enormi quantità di materia. La rea-lizzazione di un telescopio per neutrini di altaenergia, a causa della rarità dei segnali prodottida interazione neutrino-materia e della difficoltàdi rivelazione dei neutrini, può essere affrontatasolo utilizzando miliardi di tonnellate di mezzinaturali come l’acqua o il ghiaccio a migliaia dimetri di profondità. La tecnica consolidata perla realizzazione del rivelatore si basa sul traccia-mento dei muoni secondari prodotti nelle inte-razioni di neutrini con il mezzo trasparente(ghiaccio o acqua) in prossimità del rivelatore.Questi muoni relativistici producono radiazioneelettromagnetica Cherenkov, che può essere rive-lata da un’opportuna matrice di alcune migliaiadi sensori ottici (fotomoltiplicatori), consenten-done il tracciamento. In questo schema il mezzonaturale svolge sia la funzione di rivelatore che dischermo per attenuare il fondo prodotto dai raggicosmici. Le sfide tecnologiche che una simile im-presa comporta hanno richiesto molti anni di studidi fattibilità e un’intensa attività di ricerca e svi-luppo. Oggi, grazie all’esperienza dei progettipilota di prima generazione, le tecnologie sonomature per affrontare la realizzazione di osser-vatori di neutrini della scala del km3.Per osservare l’intero cielo sono necessari duetelescopi di neutrini posizionati in emisferi op-posti. La costruzione di IceCube, un telescopioda un kilometro cubo che osserva l’emisfero
Nord, nelle profondità dei ghiacci dell’Antartide,è stata completata a fine 2010. Il telescopio pro-posto dalla collaborazione europea KM3NeT, in-stallato nel Mediterraneo, grazie alla rotazionedella terra osserverebbe l’87% del cielo, com-preso il Centro Galattico e la maggior parte delPiano Galattico in cui sono stati individuati nu-merosi oggetti candidati come sorgenti di neu-trini di alta energia. La costruzione di untelescopio per neutrini nelle profondità del MarMediterraneo (a circa 3000 m di profondità) ri-chiede la soluzione di problemi tecnologicimolto complessi, dovuti alle condizioni ambien-tali estreme: pressioni enormi (centinaia di bar),corrosione dei componenti da parte dell’acquamarina, ecc. Inoltre, data la limitata accessibilitàdel telescopio, la strumentazione deve avere unalto grado di affidabilità e ridondanza tale daminimizzare il numero e la complessità degli in-terventi di manutenzione. Le operazioni di posa,che devono essere effettuate con robot control-lati dalla superficie, devono essere sicure, “ro-buste” e precise. Il progetto KM3NeT sfruttal’esperienza accumulata dai progetti pilota ope-ranti nel Mar Mediterraneo (Antares, Nemo, Ne-stor) e il know-how di altre discipline e industrieoperanti ad alte profondità marine.KM3NeT, grazie all’unicità del suo potenzialescientifico multidisciplinare e alla maturità delprogetto dal punto di vista tecnologico, è statoselezionato nel 2006 dal panel di ESFRI (Euro-pean Science Forum for Research Infrastructu-res) tra le 35 infrastrutture di ricerca ad altapriorità e successivamente confermato nei pro-cessi di revisione del 2008 e 2010.L’infrastruttura KM3NeT offre anche un’eccezio-nale possibilità di ricerca per un ampio spettro diattività scientifiche e tecnologiche che compren-dono scienze ambientali, geologia, geofisica,oceanografia e biologia marina, consentendo perla prima volta il monitoraggio in linea ed in temporeale di grandezze fisiche e biologiche di grandimasse d’acqua anche a profondità abissali. Inoltrel’infrastruttura potrà fornire informazioni rile-vanti per il sistema di allerta sismico; in partico-lare KM3NeT costituirà un nodo importante inun network globale di osservatori sottomariniintegrato con la rete EMSO (European Multidi-sciplinary Seafloor Observatory), che è un’altradelle grandi infrastrutture europee di ricerca in-dividuate da ESFRI e coordinata dall’INGV.KM3NeT è un consorzio europeo a cui parteci-pano 21 istituzioni di 10 paesi. Oltre all’Italia,rappresentata dall’INFN, sono presenti Cipro,
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
117

circa 30 strutture. Questo apparato, che fungeràda dimostratore tecnologico del telescopio, saràcomunque dieci volte più sensibile di ANTARESe consentirà l’osservazione del cielo australe edella reguone del centro galattico con sensibilitàcomparabile con quella di IceCube. Come pro-spettiva a più lungo termine, a partire dal 2015,si propone l’espansione dell’apparato fino acirca 100 torri.
GRIDDa molti anni l’Istituto ha dedicato sforzi e risorsenella costruzione di una Grid di produzione ita-liana al fine di prepararsi ad affrontare l’impegnodell’analisi dei dati all’LHC. Questo scopo è statoperseguito a vari livelli: con il proprio progettospeciale INFN-GRID (vedi paragrafo 3.8) e con inumerosi progetti in collaborazione sia italiani (ades. FRIB Grid.it) sia europei, rivolti alla costruzionedi una Grid europea per la ricerca, come Data-Grid, EGEE-I, II, III ed ora alla sua gestione soste-nibile con l’European Grid Initiative (EGI) ed ilprogetto EGI InSPIRE e allo sviluppo e consolida-mento di un middleware europeo open con il pro-getto European Middleware Initiave -EMI (vediparagrafo 3.9).Le attività Grid dell’INFN stanno evolvendo indue distinti progetti speciali: INFN-GRID e IGI.INFN-GRID continuerà a coordinare le risorsegrid dell’INFN e la loro partecipazione a wLCG;IGI, che in una prima fase è un progetto specialeINFN ma in breve confluirà in una entità legaleautonoma, è e continuerà ad essere estrema-mente importante per l’INFN poiché fornirà variservizi indispensabili per gli esperimenti INFN.
IGINel corso del 2011 è iniziato il processo per de-finire più precisamente il business model e av-viare le attività della costituenda Sc.a r.l.“CONSORTIUM IGI”.La realizzazione del “CONSORTIUM IGI” è statadecisa dal MIUR a fine 2010, in linea con unprocesso in corso a livello europeo, con l’attri-buzione di un finanziamento dal Fondo di Finan-ziamento Ordinario per la Ricerca “per l’avvio diIGI” all’INFN, quale ente capofila per l’Italia diuna JRU – Joint Research Unit – già designatadal MIUR nel passato a costituire il punto di ri-ferimento nazionale per la gestione delle infra-strutture grid distribuite per il calcolo scientificoavanzato coordinate dall’European Grid Initia-tive - EGI. Il finanziamento, di 2 M€ a valere sul bilancio
2010, è stato riconfermato per lo stesso importoa valere sul bilancio 2011 del MIUR. La JRU IGIè, a gennaio 2012, costituita dai seguenti membriche storicamente hanno contribuito ai progettigrid o hanno chiesto di collaborare su questa tec-nologia:
1. CASPUR2. CILEA3. CNR4. ENEA5. GARR6. INAF7. INFN8. INGV9. SISSA10. COMETA11. COSMOLAB12. ELETTRA13. SPACI14. Università degli Studi del Piemonte Orient.15. Università degli Studi di Napoli Federico II16. Università degli Studi di Perugia17. Università della Calabria.
Con i fondi MIUR IGI ha potuto stabilizzare sufondi ordinari quel nucleo di persone con com-petenze uniche e di eccellenza che si è formatonelle organizzazioni di ricerca Italiane durantedieci anni di partecipazione di successo e diprimo piano a numerosi progetti europei dedi-cati allo sviluppo di infrastrutture GRID per il cal-colo e l’archiviazione distribuiti.Questo nucleo costituisce una solida base perpoter continuare a competere validamente peri futuri finanziamenti previsti in Horizon 2020per questo settore e poter mantenere, grazie aquesti, l’attuale infrastruttura GRID e CLOUDnazionale agli attuali livelli di eccellenza mon-diale, agendo come motore d’innovazione a li-vello nazionale in questo campo.I progetti Europei connessi a GRID hanno per-messo al solo INFN, di ottenere, nel periodo2001-10, un finanziamento complessivamentesuperiore a 22 Milioni di Euro (su 31 progetti ap-provati) che, aggiunto a quelli degli altri enti diricerca e consorzi (ad esempio il finanziamentoottenuto dal Dipartimento ISTI del CNR), rappre-sentano il livello più alto di finanziamento otte-nuto da un singolo paese dalla CommissioneEuropea (CE) in questo decennio in questocampo.I finanziamenti dei progetti europei - spesso au-mentati da investimenti nazionali, partendo dal
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
120
mente sviluppato per applica-zioni sottomarine.In una stazione di terra, collo-cata nell’area del porto di Por-topalo di Capo Passero (SR)sono alloggiati la parte di terradel sistema di potenza e gliapparati di acquisizione dati.L’edificio comprende ancheuna seconda parte, che ospi-terà un padiglione per l’as-semblaggio e il test di grandistrutture meccaniche, la cui ri-strutturazione è programmatain futuro.Con il progetto PEGASO, cofi-nanziato dalla Regione Sicilia erealizzato dall’INFN in collabo-razione con l’INGV, si è ancheacquisita una infrastruttura perle operazioni in acque profondeche comprende un robot con-trollato dalla superficie in gradodi ispezionare e manipolare lastrumentazione di profondità edi un sistema adatto all’installa-zione ed al posizionamento con
grande precisione delle strutture sottomarinepiù pesanti. Nel Technical Design Report il con-sorzio KM3NeT ha delineato lo sviluppo tempo-rale delle azioni previste per arrivare allacostruzione del telescopio, che comporta l’avviodella fase di costruzione dopo il completamentodei test sui prototipi in corso nell’ambito del pro-getto di Preparatory Phase. Per quanto riguardale dimensioni dell’apparato, la collaborazione siè posta l’obiettivo finale molto ambizioso di su-perare di almeno sei volte su tutto il cielo osser-vabile la sensibilità di ICECUBE.Il raggiungimento di questo obiettivo comportala realizzazione di un apparato composto dacirca 300 strutture di rivelazione a torre, cia-scuna di 800 m di altezza e spaziate tra di lorodi 180 m, occupanti un volume totale di 5 km3
(figura 4.28). Il costo complessivo è valutato incirca 220 milioni di Euro.La complessità di un tale apparato impone che siarealizzato con più cluster, ciascuno comprendentedalle cinquanta alle cento strutture. I cluster po-tranno essere collocati o in un singolo sito, sepa-rati da alcuni chilometri, o in più siti. Grazie allasua modularità, l’acquisizione di dati scientificipotrà essere avviata sin dall’installazione delleprime strutture e la costruzione potrebbe avan-zare per stadi successivi, di crescente potenzialità,modulata sulla disponibilità delle risorse.Già da diversi anni la Regione Siciliana haespresso l’intenzione di concorrere al reperi-mento dei fondi necessari per la costruzionedella struttura a Capo Passero, ricorrendo afondi strutturali. Come conseguenza, una primafase del progetto è stata recentemente finan-ziata dal MIUR sul PON 2007-2013 “Ricerca eCompetitività” per un totale di 20,8 milioni diEuro. Con questo finanziamento l’INFN intendeavviare la prima fase di costruzione del nodo ita-liano di KM3NeT, realizzando un apparato di
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
119
Fig. 4.28: Visione artistica della torre di KM3NeT.SuperB nei magnetidi piegatura e negli ondulatori.
Fig. 4.31 Deployment di un prototipo meccanico della torre NEMO
Fig. 4.29: Schema di posizionamento del cavo sottomarino nel sito diCapo Passero.
Fig. 4.30: Foto scattata durante le operazioni di connessione della torreal box di alimentazione alla profondità di 2000 m.

d’Europa. È costituita da 58 data centers grandie piccoli distribuiti sul territorio nazionale cherendono disponibili via GRID complessivamentecirca 30.000 Cpu per il calcolo di vario tipo, 30PByte per l’archiviazione su disco e 10 PByte perl’archiviazione su nastro. È utilizzata da circa2.000 ricercatori appartenenti a 10 grandi areedi ricerca che comprendono fisica, biologia, chi-mica computazionale, astrofisica, medicina,scienze ambientali ed è parte integrante dell’in-frastruttura europea distribuita di EGI che oggiè costituita da più di 350 data centers, rende di-sponibili più di 300.000 Cpu, 200 PByte di sto-rage ed è usata da circa 18.000 ricercatori.
Il finanziamento ricevuto dal MIUR è servito a:
IGI in stretta collaborazione con i partner ha ini-ziato nel 2011 a svolgere più in dettaglio le se-guenti attività:-- Operare e gestire i servizi dell’infrastruttura diGRID e CLOUD nazionale, ottenuta dalla fede-razione e condivisione di risorse e servizi distri-buiti dei principali enti e consorzi di ricercaitaliani associati;-- Gestire l’integrazione dell’infrastruttura nazio-nale con quella delle altre 40 National GRID Ini-tiaves – NGI europee e dei paesi associati chesono parte di EGI e unitariamente gestiscono eoperano l’infrastruttura europea insieme alla
struttura di coordinamento EGI.eu da esse fi-nanziata; -- Sviluppare e mantenere a livello nazionale edeuropeo il middleware grid open necessario perpermettere ai ricercatori l’accesso e la condivi-sione sicura delle risorse di calcolo, storage, datie servizi disponibili nei centri di EGI avendo inparticolare la responsabilità:
-- Cominciare a fornire ed estendere con il rile-vante contributo dei soci il supporto agli utentidelle varie aree di ricerca per:
Più in dettaglio IGI ha assunto con personaleproprio pagato su fondi MIUR:-- La responsabilità dell’installazione, certifica-zione e gestione dei Servizi GRID di sito che in-cludono: • L’interfaccia unificata alle risorse di calcolo; • L’interfaccia ai sistemi di archiviazione;
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
122
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avviare l’organizzazione di IGI come un Pro-getto Speciale dentro l’INFN, ma gestito au-tonomamente dai partners della JRU, che haprogressivamente assunto dall’INFN, con per-sonale proprio pagato su fondi MIUR, la re-sponsabilità dello sviluppo e della gestionedell’infrastruttura grid nazionale;Avviare una struttura centrale a Bologna, viaRanzani, in apposita sede; Trasferire dall’INFN e altri partners le attività tec-niche all’interno di apposite unità di IGI che, incollegamento con le varie iniziative europee, sioccupano per tutti dello sviluppo e manteni-mento del middleware GRID e CLOUD, del-l’operazione dei servizi necessari alla gridnazionale ed europea e del supporto alle co-munità di ricerca e delle attività di formazione;Dare il via al programma di realizzazione dipoli di aggregazione locali o di settore chegestiscano unitariamente le risorse ICT dispo-nibili e l’integrazione di queste con l’infra-struttura nazionale di IGI e quella europea diEGI oltre al supporto specifico alle comunitàdi riferimento.
Del mantenimento e della release a livello eu-ropeo del middleware usato in EGI e svilup-pato e mantenuto dall’European MiddlewareInitiave – EMI e del suo adattatamento alleesigenze della GRID italiana (e anche dellaCLOUD in un prossimo futuro); Dello sviluppo e del mantenimento dellecomponenti di middleware di responsabilitàitaliana molte delle quali sono usate in tutti icentri europei e qualcuna anche negli USA;Dell’interfacciamento, oltre che verso il pro-getto Europeo EGI InSPIRE, anche verso l’Eu-ropean Middleware Initiative (EMI) di cuicostituisce uno dei principali partners.
Il porting delle applicazioni, l’implementazionedi use case e lo sviluppo di framework di lavoroanche all’interno di collaborazioni internazio-nali capaci di sfruttare al meglio l’infrastrutturaGRID e CLOUD nazionale ed internazionale. Inparticolare è stata avviata a livello europeo enazionale una stretta collaborazione con le ini-ziative nella roadmap di ESFRI ai fini della indi-viduazione di piattaforme di settore chepossano sfruttare al meglio i servizi GRID eCLOUD disponibili nell’infrastrttura europea ein quelle nazionali;L’interazione regolare con utenti e fornitoridi risorse per la raccolta di nuove esigenze dievoluzione dell’infrastruttura da soddisfarecon la realizzazione di nuovi componenti e/olo sviluppo di quelli esistenti; L’organizzazione periodica di attività di forma-zione e aggiornamento rivolte sia agli ammini-stratori delle risorse sia agli utilizzatori finali.
basso da esigenze non soddisfatte del mondodella ricerca e in collaborazione con progetti si-mili in USA e Giappone - hanno portato al su-peramento del modello tradizionale e rigido dicalcolo scientifico in voga fino alla fine deglianni ’90, basato sull’accesso a risorse con archi-tetture predefinite in generale costose, forniteda un singolo centro, realizzando in Europa l’in-novativa European GRID Infrastructure – EGI enel mondo altre infrastrutture simili. EGI è oggila più grande infrastruttura GRID del mondo, ot-tenuta tramite l’uso del nuovo middleware opensource grid (e in un prossimo futuro CLOUD, giàin fase avanzata di sviluppo) che permette di fe-derare e rendere condivisibili in modo robusto,scalabile e flessibile, attraverso interfacce comuni“standard”, risorse di calcolo di varia natura, sto-rage e servizi disponibili in più di 350 centri dicalcolo dei paesi europei, in generale basati surisorse commodity (High Throuput Computing)e su architetture diversificate, adattate alle esi-genze degli utenti, che includono anche l’HighParallel Computing – HPC commodity. Per lo sviluppo dei sistemi HPC più spinti, da dedi-care al calcolo parallelo con migliaia di processoriusati simultaneamente, la Commissione Europeaha promosso e finanziato in parallelo a EGI l’ini-ziativa complementare PRACE, a cui l’Italia parte-cipa con il CINECA. Nel grafico seguente sonoriportate le percentuali di finanziamento daparte dell’Unità Geant and e-Infrastructuresdella DG INFSO (Direction General of Informa-tion Society) presentato il 25 gennaio 2010 al"Research Infrastructures" Committee. La posi-zione di eccellenza dell’Italia risulta chiaramenteanche rispetto a paesi con maggiore tradizionee molto maggiori investimenti nel campo IT.
Con i servizi GRID e CLOUD di sito l’accesso uni-forme e l’uso condiviso delle risorse e servizi dimolti centri diversi diventa possibile ed indipen-dente dalle specificità e varietà delle soluzionitecniche adottate da questi. La disponibilità diservizi GRID centrali rende l’uso contemporaneodi tutte le risorse non solo possibile, ma anchepianificabile e rendicontabile ad un livello glo-bale da parte delle comunità di ricerca e delleorganizzazioni di valenza nazionale o interna-zionale aprendo così la strada a modelli di cal-colo più avanzati ed efficienti. L’esperienzapratica mostra che più aumenta la possibilità dicondivisione delle risorse e servizi disponibili sulterritorio nazionale ed europeo da parte di tuttigli utenti, più aumenta (fino a saturazione) l’ef-ficienza di utilizzo di queste ed il ritorno degliinvestimenti effettuati.In conclusione fino alla fine degli ’90, primadello sviluppo della grid, ogni ricercatore potevain generale disporre solo delle risorse e dei datidisponibili nel proprio centro nazionale di riferi-mento, oggi invece può usare indifferentementecon interfacce uniformi le risorse di svariata na-tura ed i dati di uno qualunque dei 350 centridi EGI in Europa o di altri nel mondo e usarleanche contemporaneamente sfruttando insiemei centri più liberi per ottenere i risultati nel minortempo possibile o sfruttare dei dati non dispo-nibili localmente. In sintesi IGI, nel 2011 come struttura dentrol’INFN gestita dai partners della JRU ed in futurocome organizzazione indipendente parte fon-dante dell’European GRID Initiave, ha comin-ciato ad agire autonomamente come il punto difocalizzazione e coordinamento italiano delle at-tività relative alle infrastrutture commodity dicalcolo e archiviazione distribuite per svilupparee operare in comune con la massima sinergia eil minor costo possibile i servizi GRID e CLOUDopen, non disponibili commercialmente, chepermettono di sostenere le attività collaborativedi ricerca a livello nazionale, europeo e interna-zionale, per poter competere con successo ai fi-nanziamenti previsti da Horizon 2020 per lee-Infrastrutture e poter così continuare ad inno-vare le infrastrutture GRID e CLOUD nazionalianche con fondi europei, per massimizzare losfruttamento degli investimenti nazionali fatti inqueste e il numero di ricercatori che le possonosfruttare e infine per aumentare l’impatto delleattività di outreach verso il resto della società ita-liana. Oggi l’infrastruttura di IGI è una delle più grandi
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
121
Tab. 4.2: Partecipazione dei paesi in % del budget FP allocato (conl’esclusione di DANTE)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0% al at ba be bg ch cy cz de dk ee el es fi fr hr hu ie il is it lt lu lv me mk mt nl no pl pt ro rs se si sk tr uk
% of FP7 % of FP6
Country participation in % of FP allocated budget (excluding DANTE)

Tab. 4.4: Scaletta temporaledel Progetto SuperB e stimadei costi
Sviluppo Acceleratore(130 M€)Costruzioni infrastrutture. sviluppodamping rings. sviluppo transfer linesmessa in funzione Linac, dampinglines, transfer lines, costruzioni facilityend-user
Sviluppo centri Calcolo(43 M€)Sviluppo progettazione costruzionecentro di calcolo per analisi dati
Completamento acceleratore(126 M€)Installazione componenti negli archiacceleratore, installazione zonainterazione, messa in funzioneacceleratore
Utilizzo installazione (80 M€)Costi operazione e manutenzioneacceleratore
Totale infrastrutture tecniche(379 M€)
Overheads INFN(34.3 M€ equivalente al 9%)
Cofinanziamento INFN(150 M€)
Costo Totale progetto (563.3 M€)
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
20 50 60
5 15 23
42 42 42
20 20 20 20
25 65 83 42 42 42 20 20 20 20
2.3 5.9 7.5 3.8 3.8 3.8 1.8 1.8 1.8 1.8
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
42.3 85.9 105.5 60.8 60.8 60.8 36.8 36.8 36.8 36.8
Tab. 4.3: Scaletta temporale del progetto SuperB e stima dei costi
4.4 PROFILI FINANZIARI DELLE NUOVEINFRASTRUTTURE DI RICERCA
SuperBCome descritto precedentemente, il Progetto Su-perB ha come obiettivo la costruzione di un colli-sore e+e- per la fisica fondamentale con unaluminosità cento volte superiore a quella raggiuntafinora, e con la possibilità di produrre luce di sin-crotrone pulsata ad alta brillanza. Il progetto si in-quadra in un programma di rafforzamento e dirilancio dell’eccellenza maturata in Italia nello svi-luppo di nuovi acceleratori che si afferma semprepiù come settore strategico per l’innovazione conapplicazioni in settori multidisciplinari. Le intensità
necessarie al raggiungimento degli obiettivi scien-tifici sono infatti rese possibili grazie all’impiego in-novativo di na no-fasci di elettroni e positroni. Leconoscenze per la produzione e controllo dei nano-fasci sono state sviluppate da ricercatori italiani edimostrate in esperimenti eseguiti ai Laboratori Na-zionali di Frascati dell’INFN nel corso del 2008. Nelseguito viene descritto una scaletta temporale delProgetto SuperB ed una stima dei costi.
Descrizione delle fasi di attività e del relativofinanziamentoNelle tabelle si riassumono sinteticamente le risorsefinanziarie totali richieste su un decennio, relativeai sei anni di costruzione e ai successivi di opera-zione dell’infrastruttura in milioni di euro:La parte dei costi relativi all’infrastruttura necessaria
PIANOTRIEN
NALE2010-12
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
124
• Il software per la virtualizzazione delle risorsee la realizzazione di un’interfaccia CLOUD;
• I cataloghi per l’accesso di più alto livello ai dati;• L’accounting locale;• Il monitoring delle risorse e dei servizi GRIDbasati su Nagios;
• L’inventory delle risorse GRID disponibili nelsito.
-- La responsabilità della gestione dei serviziGRID centrali che permettono la gestione dei ca-richi di lavoro per l’uso contemporaneo delle ri-sorse di Cpu e storage di vari centri; -- La rappresentanza a livello internazionale everso le comunità di ricerca ed in particolare:• Verso l’European GRID Initiative (EGI) Councile l’European Middleware Initiative (EMI)Board e le strutture responsabili delle infra-strutture ICT dei progetti ESFRI;
• Verso gli utenti per il supporto all’implemen-tazione di use case e lo sviluppo di frame-work di lavoro anche all’interno di collabora-zioni internazionali;
• Utenti verso i fornitori esterni.
IGI avrà la funzione di agire in Italia da “motoreinnovativo” mobilitando unitariamente le risorseproprie e dei soci per accelerare la trasforma-zione dei nuovi servizi e applicazioni ICT in usonelle infrastrutture GRID e CLOUD del mondodella ricerca, in innovazioni consolidate per l’in-tera società. In particolare, oltre a mirare a espandere l’at-tuale base di utenti con l’evoluzione degli attualiservizi GRID o l’introduzione di nuovi servizi perun uso più corrispondente alle esigenze dinuove comunità di ricerca, come quelle inclusenella roadmap di ESFRI, nel 2012, 2013 e 2014IGI si concentrerà, in stretta collaborazione conEGI e altre organizzazioni in USA e Asia, nellamessa punto nell’e-infrastruttura di produzionedi nuovi servizi open source CLOUD in modo darendere trasparente l’acquisizione di ambientivirtuali on demand ai team di ricerca. In Italia,nel programma di lavoro del PON RECAS recen-temente approvato dal MIUR nel 2011 conl’obiettivo di sviluppare 4 Data Centers innova-tivi nelle regioni di convergenza per il calcolo diSuper-B come riferimento principale, è stataspecificamente prevista una collaborazione conIGI per lo sviluppo e la messa a punto in questicentri di un’offerta CLOUD basata su compo-nenti open source. In questo modo, unendo glisforzi della comunità internazionale con quellinazionali, sarà possibile ottenere prodotti cloud
open di uso generale che porteranno ad un mi-glior sfruttamento degli investimenti pubblicinelle infrastrutture ICT, con diminuzione deicosti, semplificazione nella gestione da parte diciascuna Amministrazione (e/o Impresa) e la fa-cilitazione nella messa in funzione di nuovi ser-vizi basati sulla condivisione di dati e risorse daparte di amministrazioni diverse distribuite sulterritorio in favore dei cittadini. Per consolidarela propria sostenibilità IGI si propone anche disviluppare un modello di business basato sullosviluppo ed evoluzione comune con il mondoindustriale dei prodotti software open GRID eCLOUD, in modo che questi possano fornire unasolida base per una soluzione commerciale al-ternativa alle soluzioni proprietarie, ma compe-titiva a livello nazionale ed internazionale, chepossa essere facilmente installata e mantenutanei centri di riferimento della pubblica ammini-strazione o in altri centri gestiti a livello commer-ciale per soddisfare esigenze più generali. Leinfrastrutture di calcolo e archiviazione distri-buite che così si otteranno potranno essere uti-lizzate come un servizio offerto on demand viaWEB (Infrastructure as a Service – IaaS), conte-nere un’offerta, sempre via WEB, di ambienti disviluppo caratteristici di un settore specifico(Platform as a Service – PaaS) o di prodotti soft-ware e applicativi sofisticati disponibili secondonecessità (Software as a Service – SaaS). IGI fa-vorirà così nel paese lo sviluppo di un nuovomodello di business per il CLOUD basato su soft-ware open e su una proficua collaborazione traindustria e ricerca che ha già dimostrato di poteressere di grande successo per altri prodotti opendiventati ormai di uso generale come il sistemaoperativo Linux, i Web Services Apache etc. Inquesto modo l’Italia sarà perfettamente in lineacon gli obiettivi della Commissione Europea (Ho-rizon 2020) e potrà partecipare con una fortebase nazionale agli sviluppi e ai processi di stan-dardizzazione previsti in questo contesto a livelloeuropeo ed internazionale.Il bilancio del Consortium IGI comprende le se-guenti voci:
1. Contributo permanente pluriennaledal bilancio ordinario del MIUR;
2. Contributi dei soci proporzionalialle quote sociali;
3. Contributi in kind dei soci;4. Fondi dai progetti Europei;5. Fondi da progetti futuri MIUR;6. Contributi da attività di outreach.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
123
per la sperimentazione dell’IIT non è compresanella tabella. Parte dei costi di operazione potreb-bero essere coperti da accordi su Large Scale Faci-lities europee nell’ambito dell’VIII ProgrammaQuadro (FP8) o mediante accordi specifici bilateraliin un’ottica di reciprocità con l’impegno italiano inaltre infrastrutture di ricerca europee.
Copertura finanziariaL’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare copre le spesedel progetto esecutivo e le spese delle risorseumane dei profili tecnico, amministrativo, tecno-logo e ricercatore per la progettazione e costru-zione della SuperB e dei centri di calcolo ad essoconnessi nonchè delle infrastrutture tecnologiche
necessarie alla prototipizzazione degli elementidell’acceleratore.Inoltre si occupa della formazionedi giovani laureati e dottorati con competenze spe-cifiche nel settore degli acceleratori.Il personale dell’Istituto direttamente coinvolto èstimabile in circa 75 ricercatori e tecnologi, 65 tec-nici e 10 amministrativi all’anno. Includendo ancheuna valutazione dei costi di mantenimento dellestrutture tecnologiche di supporto coinvolte, il sup-porto dell’Istituto globale è valutabile in circa 15Milioni di Euro annui per l’intera durata del pro-getto per un totale di circa 150 Milioni di Euronell’arco temporale dei dieci anni complessivi di du-rata che si aggiungono a quelli richiesti per la rea-lizzazione materiale del progetto. I fondi indicaticome overheads saranno principalmente dedicatiad un programma di formazione di giovani da in-

PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
126
Tab. 4.7: Scala temporale del progetto KM3NET / Tab. 4.8: Flusso di spesa del progetto KM3NET
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
125
Tab. 4.4: risorse finanziarie totali richieste su un decennio, relative ai sei anni di costruzione e ai successivi di operazione dell’infrastruttura SuperB (inmilioni di euro).
Tab. 4.5: Scala temporale del progetto / Tab. 4.6: Flusso di spesa
serire sia nella ricerca sugli acceleratori che negli svi-luppi tecnologici ad essa collegati valutabile in circacentoventi unità ed in un programma di ospitalitàdi esperti internazionali chiamati a collaborare alprogetto.Ulteriori fonti di cofinanziamento potranno esserenegoziate per la fase II, come già accennato, e perla fase III nell’ambito di MOU internazionali con-cernenti l’utilizzazione dell’infrastruttura.
KM3NeTObiettivo del progettoCome visto precedentemente, si è recentementeavviata la realizzazione ed installazione presso il sitodi Capo Passero, ad una profondità di 3500 metrisotto il livello del mare ed una distanza dalla costadi circa 80 km, di una prima fase del nodo italianodell’infrastruttura Europea KM3NeT. Questa faseprevede la costruzione di un apparato costituito da
circa 30 torri. Il finanziamento per la realizzazionedi questa fase è stato attribuito dal MIUR sul PONRicerca e Competitività 2007-2013.
ProspettiveSi prevede di ampliare successivamente il rivelatorea partire dal 2015 fino a circa 100 torri.Le voci che riguardano il personale, il potenzia-
mento delle infrastrutture e la contingenza, rap-presentano l’impegno di cofinanziamento di re-sponsabilità INFN negli anni indicati.

3,5 M€. Questo finanziamento, insieme a quelloproveniente dalla Commissione Europea per EMIe EGI-InSPIRE, consentirà di assumere una partedel personale mancante (56 unità in totale) e dicominciare a realizzare un prototipo per l’offertacloud. Per gli anni successivi, considerando chenella prima metà del 2013 terminerà il progettoEMI e un anno dopo arrriverà a conclusione ancheil progetto EGI-InSPIRE, si prevede che il contributodel MIUR aumenti progressivamente per arrivarea regime a circa 5 M€. Questo consentirà di com-pletare l’organico previsto nel Blueprint e acquisirel’hardware necessario per trasformare il prototipocloud in un servizio effettivo a disposizione di tuttigli utenti i IGI. Per poter mantenere una posizione di eccellenzanel settore ICT, le attività di IGI dovranno sia fornireservizi solidi ed efficienti agli utenti sia intrapren-dere nuove attività innovative; queste ultime do-vranno essere finanziate anche attraverso lapartecipazione a progetti specifici sia in ambito ita-liano sia europeo, ad es. i Programmo Quadro eu-ropei (FP7 e Horizon 2020). Infine, per 3 anni a partire dal 2012, è previsto uncontributo a IGI da parte del PON ReCaS per unaattività di consulenza sulla integrazione delle ri-sorse di calcolo, gestione, monitoring e semplifi-cazione dell’uso delle risorse oggetto del progettoda parte degli utenti di SuperB. Il contributo an-nuale può essere stimato in circa 260 K€. A frontedi questo contributo IGI metterà a disposizone diReCas e SuperB il proprio know-how e i propri ser-vizi per soddisfare le esigenze dei committenti. Ènaturalmente previsto che i servizi di IGI evolvanoe che nuovi servizi siano attivati in modo da rispon-dere in modo efficae ed efficiente alle esigenze diquesti nuovi utenti.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
128
GRIDCome descritto nel paragrafo 4.3 il progetto Gridsta evolvendo verso IGI, l’Italian Grid Infrastructuree, in attesa che siano completati i passi necessariaffinchè diventi una nuova organizzazione legaleautonoma dall’INFN, è organizzata come ProgettoSpeciale dell’INFN. La struttura interna del Pro-getto Speciale, in cui sono inquadrate tutte le at-tività di IGI, è basata sulla struttura organizzativaprevista per la nuova organizzazione legale, comedescritto in un apposito documento programma-tico (“IGI: organizzazione, attività e finanzia-mento”), conosciuto come Blueprint. Le attivitàdi IGI sono o realizzate all’interno di 4 unità tec-niche, le cui necessità di personale sono statestimate sia sulla base delle attività svolte oggidai partner della Joint Research Unit sia sugliobiettivi di IGI previsti nel Blueprint e sono rias-sunte nella tabella seguente.
Attività e finanziamenti nel periodo 2010-2011In questo periodo, per ciascun anno, il progettospeciale IGI ha potuto contare sui finanziamentiseguenti:• 2 M€ dal MIUR come contributo per l’avviodelle attività di IGI;
• 1 M€ circa dalla Commissione Europea perla partecipazione ai progetti EGI-InSPIRE eEMI.
Le attività realizzate con questi finanziamentiall’interno del Progetto Speciale IGI hanno con-sentito di rispettare gli impegni europei nell’am-bito dei progetti menzionati, di consolidare leattività di mantenimento delle componenti mid-dleware di responsabilità IGI che sono usate siaa livello italiano che internazionale e di fornire icore service necessari per un mantenere un ele-vato livello di servizio nell’infrastruttura grid ita-liana. Per realizzare tutte queste attività sonostate impiegate circa 40 persone, la maggiorparte delle quali collaboravano già a queste at-tività in forza all’INFN o agli altri partner di IGI,e che ora gravano sui fondi menzionati asse-gnati al Progetto Speciale.Questo consolidamento delle attività e dei ser-vizi è una solida base su cui pianificare l’evolu-zione prevista nel periodo 2012-2014.
Piani per il periodo 2012-2014In aggiunta a quanto realizzato fino al 2011, ilBlueprint di IGI prevede una evoluzione dei ser-vizi forniti da IGI, mediante una offerta inte-
grata grid e cloud con servizi in grado di soddi-sfare un sempre maggior numero di utenti indiversi domini applicativi. L’obiettivo è aumentarein modo significativo le comunità e gruppi acca-demici e di ricerca che accedono ai servizi di IGI,che costituisce la missione principale di IGI.Per fare questo è necessario in primo luogocomprendere le esigenze dei nuovi utenti perpoi implementare nuove funzionalità nel mid-dleware esistente, realizzare nuovi servizi e for-nire un adeguato livello di supporto.Contemporaneamente è necessario anche mi-gliorare il livello dei servizi esistenti. Nel Blue-print è stato stimato il personale necessario aregime per realizzare questi obiettivi; il risultatoè riportato nella tabella 4.8, suddiviso all’in-terno delle unità operative di IGI.
I fondi necessari per la realizzazione di queste at-tività (stipendi del personale, funzionamento, mis-sioni, attività di promozione e offerta di un serviziocloud per gli utenti) sono riportati nella tabella se-guente. È stato anche previsto un contributo perle spese di funzionamento e gestione delle sediche ospiteranno i servizi ed il personale di IGI; que-sto comprende un contributo per l’affitto dei locali,le spese di climatizzazione, energia elettrica, puli-zia, e tutti i servizi accessori necessari.
Per poter realizzare questi obiettivi si prevede peril 2012 un contributo da parte del MIUR di almeno
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILABORATORINAZIO
NALI, IL
CNAFELEINFRASTR
UTTU
REDIRICERCA
127
Unità
Gestione operativa 21 16
Ricerca, Pianificazione 23 17e Mantenimento Middleware
Formazione 13,5 3e Servizi di Supporto agli Utenti
Gestione Amministrativa 7 4e Pubbliche Relazioni
TOTALE 64,5 40
Tab. 4.9: Personale necessario a regime per realizzare gli obiettividelle unità operative di IGI.
Tab. 4.10: Costi di IGI (K€), suddivisi per anno.
Risorse umanenecessarie a regime
(FTE)
Risorse umanein forza a fine
2011 (FTE)
Costi di IGI (K€), suddivisi per annoAnno 2012 2013 2014
Personale (FTE) 56,0 64,5 64,5Personale (costo unitario) 52,5 52,5 52,5Over-head (20%) 10,5 10,5 10,5Missioni 6 6 6Totale personale (salario+overhead+missioni 3864,0 4450,5 4450,5Contributo spese gestione sede 100 110 110HW per servizi 100 100 100HW per offerta cloud 200 350 350Materiale per disseminazione, eventi, licenze 150 150 150
TOTALE 4414,0 5160,5 5160,5

5. COOPERAZIONE E ACCORDICON ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
L’attività dell’Istituto si svolge, in misurasignificativa, in collaborazione con altrisoggetti nazionali ed internazionali, pubblicie privati. Il ricorso a forme di collaborazioneda parte dell’Istituto costituisce un aspettoimportante della sua attività, derivantenaturalmente dall’interdisciplinarietà dialcuni settori scientifici e dalla necessità dicondividere le risorse disponibili; il ricorso aforme di collaborazione costituisce inoltreuna modalità tramite la quale renderedisponibili all’esterno i risultati delle attivitàsvolte e utilizzarli in settori differenti daquelli istituzionali. I livelli di eccellenzaraggiunti dall’Istituto nei settori istituzionalie in quelli complementari (calcolo, GRID,ecc.) hanno permesso l’attivazione diimportanti collaborazioni, in ambito locale,nazionale e internazionale, nelle qualil’Istituto ha un ruolo di capofila ocomunque presta di regola un apportosignificativo. Per la sua rilevanza verrannotrattate separatamente le collaborazionicon le Università e le collaborazioniinternazionali nonché, in ossequio aldettato legislativo, quelle relative allapartecipazione a Consorzi, Fondazioni,Società ed Organismi associativi. In questaparte verranno pertanto sinteticamentetrattate le principali collaborazioni con altrienti nazionali, distinguendo tra enti diricerca ed altri enti.

risultati delle attività svolte. L’Istituto, infatti,nello svolgimento delle sue attività ha sviluppatoconoscenze e competenze suscettibili di trovareutilizzo in ulteriori settori, quali la medicina,l’energia e i Beni Culturali, attivando al riguardodiverse collaborazioni che hanno condotto a im-portanti realizzazioni.In ambito medico l’Istituto ha prestato un ap-porto fondamentale per la realizzazione del sin-crotrone CNAO a Pavia per il trattamento dipatologie oncologiche con fasci di particelle,sperimentato con successo e oramai entratonella fase di sperimentazione clinica, e, in colla-borazione con l’Ospedale Galliera di Genova, diun biosuscettometro per la misurazione non in-vasiva del ferro nel corpo umano, risultato vin-citore del concorso INVENTION patrocinato da“Il Sole 24 ore”; a Catania presso i LNS, è attivo,in collaborazione con l’Università di Catania e lalocale Azienda Ospedaliera, il progetto CATANAper il trattamento con fasci di particelle di alcunitumori oculari e, a Pavia una collaborazione conla SOGIN e la locale Università per la ricerca nelcampo dei radio farmaci.I livelli di eccellenza raggiunti in ambito medicohanno condotto alla definizione di Accordi Qua-dro di Collaborazione -con il Ministero della Sa-lute, la Regione Sicilia, la Fondazione IRCCSIstituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’Ospe-dale Niguarda di Milano - basati sul riconosci-mento dell’importanza delle applicazioni dellafisica di base alla medicina e alla salute, da un lato,e alla disponibilità presso l’Istituto di conoscenzee competenze suscettibili di trovare applicazioneal mondo della medicina, in particolare al campodell’Imaging morfologico e della Radioterapia,dall’altro.Nel settore dell’energia è attiva una Convenzione,del tipo “Quadro”, con l’Ansaldo Nucleare e l’Isti-tuto partecipa al Consorzio RFX per lo sviluppodell’energia nucleare; recentemente è stata infineattivata una collaborazione con l’ENEL per attivitàdi misurazione di rilasci termici anomali in sistemicostituiti da matrici metalliche a superficie nano-strutturata e isotopi dell’idrogeno. Nel settore deiBeni Culturali infine, oltre alla citata collabora-zione con il CNR, è attivo il LABEC, in collabora-zione con l’Università di Firenze, che ad oggicostituisce un punto di riferimento nell’applica-zione delle tecnologie proprie della fisica delle par-ticelle al settore dell’analisi, conservazione erestauro di Beni Culturali; l’Istituto inoltre è sociofondatore della Società COIRICH, per la realizza-zione di una Infrastruttura distribuita per la ricerca
multidisciplinare nel settore della conservazione erestauro dei Beni Culturali.L’Istituto infine, Ente di Ricerca a carattere na-zionale, è presente con le sue strutture di ricercain numerose Regioni italiane e ha attivato colla-borazioni con gli enti locali preposti.Quello regionale infatti, allo snodo tra locale enazionale, costituisce l’ambito ideale per attivareiniziative concrete di crescita del territorio diconcerto con le Regioni e gli altri enti locali, isti-tuzionalmente preposti.Alle citate collaborazioni SPARX, che vede ilcoinvolgimento anche della Regione Lazio, e nelsettore medicale con la Regione Sicilia, si ag-giungono altre collaborazioni attivate con la Re-gione Abruzzo, in tema di Alta Formazione, econ la Regione Piemonte, in tema di formazionealla ricerca, nonché con enti locali della RegioneVeneto, in tema di diffusione della cultura scien-tifica e con la Regione Toscana in tema di Ri-cerca e Alta Formazione; l’Istituto infine haallestito e gestisce il Museo della Fisica e del-l’Astrofisica in Teramo, in collaborazione con illocale Comune1.Particolarmente importante, anche per le rica-dute sul territorio, è poi la collaborazione con laProvincia Autonoma di Trento e con la Fonda-zione Bruno Kessler che ha prodotto le collabo-razioni MEMS, in tema di microsistemiinnovativi, e AURORA, in tema di supercalcolo,collaborazioni attivate in settori nei quali l’INFNriveste posizioni di assoluta eccellenza e allequali presta un contributo insostituibile.Diverse sono poi le collaborazioni finalizzate adattività di trasferimento tecnologico, realizzateda consorzi ricerche a carattere regionale, cuil’Istituto partecipa e di cui si darà conto nel se-guito.Segue nelle tabelle da 5.1 a 5.8 un elenco dellecollaborazioni e degli accordi e delle conven-zioni in atto.Accordi e convenzioni:
1. Convenzioni con le Università;2. Convenzioni con enti pubblici di ricerca;3. Convenzioni con altri enti;4. Convenzioni/rapporti Enti locali;5. Medicina;6. Beni culturali;7. GRID-ICT;8. Formazione diffusione Cultura Scientifica.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
132
5.1 LE COLLABORAZIONIE GLI ACCORDI NAZIONALI
L’Istituto da tempo intrattiene rapporti di colla-borazione con i principali enti pubblici nazionalidi ricerca (CNR, ENEA, ASI, INGV, SincrotroneTrieste e INAF); recentemente sono state attivatealtre collaborazioni con il CNISM e con l’INRM.La ricerca di base richiede spesso ingenti risorsefinanziarie, umane e strumentali, nonché cono-scenze e competenze specifiche, non disponibilipresso una sola istituzione; il ricorso a forme dicollaborazione tra enti che svolgono attività diricerca in settori affini o contigui, sia pur inparte, consente ad entrambi di ripartire i costi edi utilizzare le risorse strumentali e le compe-tenze dell’altro, permettendo così lo svolgi-mento di attività altrimenti non eseguibili e lapartecipazione a grandi collaborazioni nazionalie internazionali.La necessità di coordinare le attività reciproche insettori di comune interesse ha condotto da tempoalla stipula di apposite Convenzioni Quadro con iprincipali enti pubblici di ricerca nazionali; questeconvenzioni, basate sul riconoscimento del co-mune interesse ad attivare iniziative comuni, aloro volta regolate da specifici accordi, hanno lafunzione di agevolarne l’attivazione fornendostrumenti operativi dedicati; la partecipazionedell’Istituto a collaborazioni con altri EPR (e nonsolo) ha spesso consentito – come detto − la rea-lizzazione di iniziative comuni con risultati alta-mente positivi, altrimenti non ottenibili, avantaggio delle comunità scientifiche di riferi-mento e, in diversi casi, più ampie.Collaborazioni specifiche e progetti congiunti conaltri enti sono stati descritti anche in dettaglio neiparagrafi precedenti, in particolare nei paragrafida 3.8 a 3.11. Qui si ribadiscono alcuni degliesempi più significativi.Vale la pena citare la collaborazione SPARX, rea-lizzata congiuntamente al CNR e all’ENEA, fina-lizzata alla realizzazione di un laser ad elettroniliberi suscettibile di trovare applicazione in di-versi settori quali la genetica, la biologia, o lacollaborazione LANDIS con il CNR e relativa allosviluppo di strumentazione portatile per indagininon distruttive al settore dei Beni Culurali.Particolarmente importanti, per le risorse utiliz-zate e per il respiro internazionale, sono poi lecollaborazioni attivate con l’ASI e relative agliesperimenti AMS, PAMELA, FERMI, grandi col-laborazioni internazionali, rese possibili grazieanche all’apporto dell’Istituto e cui partecipano
diversi enti di ricerca italiani, coordinati tra loro.Con l’INGV sono attive collaborazioni finalizzateal monitoraggio sismico di alcune zone del ter-ritorio nazionale, in particolare presso i LNGS, esono state attivate inziative comuni che hannocondotto, nell’ambito dell’iniziativa denominataPEGASO, alla realizzazione di una infrastrutturasuscettibile di utilizzo in ambito marino ad ele-vate profondità con pochi paragoni a livellomondiale.L’Istituto è altresì capofila della collaborazioneIGI (Italian Grid Infrastructure) − cui partecipanotra i vari il CNR, l’ENEA, l’INGV, l’INAF, la Sincro-trone Trieste, l’Università di Napoli Federico II el’Università della Calabria, i Consorzi COMETAe COSMOLAB − finalizzata alla realizzazione diuna infrastruttura di Grid nazionale che parte-cipi e assicuri il collegamento con l’infrastrutturaEuropea di Grid (European Grid Infrastructure),settore nel quale l’INFN ha una riconosciuta ec-cellenza. L’iniziativa ha ricevuto nell’ultimo anno nuovo im-pulso grazie anche al ruolo assicurato dall’Istitutoche ha ricevuto dal Ministero un altro finanzia-mento per “l’avvio attività del programma inter-nazionale IGI/EGI”.L’apporto fornito all’iniziativa dall’Istituto, in ter-mini di competenze e di risorse di calcolo, rap-presenta un contributo fondamentale di cuipotranno beneficiare utenti di diverse disciplinescientifiche ulteriori rispetto a quelle degli entipartecipanti.L’Istituto inoltre rivolge una particolare atten-zione alla formazione scientifica e alla diffusionedella cultura nei settori istituzionali e, in tale am-bito, sostiene, anche finanziariamente, le attivitàsvolte dalla Società Italiana di Fisica e dalla So-cietà Italiana di Relatività Generale e di Fisicadella Gravitazione.È anche grazie a rapporti di collaborazione chesi sono svolte attività di diffusione della culturascientifica, quale la mostra “Astri e Particelle” -già ospitata presso il Palazzo delle Esposizioni aRoma e la Città della Scienza a Napoli e in via disistemazione presso il Museo della Fisica e del-l’Astrofisica a Teramo -, vista da oltre 180.000visitatori e realizzata insieme ad ASI e INAF, e ilprogetto EEE, in collaborazione con il CentroFermi, rivolto agli studenti delle scuole seconda-rie superiori dove riscuote un interesse cre-scente. Il ricorso a forme di collaborazione costituisce –come già anticipato – una modalità di azionetramite la quale rendere disponibili all’esterno i
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
131

nia, il CNR, l’INFN, la Camera di Commercio, In-dustria, Artigianato di Catania e la A.A.T.Al momento il Consorzio, al quale l’Istituto par-tecipa esclusivamente con servizi e competenze,è impegnato in diversi progetti: TestPEP FP7-SME-2008-2-243791 (2010-2013); SCOOP –Italian Solar Concentration technOlogies forPhotovoltaic systems - Industria 2015 Bando Ef-ficienza Energetica (2009-2011); LAST-POWER -Large Area silicon carbide Substrates and heTe-roepitaxial GaN for POWER device applications enei prossimi tre anni si prevede di svolgere e por-tare a temine i programmi di ricerca approvati epresentare nuove proposte di progetti di ricercasu bandi nazionali, regionali, europei. In ogni casosono stati già approvati diversi progetti per il trien-nio 2011-2013 e cioè: “B.R.I.D.G.€conomies- Bu-siness Relays for Innovation and Development ofGrowing €conomies (2011-2012)”; Pregetto Te-stPEP FP7-SME-2008-2-243791 (2010-2013);Progetto SCOOP – Italian Solar Concentration te-chnOlogies for Photovoltaic systems - Industria2015 Bando Efficienza Energetica (2009-2011);Progetto LAST-POWER - Large Area silicon carbideSubstrates and heTeroepitaxial GaN for POWERdevice applications, ENIAC, Sub-programme(2010- 2012).L’ultimo bilancio, relativo all’anno 2010, si è chiusocon una perdita d’esercizio pari a € 148.391.Informazioni più precise sul Consorzio e sulla suaattività sono reperibili alla pagina www.ccr.unict.it.
Consorzio Milano Ricerche:Consorzio al quale l’INFN aderisce dal giugno1988; soci consorziati sono il CNR, l’INFN, l’Uni-versità Cattolica del Sacro Cuore, l’Università diMilano, l’Università di Milano Bicocca e la Fon-dazione Museo Nazionale della Scienza e Tec-nica “Leonardo da Vinci”, oltre a undici sociindustriali tra i quali l’IBM e la Pirelli. Al momento il Consorzio è impegnato nel pro-getto SMELLER per monitoraggio emissione vei-coli in tempo reale e sono in fase di avvio 2progetti su energetica (settore smartGRID e con-trollo/ottimizzazione MicroGRID) Partecipa inol-tre a diversi progetti nel settore ICT applicati asicurezza e ambiente.I Programmi di attività del Consorzio si concen-treranno nell’effettuare ricerche sulle metodo-logie di trasferimento tecnologico, attività dipromozione e sostegno di attività di ricerca incomune tra Università, EPR, Imprese e P.A. tra-sferimento di know-how verso piccole e medieimprese. Nel prossimo triennio l’attività del Con-
5.2 LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI,A SOCIETÀ, A FONDAZIONI
Alcune collaborazioni dell’Istituto si sono tra-dotte nella costituzione e nella partecipazione aorganismi associativi, di cui segue l’elenco:
Consorzio Catania Ricerche:Consorzio al quale l’INFN aderisce dal giugno1988; soci consorziati sono l’Università di Cata-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
134
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
133
Università di Bari
Università di Bologna
Università di Bologna
Università di Cagliari
Università di Catania
Università di Ferrara
Università di Firenze
Università di Genova
Università di Lecce
Università di Milano
Università di Milano Bicocca
Università di Napoli Federico II
Università di Padova
Università di Pavia
Università di Perugia
Università di Pisa
Università di Roma La Sapienza
Università di Roma Tor Vergata
Università di Roma TRE
Università di Torino
Università di Trieste
Università di Roma Tor Vergata
Università dell’Aquila
Università di Padova
Università di Catania
Università di Brescia
Università di Cosenza
Università dell’Aquila
Università di Messina
Università di Parma
Università del Piemonte Orientale
Università Salerno
Università di Siena
Università di Trento
Università di Udine
Istituto Superiore di Sanità
Politecnico di Bari
Università di Bergamo
Università di Camerino
Politecnico di Milano
Università di Modena e Reggio Emilia
Università di Roma La Sapienza (Dip.to Energetica)
Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati
Scuola Normale Superiore Pisa
Politecnico di Torino
Università di Urbino
Seconda Università di Napoli
Università di Napoli Parthenope
Sezione
Sezione
CNAF
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Laboratori Nazionali di Frascati
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Laboratori Nazionali di Legnaro
Laboratori Nazionali del Sud
Gruppo colleg. a Sez.Pavia
Gruppo colleg. a Lab. Naz. Frascati
Gruppo colleg. a Lab. Naz. Gran Sasso
Gruppo colleg. a Sez. Catania
Gruppo colleg. a Sez. Milano Bicocca
Gruppo colleg. a Sez. Torino
Gruppo colleg. a Sez. Napoli
Gruppo colleg. a Sez. Pisa
Gruppo colleg. a Sez. Padova
Gruppo colleg. a Sez. Trieste
Gruppo colleg. a Sez. Roma
Collaborazione Quadro (Sez. Bari)
Collaborazione Quadro (Sez. Pavia)
Collaborazione Quadro(Sez. Perugia)
Collaborazione Quadro (Sez. Milano)
Collaborazione Quadro (Sez. Bologna)
Laboratori Nazionali di Frascati
Collaborazione Quadro
Collaborazione Quadro (Sez. Pisa)
Collaborazione Quadro (Sez. Torino)
Collaborazione Quadro (Sez. Firenze)
Collaborazione Quadro (Sez. Napoli)
Collaborazione Quadro (Sez. Napoli)
Fondazione CNAO
Fondazione CNAO
CERN, Fondazione CNAO
Fondazione CNAO, EBG Medaustrom
Univ.tà Catania, Policlinico di Catania, CSFNSM
Ospedale Galliera
SOGIN, Università Pavia
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Regione Sicilia
Ministero Salute
Ospedale Niguarda
CNR, Consortium GARR, Un.tà di Torino
e Milano Bicocca, Istituto Superiore di Sanità,
CASPUR, CINECA, etc.
Collaborazione Quadro
Adroterapia Oncologica
Accordo attuativo acceleratore CNAO
Conoscenze acceleratore CNAO
Collaborazione Adroterapia oncologica
Protonterapia (Progetto CATANA) (LNS)
Biosuscettometro MID (GE)
Ricerca radio farmaci
Collaborazione Radioterapia,
Adroterapia, Brachiteraopia,
Dosimetria Clinica
Applicazioni di fisica particellare
e nucleare alla medicina
Applicazioni di fisica particellare
e nucleare alla medicina
Radioterapia, Radiochirurgia,
Adroterapia e Dosimetria Clinica
Collaborazione RI-BIG
Ansaldo Nucleare
Fondazione CNAO
Fondazione CNAO
CERN, Fondazione CNAO
Fondazione CNAO, EBG Medaustrom
Univ.tà Catania, Policlinico di Catania, CSFNSM
MSFCSR “Enrico Fermi”
Ospedale Galliera
CNAF, Consortium GARR
AIF-CNR-INFM, Un.tà Padova, Comune di Padova
e la DGUSR per il Veneto
Fondazione CARIPARO
SOGIN, Università Pavia
Società Italiana di Fisica
Società Italiana Relatività Generale Fisica
della Gravitazione
ENEL Energia e Innovazione
Collaborazione Quadro
Collaborazione Quadro Adroterapia
Oncologica
Accordo attuativo acceleratore CNAO
Conoscenze acceleratore CNAO
Collaborazione Adroterapia oncologica
Protonterapia (Progetto CATANA) (LNS)
Progetto EEE
Biosuscettometro MID (GE)
Memorandum Understanding DANTE
Mostra Sperimentando (PD-LNL)
Mappatura radioattività
Regione Veneto
Radio farmaci
Collaborazione Quadro
Collaborazione Quadro
Collaborazione ricerca e studio sistemi
metallici idrogenati
Agenzia Spaziale Italiana
Agenzia Spaziale Italiana
Agenzia Spaziale Italiana
Agenzia Spaziale Italiana
Agenzia Spaziale Italiana
Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNR
CNR-INFM
CNR, INGV, Un.tà Bologna, Ferrara e Modena
e Reggio
CNR, ENEA, Un.tà Tor Vergata, MIUR, Regione Lazio
CNR, ENEA, INGV, INAF, Sincrotrone Trieste, Un.tà
Federico II, Un.tà Calabria, COMETA, COSMOLAB
CNR, Consortium GARR, Un.tà di Torino e Milano
Bicocca, Istituto Superiore di Sanità, CASPUR,
CINECA, etc.
CNR, ENEA, Un.tà Tor Vergata
Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
Istituto Nazionale di Astrofisica
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Sincrotrone Trieste
Sincrotrone Trieste
Sincrotrone Trieste
Fondazione Ettore Majorana
Fondazione CCR “Venaria Reale”
ICRANET
DAISY-Net
Centro Geotecnologie Università Siena
Istituto Zooprofilattico delle Venezie
Un.tà di Napoli “Federico II” e di Bari “Aldo Moro”
U.tà di Salerno, ENEA e CRDC Nuove Tecnologie
Consorzio Nazionale Interuniversitario Scienze
Fisiche della Materia
Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica
Collaborazione Quadro
Progetto AMS
Progetto LISA/PATHFINDER
Progetto AMS
Progetto ASI Scientific Data Center
Collaborazione Quadro
Progetto LANDIS (LNS)
Progetto SPARC (LNF)
Infrastruttura GRID/Cloud
Regione Emilia Romagna DUCK
Progetto SPARX
Collaborazione IGI
(Italian Grid Infrastructure)
Collaborazione RI-BIG
Convenzione per costituzione Società
Consortile
Collaborazione Quadro
Collaborazione Quadro
Collaborazione Quadro
Stazione Interferometrica
del Gran Sasso (LNGS)
Gestione e utilizzo infrastruttura
PEGASO
Realizzazione di una stazione di
monitoraggio geofisico e ambientale
presso il test site sottomarino dei LNS
Collaborazione Quadro
Collaborazione partecipazione italiana
infrastrutture europee di ricerca
Collaborazione partecipazione XFEL
GMBH
Collaborazione
Collaborazione (TO)
Collaborazione Quadro (RM)
Collaborazione Quadro ICT (BA)
Collaborazione (FE)
Collaborazione (LNL)
Progetto RECAS (PON)
Progetto NAFASSY (PON)
Collaborazione Quadro
Collaborazione Quadro
Tab 5.1: Convenzioni con le Università
Tab. 5.6 – Medicina
Tab. 5.3 - Convenzioni con Enti Pubblici di Ricerca
Tab 5.4: Convenzioni/Rapporti Enti Locali
Tab. 5.5 – Beni culturaliTab. 5.2 - Convenzioni con altri Enti
Provincia Autonoma di Trento/FBK
Provincia Autonoma di Trento - FBK
Provincia Autonoma di Trento -FBK
Regione Abruzzo
Comune di Teramo
Regione Piemonte, CNR, INRIM, ENEA
Regione Toscana
Regione Toscana (Bando Regionale)
Regione Sicilia
Consorzio Area Ricerca Scientifica
e Tecnologica di Trieste
Collaborazione Quadro
Progetto MEMS2
Progetto AURORA
Alta Formazione (LNGS)
Museo Fisica e Astrofisica
Alta Formazione (TO)
Collaborazione Ricerca
e Alta Formazione
Progetto ISAV (PI)
Collaborazione settore medicale
Progetto SISTER (TS)
Tab. 5.7 – GRID - ICT
CNR, ENEA, INGV, INAF, Sincrotrone Trieste,
Un.tà Federico II, Un.tà Calabria, COMETA,
COSMOLAB, etc
DAISY-Net
CNR,ESA, ENEA, LAIT (Regione Lazio)
CNAF, Consortium GARR
CNR, INGV, Un.tà Bologna, Ferrara, Modena
e Reggio Emilia e altri
ICCU
CRA
Collaborazione IGI
(Italian Grid Infrastructure)
Collaborazione Quadro ICT (BA)
Progetto MEGALAB (LNF RM2)
Memorandum Understanding DANTE
Collaborazione Grid/Cloud
Regione Emilia Romagna DUCK
Collaborazione Beni Culturali Digitali
Collaborazione ricerca
e sperimantazione Grid Computing
in Agricoltura.
Tab. 5.8 – Formazione diffusione Cultura Scientifica
Società Italiana di Fisica
Società Italiana Relatività Generale Fisica
della Gravitazione
MSFCSR “Enrico Fermi”
AIF-CNR-INFM, Un.tà Padova, Comune di Padova
e la DGUSR per il Veneto
Regione Abruzzo
Comune di Teramo
Regione Piemonte, CNR, INRIM, ENEA
Fondazione Giuseppe Occhialini
Università di Udine
Collaborazione Quadro
Collaborazione Quadro
Collaborazione
Mostra Sperimentando (PD-LNL)
Alta Formazione (LNGS)
Museo Fisica e Astrofisica
Alta Formazione (TO)
Collaborazione Quadro
Master IDIFO
CNR
Fondazione CCR “Venaria Reale”
Regione Toscana (Bando Regionale)
CNR, Un.tà Tor Vergata, e di Milano Bicocca,
Politecnico Milano e altri
Progetto LANDIS (LNS)
Collaborazione (TO)
Progetto TEMART (FI-LABEC)
Collaborazione SCarl COIRICH
1: è appena il caso di ricordare l’apporto fornito dall’Istituto all’Univer-sità dell’Aquila per i danni subiti a seguito del noto sisma dell’aprile2009, quando i LNGS ospitarono, pur tra difficoltà comprensibili, le at-tività didattiche del Corso di Laurea in Fisica, alle quali in tal modo siriuscì ad assicurare la continuità.

di Pavia. Aderisce alla Fondazione, in qualità diPartecipante, anche la Fondazione CARIPLO. La Fondazione ha il compito di realizzare e gestireil Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica eal momento è impegnata nella qualificazione fi-sico-radiobiologica dei fasci di adroni e, quantoall’INFN, nella messa a punto degli acceleratori enegli aspetti di radiobiologia. Poi l’attività si con-centrerà sugli aspetti di ricerca radiobiologica emessa a punto della linea sperimentale.Nei prossimi anni il programma di attività consi-ste nella sperimentazione dei trattamenti diadroterapia, secondo i protocolli e le modalitàdefinite e già approvate dal Ministero della Sa-lute, a seguito del quale prenderà avvio la fasedi gestione (trattamenti e ricerca) del CNAO. Nel 2011 è iniziata la fase di sperimentazioneclinica richiesta dal Ministero della Salute allaquale l'INFN sta collaborando per quanto ri-guarda la parte di radiobiologia, ovvero del mi-sure di efficacia del fascio con l'irradiazione dicellule in vitro e di cavie. In parallelo è iniziatoanche il trattamento di un campione selezionatodi pazienti. La sperimentazione clinica è prevista durare 18mesi e si prevede di trattare in totale circa 230pazienti.Si prevede di avviare nel corrente anno la lineadi ricerca con fasci di adroni nella sala sperimen-tale dedicata. L’ultimo bilancio disponibile si è chiuso con unrisultato d’esercizio pari a zero.Notizie più precise sui partecipanti e sulle attivitàdella Fondazione CNAO sono reperibili alla pa-gina web www.cnao.it.
Consorzio Ferrara Ricerche:Consorzio del quale l’INFN fa parte dal marzo2005 e al quale aderiscono, oltre all’INFN, l’Uni-versità di Ferrara tramite la Fondazione Univer-sitaria Nicolò Copernico, la Azienda OspedalieraUniv.tà “Sant’Anna”, la Azienda Unità SanitariaLocale di Ferrara la Provincia e il Comune di Fer-rara, e imprese private (Hera S.p.A. e la BercoS.p.A.). Il Consorzio è attualmente impegnato in nume-rosi progetti di ricerca in ambito nazionale, eu-ropeo ed internazionale che coinvolgono diversiambiti scientifici, tra cui quello della salute(scienze mediche, farmaceutiche,biologiche,etc.) e quello delle scienze tecniche (fisica, inge-gneria, architettura.Per il prossimo triennio i programmi di attivitàprevedono ancora attività di supporto e promo-
zione della ricerca, innovazione e trasferimentotecnologico, ponendosi come interlocutore pri-vilegiato per Università, Centri di Ricerca, EntiPubblici, Imprese Industriali, in Italia e all’estero,favorendo l’incontro tra i generatori di knowhow, le organizzazioni industriali ed il mondodel lavoro.Nel prossimo triennio l’obiettivo è di consolidaree migliorare i risultati conseguiti nel triennio pre-cedente sia in tema di partecipazione a progettidi ricerca, sia nell’organizzazione di eventi adesse collegati.Il bilancio 2010 si è chiuso con un utile d’eserci-zio pari a € 32.778,00.Informazioni più precise sono reperibili alla pa-gina web www.consorzioferrararicerche.it.
Consorzio COMETA:Consorzio costituito nel febbraio 2005 in rispo-sta all’avviso pubblico MIUR 1575/2004 (P.O.N.2000-2006) e del quale l’INFN fa parte fin dallasua costituzione. Soci del Consorzio sono le Uni-versità di Catania, Messina e Palermo, l’INFN,l’INAF, l’INGV e il Consorzio S.C.I.R.E. È an-ch’esso uno dei partner della collaborazione IGI(Italian Grid Infrastructure).Attualmente il Consorzio è coinvolto nelle atti-vità di diffusione del paradigma della Grid sia alivello nazionale che internazionale, attraversoun’intensa attività di training. Ha, inoltre, parte-cipato ad un bando PON 2007/2013 ASSE I “Interventi a sostegno della ricerca industriale”con un progetto denominato PAPRICA che coin-volge più di 40 soggetti pubblici e privati e dicui si aspetta l’esito. È in corso l’attività di con-certazione con altri Enti per la partecipazione albando PON e R&C "Distretti tecnologici e rela-tive reti" e "Laboratori pubblico-privati e relativereti", per la costituzione di distretti nel campodella bio-medicina, dei beni culturali e dell’indu-stria tecnologica. Inoltre ha presentato diversiprogetti nell’ambito della linea di intervento4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007-2013.Per il prossimo triennio Il Consorzio porteràavanti le attività di ricerca legate a 4 progetti percui ha ricevuto finanziamenti dalla U.E. ed ad 1progetto che rientra nelle azioni “Industria2015”. Tali progetti sono legati ad attività di ri-cerca nel campo della salute, dei beni culturalie dell’innovazione industriale della mobilità so-stenibile.L’obiettivo è di offrire sia al settore pubblico chea quello privato, oltre alle notevoli capacità dihardware anche supporto specifico alle applica-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
136
sorzio si svolgerà tramite la partecipazione aprogetti e bandi, nazionali ed internazionali suisettori che riguardano: ICT, Salute e Biotecnolo-gie, Beni Culturali, tecnologia Aeronautica, Set-tore Agroalimentare.L’ultimo bilancio, relativo all’anno 2010, si è chiusocon un piccolo utile d’esercizio pari a € 6.736.Informazioni più precise sono reperibili alla pa-gina web www.milanoricerche.it.
Consorzio Roma Ricerche:Consorzio al quale l’INFN aderisce dal luglio1989; soci consorziati sono le tre università ro-mane, la LUISS, il CNR, l’ENEA, l’INFN, la Ca-mera di Commercio di Roma, l’Unicredit, laFinmeccanica e la Tecnopolo s.p.a. Il Consorzio è impegnato in attività di Trasferi-mento Tecnologico, e in particolare nelle attivitàpreviste dal P.O.R. 2007-2013; nei prossimi treanni si prevede lo sviluppo di Poli per l’Innova-zione Tecnologica alle Imprese Industriali nonchésupporto alla creazione di laboratori di ricerca in-dustriali pubblico/privati e la partecipazione aiBandi di R&D e Trasferimento Tecnologico in am-bito Comunitario, nazionale e regionale.L’obiettivo è quello di sostenere la competitivitàdelle Imprese industriali, in particolare PMI, at-traverso la realizzazione di progetti di Innova-zione e Trasferimento Tecnologico e la creazionedi un Polo per la Ricerca industriale e lo sviluppotecnologico. L’ultimo bilancio, relativo all’anno 2010, si è chiusocon una perdita d’esercizio pari a € 17.728.Informazioni più dettagliate sono reperibili allapagina www.romaricerche.it.
Società Consortile Pisa Ricerche p.a.:costituito in forma di consorzio in data 9 marzo1987 e al quale l’INFN aderisce sin dalla sua costi-tuzione; i soci sono università (Università di Pisa,Scuola Normale di Pisa e la Scuola Superiore S.Anna), enti pubblici di ricerca (INFN, CNR edENEA), enti territoriali (Regione Toscana, Provinciae Comune di Pisa, Comune di San GiulianoTerme) e aziende private, quali Finmeccanica,Piaggio, Avio e altre.La Società opera nel settore del trasferimentotecnologico e svolge attività di valutazione ditecnologie, individuazione di metodologie, rea-lizzazione di prototipi e studi di fattibilità perl’industria. Partecipa a programmi di ricerca re-gionali, nazionale e comunitari e fornisce sup-porto a piccole medie aziende delle regione delcentro Italia tramite il programma Competitive-
ness Innovation Programme della CommissioneEuropea. Nel prossimo triennio si prevede attività di ri-cerca applicata nei settori di competenza (qualiinformatica, ingegneria dell’informazione, mi-croelettronica, ingegneria strutturale, fluidodi-namica, energia e ambiente) e più in generaletrasferimento tecnologico per le imprese conl’obiettivo di supportare le aziende locali e na-zionali per la creazione di valore industriale av-valendosi delle competenze delle Università edprimari Enti di Ricerca. Il Bilancio 2010 si è chiuso con un utile d’eserci-zio pari a € 33.264,00.Informazioni più precise sono reperibili all’indi-rizzo www.cpr.it.
Consorzio Criospazio Ricerche:Consorzio di ricerca del quale l’INFN fa parte dalgennaio 1990; soci consorziati sono le Univer-sità di Trento e di Padova, l’INFN, la Camera diCommercio di Trento e la Fondazione Cassa diRisparmio di Trento e Rovereto.Il Consorzio è attualmente impegnato nelle at-tività relative al Progetto LISA-Pathfinder; le at-tività in corso riguardano il test dell’hardware, ildisegno delle operazioni, l’effettuazione dellestesse e lo sviluppo dell’analisi dati.La durata del Consorzio è stata recentementeprorogata sino al 31 dicembre 2013 per com-pletare il Progetto LISA-Pathfinder, una missionedell’ESA di cui il direttore del Consorzio è il Prin-cipal Investigator. Il lancio della missione è pre-visto per la fine del 2013. La missione è ilprecursore tecnologico dell’osservatorio di ondegravitazionali LISA.Obiettivo del Consorzio nel prossimo triennio èsupportare il lavoro di ricerca dei soci, segnata-mente il gruppo di Trento nel condurre la mis-sione spaziale fino al lancio.Il bilancio consuntivo 2010 si è chiuso con unutile netto pari a € 3.044.
Fondazione CNAO:alla quale l’Istituto partecipa, in qualità di par-tecipante istituzionale, dal febbraio 2004. Nefanno parte, in qualità di Fondatori, il PoliclinicoMangiagalli e Regina Elena di Milano, il Policli-nico San Matteo di Pavia, l’Istituto OncologicoEuropeo, l’Istituto Neurologico C. Besta, l’Isti-tuto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tu-mori e la Fondazione TERA di Novara; altriPartecipanti istituzionali sono il Politecnico el’Università di Milano, l’Università e il Comune
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
135

Consorzio per l’Incremento degli Studi e delle Ri-cerche dei Dipartimenti di Fisica dell’Università diTrieste: Consorzio costituito dal Ministero e delquale fanno altresì parte l’Università di Trieste, laSISSA, l’ENEA, la Sincrotrone Trieste, il CNR,l’INAF, l’ICPT l’OGS, la Provincia e il Comune diTrieste e la Camera di Commercio di Trieste. Èmunito di personalità giuridica pubblica.Il Consorzio sostiene Sostiene iniziative di Entidi ricerca del territorio locale sulle ricerche in fi-sica. Sostiene finanziariamente il Collegio per laFisica L. Fonda (borse di studio a favore di stu-denti iscritti alle Facoltà scientifiche dell’Univer-sità di Trieste). Convenzione con l’Area SciencePark (borsa di dottorato di Ricerca in Nanotec-nologie, in collaborazione con la Sincrotrone). Nel prossimo triennio si prevede di continuarequanto iniziato negli anni precedenti, soprat-tutto rispondendo alle esigenze scientifichedegli Enti di ricerca del territorio locale sulle ri-cerche in fisica. Il Consorzio è attualmente impegnato in dueprogetti (per le Nanotecnologie e sulla Cripto-grafia quantistica) e nel Sexten Center for Astro-physics.Il bilancio d’esercizio 2010 si è chiuso con unavanzo d’amministrazione pari a € 296.730,48.
CoIRICH. - Italian Research Infrastructure forCultural Heritage- S.C.ar.l.:Società consortile costituita nel settembre 2010e della quale fanno parte il Consiglio Nazionaledelle Ricerche, l’Università di Roma Tor Vergata,il Politecnico di Milano, l’Università di Milano Bi-cocca e due Società private (KANSO srl e EFM srl).La recente costituzione della Società non con-sente ad oggi indicazioni su di piani di attività: ilComitato tecnico scientifico sta predisponendo ipiani di lavoro, coordinando le competenze deipartner anche in vista della partecipazione abandi regionali, nazionali ed europei per analisidi materiali e strutture, datazioni, di manufatti diinteresse storico, artistico, archeologico.Obiettivo è realizzare una struttura distribuita diricerca per la conservazione e analisi del patri-monio culturale; assicurare agli enti di tutela ac-cesso alla strumentazione dei laboratori dellastruttura; intensificare lo scambio di know-how;promuovere iniziative di diffusione e pubbliciz-zazione; in particolare, l’INFN sarà impegnato inattività relative ad analisi composizionali di ma-nufatti artistici con tecniche nucleari, e in data-zioni di reperti storici e archeologici col metododel radiocarbonio, utilizzando la Spettrometria
di Massa con Acceleratore.Il bilancio d’esercizio 2010 si è chiuso con unaperdita d’esercizio paria euro 674.
CABIBBOLAB:Consorzio non a scopo di lucro costituito il 7 ot-tobre 2011 con l’Università di Roma Tor Vergataper la realizzazione e la gestione dell’accelera-tore SuperB, uno dei Progetti bandiera inseritonel Programma Nazionale della Ricerca.L’attività del Consorzio si articola, secondo loStatuto, nelle due fasi della realizzazione dell’in-frastruttura e della gestione dell’acceleratore edell’avvio delle attività sperimentali; per questaseconda fase è anche prevista la costituzione diun ERIC a ciò dedicato. Attualmente il Consorzio sta completando la co-stituzione degli Organi e nel breve periodo siprevede la loro piena costituzione e il comple-tamento dell’assetto amministrativo; successiva-mente si procederà con l’avvio delle attività diingegneria civile che prevedono, entro la finedell’anno, il lancio del Progetto Esecutivo e, peril 2013, l’avvio della costruzione dell’infrastrut-tura civile che dovrà ospitare la macchina e lesale sperimentali. Parallelamente si sta proce-dendo con la definizione del quadro di riferi-mento per il personale e con le attivitàprogettuali necessarie alla realizzazione dell’ac-celeratore.
Sono infine in via di perfezionamento le proce-dure di adesione al Polo di Innovazione per l’Ef-ficienza Energetica e le Fonti Rinnovabili S.C. ar.l. e alla TICASS S.C. a r.l.L’INFN inoltre, insieme alla Fondazione CRUI, ilCNR e l’ENEA, fa parte in qualità di socio pro-motore dell’Associazione Consortium GARR,(www.garr.it), costituita con il compito di gestiree implementare la rete di telecomunicazioni alarga banda per la comunità scientifica e acca-demica italiana.Partecipa inoltre all’Associazione “Festival dellaScienza”, organismo senza scopo di lucro fina-lizzato alla promozione, valorizzazione e divul-gazione della cultura scientifica e tecnologica,con particolare attenzione alle risorse scientifi-che e tecnologiche della Regione Liguria; nefanno altresì parte l’Università di Genova, il CNRe altri enti, territoriali e non.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
138
zioni, agli utenti, nonché formazione specifica.I benefici attesi sono principalmente due: 1) In-tegrazione con il territorio siciliano partecipandoad attività capaci di valorizzare i servizi offertidal Consorzio; 2) Incrementare le proprie com-petenze specifiche nel settore in cui opera.Il bilancio relativo all’anno 2010 si è chiuso conuna perdita d’esercizio pari a euro 419.596,82,dovuta sostanzialmente all’ammortamento d’e -sercizio e al ribaltamento dei costi di personalee risulta interamente coperta dal fondo di ri-serva.Notizie più dettagliate sul consorzio possono es-sere rintracciate alla pagina web: www.consor-zio-cometa.it.
Consorzio CYBERSAR:denominazione esatta è “Consorzio Cybersarper il Supercalcolo, la modellistica computazio-nale e la gestione di grandi database”. Costitui-sce la continuazione del Consorzio COSMOLAB,costituito in risposta all’Avviso MIUR 1574/2004e del quale l’INFN fa parte fin dalla sua costitu-zione nel febbraio 2005, al pari del ConsorzioCOMETA. Ne fanno parte, oltre all’Istituto, leUniversità di Cagliari e Sassari, l’INAF, il CRS4, laTISCALI Italia srl e la NICE srl. È uno dei partnerdella collaborazione IGI nell’ambito del quale almomento svolge le sua attività.Per il prossimo triennio è prevista la realizzazionedi progetti di ricerca nell'ambito del supercal-colo, della modellistica computazionale e dellagestione di grandi database, in particolare inambito GRID ( con la partecipazione all’iniziativadi Grid Italiana (IGI)), Cloud Computing e DigitalLibrary.L’obiettivo è di incrementare la partecipazione,come proponenti, partner tecnologici o fornitoridi servizi, a progetti di ricerca finanziati su fondipubblici (in particolare della EU e regionali). Col-laborare con imprese ( in particolare regionali)in progetti di innovazione tecnologica.Il bilancio d’esercizio 2010 si è chiuso con unaperdita d’esercizio pari a € 1.123,00.Informazioni più precise sul consorzio e sulla suaattività sono reperibili alla pagina www.cyber-sar.com.
Consorzio RFX:Consorzio del quale l’INFN fa parte dal gennaio2006; gli altri soci consorziati sono il CNR,l’ENEA, l’Università di Padova e la Acciaierie Ve-nete s.p.a.Le attività del Consorzio si inquadrano nell’am-
bito del Progetto ITER e al momento il Consorzioè impegnato nella manutenzione della mac-china RFX e della strumentazione relativa e incampagne sperimentali con la macchina; ge-stione gare per le infrastrutture, edifici e im-pianti per la test facility. Nell’ambito delle attivitàdel Consorzio l’INFN è particolarmente impe-gnato nello sviluppo di un prototipo della sor-gente e nello studio della dinamica dei fascidella test facility.Per il prossimo triennio si prevede di proseguirela collaborazione relativa alla partecipazione alprogramma europeo sulla fusione termonu-cleare controllata mediante il pieno utilizzo dellamacchina RFX e la partecipazione al progettoITER, realizzando a Padova la TEST FACILITY perlo sviluppo dell’iniettore di neutri NBI e della sor-gente di ioni relativa. L’obiettivo è di procederealla sperimentazione alla macchina RFX al mas-simo delle sue potenzialità, al completamentodelle infrastrutture per ospitare la test facility;approvvigionamento dei materiali e della stru-mentazione per la sorgente di ioni e per il neu-tral beamL’ultimo bilancio d’esercizio, relativo all’anno2010, si è chiuso con una perdita d’esercizio paria 653.444 euro.Informazioni più precise sono reperibili alla pa-gina web www.igi.cnr.it.
CRDC Nuove Tecnologie per le Attività Produt-tive S.C.ar.l.:Società consortile della quale l’INFN fa parte dalmaggio 2007; gli altri soci sono le Università diNapoli “Federico II”, la Seconda Università diNapoli e la Parthenope, nonché l’Università diSalerno, l’Università del Sannio e il CNR.L’attività che la Società si propone di svolgere è diricerca pre-competitiva ed applicata, trasferi-mento tecnologico e spin-off, formazione nei set-tori dell’ elettronica, dell’energia e dei materiali.Nel prossimo triennio si prevede di intraprendereiniziative idonee allo sviluppo di un centro regio-nale per l’innovazione di prodotto e di processoa beneficio principale, anche se non esclusivo,delle piccole e medie imprese.Gli obiettivi sono il trasferimento tecnologico, iservizi e la formazione nei settori dell’ingegneriaindustriale, con particolare riferimento all’inno-vazione di prodotto e di processo, in aree tec-nologiche quali elettronica, energia e materiali.Il bilancio 2010 registra un utile d’esercizio paria € 1.710,00
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
137

PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
140
5.3 LE COLLABORAZIONIE GLI ACCORDI INTERNAZIONALI
L’INFN, per la natura delle ricerche che pro-muove e coordina, è inserito in un contesto dicollaborazioni internazionali.Più specificamente:
Gli ultimi due punti saranno trattati in dettaglionel paragrafo 7.6.
È in ragione della natura internazionale dellacollaborazione scientifica nel campo della fisica,che è improprio operare una netta distinzionetra attività interna e internazionale dell’IstitutoNazionale di Fisica Nucleare. La gran parte dellaattività scientifica promossa e condotta dall’Isti-tuto si svolge infatti nell’ambito di collaborazioniinternazionali, sia presso laboratori stranieri e in-ternazionali, sia presso proprie strutture, che in-cludono scienziati di tutto il mondo.Ciò premesso, è possibile tuttavia identificare icasi in cui tale collaborazione assume particolarerilevanza distinguendo tra attività svolta al-l’estero e attività svolta in Italia.Nel primo caso, merita certamente massimo ri-lievo l’attività condotta dall’Istituto presso ilCERN di Ginevra. L’Italia è tra i paesi fondatoridel Laboratorio europeo e, per tramite dell’INFN,è tuttora uno dei pembri più attivi. È significa-tivo al riguardo che presso il Laboratorio ope-rano gruppi di ricerca INFN, per complessivi circa1000 ricercatori, impegnati in tutti gli esperi-menti condotti con la macchina LHC (CMS,ATLAS, ALICE, LHCb).Ciò detto, l’Istituto è anche molto impegnatonelle attività sperimentali che si svolgono pressoaltri grandi Laboratori all’estero quali, per ci-tarne alcuni: FERMILAB, SLAC, BNL, e TJNAF(Stati Uniti); PNPI, BINP e JINR (FederazioneRussa); CIAE e IHEP (Cina); RIKEN e KEK (Giap-pone); BARC (India), DESY e GSI (Germania);ESRF (Francia), ecc.In Italia, la collaborazione internazionale è so-
prattutto concentrata presso i quattro Labora-tori Nazionali dell’Istituto dove sono in funzione,e a disposizione della comunità scientifica, i piùgrossi apparati sperimentali. E così, presso i La-boratori Nazionali di Frascati, sulla macchinaDAFNE, citiamo gli esperimenti KLOE, FINUDA eDEAR. Presso i Laboratori Nazionali del GranSasso, particolare menzione va fatta per gliesperimenti BOREXINO, CUORE, ICARUS, LVD,DAMA e per il progetto CNGS (CERN Neutrinosto Gran Sasso). Ai Laboratori Nazionali di Le-gnaro le attività sperimentali utilizzano il com-plesso di acceleratori TANDEM e ALPI, mentre aiLaboratori Nazionali del Sud e in funzione il mo-derno Ciclotrone Superconduttore. Tra le attivitàsvolte in Italia si rammenta anche che a Cascina,nei pressi di Pisa, è in funzione l’antenna inter-ferometrica VIRGO, che costituisce un rilevanteprogetto condotto in joint-venture con il CNRS-IN2P3 francese.
A complemento delle informazioni si fornisce intabella 5.9 un elenco delle Istituzioni scientifichestraniere, e relativi paesi, con le quali l’INFN haconcluso nel tempo accordi di collaborazionescientifica.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ COOPER
AZIO
NEEACCORDICONENTIED
ORGANISM
INAZIO
NALIED
INTER
NAZIO
NALI
139
Collabora a esperimenti nei maggiori centridi ricerca europei e mondiali; Adotta convenzioni, a carattere scientifico eper la diffusione della cultura scientifica, conistituzioni estere; Finanzia l’ospitalità, presso le proprie strut-ture, di ricercatori stranieri con appositi fondi(Fondo Affari Internazionali); Finanzia programmi di borse di studio per loscambio di ricercatori.
•
•
•
•
ArgentinaArmeniaAustraliaBelgio
Brasile
BulgariaCanada
Corea del Sud
Cina
Francia
Germania
Giappone
Grecia
IndiaIsraelePolonia
Regno UnitoRomaniaFederazione Russa
Repubblica CecaRepubblica SlovaccaSpagnaStati Uniti d'America
Svizzera
TurchiaUcraina
Comision Nacional de Energia Atomica (CNEA)State Committee of ScienceMelbourne University Ion Beam Applications (IBA)International Association for the promotion of cooperation withscientists from the New Indipendent States of the former SovietUnion (INTAS)Università Statale di CampinasUniversidade de São Paulo (IFUSP)Universidade Federal Fluminense (IFUFF)Institute of Nuclear Research and Nuclear Energy (INRNE)Canadàs National Laboratory for Particle and NuclearPhysics (TRIUMF)Institute of Particle Physics (IPP)Research Institute of Basic Science (RIBS), SeoulKorea Institute of Science and Technology Information (KISTI)China Institute of Atomic Energy (CIAE), BeijingChinese Academy of Sciences (CAS), BeijingInstitute of High Energy Physics (IHEP), BeijingInstitute of Theoretical Physics (ITP), BeijingInstitute of Modern Physics (IMP), BeijingNational Natural Science Foundation of China (NSFC)South East University of Nanjing (SEU), NanjingCentre National de la Recherche Sciéntifique (CNRS), ParisInstitut National de Physique Nucléaire et de Physique desParticules (IN2P3), ParisGIP Cyclotron ArronaxCommissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives(CEA) Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), AmburgoGesellaschaft für Schwerionenforschung (GSI), DarmstadtMax-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,MonacoPhysikalische Technische Bundesanstalt (PTB)Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN), TokyoNational Laboratory for High Energy Physics (KEK)Nagoya University, NagoyaInstitute for Chemical Research (ICR), Kyoto UniversityJapan Aerospace Exploitation Agency (JAXA)Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)Japan Proton Accelerator Research Complex (JARC)University of AthensUniversity of CreteUniversity of IoanninaUniversity of PatrasUniversity of ThessalonikiNational Center for Sceintific Research (NCSR) “Demokritos”National Technical University of AthensFoundation of Research and Technology (FORTH)Bhabha Atomic Research Center – BARCIsrael Commission for High Energy Physics (ICHEP)H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics in Krakow (INPK),CracoviaParticle Physics and Astronomy Research Council (PPARC)Institutul National de C&D Centru Fizica Inginerie Nucleara(IFIN-HH)Russian Academy of Sciences (RAS)Petersburg Nuclear Physics Institute (PNPI)Lebedev Physical InstituteBudker Institute for Nuclear Physics (BINP), NovosibirskNovosibirsk State University, NovosibirskMoscow State Engineering Physics Institute (MEPhI)Institute for Theoretical and Experimental Physics (ITEP), MoscowJoint Institute of Nuclear Research (JINR), DubnaRussian Research Center Kurchatov Institute (RRC KI), MoscowMoscow Institute of Steel and Alloys (MISIS)Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, MoscowCzech Academy of SciencesSlovak Academy of SciencesMinisterio Ciencia y Tecnologia (MICINN), MadridNational Science Foundation (NSF)Fermi National Accelerator Laboratory (FERMILAB)Stanford Linear Accelerator Centre (SLAC)Brookhaven National Laboratory (BNL)Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF)Massachusetts Institute of Technology (MIT)Michigan State University (MSU)Argonne National LaboratoryLaboratory of Elementary Particle Physics, Cornell UniversityBrown UniversityIndiana UniversityUniversity of California Los Angeles (UCLA)Oak Ridge National Laboratory (ORNL)European Organization for Nuclear Research (CERN), GinevraSwiss Federal Institute of Technology (ETHZ), ZurigoPaul Scherrer Institute (PSI), ZurigoTurkish Atomic Energy Authority (TAEK)National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)
Tab. 5.9: Accordi Internazionali
L’INFN inoltre:
5.4 ACCORDI PER LA COMUNICAZIONE VERSO LA COMUNITÀ SCIENTIFICA E L’OPEN ACCESS
Il principio dell’Open Access (OA), o Libero Ac-cesso in italiano, consiste nell’affermare che ognirisultato della ricerca di base finanziata con fondipubblici debba essere disponibile immediata-mente e gratuitamente a tutta la comunità scien-tifica. Una delle prime importanti dichiarazioniinternazionali sull'OA è il Budapest Open AccessInitiative del 2001, che viene riconosciuto comeil primo raduno storico di fondazione dell'OpenAccess. Una seconda importante iniziativa inter-nazionale, del 2003, è la dichiarazione di Berlinosull'accesso aperto alla letteratura scientifica. Essasi costruisce e si basa sulla definizione della con-ferenza di Budapest.
L’INFN ha da sempre fatto ricerca seguendo ilprincipio dell’OA ed è quindi considerato unpunto di riferimento nel panorama della ricercaitaliana. L'archivio di note interne dell'INFN (recen-temente reso disponibile online) risale agli annicinquanta. Molto prima dell'invenzione del WEBi fisici italiani erano soliti diffondere e scambiarearticoli prima della pubblicazione per via postalecon la comunità internazionale. Sottoscrivendonel 2008 la dichiarazione di Berlino, l'INFN ha vo-luto riaffermare l’importanza della libera circola-zione dei risultati per una ricerca di qualità nelsettore della fisica fondamentale. Nel 2009 i gruppi INFN partecipanti ai quattroesperimenti all'LHC del CERN hanno sottoscrittola raccomandazione per la pubblicazione dei ri-sultati scientifici su riviste OA. Nel 2010 l'INFN èstato scelto come organizzatore della partecipa-zione italiana che ha prodotto la dichiarazionedell'Alhambra, atto finale del gruppo di studio pa-trocinato dall'UE per la determinazione delle rac-comandazioni per le politiche di sviluppo dell’OAnell’Europa meridionale e del piano d’azione perdiffondere l’OA nell’Europa meridionale.
L'INFN è membro del consorzio Sponsoring Con-sortium for Open Access Publishing in ParticlePhysics (SCOAP3) che, sotto il patrocinio delCERN, ricerca un modello economico alternativoe accettabile da autori e editori, contro l'aumentoincontrollato dei costi degli abbonamenti alle rivi-ste scientifiche. Nel corso del 2011 si è passati allafase operativa del progetto che è previsto partirenel gennaio 2013.
Partecipa a programmi europei nei settori delcalcolo scientifico e della fisica nucleare; Insieme a numerose istituzioni di ricerca deimaggiori paesi europei è fondatore di ApPEC(Astroparticle Physics European Coordina-tion); È socio fondatore del Consorzio italo-fran-cese “European Gravitational Observatory”(EGO); (Cascina-Pisa); È socio della “European Science Foundation”(ESF) di Strasburgo; Ha propri rappresentanti nel comitato di espertiNuPECC (Nuclear Physics European Collabora-tion Committee), nel comitato scientifico PESC(Physical and Engineering Sciences) di ESF (Eu-ropean Science Foundation), in ICFA (Interna-tional Committee Future Accelerators) e inECFA (European Committee Future Accelera-tors);È socio della European Association for thePromotion of Science and Technology (EURO-SCIENCE) di Strasburgo;È azionista, insieme al CNR ed all’INFM, del-l’European Synchrotron Radiation Facility(ESRF) di Grenoble.
•
•
•
•
•
•
•

6. RAPPORTI E CONVENZIONICON LE UNIVERSITÀ

incarico gratuito di ricerca − ha le stesse prero-gative del personale dipendente dell’INFN, intermini di accesso a strutture, strumentazione efinanziamenti e di partecipazione alla program-mazione, alla gestione e al coordinamento delleattività dell’Ente. A questi si aggiungono circa1100 fra professori, ricercatori e tecnici univer-sitari (incarichi di associazione), associati solo peruna frazione delle loro attività di ricerca, chehanno comunque accesso a strutture, strumentie finanziamenti dell’Istituto.
Alta formazioneL’INFN ha interesse e vocazione a seguire, as-sieme all’Università, il percorso formativo versola ricerca e l’innovazione tecnologica nel propriocampo di interesse, in particolare tramite il Dot-torato di Ricerca per cui l’Ente finanzia diretta-mente una quarantina di borse per ciascun ciclo,nelle Università dove hanno sede le propriestrutture.Complessivamente, sono associati alle attivitàdell’INFN oltre 1400 laureandi magistrali, dotto-randi, specializzandi, borsisti e assegnisti di ri-cerca, che perfezionano col lavoro di tesi e diricerca presso l’Ente la propria formazione pro-fessionale.Di essi oltre 600 sono dottorandi e circa 400sono giovani ricercatori in formazione, in pos-sesso di dottorato di ricerca, vincitori di contrattibiennali (assegni di ricerca) dei quali una ottan-tina a totale carico dell’INFN e i restanti in cofi-nanziamento con le singole Università. Sononumeri che testimoniano l’impegno e l’impor-tanza attribuita loro dall’Istituto e, pur nella di-versità dei ruoli, la forte interazione con leUniversità anche per quanto riguarda la didat-tica, nell’interesse reciproco e, si ritiene, dell’in-tero sistema Paese.Un confronto con le informazioni disponibilinella banca dati del Ministero dell'Università edella Ricerca (MIUR) è mostrato in Tabella 6.2,prendendo l’intera Area (02) di Fisica come rife-rimento:
Il numero di Lauree di ambito INFN resta sostan-zialmente costante, intorno al 30%, dimo-strando che l'interesse per i temi di ricerca
dell’Ente non è influenzato da fenomeni esterni,correlati spesso a percezioni di ridotte opportu-nità di lavoro. Per il Dottorato di Ricerca si puònotare che, sempre rispetto all’Area di Fisica,l’INFN integra circa il 50% dei dottorati, unchiaro segno del continuo interesse indottodalle proprie attività nelle giovani generazioni. Ildatabase MIUR è mancante di questo dato pergli ultimi due anni, ma verifiche a campiona-mento in grandi Atenei come Padova, Pisa eRoma confermano questa percentuale.Le strutture dell’INFN – nelle Sezioni, nei Labora-tori Nazionali e presso i più grandi centri di ricercamondiali − offrono a laureandi e dottorandi con-crete opportunità di inserirsi nell’ambito delle at-tività di eccellenza scientifica dell’Ente.I giovani sono coinvolti direttamente nei gruppidi ricerca, acquisendo competenze sulle tecni-che e le metodologie di indagine che potrannoessere utili anche al di fuori della ricerca acca-demica, nei più diversi settori dell’industriaavanzata. Ricercatori e tecnologi dell’INFN con-tribuiscono direttamente al processo formativodegli studenti, seguendoli nella preparazionedelle tesi di laurea (triennale e magistrale) e didottorato, e tenendo insegnamenti universitariin cui portano la loro diretta esperienza di ri-cerca. L’ultima rilevazione dell’apporto fornito alle at-tività didattiche universitarie, relativa all’anno2006, ha fornito i dati riportati nella tabella 6.3(sono indicati il numero di corsi svolti nei vari li-velli di formazione e delle tesi seguite, da partedi personale INFN).
Reciprocamente, l’INFN trae beneficio da questasua implicazione nell’alta formazione universi-taria. L’attività di ricerca richiede capacità pro-fessionali altamente qualificate, risorsa nonmeno importante di quelle finanziarie, e le Uni-versità costituiscono la sede ideale cui attingereper assicurare la qualità e la continuità dell’atti-vità di ricerca.
L’interesse al potenziamento delle attività, didat-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ RAPPO
RTIECONVENZIO
NICONLEUNIVERSITÀ
144
INFN e Università: simbiosi e sinergiaÈ infatti in stretta connessione con le Universitàche l’Istituto svolge la missione di promuovere,coordinare e condurre la ricerca nei propri set-tori di pertinenza e lo sviluppo delle tecnologieconnesse, sempre nel contesto della collabora-zione e del confronto internazionale. È proprioda questa stretta connessione, in termini distrutture, personale e processi di formazione,che è scaturita la sinergia che ha permesso allaricerca in fisica nucleare e subnucleare del no-stro paese di raggiungere e mantenere un altolivello e una dimensione internazionale univer-salmente riconosciuta.
Simbiosi delle struttureSono trentuno le università dove l’INFN ha pro-prie strutture. Le 20 Sezioni, e i loro 11 gruppicollegati (vedi tabella 6.1), hanno infatti sedepresso altrettanti dipartimenti universitari e rea-lizzano il collegamento diretto, l’integrazione,tra l’Istituto e le Università.Con ciascuna Università è stipulata una conven-zione che regola l’utilizzo di spazi, personale eattrezzature per il perseguimento delle finalitàscientifiche di comune interesse. Complessiva-mente l’INFN versa annualmente alle Universitàconvenzionate circa 1,5 milioni di Euro comecontributo alle biblioteche e alle spese di ge-stione delle strutture universitarie.Nel corso del 2010 sono stati finanziati 2,6 mi-lioni di Euro per 49 borse di dottorato e 1,656milioni di Euro per 5 posizioni a tempo indeter-minato di ricercatori universitari, secondo i det-tagli descritti nel seguito.
La perfetta integrazione delle Sezioni INFN al-l’interno delle Università permette di disporre“in loco” di infrastrutture (camere pulite, offi-cine, ecc.) e di servizi tecnici (calcolo e reti, elet-
tronica, meccanica, ecc.) di cui usufruiscono do-centi, ricercatori e studenti universitari.Non di rado questa integrazione ha consentitola realizzazione di laboratori congiunti partico-larmente avanzati, quale, a titolo di esempio, ilLABEC, laboratorio della Sezione di Firenze, chead oggi costituisce un punto di riferimento in-ternazionale per la ricerca con tecniche nucleariapplicata ai settori dei Beni Culturali e del moni-toraggio ambientale, e il TIER1 del CNAF, instal-lato presso il Dipartimento di Fisica dell’Universitàdi Bologna, che è il più grande centro di calcoloitaliano ed uno dei più importanti in Europa, chelavora sul calcolo distribuito e rappresenta unpunto di riferimento unico nel panorama italiano.L’INFN dispone inoltre di quattro grandi labora-tori nazionali e di due centri scientifici (il CNAFdi Bologna ed il consorzio EGO a Cascina), consedi indipendenti al di fuori dei dipartimenti uni-versitari. Le macchine acceleratrici e le grandi apparec-chiature e infrastrutture di questi centri sono adisposizione delle Università e più in generaledella comunità scientifica nazionale e interna-zionale. La presenza dell’Istituto presso le Uni-versità, soprattutto, ha l’effetto di riunire lacomunità dei fisici nucleari italiani e di indirizzaree coordinare la loro attività, in particolare nellegrandi collaborazioni internazionali che hannoluogo presso i più importanti laboratori di ri-cerca in Italia e all’estero. Le sezioni ed i Labo-ratori Nazionali dell’Istituto, riconosciuti centridi eccellenza nel settore della fisica di base, ope-rando in maniera coordinata, costituiscono in-fatti un’organizzazione strategica che consentelo svolgimento di programmi di ricerca altri-menti non realizzabili con le risorse, finanziariee non, delle singole Università e del sistema uni-versitario nel suo complesso.In senso lato, l’azione di stimolo e l’opportunitàofferta ai docenti, ai ricercatori e agli studenti uni-versitari di sviluppare e partecipare ad avanzateiniziative di ricerca, di ampio respiro e dimensione,rappresentano il contributo fondamentale dell’Isti-tuto nei confronti del mondo universitario.
Personale associatoL’INFN assimila al proprio personale dipendentecirca 900 professori e ricercatori universitari (in-carichi di ricerca), oltre a circa 100 tecnici uni-versitari (incarichi di collaborazione tecnica), iquali svolgono prioritariamente la propria atti-vità di ricerca nei settori di pertinenza dell’Ente.Questo personale − associato all’Istituto con un
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ RAPPO
RTIECONVENZIO
NICONLEUNIVERSITÀ
143
SEZIONIBari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara,Firenze, Genova, Lecce, Milano, MilanoBicocca, Napoli, Padova, Pavia, Perugia,
Pisa, Roma, Roma “Tor Vergata”,Roma TRE, Torino e Trieste
GRUPPI COLLEGATIBrescia, Cosenza, L’Aquila,
Messina, Parma, Piemonte Orientale,Salerno, Siena, Trento, Udine eIstituto Superiore di Sanità
Tab. 6.1: Sezioni e gruppi collegati INFN
INFNMIUR
2008368849
2007333854
<04-06>332990
2009139n/a
2008163n/a
2007153342
<04-06>180388
Tab. 6.2: Laureati magistrali e dottorati che hanno svolto attività inambito INFN, rispetto ai dati totali MIUR.
2009302785
Laurea Magistralis Ph. D.
Corsi di Laurea 139
Corsi di Dottorato 40
Corsi di Master 13
Scuole di Specializzazione 10
Tirocini di Formazione 60
Tesi di Laurea 200
Tesi di Dottorato 56
Tab. 6.3: Supporto alla didattica

tiche e di ricerca, delle Università è testimoniatodall’impegno dell’Istituto nell’assunzione di ri-cercatori universitari a tempo indeterminato.Nell’anno 2010 l’Istituto ha sottoscritto cinqueconvenzioni (con le Università di Bari, Pavia, Bo-logna, Napoli Parthenope e Genova) per l’assun-zione a tempo indeterminato di altrettantigiovani ricercatori nei settori Scientifico Discipli-nari di attività INFN, a dimostrazione ulterioredella profonda interazione, simbiosi come detto,tra l’Istituto e le Università. A seguito di queste Convenzioni sono stati as-sunti e hanno preso servizio due ricercatori e perun altro il concorso dovrebbe concludersi neiprossimi mesi; in un altro caso non è stato pos-sibile ad una Università procedere con le proce-dure concorsuali e l’iniziativa verrà ripetuta perdue ricercatori a tempo determinato secondoquanto ora previsto dalla “riforma Gelmini”.L’INFN è presente anche nei corsi di Master (diprimo e secondo livello), e ha attivato nel corsodegli ultimi anni, assieme alle Università, nume-rosi corsi orientati a fornire agli studenti un’istru-zione caratterizzata da un elevato potenzialeapplicativo, ad esempio:Tecniche nucleari per l’Industria, l’Ambiente e iBeni culturali (Università di Tor Vergata e La Sa-pienza), Trattamenti di superficie applicati a Tec-nologie Industriali (LNL), Complessità e sueapplicazioni interdisciplinari (Università di Pavia),Progettazione Microelettronica (Università di Pa-dova), Information Technology (LNF), Basi fisichee tecnologiche dell’adroterapia e della radiote-rapia di precisione (Università di Tor Vergata),Scienze e Tecnologie degli impianti nucleari(Università di Genova e Ansaldo Nucleare).
Questi corsi costituiscono un ponte importantetra la ricerca di base e le necessità professionalidelle aziende, un processo di trasferimento tec-nologico estremamente utile che l’Ente intendeperseguire e ampliare attivamente nel prossimotriennio.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ RAPPO
RTIECONVENZIO
NICONLEUNIVERSITÀ
145

7. PIANO DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Fig. 7.1: Evoluzione temporale della pianta organica e del personaledipendente in servizio.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
01994 1996 1998 2008 20102000 2002 2004 2006
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.0001994 1996 1998 2008 20102000 2002 2004 2006
PIANTA ORGANICA
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Con riferimento al personale a tempo indetermi-nato, si evidenzia che, a differenza di quanto ac-caduto negli anni precedenti, l’Ente, che avevarappresentato la propria dotazione organica arti-colandola soltanto per profili, ha provveduto adelaborarla anche per livelli, adottando a tal fine ladeliberazione n. 12084 del 28 ottobre 2011,come richiesto dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri Dipartimento della Funzione Pubblica conNota 51924 del 18 ottobre 2011. L’evoluzionetemporale della dotazione organica e del perso-nale in servizio è mostrata in figura 7.1. Si può no-tare che, a fronte di una riduzione della dotazioneorganica da 2014 a 1906 avvenuta nel 2005,l’Istituto ha completato le assunzioni a tempo in-determinato, compatibilmente con le restrizioni dilegge, comprendo parzialmente il fabbisogno ri-chiesto dalle proprie attività e giungendo, però,alla quasi saturazione della pianta organica. Si re-gistra inoltre una flessione del personale in servizioper la mancata autorizzazione a procedere alle as-sunzioni previste nel 2010 e nel 2011. Si notianche l’andamento correlato relativo al personalea tempo determinato.
Il fabbisogno di personale è sostanzialmente de-terminato, sul piano operativo, dalla programma-zione pluriennale delle imprese scientifiche a cuil’Ente partecipa a livello nazionale ed internazio-
nale. Tali partecipazioni implicano, da un lato, laconduzione di esperimenti di grandi dimensionipresso laboratori internazionali (es. CERN) e na-zionali (i quattro Laboratori Nazionali dell’Ente), edall’altro, la realizzazione di avanzate infrastrut-ture tecnico-scientifiche presso i Laboratori Nazio-nali e in ambito europeo, coerentemente con ilPNR ed in accordo con la programmazione messain atto da ESFRI.
Sono parte di queste attività:
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
150
7.1 LE RISORSE DI PERSONALEDELL’ISTITUTO
La distribuzione del personale dipendente atempo indeterminato e dei relativi costi in servi-zio al 31-12-2011 è riassunta in tabella 7.1a.La distribuzione per profili del personale dipen-dente a tempo determinato in servizio al 31-12-2011 è illustrata in tabella 7.1b.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
149
Tab. 7.1a: Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dei costi relativi, al 31 dicembre 2011.
Tab. 7.1b: Distribuzione del personale dipendente a tempo determinato e dei costi relativi, al 31 dicembre 2011.
La sperimentazione presso LHC al CERN: lafase di presa dati è continuata con successo pertutto il 2011 coinvolgendo tutti gli esperimentia cui l’INFN partecipa. È necessario assicurarenei prossimi anni un numero adeguato di per-sonale ricercatore e tecnologo da coinvolgerenella fase di presa ed analisi dati, sia presso ilCERN che presso le sezioni, grazie alla pienaoperatività dei centri TIER1 e TIER2 presenti sulterritorio nazionale;Ai Laboratori Nazionali di Frascati, è continuata,da parte di una collaborazione internazionaleche coinvolge numerose e prestigiose Istituzionidi Ricerca, la fase di progettazione del collisoredenominato Super-B che avrà prestazioni 100volte maggiori degli attuali collisori. Come ampiamente sostenuto dalla comunitàscientifica internazionale, la Super-B aprira nuove finestre di studio dei fenomeni rari, uncampo ove piccole deviazioni dalle predizionidel Modello Standard sarebbero un sicurosegno di nuova fisica. Con l’approvazione delprogetto da parte del MIUR e del CIPE i primifinanziamenti di 19 M€ e 21M€ formalizzaticon il riparto del fondo ordinario EPR per il2010 e 2011, le attività del progetto subirannouna forte accelerazione impegnando un con-gruo numero di personale dipendente a tempodeterminato ed indeterminato.La costruzione dell’acceleratore e delle relativeinfrastrutture è affidata al neonato Consorziodenominato “Cabibbo-Lab” di cui sono socifondatori l’INFN e l’Università di Tor Vergata; Presso i LNGS è continuata con successo la fasedi presa dati dedicata allo studio delle oscilla-zioni dei neutrini con il fascio CNGS prove-niente dal CERN e con l’apparato OPERA. Irisultati fin qui ottenuti sono di assoluto valoreinternazionale e confermano l’ipotesi dellacreazione di neutrini Tau nel fascio CNGS. L’al-tro grande apparato, unico nel suo genere a li-vello internazionale, ICARUS, è stato messo infunzione ed è in fase di presa dati;
•
•
•
PROFILO
DIRIGENTE I FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA
DIRIGENTE DI RICERCA
PRIMO RICERCATORE
RICERCATORE
DIRIGENTE TECNOLOGO
PRIMO TECNOLOGO
TECNOLOGO
CTER IV
CTER V
CTER VI
OPERATORE TECNICO VI
OPERATORE TECNICO VII
OPERATORE TECNICO VIII
AUSILIARIO TECNICO VIII
FUNZIONARIO AMM. IVFUNZIONARIO AMM. VCOLLABORATORE AMM. VCOLLABORATORE AMM. VICOLLABORATORE AMM. VIIOPERATORE AMM. VIIOPERATORE AMM. VIII
N. FONDIPROGETTO
141
57
12
2
113
71.551,111.983.859,47
2.830.145,77
468.162,60
5.353.718,95
11151139
34
2
5
31
130
COSTO SU BASEANNUA CONTRATTI
FONDIPROGETTO
N. FONDIENTE E
OVERHEAD
IN SERVIZIOAL
31/12/12
01150120
8
2
2
22
71
COSTO SU BASE
ANNUA CONTRATTI
FONDI ENTE E
OVERHEAD
139.456,4171.551,11717.608,7093.193,0860.657,80
1.876.922,26
1.326.460,70
65.216,54
215.366,35
1.093.353,26
5.659.786,21
COSTO
0,0071.551,11717.608,70
0,0060.657,80962.524,24
312.108,40
65.216,54
86.146,54
775.928,12
3.051.741,45
-1
-1
-19
-26
-3
-9
-59
VARIAZIONI
RIMODULAZIONE DISTRIBUZIONE PROFILI 2012
IN SERVIZIOAL
31/12/12
019
120
8
2
2
22
65
COSTO
0,0071.551,11430.565,22
0,0060.657,80962.524,24
312.108,40
65.216,54
86.146,54
775.928,12
2.764.697,97
-6
-6
VARIAZIONI
2013
ON MEMORY
IN SERVIZIOAL
31/12/12
019
120
8
2
2
22
65
COSTO
71.551,11430.565,22
60.657,80962.524,24
312.108,40
65.216,54
86.146,54
775.928,12
2.764.697,97
VARIAZIONI
2014
PROFILO E LIVELLO
DIRIGENTE I FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA
DIRIGENTE DI RICERCA
PRIMO RICERCATORE
RICERCATORE
DIRIGENTE TECNOLOGO
PRIMO TECNOLOGO
TECNOLOGO
CTER IV
CTER V
CTER VI
OPERATORE TECNICO VI
OPERATORE TECNICO VII
OPERATORE TECNICO VIII
AUSILIARIO TECNICO VIII
FUNZIONARIO AMM. IVFUNZIONARIO AMM. V
COLLABORATORE AMM. VCOLLABORATORE AMM. VICOLLABORATORE AMM. VII
OPERATORE AMM. VIIOPERATORE AMM. VIII
RISORSE ASSUNZIONALI DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNO 2011
RISORSE ASSUNZIONALI DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNO 2009
RISORSE ASSUNZIONALI DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNO 2010
TOTALE
DOTAZIONEORGANICA
1112
11826822461045941142533371739460489129
110775117681665720243729
1.906
2011
1192701845734492942303431746157891123
10677526581685711243707
1.864
3
38
IN SERVIZIOAL
31/12/2013
ASSUNTI NELCORSO
DELL’ANNO
COSTO UNITARIOEX DM MIUR18/08/11
(IN MIGL. DI E)
70,000,000,00
159.551,18189.363,63152.167,23
0,0079.775,59
0,000,000,00
345.305,3145.407,31
0,000,00
251.061,600,000,000,000,000,00
98.658,660,000,00
90.814,620,000,000,000,000,000,00
1.412.105,13
282.421,033.211.164,23574.352,08
4.067.937,34
COSTO UNITARIOEX DM MIUR18/08/11
478.110,7678.110,76
79.775,5963.121,2150.722,41
79.775,5963.121,2150.722,41
49.329,3345.407,3141.843,60
41.843,6038.574,0436.355,14
36.355,14
49.329,3345.407,31
45.407,3141.843,6038.574,04
38.574,0436.355,14
5 6
233
1
71
6
2
2
27
20%100%20%
PASSAGGI DI
PROFILO N.
ASSUNZIONI PREVISTE
IN SERVIZIO AL31/12/2011(2+3+5+6)
801
11267219
439294
33617361
85123
7
506
1665711
70
1.807
COSTO PERSONALEIN SERVIZIO AL31/12/2011
9
79.502,07
13.809.553,9721.757.413,5412.159.862,96
4.956.893,557.278.472,035.258.364,14
16.432.369,457.471.794,772.386.319,18
3.412.377,73424.275,5597.824,81
239.801,47
2.569.769,80273.108,13
7.398.588,542.240.364,63387.964,06
258.520,45
108.893.140,83

PROFILO
DIRIGENTE I FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA
DIRIGENTE DI RICERCA
PRIMO RICERCATORE
RICERCATORE
DIRIGENTE TECNOLOGO
PRIMO TECNOLOGO
TECNOLOGO
CTER IV
CTER V
CTER VI
OPERATORE TECNICO VI
OPERATORE TECNICO VII
OPERATORE TECNICO VIII
AUSILIARIO TECNICO VIII
FUNZIONARIO AMM. IVFUNZIONARIO AMM. VCOLLABORATORE AMM. VCOLLABORATORE AMM. VICOLLABORATORE AMM. VIIOPERATORE AMM. VIIOPERATORE AMM. VIII
DOTAZIONEORGANICAVIGENTE AL31/12/11
111
1182682244594114337173948912975117166572072
1.906
APPLICAZ.ART.4CCNL
2008-09SOPPRES.PROFILO DI
AUSILIARIO
7
7-7
0
N.ANNO2010(*)
9
13
20
8
7
48
NUOVADOTAZIONEORGANICA(1+4)
611
11826822445941143371739489121605117166572072
1.906
PERSONALEIN SERVIZIO
AL31/12/11
101
11726721943929433617361851237506
166571170
1.807
POSTIDISPONIBILI
AL31/12/11(1-2)
31011522201033406011100902
1.807
N.
14
95353
3
28
PERSONALEIN SERVIZIO
AL31/12/11(2+9+10+11+14)
1601
10826221640891133331738785121005014166572070
1.843
POSTIDISPONIBILI
(6-2+7)
8101152220103340601110090299
N.
4
7-7
0
COSTO
5
36.355,14-36.355,14
0
COSTOCOMPLESSIVO
12
96.429,97
963.725,79
1.087.933,60
363.258,48
347.166,36
2.858.514,20
COSTOCOMPLESSIVOASSUNZIONI ERIMODULAZIONEDOTAZIONEORGANICA(5+12)
13
0,000,000,000,00
96.429,970,00
963.725,790,000,00
1.087.933,600,000,00
36.355,14-36.355,14
0,00363.258,48
0,000,00
347.166,360,000,00
2.858.514,20
COSTO
15
717.980,31315.606,05152.167,23398.877,95189.363,63
147.987,99
1.921.983,16
N.ANNO2011(*)
10
2
4
6
12
N.ANNO2012(*)
11
2
2
4
COLLOCAM. RIPOSO NELL’ANNORIMODULAZ. DISTRIB. PROFILI ASSUNZIONI PREVISTE
VARIAZIONE
(*) ASSUNZIONI CHE SI PREVEDE DI EFFETTUARE CON RISORSE DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNO 2009(**) ASSUNZIONI CHE SI PREVEDE DI EFFETTUARE CON RISORSE DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNO 2010(***) ASSUNZIONI CHE SI PREVEDE DI EFFETTUARE CON RISORSE DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNO 2011
a livello nazionale e internazionale. Non si è potutoinvece dar seguito all’avvio delle procedure ordi-narie di reclutamento di cui ai piani di fabbisognoprogrammato per gli anni 2010 e 2011 (budget2009 e 2010), non essendo ancora intervenute leprescritte autorizzazioni di legge: per tale motivole assunzioni previste per detto biennio il cui avviodelle procedure dovrebbe essere autorizzato nelcorso del 2012, sono state inserite nella program-mazione di tale ultima annualità. Il numero di po-sizioni a tempo indeterminato, messe in gioco conla programmazione di cui sopra per ogni profilo ela loro temporizzazione, tiene conto di un rap-porto ottimale fra le varie figure professionali ne-cessarie allo svolgimento dei programmi e progettidescritti nel presente documento.
Il piano di assunzioni sopra descritto:
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
152
A dette attività si aggiungono progetti strategicidi carattere applicativo e di trasferimento tecno-logico, quali ad esempio:
La posizione di leadership e di eccellenza, che l’Isti-tuto ricopre nello scenario internazionale, può es-sere seriamente compromessa in un futuroprossimo, se il quadro normativo non permetteràalmeno il ripristino della sostituzione del Turn-overnel breve periodo ed una sia pure ragionevole au-mento della Pianta Organica nel medio periodo.Lo scopo è quello di immettere nuove generazionidi personale tecnico-scientifico nell’ENTE per favo-rire il consolidamento e lo sviluppo dei progettigià in cantiere. Si sottolinea inoltre come neltempo le spese del personale stiano erodendo dianno in anno gli investimenti in ricerca che sonopassati nel periodo 2002-2011 da 100 a ≈56 M€.Investimenti significativi come la realizzazione delprogetto Super B introducono di fatto una primainversione di tendenza rispetto al recente passato.Nei primi mesi del 2011, a seguito del completa-mento delle procedure di attuazione del pianostraordinario di assunzione dei ricercatori, di cui alD.M. 3.12.2008, sono state assunte a tempo in-determinato 37 unità di personale ricercatore,concretizzando così l’ingresso in servizio di unanuova generazione di ricercatori fondamentale peril successo di iniziative che l’Istituto ha in cantiere
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
151
Il Progetto SPES presso i LNL, dedicato alla pro-duzione e accelerazione di nuclei instabili diprossima generazione, è in fase di realizzazioneper quanto riguarda la cosiddetta fase alfa.Sono state portate a maturazione progettualealcune iniziative applicative che si integrano inmodo sinergico con le installazioni dedicate allaFisica Nucleare e che potranno essere suppor-tate con risorse esterne all’ Ente. Dette iniziativeriguardano la produzione di radioisotopi inno-vativi per applicazioni mediche e la realizza-zione di sorgenti di neutroni dedicate alla Fisicadei sistemi di quarta generazione ed agli studisul danneggiamento di dispositivi elettronici; Il Progetto NEMO (LNS). Continua il collaudo diun dimostratore e delle infrastrutture tecnolo-giche ad esso associate alle profondità marinedi interesse. Il finanziamento ricevuto con il ri-parto 2011 rafforza la possibilità di realizzareun osservatorio europeo sottomarino di neutrinida realizzare in Sicilia al largo di Capo Passero;Il Progetto Strategico NTA, per la ricerca e losviluppo nel campo di nuove tecniche di acce-lerazione di particelle e delle relative parti tec-nologicamente critiche, continua ad esserefinalizzato al supporto di linee di interessescientifico prioritario per la programmazione alungo termine dell’Istituto.
Adroterapia: continua la fase preclinica di qua-lifica e caratterizzazione a Pavia della macchinaper adroterapia del progetto CNAO realizzatacon il contributo determinante dell’Istituto. Ilprogetto strategico denominato INFN-MED, ar-ticolato in cinque sottoprogetti ha continuatocon successo lo sviluppo di un nuovo avanzatoTreatment Planning System per adroterapia ba-sato su metodiche di calcolo tipiche della fisicanucleare e delle particelle. Questa attività è svi-luppata in collaborazione con una primaria in-dustria privata del settore;Ai LNF, il progetto SPARC, per ricerca e sviluppodi un laser ad elettroni liberi di nuova conce-zione con lunghezza d’onda di 500Å (lucegialla), ha prodotto risultati di rilevanza interna-zionale. È in fase di avvio l’espansione di SPARCall’interno della linea di sviluppo tracciata inpassato, che prevede lo sviluppo di tecniche in-novative in vista della costruzione di lasers aelettroni liberi alla frequenza dei raggi X molli;Il progetto INFN-GRID (CNAF), ha come obiet-
tivo lo sviluppo ed il coordinamento del middle-ware per il calcolo distribuito e la diffusione delparadigma di GRID ad altre discipline scientifi-che. È previsto e finanziato l’avvio di IGI nell’am-bito della strategia europea di avere un unicointerlocutore nazionale per quanto riguarda irapporti con EGI; L’INFN, per conto del Governo Italiano, parte-cipa al progetto ITER e al Progetto IFMIF-EVEDA,occupandosi di parti estremamente critiche sulpiano concettuale e tecnologico. Trattasi dei sot-toprogetti NBI (Neutral Beam Injection, ITER) at-traverso il Consorzio RFX e del sottoprogettoRFQ del quale l’INFN ha la responsabilità direttae di cui è iniziata la fase realizzativa. Quest’ul-timo sottoprogetto è fi naliz zato allo studio deimateriali da impiegare nei reattori di fusione;L’INFN, attraverso il progetto strategico INFN-E, co-ordina progetti di R&S nel campo della produzionedi energia da fissione e fusione, promuovendo laformazione del personale ed il trasferimento tec-nologico con l’industria del settore. In particolareil programma RIACE si occupa di temi quali: la si-curezza in ambiente nucleare, la sicurezza nei tra-sporti ed ai varchi, i sistemi di monitoraggio, laproduzione da energia di fissione (generazionequarta, neutronica etc.) e la produzione di energiada fusione (vedi punto precedente).
Ha l’obiettivo di inserire da un lato giovanibrillanti e, dall’altro, di ottimizzare la riparti-zione delle risorse umane nel territorio (Se-zioni, Laboratori Nazionali e CNAF) e fra levarie linee scientifiche dell’Istituto;Contiene l’impegno di procedere all’assun-zione di personale disabile per i posti che sirendano disponibili nella dotazione organicaa seguito di cessazione di personale apparte-nente a profili per il cui accesso è richiesto ilsolo requisito della scuola dell’obbligo;Prevede l’assunzione di personale disabile cherisulti idoneo nelle selezioni pubbliche anchein misura superiore alla riserva riferibile a cia-scuna procedura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tab. 7.2, 7.3a: Programmazione delle assunzioni per gli anni 2012, 2013.
PROFILO
DIRIGENTE I FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA
DIRIGENTE DI RICERCA
PRIMO RICERCATORE
RICERCATORE
DIRIGENTE TECNOLOGO
PRIMO TECNOLOGO
TECNOLOGO
CTER IV
CTER V
CTER VI
OPERATORE TECNICO VI
OPERATORE TECNICO VII
OPERATORE TECNICO VIII
AUSILIARIO TECNICO VIII
FUNZIONARIO AMM. IVFUNZIONARIO AMM. VCOLLABORATORE AMM. VCOLLABORATORE AMM. VICOLLABORATORE AMM. VIIOPERATORE AMM. VIIOPERATORE AMM. VIII
DOTAZIONEORGANICAVIGENTE AL31/12/12
111
11826822445941143371739489121605117166572072
1.906
N.(*)
8
2
1
7
2
12
N.(*)
12
34
44
15
--=
N.
15
22
1
5
1
2
13
50%
NUOVADOTAZIONEORGANICA(1+4)
611
11826822445941143371739489121605117166572072
1.906
PERSONALEIN SERVIZIO
AL31/12/12
101
10826221640891133331738785121005014166572070
1.843
POSTIDISPONIBILI
AL31/12/12(1-2)
31010685514074060130000263
PERSONALEIN SERVIZIO
AL31/12/13(2+8+10+12-15)
1701
10926422444921143281739484121005017164572070
1.864
POSTIDISPONIBILI
(6-2+7)
71010685514074060130000263
N.
4
COSTO
5
COSTO(RISORSE DATURN OVER2009-2011)
90,000,000,000,000,00
101.444,820,000,00
50.722,410,000,00
292.905,200,000,000,000,000,00
90.814,620,000,000,000,00
2.858.514,20
COSTO COMPLES-SIVO ASSUNZIONIDA TURN OVER2009-2011 ECONCORSI PERACCESSO LIVELLOI E II (9+14)
140,000,00
176.205,56151.040,02101.444,82192.859,94151.040,0250.722,41
0,000,00
292.905,200,000,000,000,000,00
90.814,620,000,000,000,000,00
1.207.032,59
COSTO (RISORSEDA TURN OVER2009-2012)
13
176.205,56151.040,02
192.859,94151.040,02
671.145,54
COSTO
16
159.551,18126.242,42
63.121,21
246.646,65
41.843,60
90.814,62
728.219,68
364.109,84
N.(**)
10
6
1
7
COSTO(RISORSE DATURN OVER2012)
110,000,000,000,00
304.334,460,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
45.407,310,000,000,000,00
349.741,77
4.067.937,342.858.514,201.207.032,59
2.390,55
COLLOCAM. RIPOSONELL’ANNO
RIMODULAZ. DISTRIB. PROFILI ASSUNZIONI PREVISTE ACCESSO LIVELLI I E IIPROFILI DI RICERCATOREE TECNOLOGO (ART. 15CCNL2002-2005)
VARIAZIONI
(*) ASSUNZIONI CHE SI PREVEDE DI EFFETTUARE CONRISORSE NON UTILIZZATE NEGLI ANNI 2010-2012
(**) ASSUNZIONI CHE SI PREVEDE DI EFFETTUARECON RISORSE DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNO 2012
RISORSE COMPLESSIVE TURN OVER 2009-2011
SPESA COMPLESSIVA ASSUNZIONI ANNO 2012
SPESA COMPLESSIVA ASSUNZIONI ANNO 2013 SU RISORSE TURN OVER 2009-2011

PROFILO
ASSEGNI PER LACOLLABORAZIONEALL’ATTIVITÀ DI RICERCA
109
N. COSTO
2.725.000,00
COSTO
2.725.000,00109
VARIAZIONIIN SERVIZIO AL31/12/2013COSTO
2.725.000,00 109
VARIAZIONIIN SERVIZIO AL31/12/2012
IN SERVIZIO AL 31/12/2011 2012 2013
COSTO
2.725.000,00
VARIAZIONIIN SERVIZIO AL31/12/2013
2014
Tali attività hanno richiesto e richiedono nelbreve periodo l’attivazione di contratti a tempodeterminato (a carico di fondi esterni) durantela fase di progettazione e costruzione, e l’inse-rimento graduale di un numero ragionevole dipersonale a tempo indeterminato, per il mante-nimento di infrastrutture e del know-how tec-nologico, che è quantificabile intorno a uncentinaio di unità a partire dai prossimi anni.L’Istituto è altresì impegnato ad attivare le pro-cedure concorsuali con cadenza biennale per ilI° e II° livello dei profili di ricercatore e tecno-logo, i livelli apicali di ciascun profilo e i passaggia livello superiore nel profilo per il personale tec-nico-amministrativo. Il numero di posti a con-corso è evidenziato nelle tabelle 7.4.
7.2 LE RISORSE FINANZIARIE
Evoluzione finanziaria 2002-2010Allo scopo di presentare un quadro significativodelle Entrate, sulle quali l’Istituto ha potuto con-tare, e delle conseguenti Spese, tramite le qualiha finanziato la propria attività di ricerca, è quianalizzata una serie storica di dati tratti dai Bi-lanci consuntivi dell’Istituto degli ultimi esercizi,rettificati con il sistema dei “prezzi costanti”; insostanza, sono stati eliminati gli effetti delle va-riazioni del potere di acquisto della moneta perlo studio delle variazioni in volume:-- adottando un unico sistema di prezzi riferitoall’anno 2010, con l’applicazione dei i seguenticoefficienti (Fonte: ISTAT):
-- rendendo, conseguentemente, possibile com-parare nel tempo le variazioni reali intervenuteattraverso una serie di grafici per le principali ti-pologie di andamenti, nonché traendo spunti diriflessione per i prevedibili andamenti futuri(Tutti i confronti comparativi nel periodo sonopresentati, rispetto alla mediana del 2006, evi-denziando la media aritmetica semplice dei 4anni dal 2007 al 2010 rispetto alla media arit-metica semplice dei 4 anni dal 2002 al 2005).
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
154
Le tabelle 7.2, 7.3 e 7.4 illustrano rispettivamenteil piano delle assunzioni e i relativi costi, e i pas-saggi a livello superiore per gli anni 2012, 2013,2014. In attesa dell’applicazione delle nuove di-sposizioni di legge in materia di concorsi riservatial personale interno (D.vo 150/2009), l’Istituto èinoltre impegnato, vista l’importanza e la criticitàdella materia, a trovare, nelle sedi istituzionali op-portune, una soluzione che soddisfi le legittimeaspettative del personale in servizio a tempo in-determinato tanto più oggi che le risorse finan-ziarie disponibili per i concorsi sono statedrasticamente ridotte dagli interventi legislativi del2010. Tali interventi limitano le risorse, per gli anni2012 e 2013 al 20% e per il 2014 al 50% del-l'ammontare degli stipendi del personale che hacessato il servizio nell'anno precedente, con unalimitazione ancora più incisiva se si tiene contodelle modalità di calcolo delle risorse liberate dal
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
153
Tab. 7.3b: Programmazione delle assunzioni per l‘anno 2014.
2012 2013 2014
CTER IV 4CTER VOP.TEC. VI 4OP.TEC. VIIAUS.TEC. VIIIFUNZ.AMM. IV 1COLL.AMM. VCOLL.AMM. VI
9
Tab. 7.4: Numero di posti a concorso per il triennio 2012-2014, perle progressioni economiche e i passaggi a livello superiore per il per-sonale tecnico-amministrativo.”
Anno
20022003200420052006
Tab. 7.5: coefficienti per un sistema unico di prezzi riferito all’anno2010 (Fonte: ISTAT) :
Coefficiente
1,16451,13661,11441,09581,0743
Anno
2007200820092010
Coefficiente
1,05621,02311,01551,0000
510,0
490,0
470,0
450,0
430,0
410,0
390,0
370,0
350,0
330,0
310,0
290,0
270,0
250,0
2002 2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
previsioni definitive di spesa
“LA COMPETENZA”: CORRELAZIONE TRA ENTRATE, SPESE PREVISTE E IMPEGNATE(prezzi costanti 2010 - milioni di euro)
media 2007-2010su media 2002-2005
-19,8%
media 2007-2010su media 2002-2005
-9,4%
media 2007-2010su media 2002-2005
-17,3%
entrate totali spese impegnate totali
Evidenze:
Tutti gli andamenti evidenziano sistematiche riduzioni, c.s.:• le Previsioni definitive di spesa diminuiscono del 19,8%;• le Entrate totali accertate si sono erose del 9,4%; fra que-ste, i Trasferimenti dello Stato ordinari ed a destinazione spe-cifica, dagli anni 2002-2005 agli anni 2007-2010, sonopassati dal 94% al 92% delle Entrate totali; (si noti che, peressere comparabili con gli esercizi precedenti, le Entrate2010 non includono i 25,5 milioni a destinazione specifica,comunicati nel dicembre 2010, fra i quali rilevano 19 milioniper SuperB);• le Spese totali impegnate si connotano per un conse-guente progressivo contenimento del 17,3%, con variazioniannuali molto accentuate, anche di segno opposto, sostan-zialmente causate dalla assegnazione degli Avanzi pregressie dal conseguente utilizzo negli anni successivi rispetto al-l’esercizio di origine; si noti che, negli anni in cui l’utilizzodegli Avanzi pregressi è maggiore, si registra un volume dispese impegnate superiore alle entrate accertate nell’eser-cizio specifico (c.d. “disavanzo di competenza”).
Commenti:
Nell’ambito della sistematica riduzione di risorse, emergeuno spazio temporale circa triennale nel reale impegno dellerisorse disponibili per la spesa rispetto alle previsioni (picchidelle Spese totali nel 2003, 2006 e 2009), verosimilmenteanche a conferma che la convenzionale “competenza” an-nuale sta stretta al ciclo produttivo della ricerca INFN.Nondimeno, la progressiva erosione degli Avanzi disponibili,documentata in uno specifico grafico a seguire:- fa venir meno una fonte storica di finanziamento su cuil’Istituto ha potuto contare da molti anni, e- rende sempre più necessario affinare il processo previsio-nale, anche pluriennale, basato sugli stanziamenti annualiMIUR che costituiscono il limite strutturale alla spesa di base. In questo senso, la riduzione di 35,6 milioni dell’assegna-zione MIUR per la Previsione 2011 rispetto ai precedentiesercizi – con una parziale correzione migliorativa costituitadalla futura quota “premiale” - costituisce una forte acce-lerazione di questo processo.
PROFILO
DIRIGENTE I FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA
DIRIGENTE DI RICERCA
PRIMO RICERCATORE
RICERCATORE
DIRIGENTE TECNOLOGO
PRIMO TECNOLOGO
TECNOLOGO
CTER IV
CTER V
CTER VI
OPERATORE TECNICO VI
OPERATORE TECNICO VII
OPERATORE TECNICO VIII
AUSILIARIO TECNICO VIII
FUNZIONARIO AMM. IVFUNZIONARIO AMM. VCOLLABORATORE AMM. VCOLLABORATORE AMM. VICOLLABORATORE AMM. VIIOPERATORE AMM. VIIOPERATORE AMM. VIII
DOTAZIONEORGANICAVIGENTEAL
31/12/2013
111
11826822445941143371739489121605117166572072
1.906
201
10926422444921143281739484121005017164572070
1.864
3109401209005060102000242
PERSONALE INSERVIZIO AL31/12/2013
POSTIDISPONIBILI31/12/2013(1-2)
POSTIDISPONIBILI(6-2)
7109401209005060102000242
COSTO COMPL.ASSUNZIONI ERIMODULAZIONEDOTAZIONEORGANICA(5+9)10
N.
11
84
3
161
1
24
COSTO
12
638.204,72252.484,84
239.326,77
50.722,41295.975,9845.407,31
41.843,60
1.563.965,63
PERSONALE INSERVIZIO AL31/12/2013(2+8-11)
1301
1012622264193114322172948312100501716457207042
8
22
11
6
90,000,000,00
126.242,42101.444,82
0,0063.121,21
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0042
N.(*) COSTO
N.
4 5 611
11826822445941143371739489121605117166572072
1.906
COSTO
NUOVADOTAZIONEORGANICA(1+4)
RIMODULAZIONE DISTRIBUZIONE PROFILI ASSUNZIONI PREVISTE COLLOCAMENTI A RIPOSO
VARIAZIONI
(*) ASSUNZIONI CHE SI PREVEDE DI EFFETTUARE CON RISORSE DERIVANTI DA CESSAZIONI ANNO 2013
personale che cessa dal servizio, previsti dal D.M.del MIUR del 10.08.2011. Nella situazione pre-sente di gravi carenze dell'organico, l’Istituto haritenuto prioritario, negli anni 2012, 2013, 2014,concentrare le risorse finanziarie disponibili perl’assunzione di nuovo personale, creando le con-dizioni per l ’inserimento, tra l'altro, di un congruonumero di personale dipendente con contratto atempo determinato. È altresì da sottolineare chel’Istituto, alla luce dell’approvazione del MIUR edel CIPE, ha iniziato la fase di pre-costruzione invista della realizzazione della Super B-Factory.L’Istituto è inoltre coinvolto in un numero signifi-cativo di progetti strategici, finanziati con fondidell’Unione Europea, delle Regioni o con inter-venti governativi straordinari in ottemperanza diaccordi internazionali.
Tali progetti coprono attività di primario interessenazionale e riguardano:Lo sviluppo dell’infrastruttura GRID e l’istitu-zione di IGI; Applicazioni mediche, tra cui la partecipazionealla fase preclinica di qualifica e caratterizza-zione del fascio nonché alle attività di radiobio-logia del Centro Nazionale di AdroterapiaOncologica (CNAO); Progetti nel campo dell’Energia, tra cui unapartecipazione alla costruzione di ITER e diIFMIF-EVEDA, e problematiche connesse allosviluppo dei reattori di quarta generazione.
•
•
•

PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
156
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
155
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2002 2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
spese ricerca, prog specialie strategici, calcolo
LA CORRELAZIONE TRA SPESE DI RICERCA, FUNZIONAMENTO, SERVIZI-ATTREZZATURE, PERSONALE(prezzi costanti 2010 - milioni di euro)
media 2007-2010su media 2002-2005
-46,8%
servizi e attrezzaturedi base
media 2007-2010su media 2002-2005
-44,8%
funzionamentomedia 2007-2010su media 2002-2005
+2,7%
media 2007-2010su media 2002-2005
+6,4%
media 2007-2010su media 2002-2005
-35,2%
spese per il personale spese ricerca
Evidenze:
• La Spesa per il Personale é incrementata del 6,4%, sep-pure in maniera non lineare, prevalentemente a causa deglieffetti retroattivi dovuti ai ritardati rinnovi del CCNL (neglianni 2006 e 2009 i picchi di spesa sono stati così rilevantida recare effetto visibile sull’andamento della spesa totale);l’incremento origina anche dalle assunzioni di nuovo perso-nale, in gran parte finanziate con fondi diversi dai trasferi-menti ordinari MIUR, come dettagliato negli ultimi 6 graficidi questa presentazione. L’incidenza della spesa per il per-sonale sul totale delle spese –utilizzando le classificazioniuniformi evidenziate nei bilanci consuntivi degli anni consi-derati— è così salita dal 37% (media 2002-2005) al 47%(media dal 2007 al 2010). • La Spesa per la Ricerca è presentata con due sintesi:- quella direttamente controllata dalle Commissioni scienti-fiche nazionali, che presenta un decremento del 35,2%;- quella inclusiva dei Progetti strategici e speciali e del Calcolo,che evidenzia una riduzione ancor più marcata del 46,8%.• La Spesa per Servizi ed attrezzature di base presenta, an-ch’essa, un andamento decrescente del 44,9%, trattandosidi tipologie di spesa soggette a decisioni periodiche, di normarelative a forniture esterne, più facilmente comprimibili in pre-senza di una riduzione evidente nelle risorse disponibili.• La Spesa per il Funzionamento presenta un andamentocrescente (+2,7%), corrispondentemente all’effetto di tra-scinamento che l’ordinaria operatività reca con sé in unapluralità di articolazioni logistiche come quelle dell’INFN.
Commenti:
Si conferma la natura tendenzialmente variabile delle speseper la ricerca, che stanno sostenendo il carico maggiore de-rivante dalla compressione delle risorse complessivamentedisponibili. Per altro verso, il costante incremento dellaSpesa per il Personale, unitamente a quello della Spesa peril Funzionamento, confermano l’esistenza di un solido trendin crescita, verosimilmente non modificabile se non me-diante interventi sulle strutture e sull’organizzazione.
Evidenze:
• La Spesa in conto capitale presenta un andamento quasicostantemente decrescente (-63,2%), con picco contrarionel 2003/2004 dipendente dalle intense attività di investi-mento realizzate nel periodo (LHC, Fasci neutrini al GranSasso, Virgo).• La Spesa corrente presenta un incremento complessivo del3,2%, con picchi nel 2002 per il progetto GARR e nel 2006e 2009 prevalentemente causati dagli effetti dei rinnovi con-trattuali.• La Spesa totale decresce dell’17,3% come effetto nettodei due opposti andamenti rilevati nella Spesa in conto ca-pitale ed in quella corrente.
Commenti:
“Spesa in conto capitale” e “Spesa corrente” configuranodue grandi agglomerati –che, di per sé, classificano tutte lespese a fini tipicamente contabili-- i cui andamenti, comun-que, confermano che l’attuale struttura e funzionalità del-l’Ente tendenzialmente assorbono risorse crescenti.In tal modo, la riduzione espressa dalla spesa per interventidi tipo pluriennale – fra i quali spiccano quelli per la ricerca- oltre a scontare la contrazione complessiva delle Entrate,deve anche compensare una siffatta crescita per trascina-mento delle spese correnti.
Evidenze:
• L’istogramma evidenzia come, mentre l’ Avanzo totale de-crementa del -36,2%, l’Avanzo disponibile quasi raddoppiatale abbattimento raggiungendo un decremento di -67,4%.• In percentuale sulle Previsioni definitive di spesa, l’Avanzo di-sponibile decresce costantemente fino all’esercizio 2005 per,poi, assestarsi su un range del 5%-8% dal 2006 fino al 2010.
Commenti:
La dimensione dell’Avanzo si conferma essere finora una rile-vante fonte di risorse, generata nell’esercizio di competenza eriassorbita in quelli successivi, specialmente il primo; esso di-mostra quanto strutturale sia lo sfasamento temporale fra leassegnazioni “per competenza”, tipiche della contabilità diStato, e gli effettivi impieghi disposti in base ai progetti stabiliti.Nondimeno, la sua progressiva erosione –soprattutto per laparte di Avanzo disponibile-chiaramente conferma una situa-zione progressiva in cui:• la parte giuridicamente vincolata dell’Avanzo è dominate,lasciando parti residuali alla libera disponibilità ad integrazionedelle previsioni di competenza; • le Previsioni di competenza dovrebbero essere:- ragionate in ottica pluriennale e non solo sull’esercizio di 12mesi, e - costruite in maniera analitica per singolo esperimento, pro-getto, struttura di funzionamento o linea di responsabilità at-tuativa.
Evidenze:
I Residui passivi (debiti verso terzi) scendono del 39,4%, se-guendo un trend pressoché costante negli anni, per effettodei seguenti andamenti contrapposti, evidenziati dall’isto-gramma:• decremento dei debiti generati dall’acquisto di beni durevoli(costruzione apparati, macchinari, mobili,…);• incremento del debito verso dipendenti per Trattamento fineservizio/rapporto;• andamento fisiologico dei debiti correnti (spesa per consumi,servizi,…) riconducibile ad una media semplice di 84 milioniannui.
Commenti:
I residui passivi si riferiscono a impegni di spesa, in sostanza,riconducibili a tre diverse nature:a. impegni per i quali è prossimo il ricevimento del bene/servi-zio acquistato e, quindi, è prossimo anche il pagamento, conla relativa chiusura del residuo; in presenza di disponibilità dicassa, tali residui hanno vita breve;b. impegni per acquisti di beni durevoli e immobilizzazioni tec-niche, nonché per il trattamento di fine rapporto del perso-nale, il cui effettivo pagamento avverrà nel medio/lungotermine; c. impegni su procedure in via di espletamento (inclusi i c.d.“impegni di stanziamento”) per i quali, ove a fine esercizionon siano state assunte obbligazioni di spesa verso terzi, è nor-mativamente prevista la rilevazione di un’economia di bilanciocon generazione di avanzo; di fatto, essi tendono a restare invita oltre la fine dell’esercizio.Il decremento costante dei debiti verso terzi rilevato negli anniesaminati:• è stato reso concretamente possibile anche dal venir menodelle forti limitazioni di cassa conosciute negli anni passati, ma• sostanzialmente evidenzia un rallentamento nell’attività dicostruzione di nuovi esperimenti per la quale dall’assunzionedell’”impegno” al relativo pagamento trascorre un tempo fi-siologicamente più lungo.Nel 2010 si è, comunque, proceduto ad una rilevante “puli-zia” di residui storici non più giustificati.
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2002 2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
spesa totale
LA CORRELAZIONE TRA SPESA TOTALE, SPESA CORRENTE E SPESA IN C/CAPITALE(prezzi costanti 2010 - milioni di euro)
media 2007-2010su media 2002-2005
-17,3%
media 2007-2010su media 2002-2005
+3,2%
media 2007-2010su media 2002-2005
-63,2%
spesa corrente spesa conto capitale
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,02002 2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
avanzo totale
L’EREDITÀ AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(prezzi costanti 2010 - milioni di euro)
media 2007-2010su media 2002-2005
-36,2%
media 2007-2010su media 2002-2005
-67,4%
avanzo disponibile %avanzo disponibilesu previsioni definitive
di spesa
24%
20%
10%7%
5%
8% 7%6%
5%
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,02002 2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
beni durevoli
L’EREDITÀ AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI: RESIDUI PASSIVI(prezzi costanti 2010 - milioni di euro)
trattamentofine servizioe simili
debiti correnti totalitotale residuimedia 2007-2010su media 2002-2005
-39,4%
325 314,2331,3
296,7
242,3 209,9
189,8
196,4
171,7

Su tale base, le previsioni di entrata e di spesanel triennio, di seguito presentate, utilizzano iseguenti criteri di riferimento.
EntrateSi assume una base minima di finanziamento delMIUR equivalente a quello previsto per il 2012anche per i due esercizi successivi; ad essa è ag-giunta un’assegnazione premiale nell’ordine del10%, derivante dal raggiungimento di obiettivispecifici posti dal MIUR, ed un’assegnazione vin-colata per “progetti bandiera” interamente assor-bita da corrispondenti spese.L’Istituto è, inoltre, attivo –sia a livello centrale, daparte delle Commissioni scientifiche e degli Or-gani di governo dell’Ente, sia a livello locale, daparte delle singole strutture territoriali-- nella ri-cerca di “fondi esterni” finalizzati a specifiche fi-nalità di ricerca, tali da integrare in quantitàcrescente il trasferimento dello Stato (es.: UnioneEuropea, Regioni, ASI, altri enti di ricerca, privati);tali fondi non sono inseriti nella previsione trien-
il profilo triennale delle risorse disponibili edella spesa 2012-2014Le previsioni di spesa per gli esercizi compresinel bilancio triennale riflettono il diverso sistemadi finanziamento adottato dal MIUR a partire dal2011 – a seguito del D.Lgs 31.12.2009 n. 213(riordino degli Enti di ricerca) – in sintesi consi-stente in:
nale sia per la difficoltà di quantificarli in misuraragionevolmente precisa sia perche sono obbliga-toriamente destinati a finanziare specifici progettidi ricerca e conseguenti spese da essi dipendenti.Si conferma, comunque, che ogni Avanzo di Am-ministrazione generato dai singoli esercizi sarà in-teramente utilizzato nell’esercizio successivo.
SpeseI progetti di ricerca dell’Istituto si caratterizzano nor-malmente per una durata pluriennale che può facil-mente raggiungere il decennio, nel corso della qualel’assorbimento di risorse finanziarie varia considere-volmente in funzione della specifica fase di sviluppo(es.: Conceptual Design report, R&D, Technical De-sign Report, Ingegnerizzazione, Costruzione, Com-missioning, Presa dati, Decommissioning).È, dunque, indispensabile poter contare su un flussoragionevolmente costante di risorse che, mediandole diverse fasi di avanzamento dei progetti, assicurila copertura di un volume di spesa sostanzialmentecorrispondente, seppure composto da tipologieassai diverse nel tempo. A parte le spese per progettifinanziati specificamente dal MIUR –esposte per to-tale nella stessa misura delle entrate, senza dettaglioper specifica tipologia-- si è assunto il mantenimentodelle spese per Ricerca, Personale, Funzionamentoe Attrezzature e Servizi ai livelli 2012. Come evidenziato nella seguente tabella 7.6non si può, tuttavia, fare a meno di rilevare che:
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
158
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
157
25.000
20.000
15.000
10.000
5.00
02002
23.595,8
3.110,512%
8.205,2
2.069,120%
8.815,9
2.104,719%
9.193,5
1.592,315%
9.331,6
1.777,616%
8.668,0
1.307,013%
8.141.8
1.574,016%
8.954,1
1.826,817%
8.931,9
1.783,017%
8.623,7
1.943,218%
23.359,0
2.354,49%
22.848,2
6.445,322%
24.490,6
3.657.613%
24.319,4
3.514,513% 21.417,5
3.147,813% 19.309,1
2.694,712%
2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
SPESE MISSIONI
(prezzi costanti 2010 - milioni di euro)
17.897,917.897,913%
14.003,3
4.297,323%
missioni all’esteromedia 2007-2010su media 2002-2005
-23%
sopra: Impegnatosotto: avanzo e %
su previsioni definitivemedia 2007-2010su media 2002-2005
-3%
missioni in Italia
Evidenze:
• Le missioni estero decrescono del 23%, con forte accen-tuazione nel 2010 per effetto dell’eliminazione delle diariea partire da giugno (numeri sopra rette); nonostante ciò,mantengono significativi avanzi rispetto alle assegnazioniiniziali, sia in valore assoluto sia in percentuale (numeri e %sotto rette).• Le missioni Italia decrescono del 3% mantenendo, tutta-via, un trend sostanzialmente lineare nel tempo; ciò anchecon riferimento agli avanzi rispetto alle assegnazioni iniziali.
Commenti:
Siamo in presenza di una forte riduzione complessiva dellespese per missioni:– già sostanzialmente emersa per le missioni estero, sia perle minori attività realizzate sia, nel 2010, per le disposizionidi legge,– prevista nel 2011 anche per le missioni Italia, per le me-desime disposizioni di legge.In questa situazione - in presenza di una diffusa, lamentatainsufficienza di disponibilità sulle missioni – sembrerebbestrano il permanere di cospicui avanzi rispetto alle assegna-zioni iniziali, sia in valore assoluto sia in percentuale, talvoltaconsiderato fisiologico.
Al proposito, volendosi mantenere l’assegnazione specificadelle missioni ai singoli esperimenti/unità organizzative, sidovrebbero almeno adottare prassi per giungere ad unamaggiore rapidità sia nell’approvazione degli storni sia nel-l’emissione dei mandati; in tal senso, il nuovo regolamentodi amministrazione ed il “mandato informatico” potrebberorecare significativi benefici.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
02002 2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
totale dipendenti a tempoindeterminato (a)
NUMERO DI PERSONALE DIPENDENTE (TEMPO INDET.+TEMPO DET.) E ASSOCIATO(Fonte: Bilanci Consuntivi)
media 2007-2010su media 2002-2005
-1%
totale dipendenti a tempodeterminato (b)media 2007-2010su media 2002-2005
+20%
totale dipendenti a tempoindet. (a) + det (b)media 2007-2010su media 2002-2005
+2%
personale associatomedia 2007-2010su media 2002-2005
+7%
3.282
2.048
1.790
258 197 230 345 389 393 329 275 243
1.779 1.816 1.811 1.771 1.737 1.790 1.818 1.801
1.976 2.046 2.156 2.160 2.130 2.119 2.093 2.044
3.308 3.372
3.8603.697 3.572
3.701 3.747 3.746
800
700
600
500
400
300
200
100
02002 2003 2004 2009 20102005 2006 2007 2008
totale amministrativimedia 2007-2010su media 2002-2005
+6%
NUMERO DIPENDENTI (TEMPO INDET.+TEMPO DET.) PER AREA DI IMPIEGO(Fonte: Bilanci Consuntivi)
totale ricercatorimedia 2007-2010su media 2002-2005
0%
totale tecnicimedia 2007-2010su media 2002-2005
-3%
T.d. ex art. 15media 2007-2010su media 2002-2005
-5%
T.d. ex art. 23media 2007-2010su media 2002-2005
+40%
totale tecnologimedia 2007-2010su media 2002-2005
-2%
732
563
273222
136164
79
270
217 221
209 214
222 213
186
89107
152144
230283 280 275 269
302 304 302
108 123
565 587 586 573 566 563595 574
727 725 726 714 701 711 706 695
219
212
13310789
122
245 241
201
Fig. 7.2 a): Evoluzione temporale del personale dipendente a tempodeterminato, indeterminato e associato
Fig. 7.2 b): Evoluzione temporale del numero di dipendenti per “areadi impiego”
Lo stanziamento diretto, a valere sul Fondo ordi-nario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, di:- una quota non inferiore al 7% del Fondo per il“finanziamento premiale di specifici programmi eprogetti, anche congiunti, proposti dagli enti”, e- una quota pari all’8% del Fondo per il “sostegnodei progetti bandiera inseriti nella programma-zione nazionale della ricerca e per il finanziamentodi progetti di ricerca ritenuti di particolare interessenell’ambito delle scelte strategiche e/o degli indi-rizzi di ricerca impartiti dal MIUR”;La conseguente assegnazione strutturalmenteridotta per il 2012, equivalente all’assegna-zione ordinaria per il 2011 ma pari all’87% diquella stabilita per il 2010 che, per INFN, signi-fica una riduzione di 32,2 milioni di euro (da273,8 nel 2010 a 241,6 nel 2011 e 2012).
Il trend storico delle principali tipologie dispesa presenta caratteristiche sostanzial-mente diverse da quelle che sarà necessarioimprimerle per il futuro, in considerazionedella drastica riduzione di finanziamentopubblico applicata, econseguentemente, potente si presenta la sfidadi mantenere l’attuale livello di eccellenza nellaricerca con una siffatta contrazione:
•
•
•
•
I rinnovi dei CCNL e l’incremento del personale hanno generato il trend dicrescita; l’applicazione della Legge 30.7.10, n. 122, con il relativo limite alrinnovo del turn-over ed il blocco dei CCNL sta determinando l’interruzionedi questo trend. Nella sostituzione del turn-over si dovranno concentrarele nuove assunzioni su ricercatori e tecnologi.
Le dimensioni ormai raggiunte dall’Istituto, con l’attuale articolazione or-ganizzativa, hanno alimentato una dimensione crescente di queste spese,che tendono a diventare fisse. Per il futuro si rende necessaria una signifi-cativa razionalizzare delle strutture e semplificazione delle prassi di lavoro.
La contrazione passata delle Entrate (-9,4% nel periodo medio 2007-2010rispetto al medio 2002-2005, a “valori costanti” 2010) è stata, sostanzial-mente, assorbita da minori spese per la ricerca e per Attrezzature e Servizi.Per il futuro si dovrà quanto meno recuperare maggiori livelli di efficienza,in tutti i settori, liberando risorse per la ricerca.
Variazione Media 2007-2010su media 2002-2005(valori costanti 2010)
+6,4%
+2,7%
-46,8%
-44,9%
% sul totale 2010
55%
11%
23%
11%
100%
Tipologia di spesa
Personale
Funzionamento
Ricerca (senza personale)
Attrezzature e Servizi
Tab. 7.6: Profilo di spesa per Ricerca, Personale, Funzionamento, Attrezzature e Servizi.

7.4 LA FORMAZIONE E LE AZIONIDI SOSTEGNO DEI GIOVANI
L’Istituto pone particolare attenzione alla forma-zione dei giovani attraverso le proprie ricerche,sia durante gli studi universitari per il consegui-mento della laurea magistrale, sia dopo la laureacon il dottorato e i master universitari, e infinecon un vasto programma annuale di borse distudio, di formazione e assegni di ricerca scien-tifica o tecnologica. Sono stati anche istituiti as-segni di ricerca dedicati alla valorizzazione, inambito produttivo, delle metodologie e delletecnologie legate alle attività di ricerca dell’INFN,a supporto dell’impegno sul versante del trasfe-rimento tecnologico e di conoscenze verso ilmondo sociale ed economico.
Nel 2011 sono state bandite:
Inoltre sono stati banditi i seguenti premi:
Del ruolo e del coinvolgimento dell’Istituto nelleuniversità si è già detto (vedi capitolo 6). Per la for-mazione dei giovani sono altrettanto essenziali lenumerose iniziative e attività con le scuole (vediad es. il progetto EEE al paragrafo 3.10), di comu-nicazione e di diffusione della cultura scientificaattraverso mostre, eventi, seminari, come è de-scritto in dettaglio nel successivo capitolo 8, or-ganizzate sia a livello centrale sia a livello deilaboratori nazionali e delle singole strutture.
7.5 LE PARI OPPORTUNITÀ E LAVALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE COME ELEMENTI DI SVILUPPO DIUNA SCIENZA CONSAPEVOLE
Il CUG e il Piano di Azioni Positive 2011-2013Sulla base della legge 4 novembre, n. 183 (c.d.Collegato lavoro), con l’art 21, l’INFN, con Di-sposizione n. 14378 del 14 aprile 2011 del Pre-sidente dell’Istituto, istituisce il Comitato Unicodi Garanzia (sito web: www.infn.it/CUG ).Nel 2011, anno di transizione dal ComitatoPa-riOpportunità (CPO) al CUG, il nuovo Comitatoha iniziato, presso le Strutture dell’Ente, un per-corso di sensibilizzazione inerente le proprie te-matiche ed attività, di avvicinamento alle nuoveproblematiche sul benessere organizzativo e diinterazione con la dirigenza dell’ente nel tenta-tivo di formalizzare una modalità di collabora-zione continuativa ed efficace. Durante il corsodell’anno il Comitato si è dotato di un regola-mento proprio pubblicato sul sito.
Dai Comitati per le Pari Opportunità (CPO)ai Comitati Unici di Garanzia (CUG)Le “misure per favorire pari opportunità nel lavorotra uomini e donne” sono entrate a far parte dellematerie oggetto della contrattazione decentratanel 1988 con la nascita dei CPO, costituiti nelpubblico impiego grazie alla contrattazione col-lettiva.I CPO hanno avuto un ruolo di riflessione e pro-positivo nell’individuazione di azioni in favore delpersonale, per tutelare la dignità della persona emigliorare la qualità della vita lavorativa attraversouna più efficace e sensibile valorizzazione delle ca-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
160
Spesa amministrativaCon specifico riferimento alla spesa amministra-tiva sostenuta per la gestione dell’Ente, oltre allegenerali “spese per il funzionamento” – quan-tificabili nell’ordine del 5% della spesa totale –si può far riferimento alla spesa necessaria perle retribuzioni del personale amministrativo; sifornisce, al proposito, la seguente sintesi:
7.3 IL CONTRIBUTO DEL PERSONALEASSOCIATO
Il ruolo ed il contributo del personale associato al-l’INFN è stato ampiamente evidenziato – nel casodi gran lunga prevalente costituito dal personaleuniversitario – nel capitolo 6. La collaborazionealle ricerche dell’Ente da parte del personale as-sociato, anche non universitario, si esplica nelleattività scientifiche coordinate dalle commissioniscientifiche nazionali e nei progetti strategici especiali, nei progetti europei e in particolare neiprogetti congiunti con altri Enti (vedi capitolo 3),sostenuti quasi sempre da specifici accordi e con-venzioni (vedi capitolo 5). Si riporta in tabella 7.9il quadro completo delle associazioni aggiornatoal 21 febbraio 2011. L’ampiezza e la qualità delcontributo del personale associato alle ricerchedell’INFN, in particolare quello universitario, costi-tuisce un eccellente esempio di sinergia fra acca-demia e enti di ricerca, previsto anche dal Decretodi riforma degli Enti Pubblici di Ricerca, nonché unelemento fondante del successo delle attività nelcontesto nazionale e mondiale.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
159
ENTRATE:Assegnazione ordinaria MIURAssegnazione premiale MIURAssegnazione vincolata MIUREntrate diverse
Totale Entrate
SPESE:ATTIVITÀ DI RICERCA:Fisica delle particelleFisica AstroparticellareFisica NucleareFisica TeoricaRicerche Tecnologiche
Progetti strategici, speciali ed altreiniziative specifiche
Progetti finanziati specificamente MIUR:ITER e Broader ApproachAgenzia Fusion for EnergyIGI - EGIKm3NetSuperB
Totale RicercaFUNZIONAMENTO STRUTTURE:LNFLNGSLNLLNSCNAFSezioni e Gruppi CollegatiOrgani Direttivi e Strutture Centrali
Totale Funzionamento
FONDI CENTRALI E PARTECIP.A CONSORZI(include Energia elettrica e Contributia altri Enti di ricerca)PERSONALEFONDO DI RISERVA
Totale Spese
RISORSE FINANZIARIEDISPONIBILI 2012-2014
241,46--
3,17244,63
19,3013,019,912,483,9648,66
7,75
- 56,41
8,006,425,895,631,089,941,0037,96
3,18
145,002,08
244,63
2012
238,1723,8245,003,66
310,65
48,66
7,75
45,00 101,41
37,96
22,31
146,892,08
310,65
2013
238,1723,8255,003,66
320,65
48,66
7,75
55,00 111,41
37,96
22,31
146,892,08
320,65
2014
Tab. 7.8: Profilo di spesa relativo al triennio 2012-2014.
Tab. 7.7: coefficienti per un sistema unico di prezzi riferito all’anno2010 (Fonte: ISTAT)
2012
13.300
12.748
1.200
Spese per il funzionamento
Spesa per il personaleamministrativo
Sistema informativo
2013
13.200
12.700
700
2014
13.100
12.600
400
Scientifica Ricercatori/Professori università 497Scientifica Professori a Contratto 16Scientifica Dipendenti altri enti 130Scientifica Istituti secondari 48Scientifica Enti stranieri (FAI) 4Scientifica Enti stranieri 59Scientifica Consorzi Ricerca 0Scientifica Laureandi Magistrali 174Scientifica Borse INFN 108Scientifica Dottorandi, Borse non INFN e Assegni 861Scientifica Borse Private 1Scientifica Specializ. Fis. Sanitaria 10Scientifica Contratti a tempo det. 19 12Scientifica Personale E.P. 2Scientifica Senior 216Scientifica Master 5Scientifica attribuita dal Presidente 47Tecnologica Contratti a tempo det. 19 4Tecnologica Ricercatori/Professori università 106Tecnologica Altri Enti (laurea o diploma univ.) 26Tecnologica Laurea Magistrale 14Tecnologica Borse INFN 83Tecnologica Dottorandi, Borse non INFN e assegni 136Tecnologica Consorzi ricerca 3Tecnologica Personale E.P. 12Borsisti INFN per Estero 0Incarico di Ricerca scientifica 818Incarico di Collaborazione Tecnica 104Incarico di Ricerca attribuito dal Presidente 15Incarico di Ricerca tecnologica 34Associazione Tecnica 119Associazione Tecnica Senior 28
TOTALE 3692
INCARICHI DI ASSOCIAZIONE TOTALE ASSOCIAZIONI
Tab. 7.9: Distribuzione del personale associato all’INFN al 31-12-2011
di ricerca con una tesi nel campo della fisicaastroparticellare;Premio Nazionale “Marcello Conversi” perdottorati di ricerca con una tesi nel campodella fisica subnucleare.
20 borse di formazione tecnica per giovanidiplomati; 3 borse di formazione e studio per attivitàamministrativo-gestionali per diplomati;21 borse di studio per laureandi;20 borse di studio per neolaureati;8 borse di studio per tecnologi (laureati) neisettori meccanico, impiantistico, materiali;24 borse di studio (per laureati) nei settori in-formatico, elettronico, strumentale e accele-ratori;15 borse di studio per cittadini stranieri (fisiciteorici);20 borse di studio per cittadini stranieri (fisicisperimentali);1 borsa per la comunicazione esterna e divul-gazione scientifica;2 borse per neolaureati in ambito informatico;45 posizioni di Associate (associated memberof the personnel) presso il CERN nell’ambitodegli esperimenti a LHC;82 assegni di ricerca scientifica o tecnologica;
Premio Nazionale “Francesco Resmini” perdottorati di ricerca con una tesi nel campodella fisica degli acceleratori e delle nuovetecnologie;Premio Nazionale “Sergio Fubini” per dotto-rati di ricerca con una tesi nel campo della fi-sica teorica;Premio Nazionale “Claudio Villi” per dotto-rati di ricerca con una tesi nel campo della fi-sica nucleare;Premio Nazionale “Bruno Rossi” per dottorati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La seguente tabella 7.8 illustra le risorse disponibilirelativamente al triennio 2012-2014
in milioni di euro

1. Implementazione di un Bilancio Sociale dell’Enteattraverso statistiche di genere e generazionaliStudio della distribuzione delle donne e degliuomini per ciascuna categoria professionale tra-mite la realizzazione di un Bilancio Sociale chetenga conto del genere e dell’età.
Il personale INFN a tempo indeterminato conta,a dicembre 2011, 1806 dipendenti; le donnesono solo 442, pari al 24% del totale. Le ricer-catrici donna sono 131, pari al 22% dei ricerca-tori, 31 sono le tecnologhe (14%), 35 le tec niche(5%), 245 le amministrative (82%).Mentre il numero di dipendenti e la frazione didonne nei diversi profili è rimasto pressoché co-stante negli ultimi 10 anni, la distribuzione perfasce di età del personale è variata considere-volmente portando a un complessivo sensibileinvecchiamento; invecchiamento dovuto sia allasignificativa diminuzione delle assunzioni sia al-l’incremento dell’età dei neo-dipendenti. A titolo di esempio riportiamo in figura 7.4 ledistribuzioni delle varie tipologie di personaleper fasce di età aggiornate a dicembre 2010.Il personale sotto i 40 anni rappresenta ora soloil 16%, fortemente in calo rispetto al 30% del2003, variando dal 13% dei ricercatori al 19%dei tecnici. Nel 2003 queste frazioni erano 20%e 35%, rispettivamente. Uno dei problemi con-seguenti alla carenza di giovani è sicuramente iltrasferimento di competenze tra generazioni, sipensi ad esempio al trasferimento di compe-tenze tecniche nelle piccole sezioni. Inoltre, per i ricercatori, si riscontra che la dimi-nuzione di assunzioni è più grande per le gio-vani donne che per gli uomini, il che comportauna maggiore disparità di genere tra le nuovegenerazioni.
Le donne sotto i 50 anni rappresentavano, in-fatti nel 2003, il 76% della popolazione femmi-nile riducendosi al 52% nel 2010, mentre gliuomini al di sotto dei 50 anni sono passati sol-tanto dal 68 al 54%.Uno studio della presenza femminile all’internodell’ente non può prescindere da un confrontocon il personale in corso di formazione, cioè conlaureandi, dottorandi e assegnisti con associa-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
162
pacità di tutte le persone, coinvolgendole nel pro-cesso di trasformazione del modello organizzativodell’amministrazione.Nel 2010, viene istituito, in sostituzione dei CPOe dei Comitati sul fenomeno del mobbing, il Co-mitato unico di garanzia (CUG) per le pari oppor-tunità, la valorizzazione del benessere di chi lavorae contro le discriminazioni. Il CUG, le cui modalitàdi funzionamento sono disciplinate da lineeguida contenute nella direttiva pubblicata sullaGazzetta Ufficiale nr. 134 dell’11 giugno 2011,ha il compito di assicurare nell’ambiente di la-voro parità e pari opportunità di genere, raffor-zando la tutela dei lavoratori e delle lavoratricie garantendo l’assenza di qualunque forma diviolenza morale o psicologica e di discrimina-zione, diretta e indiretta, relativa al genere, al-l’età, all’orientamento sessuale, all’origineetnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.Con l’entrata in vigore della legge 183, per laprima volta i concetti di parità, di pari opportunitàe di benessere organizzativo diventano un princi-pio generale di riferimento alla base del sistemadi valutazione delle performance organizzativedelle amministrazioni pubbliche, spingendole amigliorare il loro funzionamento organizzativo.I nuovi e più ampi compiti propositivi, consultivie di verifica del Comitato richiedono che lostesso metta a fuoco i problemi concreti cheostacolano la parità, formuli proposte, attui ini-ziative inerenti le parità e le pari opportunità(piani di azioni positive, promozione di iniziativeper il potenziamento delle politiche di concilia-zione vita/privata lavoro, etc) e verifichi l’operatodell’amministrazione di appartenenza su taliproblematiche.Appare chiaro che per l’attuazione dei principidi cui sopra è necessario passare attraverso unprocesso di cambiamento culturale e strutturalein cui il CUG assume un ruolo chiave dovendooperare in collaborazione continua con la diri-genza dell’amministrazione di appartenenza econ tutte le persone che in essa lavorano, chia-mandole a contribuire in prima persona.
Le Azioni PositiveNel 2011 l’INFN ha adottato un innovativo PianoTriennale di Azioni Positive (PTAP) relativo altriennio 2011-2013, proposto dal CUG ed ap-provato dai sindacati. Il Piano nasce sul solco delpercorso già tracciato dal CPO nei PTAP prece-denti (2002-04; 2005-07; 2008-10) e si ispiraalle strategie proposte dalla Comunità Europeaper la realizzazione delle Pari Opportunità fra
uomini e donne nella società ed in particolarenella scienza. Il Piano sottolinea come il concetto di parità e dipari opportunità sia non solo una questione diequità ed imparzialità nell’accesso alle opportu-nità lavorative, ma anche di comprensione del-l’influenza che le differenze sia di genere, chegenerazionali possono aver in termini di cam-biamenti strutturali e culturali (diversity mana-gement). Il PTAP vuole essere uno strumento vivo, cheserve da spunto, che offre strumenti alla diri-genza e a tutti i dipendenti per valorizzare il ta-lento ed il merito, per attuare il cambiamentoculturale verso la parità e la pari opportunità eper perseguire il benessere organizzativo nel-l’ente.Il Piano 2011-2013 si pone tre obiettivi, cherientrano nello spirito del programma europeoHorizon 2020 di risoluzione dello squilibrio fra igeneri, sfruttando il pieno potenziale dei ricer-catori donne e uomini e integrando la dimen-sione di genere nel contenuto dei progetti alfine di migliorare la qualità della ricerca e stimo-lare l'innovazione:
Per il conseguimento di tali obiettivi, il PTAP indi-vidua le seguenti aree di intervento in cui indicaremisure e comportamenti che l’INFN potrà adot-tare tramite l’applicazione di atti regolamentari:
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
161
Il superamento delle situazioni di disagio e didiscriminazione nell’ambiente di lavoro, tramitela maggiore partecipazione delle donne ai pro-cessi decisionali dell’ente (empowerment);L’identificazione di attività volte ad approfon-dire la cultura di genere e a migliorare la qua-lità della vita, tramite conciliazione tempo dilavoro/tempo di cura, indagini sul benesserelavorativo, salute e sicurezza dal punto divista di genere;Lo sviluppo di un piano per l’implementazionedi una strategia delle risorse umane, che sap-pia fare della diversità (di genere, generazio-nale e culturale) una ricchezza per l’ente.
Implementazione di un Bilancio Sociale del-l’Ente attraverso l’analisi di statistiche di generee generazionali;Promozione della cultura di genere;Valorizzazione delle Risorse Umane;Salute e benessere organizzativo;Elaborazione di una strategia delle risorseumane per i ricercatori.
•
•
•
•
•
•
•
•
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0ricercatori4721310,22
MF
F/tot.
amministrativi522450,82
tecnici642350,05
tecnologi198310,14
totale13644420,24
PERSONALE INFN 2011
Figura 7.3. Distribuzione del personale assunto a tempo indetermi-nato nei diversi profili, separatamente per donne e uomini.
Figura 7.4. Distribuzione del personale per fasce di età, separata-mente per donne e uomini, nei diversi profili.
60
50
40
30
20
10
030-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE TECNOLOGO PER FASCE DI ETÀ 2010
140
120
100
80
60
40
20
0
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE RICERCATORE PER FASCE DI ETÀ 2010
30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64
NUMERODIDIPENDENTI
NUMERODIDIPENDENTI
NUMERODIDIPENDENTI
160
140
120
100
80
60
40
20
0<29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE TECNICO PER FASCE DI ETÀ 2010
70
60
50
40
30
20
10
0
M F
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER FASCE DI ETÀ 2010
<29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64
NUMERODIDIPENDENTI
NUMERODIDIPENDENTI

tare dirigente di ricerca è doppia per gli uomini ri-spetto alle donne. Le donne dirigenti di ricercasono in tutto 14 su 131 ricercatrici (11%), mentregli uomini dirigenti di ricerca 103 su 472 con unapercentuale del 22%, esattamente doppia ri-spetto alle donne. Analogamente tra i tecnologi,le donne dirigenti sono il 10% delle tecnologhe(3 su 31) mentre gli uomini dirigenti sono il 17%dei tecnologi (40 su 238). Le dirigenti di ricercadonna sono inoltre concentrate in alcune sezioni,con una sola donna dirigente di ricerca in tutto ilsud e una in tutto il nord-est.Nella giunta esecutiva c’è per la prima volta unadonna, 4 sono gli uomini. Nel consiglio direttivoci sono 3 donne e 33 uomini. Infine, le donne eva-porano nelle commissioni tecniche e scientifiche,rimanendo una frazione rilevante solo nei soli co-mitati CUG (66%), OIV (66%), comitato scienti-fico dei laboratori del Sud (42%, 3 su 7),disciplinare (33%) mentre sono completamenteassenti nei comitati scientifici di Frascati, Legnaro,Gran Sasso (25 uomini).Una nota certamente positiva è la presenza didonne italiane in posizioni di responsabilità al-l’estero: Fabiola Giannotti spokesperson di Atlas,Patrizia Rossi nominata vice-direttore della Divi-sione Fisica del Jefferson Lab negli Stati Uniti, percitare solo alcuni casi.
2. Promozione della cultura di genere – le mile-stoneImplementare un linguaggio non sessista nei do-cumenti ufficiali dell’ENTE.Organizzare di corsi di formazione, seminari eworkshop sulle normative e strategie italiana edeuropea relative alle tematiche di genere per laformazione-informazione del personale ai varilivelli, compresa la dirigenza. Definire dei modulididattici per la promozione della cultura di ge-nere da inserire nei corsi di formazione nazionalidell’Istituto.Utilizzare le pagine INFN per la diffusione di noteinformative sulla distribuzione del personale in ot-tica di genere, sulle eccellenze femminili, sui si-stemi di mentoring al femminile.
3. Valorizzazione delle Risorse Umane - le mile-stonePromuovere la presenza femminile nei livelli deci-sionali, monitorando il raggiungimento dell’obiet-tivo del 25% richiesto dalla CommissioneEuropea.Introdurre BEST PRACTICE tramite delibere del-l’Ente, come l’ampliamento, a tutte le commis-
sioni giudicatrici dell’ente, della norma stabilitadall’art. 9, comma secondo, del d.P.R. n. 487/1994che stabilisce che almeno un terzo dei posti deicomponenti delle commissioni di concorso sia ri-servato alle donne“ salvo motivata impossibilità”,ponendo l’attenzione all’im plementazione di unfuturo vero equilibrio di genere (50%).Porre attenzione alle Norme sulla TRASPARENZA:istituire una banca dati per ogni concorso con icurricula dei concorrenti e dei commissari. Ren-dere pubblici i curricula di tutti i dipendenti al-l’interno del portale INFN. Dare visibilità allecompetenze riconosciute per l’attribuzione di re-sponsabilità e di incarichi.Individuare di buone prassi per prevenire o ri-muovere situazioni di discriminazioni o violenzesessuali, morali o psicologiche nell’Istituto.Definire azioni atte a conciliare il tempo di la-voro ed il tempo di cura (vedi ridistribuzione deifondi per asili nidi, scuole materne, scuoleestive, sostegno genitori anziani).Introdurre sistemi di mentoring per le giovani ri-cercatrici.
4. Salute e benessere organizzativo – le milestone Adottare programmi di miglioramento della sicu-rezza e salute sul lavoro, con particolare riguardoalla valutazione in ottica di genere del rischio edelle fonti di stress lavoro-correlato (Testo Unicoin materia di Sicurezza -D.Lgs n. 106/09, giàD.Lgs. 81/08). Completare il progetto “Benessere organizzativoe management” tramite la somministrazione delquestionario Magellano del Dipartimento dellaFunzione Pubblica in tutte le strutture. Svolgi-mento di azioni di miglioramento, a cura di unapsicologa, per affrontare alcune delle problemati-che riscontrate, per la risoluzione ad esempio disituazioni conflittuali fra dipendenti.Nel 2012, preparazione e presentazione di un do-cumento di analisi finale che servirà inoltre dapunto di partenza per l’elaborazione di linee guidauniche (stress e benessere) a cura di un opportunogruppo di lavoro della commissione CNPISA, incollaborazione con componenti del CUG.Introdurre di sistemi di reintegro al lavoro del per-sonale che è stato assente per maternità, pro-blemi di cura dei figli e/o dei genitori.
5.Elaborazione di una strategia delle risorseumane per i ricercatori – le milestoneIdentificare misure che conducano all’elabora-zione e all’adozione di una strategia delle risorseumane per i ricercatori (HRS) definita sulla base
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
164
zione INFN, che rappresentano il bacino di futuriricercatori e tecnologi. Le donne vanno dal 27% dei dottorandi al 30%degli assegnisti. Questi dati ben si accordano conquelli del MIUR degli ultimi 15 anni, secondo iquali le donne sono state costantemente il 27-30% tra coloro che hanno com pletato il PhD inFisica in Italia. Si evidenzia quindi una diminu-zione significativa della presenza femminile nelpassaggio a posizioni a tempo indeterminato,considerato che fino al 2008 le ricercatrici conmeno di 45 anni nell’INFN erano solo il 19%. Unleggero miglioramento si è avuto con le assun-zioni del 2009 e più recentemente in seguito alconcorso nazionale del 2010, in cui sono stateassunte 10 donne su 37 posti disponibili (27%);le donne che avevano applicato erano il 26%.
Per cercare di capire sia il ruolo che il contributofemminile nell’Ente, è necessario portare avantiun’analisi più complessa che entri nello specificodelle diverse Commissioni Scientifiche e che tengaconto anche del personale associato. Dai dati deiConsuntivi Scientifici, al momento i dati disponibilicompleti sono quelli relativi al 2010, risulta la se-guente distribuzione per le cinque CommissioniNazionali (in tabella è riportato la frazione didonne rispetto al totale per ogni voce).
È interessante notare come la presenza delledonne non sia uniforme nelle varie CommissioniNazionali Scientifiche. Si vede, per esempio, chenelle commissioni 2 e 3 le dottorande superanogli uomini, mentre costituiscono il 31%, 35% e17% nelle commissioni 1, 5 e 4. Dalla Tabella7.10, si vede che, per tutte le CNS, la produ-zione scientifica delle donne valutata in terminidi presentazioni a conferenze, è maggiore dellaloro presenza numerica.
Nelle commissioni 1, 2 e 3 la presenza femminilein posizioni di responsabilità è maggiore dellaloro presenza numerica; le donne sono solo il15-23% in termini di FTE, la percentuale didonne tra i responsabili locali varia dal 15% al23%, ma sale al 22-33% tra i responsabili na-zionali e al 26-31% tra i coordinatori locali, ca-rica di tipo elettiva. Appare più critica lapresenza delle donne nel gruppo teorico, doverappresentano solo il 6% dei responsabili nazio-nali pur essendo il 12% degli FTE. Una disparità simile sulla distribuzione femmi-nile nei gruppi di ricerca si ritrova anche quandosi analizza il personale non INFN con associa-zione scientifica (Ricercatori/Professori Universi-tari) e con incarico di ricerca.La Figura 7.6 mostra che le ricercatrici teoriche,benché presenti fra gli associati (il dato assolutoè simile a quello del Gruppo 1 o 3), risultano inpercentuale molto di meno delle ricercatrici spe-rimentali. Complessivamente il numero di donnecon associazione INFN è minore del numero di ri-cercatrici con posizione a tempo indeterminatonell’INFN.Critica resta la carriera per le donne o la loro pre-senza in posizioni di responsabilità. Per i ricercatorie i tecnologi, ad esempio, la probabilità di diven-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
163
600
500
400
300
200
100
0laureandi2961140,28
MF
F/tot.
assegnisti3161370,30
dottorandi5492060,27
NUMERODIASSOCIATI
Figura 7.5. Numero di laureandi, dottorandi e assegnisti associatiall’INFN, separatamente per donne e uomini (dati 2011).
Figura 7.6. Personale universitario a tempo indeterminato con asso-ciazioni scientifica, separatamente per donne e uomini.
Responsabili naz.
Responsabili locali
Coordinatori
FTE INFN
FTE Università
Presentazione aconferenze
Tesi PhD INFN
Tab 7.10. Frazione di donne nelle differenti commissioni scientifichenazionali, dati dei consuntivi scientifici 2010
CSN122%
23%
31%
17%
19%
28%
31%
CSN220%
15%
26%
15%
20%
29%
55%
CSN333%
21%
38%
20%
23%
33%
58%
CSN510%
18%
6%
12%
28%
35%
35%
CSN46%
11%
18%
12%
12%
15%
17%
800
700
600
500
400
300
200
100
0sperimentali
6831840,21
MF
F/tot.
gruppo 3114310,21
gruppo 2193410,18
gruppo 1202450,18
gruppo 4174670,28
PERSONALE CON ASSOCIAZIONE 2011
gruppo 5421430,09
NUMERODIASSOCIATI

europei: Fondazione Brodolini, AssociazioneDonne e Scienza, International Training Centre ofthe International Labour Organization (Italia), Ble-kinge Tekniska Hogskola (Svezia), Faculty of Te-chnology and Metallurgy Univ. of Belgrade(Serbia), Kemijski Institut (Slovenia), Leibniz Inst.Fur polymerforschung Dresden E.V. (Germania),Agencia Estatal Consejo Superior de Investigacio-nes Cientificas (Spagna). Il progetto, della duratadi 48 mesi, si propone di realizzare alcuni cambia-menti strutturali nelle organizzazioni scientifichecoinvolte, al fine di superare i fattori che limitanola partecipazione delle donne nella ricerca attra-verso la promozione di azioni comuni e lo scam-bio di best practices e metodologie innovative perla promozione del mainstreaming nella scienza. Il progetto opererà in tre aree di azione prioritarie:Gestione risorse umane e genere; Dimensione fi-nanziaria dell’organizzazione e “gender budge-ting”; Cultura organizzativa e stereotipi.Nella prima fase strutture campione dei 6 partnerscientifici sono state coinvolte in un Audit Parte-cipativo di Genere (coordinato dall’ITC/ILO), cheaveva lo scopo di individuare i punti forza e i puntidi debolezza di ciascuna istituzione. I risultati ditale analisi saranno la base di partenza per leazioni di miglioramento che verranno program-mate e attuate nelle successive fasi progettuali.Per l'INFN e' stata scelta la struttura di Trieste. Perapprofondimenti: www.genislab-fp7.euI piani di azioni di miglioramento dell’Ente an-dranno pianificati con l’ausilio del CUG.
7.6 GLI SCAMBI INTERNAZIONALIDEL PERSONALE DI RICERCA
L’Istituto, consapevole del suo ruolo nel contestointernazionale, ha da sempre promosso e favoritoogni iniziativa intesa a intensificare i rapporti scien-tifici con le istituzioni e i ricercatori stranieri, sia at-traverso appositi programmi di ospitalità di stranieriin Italia, sia attraverso lo scambio di ricercatori sullabase di convenzioni e accordi specifici.
Fondo Affari Internazionali (FAI)Il Fondo Affari Internazionali (Fondi FAI) è finan-ziato sugli appositi capitoli denominati “Spesesoggiorno ospiti ricercatori” del Bilancio dell’Isti-tuto. Il Direttore può ospitare presso la propriasezione/laboratorio ricercatori ospiti stranieri perdefiniti periodi di tempo (minimo due settimane,massimo sei mesi) sulla base di un programmadi ricerca definito. Ai ricercatori ospiti stranieri
possono essere rimborsate, dietro presentazionedei relativi documenti, le spese di viaggio e sog-giorno, purché esse non risultino già previste,nel quadro di accordi di cooperazione interna-zionale, a carico dell’istituzione di apparte-nenza. In figura 7.7 si fornisce un quadro deisoggiorni FAI assegnati nel corso del 2010 a ri-cercatori ospiti stranieri distinti per nazionalità.
Borse per lo scambio dei ricercatoriSono attivi diversi programmi per l’assegnazionedi borse per scambio di ricercatori, formalizzatiin apposite convenzioni bilaterali con istituzionistraniere e Organizzazioni Internazionali (vedi fi-gura 7.8).
1) Borse di studio a favore di giovani ricercatoriitaliani presso il MIT (Borse Bruno Rossi)Finalità: conseguimento del PhD in Fisica pressoil MIT; Programma scientifico e regolamentazionecorso PhD: secondo normativa MIT ;Selezione candidati: effettuata da appositaCommissione paritetica INFN/MIT; Supporto finanziario: 1° e 2° anno INFN – 2° e 3°anno MIT – eventuale prolungamento congiunto.
2) Borse di studio a favore di giovani ricercatoriitaliani presso il MIT (Borse post-doc presso il MIT)Durata: in corrispondenza con Anno Accade-mico MIT per 1 o 2 anni; Finanziamento: a carico INFN.
3) Borse di studio a favore di giovani ricercatoripresso il CERNTipologie: Senior Fellowship Programme – Ju-nior Fellowship Programme; Durata: un anno rinnovabile. In casi eccezionalipossibile estensione per un terzo anno. Supporto finanziario: a carico del CERN; Selezione candidati: 1° livello Stati Membri – 2°livello CERN.
4) Borse di studio a favore di ricercatori cinesi(CIAE)Numero e durata: 5 borse di durata annuale; Finanziamento: a carico INFN; Sedi di destinazione: Laboratori Nazionali di Le-gnaro e Laboratori Nazionali del Sud;Selezione candidati: effettuata da parte della sededi destinazione su temi di ricerca prestabiliti.
5) Borse di studio a favore di giovani italiani estatunitensi (Summer Exchange Programme
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
166
della “Human Resources Strategy for Researchers“per l’attuazione della Carta Europea dei Ricercatorie del Codice di Condotta per l’assunzione dei ri-cercatori. La verifica dell’attuazione dell’HRS e va-lutazione della necessità di eventuali modificheviene effettuata massimo ogni due anni.
Il Progetto Europeo GENIS LAB –The Gender in Science and TechnologyL’INFN, in qualità di partner del progetto GENISLAB (Support Actions, FP7-Science in Society-2010-1), da gennaio 2011 è coinvolto in un pro-gramma di lavoro condiviso con gli altri partners
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
165Fig.7.7: Ricercatori stranieri ospiti presso strutture INFN (FAI) nel 2010 per un totale. di 447
Fig. 7.8: Accordi bilaterali in vigore per scambi borsisti.
CANADA 3
DANIMARCA 1FINLANDIA 1FRANCIA 20GERMANIA 15GRAN BRETAGNA 7GRECIA 1SPAGNA 106SVIZZERA 3UNGHERIA 1
ALGERIA 2ARABIA SAUDITA1ISRAELE 1SUD AFRICA 1TURCHIA 8
ARMENIA 1BULGARIA 7CROAZIA 7GRECIA 1POLONIA 26REPUB. CECA 6ROMANIA 11SERBIA EMONTENEGRO 6UCRAINA 11
USA 61
CUBA 7
CINA 9
INDIA 11
BRASILE 4
ARGENTINA 4VENEZUELA 4
AUSTRALIA 1
BIELORUSSIA 4UZBEHISTAN 1RUSSIA 85
COREA DEL SUD 1GIAPPONE 8

INFN/DOE/NSF)Numero: 20 borse per fisici italiani presso labo-ratori USA − 20 borse per fisici USA pressoStrutture INFN;Finanziamento: 10 a carico DOE – 10 a caricoNSF – 20 a carico INFN; Destinatari: laureandi in fisica, ingegneria, infor-matica; Durata: soggiorni di 10 settimane (periodo 1°giugno – 30 novembre); Selezione candidati: effettuata da appositeCommissioni paritetiche INFN/DOE/NSF.
7.7 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONEE DI INFORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione e lo sviluppo delle risorseumane nell’INFN tra passato e futuroA oltre dieci anni dal lancio del primo PianoFormativo Nazionale, la formazione nell’Ente hafatto molta strada sia dal punto di vista qualitativoche quantitativo (statistiche ed analisi sono disponibilisul sito della formazione:www.ac.infn.it/personale/formazione). Ma la sfidaè di migliorare ancora, armonizzando sempre piùda un lato le potenzialità delle persone che “sono”l’INFN e dall’altro le esigenze operative e le sfide dieccellenza che attendono il nostro Istituto. Isuccessi, nella ricerca come in qualsiasi altro campo,si ottengono nella misura in cui si migliorano le re-lazioni umane, la capacità di “fare squadra”, con-sentendo a ciascuno di mettere in campo le miglioripotenzialità di cui per natura dispone. L’uomo èinfatti un essere complesso, che non funziona inmodo puramente “meccanico”, ma si muove sullabase di una motivazione, cioè investe nell’azionese quell’azione corrisponde alla base dei suoi valori,dei suoi obiettivi. Se si vuole ottimizzare il rapportodi lavoro, occorre “umanizzare”, cioè occorre in-tercettare il valore di cui ciascuno è portatore ed ifini verso cui tende: la formazione nasce proprioda questo, dal convincimento che l’essere umanoè un sistema complesso, che ha una sua intrinsecapotenzialità da realizzare.Nel primo Piano Formativo del 1998, si parlava del“faro” che univa gli operatori e che era la ricerca;oggi occorre prendere atto che la ricerca è produttivase riesce a motivare la creatività dei migliori.“Formare” significa individuare e sviluppare il po-tenziale individuale. In questo senso, è importantesaper “costruire” un percorso formativo adattoalle potenzialità di ciascuno. Dunque l’offerta for-mativa, all’inizio “generalizzata”, oggi dev’essere
in grado di farsi sempre più vicina alle capacità diciascuno e all’esigenza dell’Ente, che è quella ditrarre il massimo dalle persone di cui dispone, infunzione dei propri programmi e obiettivi. La spesaformativa, se pianificata oculatamente, è un “in-vestimento sul futuro” e sulle persone con cui sidecide di costruire quel futuro.
Assegnazioni 2012Come avviene già da alcuni anni, l’offerta formativaINFN si articola in diverse aree:a) Formazione di base tecnico-gestionale,b) Formazione scientifica e tecnologica,c) Formazione in materia di igiene e sicurezza.
Tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto leggen.78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010,per consentire lo svolgimento del Piano FormativoNazionale, dei Piani Formativi Locali promossi dalleStrutture (consultabili sulla pagina web della for-mazione) e delle proposte formative CSN e CCR,per l’anno 2012 la Formazione INFN dispone diuno stanziamento complessivo di 1.100 k€ .Il provvedimento normativo sopra indicato ha sta-bilito, inoltre, che le attività di formazione devonoessere svolte prioritariamente tramite la Scuola Su-periore per la Pubblica Amministrazione, ovverotramite organismi di formazione interni alle singoleamministrazioni. La Presidenza del Consiglio deiMinistri con Direttiva n. 10/2010 ha richiesto,infatti, che anche gli Enti pubblici di ricerca qualil’INFN comunichino il Piano Formativo Nazionaleal Dipartimento delle Funzione Pubblica ed allaSSPA i quali, definiti gli obiettivi qualitativi e quan-titativi di ciascuna attività, procedono all’organiz-zazione delle attività formative sulla base di appositeconvenzioni. Soltanto laddove la SSPA non sia ingrado di fornire, in modo diretto od indiretto,l’attività di formazione richiesta, l’Ente potrà rivolgersiall’esterno.La CNF ha portato avanti il progetto di estenderele opportunità del programma di formazione ancheai giovani ricercatori e tecnologi titolari di contrattidi associazione che, non essendo dipendenti del-l’Ente, non possono usufruire delle risorse a dispo-sizione della formazione e propone alla GiuntaEsecutiva di mettere una cifra in Bilancio dedicataalla formazione di queste categorie. La CNF intendeproporre alla Giunta Esecutiva di mettere una cifrain bilancio dedicata alla formazione di questa ca-tegoria. A questa tipologia di personale, fino adoggi, è consentita la fruibilità delle iniziativeformative INFN in qualità di uditori e senza ulterioreaggravio della spesa formativa.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ PIANODISVILU
PPODELLE
RISO
RSEUMANEEFIN
ANZIA
RIE
167

8. LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONEE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

8.1 LA COMUNICAZIONE PER I MEDIAE LA COMUNITÀ
La comunicazione da e verso i mediaNel corso del 2011 l’Ufficio Comunicazione ha ulte-riormente espanso l’immagine dell’INFN sui mediastampati, online e radiotelevisivi. Dopo il grande ex-ploit del settembre 2008, i buoni risultati del 2009 el’incremento del 15% della copertura mediatica del2010, il 2011 ha registrato un’ulteriore crescita dellapresenza dell’istituto nei media. In quest’ultimoanno, infatti, si è raggiunto il record assoluto di cita-zioni. I riferimenti con il 2007 ci dicono che la pre-senza dell’INFN sulla stampa è più che triplicata intre anni. Si è consolidata inoltre la convinzione neimedia che l’INFN sia il punto di riferimento obbligatoper tutto quel che riguarda il CERN di Ginevra e inparticolare le ricerche del l’acceleratore LHC. Sulpiano dell’immagine, il lavoro dell’Ufficio Comuni-cazione ha puntato soprattutto su due brand carat-terizzanti l’Istituto:1) rappresentare una comunità scientifica qua-lificata in grado anche di attirare ricercatorida molti paesi stranieri;
2) rappresentare un potenziale scientifico e tec-nologico di grande importanza per il Paese.
Per questo, assieme alla valorizzazione del lavoroe delle personalità del vertice dell’Istituto, l’UfficioComunicazione ha creato le opportunità perché imedia citassero e mostrassero ricercatori INFN im-pegnati in diversi settori di ricerca e in grado di as-sumere responsabilità di rilievo a livello nazionalee internazionale. Un particolare accento è statoposto sulla componente femminile della comunità.
La comunicazione istituzionaleCon il riavvio di LHC, l’attenzione della stampa edella comunità scientifica si è nuovamente con-centrata sul CERN di Ginevra. L’Ufficio Comuni-cazione ha quindi realizzato un sito internetdedicato a LHC in italiano.Il sito internet (http:// www.infn.it/lhcitalia/) offreinformazioni tempestive su LHC e si propone didar voce alla comunità scientifica italiana impe-gnata in LHC e nei suoi esperimenti. Al sito si ac-cede direttamente dalla home page del sito INFN.Il sito ha rappresentato un punto di riferimentoreale per un pubblico selezionato e attento. Spessoè stato citato dai media (in particolare dalle agen-zie di stampa) come fonte di informazione prima-ria per le notizie in italiano sulla ricerca in LHC.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIVITÀDICOMUNICAZIONEEDIDIVULGAZIONESCIENTIFIC
A
172
Fig.8.2: Installazioni multimediali alla mostra “Estremo” allestita per la prima volta a Bologna nel Febbraio 2011 in occasione della manife-stazione “Arte e Scienza in piazza”.
L’Ufficio Comunicazione dell’INFN gestisce le at-tività di comunicazione, trasmissione della cul-tura scientifica e divulgazione in forme diversee correlate.Nei rapporti con i media, in particolare, l’INFN èdiventato un’importante fonte di informazionee un punto di riferimento per i giornalisti scien-tifici italiani e le agenzie di stampa: un’opportu-nità di diffusione di conoscenza nel contestodella fisica fondamentale sempre più conosciutaanche dal grande pubblico.Sul fronte della divulgazione e della comunica-zione museale, va segnalata l’inaugurazionedella nuova mostra dell’INFN: “ESTREMO lemac chine della conoscenza” che è stata allestitaa Bologna in primavera e a Perugia in novembre.Nel corso del 2011, inoltre, sono stati realizzatidue nuovi allestimenti interattivi a Spoleto(L’Universo a portata di mano), in occasione delFestival dei due Mondi, e a Genova (L’essenzialeè invisibile agli occhi) in occasione del Festivaldella Scienza.Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 annid’Italia l’INFN, in collaborazione con l’Universitàdi Pavia e l’Università di Perugia, ha realizzato lamostra “An Italian History of Innovation” alle-
stita a Ginevra presso la sede dell’Organizza-zione Mondiale della Proprietà Intellettuale(OMPI). Inoltre, sempre per il centocinquante-simo dell’unità d’Italia, l’Ufficio Comunica-zione ha contribuito all’allestimento dellamostra “150 anni di genio italiano”, realizzatadalla Fondazione Rosselli e portata a Genovae a New York.
Le monografie su temi di fisica fondamentale edi frontiera, offerte al pubblico tramite la rivistaAsimmetrie e distribuite tra gli altri a tutti i liceiitaliani, rappresentano una rara opportunità didialogo con il pubblico scolastico − e non solo− e una ricca risorsa di aggiornamento per gliinsegnanti.Dalla sinergia tra i diversi strumenti della comu-nicazione scaturisce un nuovo linguaggio, fattodi metafore e di immagini, alla portata deimedia e del grande pubblico: un patrimonio diinformazione che contribuisce sempre più allacondivisione del valore e dei contenuti della ri-cerca di base, che impegna l’INFN e la sua co-munità di ricercatori.
Fig. 8.1: Installazione di video-arte alla mostra l’’L’essenziale è invisibile agli occhi” allestita nell’Ottobre 2011 a Palazzo della Meridiana,Palazzo Ducale e Biblioteca Universitaria di Genova in occasione del Festival della Scienza 2011.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIVITÀDICOMUNICAZIONEEDIDIVULGAZIONESCIENTIFIC
A
171

da una grafica coinvolgente, rivolta in particolarea un pubblico giovane, le monografie sono im-perniate su temi di fisica di frontiera. La tiratura della rivista è di 15.000 copie. Asim-metrie viene distribuita a 3126 scuole medie su-periori, e a circa 8.000 destinatari (membri delgoverno, addetti scientifici delle ambasciate, as-sessorati alla cultura, aziende, docenti e studentiuniversitari, studenti di scuola media superioreecc.), la maggior parte dei quali si sono iscritti,compilando il modulo di richiesta di abbona-mento gratuito, sul sito della rivista, www.asim-metrie.it. Allo stesso indirizzo sono consultabilie scaricabili tutti i numeri di Asimmetrie.I riscontri avuti fino a oggi da insegnanti, stu-denti e cittadini abbonati ad Asimmetrie sonomolto positivi. Una valutazione statistica delle vi-site al sito, fatta con gli strumenti ufficiali di Goo-gle Analytics, ha messo in evidenza datisignificativi e incoraggianti per quanto attiene al-l’attività del sito.
8.3 MOSTRE E MULTIMEDIA
La comunicazione multimedialeUno degli aspetti a cui l’Ufficio ComunicazioneINFN ha dedicato crescente attenzione negli ultimianni è stata la realizzazione di prodotti di comu-nicazione audiovisiva e multimediale. Si tratta di
un linguaggio in rapida evoluzione, ma indispen-sabile per una comunicazione efficace sia suimedia tradizionali che sul web, come nell’ambitodi mostre o altre attività di outreach. Particolar-mente originali e innovative, e di straordinariosuccesso per la comunicazione di contenuti scien-tifici, sono le installazioni multimediali e interattiveprodotte dall’Ufficio Comunicazione in collabora-zione con video-artisti ed esperti di comunica-zione digitale. Questa esperienza cominciata inoccasione della mostra Astri e Particelle è stataportata avanti con successo nel corso degli annicon nuovi allestimenti in mostre e Festival.Estremamente significativa è stata negli ultimi treanni anche la realizzazione di brevi filmati delladurata di pochi minuti sui singoli esperimenti oprogetti, su idee o temi scientifici più generali osu temi di carattere storico. Una cinquantina divideo con questo formato sono stati realizzati perle mostre allestite nel 2010 e 2011 e in altre oc-casioni, ma sono naturalmente riutilizzabili in tuttii contesti già citati.
Le mostreLa mostra “Estremo – le macchine della co-noscenza”“Estremo - le macchine della conoscenza” è unamostra multimediale e interattiva che mette alcentro le grandi macchine e infrastrutture dellafisica delle alte energie. Realizzata in collabora-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIVITÀDICOMUNICAZIONEEDIDIVULGAZIONESCIENTIFIC
A
174
Fig.8.4: Modellino in scala reale del rivelatore AdA di Frascati (1962) e sfera armillare di Geronimo della Vulparia (1575), esposti nel Maggio2011 nella sede dell’OMPI a Ginevra, in occasione della mostra ‘’An Italian History of Innovation”
La comunicazione intranazionaleL’Ufficio Comunicazione rappresenta l’Italia inalcuni network internazionali di outreach, colla-borando alla comunicazione e divulgazione deitemi e delle attività di ricerca di interesse co-mune, a livello europeo e globale. Nell’ambitodel consorzio europeo per la fisica delle astropar-ticelle, ASPERA − AStroparticle Physics EuropeanResearch Area − l’Ufficio Comunicazione è impe-gnato nella gestione della newsletter, del sito diinteresse divulgativo www.astroparticle.org, nellarealizzazione di mostre sulla fisica delle astropar-ticelle e nella diffusione di comunicati stampa ainteresse europeo. Nell’ambito del network mon-diale INTERACTIONS e del network europeo Eu-ropean Particle Physics Communication Network(EPPCN), sono discusse le strategie di comunica-zione di LHC a livello globale e l’uso dei newmedia per un efficace coordinamento della co-municazione della fisica delle particelle e delle at-tività di ricerca correlate.L’INFN è inoltre coinvolto nella pubblicazione dinotizie di rilievo internazionale sulla InteractionsNews Wire e all’elaborazione di un protocollo dipeer review delle attività di comunicazione dei di-versi paesi.Quale membro del network europeo per la divul-gazione della fisica delle particelle European Par-ticle Physics Outreach Group (EPPOG), l’UfficioComunicazione coordina l’edizione italiana delleMasterclasses, lezioni e seminari su argomenti
fondamentali della fisica delle particelle indirizzatia studenti e insegnanti delle scuole superiori e se-guiti da esercitazioni al computer. Nel 2011 le Ma-sterclasses si sono svolte in undici sedi INFN, ai LNFe contemporaneamente in 23 nazioni europee ein 30 istituti statunitensi, coinvolgendo più di8.000 studenti delle scuole superiori.
8.2 LA RIVISTA ASIMMETRIE
La rivista Asimmetrie rappresenta l’impegnodell’INFN nella diffusione della cultura scientifica.Indirizzata a non-specialisti con particolare atten-zione agli allievi delle scuole superiori e ai lorodocenti, ha visto crescere quest’anno il numerodi libere sottoscrizioni da poco più di 4000 a piùdi 5000. La rivista, dedicata ai temi di ricerca fon-damentali cui l’INFN contribuisce in modo deter-minante, è distribuita a una lista di insegnantidelle scuole superiori, costantemente aggiornatae arricchita e a chiunque ne faccia libera richie-sta. Ogni numero monografico si sviluppa at-torno a un tema scientifico di forte impatto,come l’antimateria, le onde gravitazionali, nucleie stelle, la materia oscura, i raggi cosmici, leasimmetrie.L’argomento è sviluppato in progressione logicae in modo tale da avvicinare il lettore ai mecca-nismi e alle fascinazioni che motivano il lavoroquotidiano dei fisici ricercatori. Ideate partendo
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIVITÀDICOMUNICAZIONEEDIDIVULGAZIONESCIENTIFIC
A
173
Fig.8.3: le copertine dei numeri 11 e 12 della rivista Asimmetrie

8.4 EVENTI DI DIVULGAZIONE
Nel corso dell’ultimo anno sono state nume-rose le manifestazioni di comunicazione scien-tifica a cui l’INFN ha partecipato, con iniziative,mostre o installazioni curati dall’Ufficio Comu-nicazione o dalle sezioni locali.Nel 2011, in particolare, l’Ufficio Comunica-zione ha curato la partecipazione alle seguentimanifestazioni: Massascienza con la mostra“Accelerare la tecnologia”; Arte e scienza inpiazza” a Bologna, con la mostra “Estremo, lemacchine della conoscenza”; Spoletoscienza,con la mostra “L’universo a portata di mano”;Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italiaa Ginevra, con la mostra “An Italian History ofInnovation”; Festival della Scienza di Genovacon la mostra “L’essenziale è invisibile agliocchi”. Come ogni anno, inoltre i LaboratoriNazionali di Legnaro e la Sezione INFN di Pa-dova, hanno curato l’organizzazione di Speri-mentando, una manifestazione-mostra nellaquale studenti delle scuole superiori concepi-scono e realizzano esperimenti che sono suc-cessivamente esibiti al pubblico per un mese.
Le conferenze per il pubblicoTra le iniziative di divulgazione hanno riscontratoparticolare successo e partecipazione le confe-renze per il pubblico spesso organizzate in oc-casione di Festival o mostre. In collaborazionecon la Fondazione Sigma-Tau, nell’ambito del-l’iniziativa “SCUOLA ed ECCELLENZA: Scuoledi scienza nel Novecento italiano”, l’INFN haorganizzato due conferenze dal titolo “Quantidi salute. Fisica quantistica e Medicina: universiparalleli” e “Più veloci della luce? Alla ricerca diconferme sui neutrini del Gran Sasso”. Gliincontri si sono svolti a Roma e hanno coinvoltooltre 1000 studenti delle scuole medie superiori.In occasione dell’allestimento della Mostra “ES-TREMO- le macchine della conoscenza” a Bo lo -gna e, in collaborazione con la sezione localedell’INFN, si sono svolte due conferenze rispetti -va mente dedicate agli esperimenti internazionaliLHC e AMS che hanno avuto un gran de successodi pubblico. In occasione del l’inaugurazione diESTREMO a Perugia si è invece svolto un incontrodibattito che ha visto la partecipazione del pres-idente dell’INFN e di Patrizio Roversi dei “Velistiper caso”.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIVITÀDICOMUNICAZIONEEDIDIVULGAZIONESCIENTIFIC
A
176
Fig. 8.6: Un’immagine dell’evento-incontro “Lo strano mondo di LHC” che si è svolto a Dicembre 2011 al Museo Nazionale della Scienza edella Tecnologia di Milano.
zione con la Fondazione Golinelli e con il contri-buto di ASG Superconductors è stata ina u gurataa Bologna nel febbraio del 2011 nell’ambitodella manifestazione “Arte e scienza in piazza”.L’allestimento propone un percorso fatto d’im-magini, narrazioni e videoinstallazioni interattiveche raccontano quanto vi sia di estremo nella fi-sica delle particelle e delle alte energie.La mostra è suddivisa in quattro aree tematiche:l’universo estremo e gli strumenti per esplorarlo,LHC la più grande macchina mai costruita per laricerca scientifica, le reti planetarie per la condi-visione e lo scambio della conoscenza, le tec-nologie che nascono dalla ricerca di base e chesono usate per importanti applicazioni in medi-cina e nei beni culturali.“Estremo- le macchine della conoscenza” è stataallestita nuovamente a Perugia nel novembre2011 presso il Museo Archeologico Na zio na ledell’Umbria dove è rimasta per tre mesi.
La mostra “An italian History of innovation”La mostra a cura di INFN, Università di Pavia eUniversità di Perugia, è stata allestita nel giugno2011 a Ginevra nella sede dell’ OrganizzazioneMondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) in oc-casione dell’anniversario dei 150 anni dell’Unitàd’Italia. “An italian History of innovation” raccontaalcune delle tappe fondamentali della straordinariastoria di evoluzione del pensiero scientifico in Italia,da Galileo a oggi, attraverso la testimonianza di
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIVITÀDICOMUNICAZIONEEDIDIVULGAZIONESCIENTIFIC
A
175
Fig. 8.5: Locandine e brochure delle mostre e allestimenti realizzatinel corso del 2011.
oggetti storici, riproduzioni di strumenti, ricostru-zioni di macchine e parti di moderni rivelatori diparticelle. L’allestimento ripercorre anche la nascitadell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nel1951 quando si costituisce in Italia una comunitàdi scienziati, erede della scuola di fisica fondata daFermi, unica per ricchezza di inventiva, capace diesportare idee e metodo in tutto il mondo.
L’allestimento “L’essenziale è invisibile agliocchi”L’INFN ha partecipato all’edizione 2011 del Festi-val della scienza di Genova con un allestimentoche si compone di tre installazioni in terattive rea-lizzate con la collaborazione di videoartisti italianidal titolo “L’essenziale è invisibile agli occhi”. Inparticolare è stata realizzata un’istallazione ineditadal titolo “Poesia fatta a mano” frutto della colla-borazione tra l’INFN e l’artista torinese Ennio Ber-trand ispirata alla rete di calcolo planetaria GRIDe alla poesia combinatoria di Raymond Queneau.
L’allestimento “L’universo a portata di mano”In occasione del 54esimo Festival dei Due Mondidi Spoleto, per la manifestazione Spoleto-scienza, l’INFN ha proposto un nuovo allesti-mento interattivo sui misteri dell’Universorealizzato in collaborazione con la FondazioneSigma-Tau. L’Universo a portata di mano pro-pone un percorso multisensoriale, in cui si susse-guono videoinstallazioni artistiche che invitano ilvisitatore a toccare con mano i misteri dell’Uni-verso. Si compone di sei videoinstallazioni: Spazioe Tempo curvi, Fai le collisioni, Svela l’invisibile,L’espansione dell’Universo, La doccia cosmica.

La conferenza divulgativa più importante del2011 è stato l’incontro dal titolo “Lo stranomondo di LHC” che si è svolta a dicembre pressoil Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologiadi Milano. L’iniziativa ha portato sul palco i coor-dinatori internazionali degli esperimenti di LHC,tutti italiani, è stata trasmessa via streaming dalsito Scienzainrete.it e ha visto un collegamento indiretta con la trasmissione Radio3 Scienza. Al-l’evento hanno partecipato oltre 500 persone edè stato necessario allestire una sala dove proiettarela diretta. L’iniziativa sarà replicata nel 2012 aCatania. Nel 2011 si è svolta la quinta edizione diFisica in barca, l’iniziativa di divulgazione scientificapromossa dall’INFN in collaborazione con “Velistiper caso” che coinvolge in ogni edizione centinaiadi studenti. Nel 2011 Adriatica è partita da Genovain aprile e, dopo aver circumnavigato l’Italia, èapprodata a Cagliari in giugno, meta finale di untour di 7 tap pe. L’Ufficio Comunicazione ha con-tribuito all’ideazione e al coordinamento dell’e -vento, ne ha gestito la co municazione alla stampain collaborazione con le sezioni coinvolte e si ècurato di realizzare un’immagine coordinata.
La comunicazione e la divulgazione scienti-fica promossa localmente dalle struttureL’attività di comunicazione e di divulgazionescientifica viene svolta anche localmente nellestrutture dell’Istituto (Sezioni, Gruppi collegatie Laboratori nazionali), spesso in collaborazionecon le Università, le scuole, e gli enti territoriali,ed è rivolta agli studenti, agli insegnanti ed alpubblico non esperto. Tali attività includono se-minari, incontri, visite guidate presso le struttureed i laboratori in Italia e all’estero. Il festivalSperimentando, in particolare, curato dai Labo-ratori Nazionali di Legnaro dalla sezione INFN diPadova, è visitato da circa 10000 visitatoril’anno. Molte sezioni dell’INFN organizzanoinoltre annualmente le Masterclasses, sessionidi presentazioni e di attività pratiche per gruppiselezionati di studenti. Sono inoltre gestite dalaboratori e sezioni INFN giornate di Open Day,incontri e visite di formazione per gli insegnan-ti.
8.5 PROSPETTIVE
Anche per il 2012 l’INFN coniugherà le iniziativedi divulgazione con quelle di informazione. So-prattutto per quel che riguarda la ricerca conl’acceleratore di particelle LHC di Ginevra.
Sono previste conferenze a “La scienza in piaz -za” (Bologna) e un grande appuntamento perla scienza a Catania. Qui i maggiori responsabiliitaliani della ricerca in LHC si incontreranno conun pubblico composto soprattutto da centinaiadi studenti delle scuole medie superiori. Assiemea loro vi saranno anche i dirigenti della ricercainternazionale che si svolge e si svilupperà in Si-cilia. Nella primavera del 2012 l’INFN aprirà unamostra dedicata all’Universo realizzata assiemealla Specola Vaticana.Un punto di vista originale sulla storia del Cosmoe della ricerca per comprenderlo.In questa mostra saranno concentrati alcuniexhibit interattivi che hanno già avuto una espo-sizione nel corso del 2011.Altri appuntamenti previsti: la partecipazione adue mostre sui 150 anni dello Stato italiano,quella organizzata dalla Fondazione Rosselli equella promossa dal Ministero degli Affari Esterie dal CNR.È prevista inoltre la partecipazione al Festivaldella Scienza di Genova con una mostra sul bo-sone di Higgs che comprende anche un exhibitinterattivo originale. Il tema del bosone di Higgsè particolarmente sensibile, perché esistono fon-date speranze che entro il 2012 si avrà, dalla ri-cerca in LHC, una risposta definitiva sul l’esistenzadi questo bosone nei parametri previsti dal Mo-dello Standard. Sarà questo uno dei temi piùimportanti anche della campagna verso i medianel corso del 2012.Proseguirà anche l’impegno nella diffusionedella cultura scientifica mediante la pubblicazioneperiodica della rivista Asimmetrie. I riscontri ot-tenuti incoraggiano la redazione a pro seguire ilpercorso di diffusione del patrimonio di cono-scenza proprio della comunità dei ricercatoridell’INFN e delle sue attività di ricerca.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIVITÀDICOMUNICAZIONEEDIDIVULGAZIONESCIENTIFIC
A
177

9. LE ATTIVITÀ DI IMPATTOSOCIO-ECONOMICOE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIV
ITÀDIIMPATTO
SOCIO-EC
ONOMICHEEDITRAFER
IMENTO
TECNOLOGICO
182
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIV
ITÀDIIMPATTO
SOCIO-EC
ONOMICHEEDITRAFER
IMENTO
TECNOLOGICO
181
tito di raggiungere già qualche anno fa esem-plari forme di sinergia con le industrie e ilmondo accademico (citiamo ad esempio la col-laborazione con l’IBA e il Dipartimento di Fisicadell’Università di Torino), ha avvertito l’esigenzadi migliorarle e implementarle per risponderemeglio alle richieste di collaborazione sempremaggiori provenienti dal mondo produttivo,senza però perdere la vocazione naturale per laricerca di base, che è e resta caratteristica pro-pria dell’Ente.Gli alti livelli di innovazione e di capacità di rea-lizzazione sono la base della forza tecnologicadell’Ente, attraverso la promozione della ricercasu dispositivi, materiali, tecniche e processi mi-rati alla sua attività sperimentale. Allo stessotempo alcuni di questi sviluppi, in origine stimo-lati dalle necessità di costruzione degli apparatisperimentali, possono successivamente trovareuna nuova vita negli sviluppi interdisciplinari, avolte in modo rivoluzionario.Esempi di queste incarnazioni sono le attività nelsettore acceleratori, che partono dalle nuovetecniche per le flavour factories e si muovonoverso la realizzazione di fasci radioattivi e deifree electron laser. Gli sviluppi di elettronica abassa potenza, resistente alle radiazioni, per-metteranno di costruire nuovi sensori per le mis-sioni spaziali, mentre nuove tecniche di diagnosiper l'imaging medico sono complementari a ini-ziative di più ampia portata come l’adroterapiaal CNAO o la modellizzazione neurologica.All’ambito del Trasferimento Tecnologico puòinoltre essere ricondotta l’attivazione di assegnidi ricerca destinati alla valorizzazione in ambitoproduttivo delle conoscenze, delle metodologiee delle tecnologie legate alle attività di ricercadell'INFN. Si tratta di assegni di ricerca da svol-gersi presso i laboratori e i centri di ricerca di in-dustrie ad elevata capacità e innovazionetecnologica; hanno durata annuale eventual-mente prorogabile di un ulteriore anno, d’intesacon l’industria che sostiene la metà dei costi re-lativi alla seconda annualità. I settori interessatisono quelli delle tecnologie informatiche (ICT),della sensoristica, dell’elettronica, della mecca-nica e dell’impiantistica, dell’analisi e qualificadei materiali.L’iniziativa, che coniuga trasferimento tecnolo-gico e placement, ha incontrato un notevole in-teresse da parte del mondo industriale. Sono116 infatti le industrie, di differenti settori e re-gioni, che hanno risposto alla call dell’Istituto etra queste figurano vere e proprie eccellenze ita-
liane (Ferrari, Ducati Corse, IBA, Ansaldo Nu-cleare, Telespazio, Alenia Areounatica, CentroRicerche FIAT, OCEM, Magneti Marelli, AnsaldoSistemi Industriali, etc.), a testimonianza dellecapacità di innovazione tecnologica, nonchéformativa, dell’Istituto.
9.2 CONTO TERZI
È stato approvato dai competenti Uffici ministerialiil Regolamento per la ripartizione dei compensiderivanti dalle attività in favore di terzi, come pre-visto dall’art. 19 del CCNL 2002-2005, relativo alpersonale del comparto degli enti pubblici di ri-cerca. L’INFN era già dotato di un Regolamentoper la prestazione di attività e servizi a favore diterzi, pubblicato nella GU n. 124 del 30/5/2006,questo rinviava al testo ora approvato la defini-zione dei criteri per la ripartizione e l’assegnazioneal fondo di incentivazione del personale di unaquota dei corrispettivi derivanti da tali attività. Intale testo si prevede di assegnare al predettofondo una percentuale degli utili, dedotti tutti glioneri diretti e indiretti, e di prevedere alcune limi-tazioni sull’impegno di tempo massimo che cia-scun dipendente può investire in questo generedi attività, che si svolgono comunque durantel’orario di lavoro.
9.3 SPIN-OFF
Nell’ambito delle finalità istituzionali volte allapromozione del trasferimento delle conoscenzee delle tecnologie acquisite, l’Istituto si è dotatodi un regolamento che disciplini gli spin-off, ov-vero la costituzione di società di capitali (im-prese), aventi come scopo sociale la produzionedi beni o la fornitura di servizi derivanti in tuttoo in parte dall’utilizzazione in contesti innovatividei risultati ottenuti nell’ambito delle ricerchedell’INFN.Con il regolamento approvato dal Consiglio Di-rettivo dell’Istituto a settembre 2010 e appro-vato con provvedimento del 26 gennaio 2011dal Ministero, si è disciplinata la procedura au-torizzativa che deve essere seguita dal perso-nale, sia dipendente che associato, interessatoa promuovere la costituzione di realtà impren-ditoriali per la produzione di beni o la fornituradi servizi derivanti in tutto o in parte dall’utiliz-zazione in contesti innovativi dei risultati otte-nuti nell’ambito delle ricerche dell’INFN. Sono
9.1 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
L’Istituto sta portando a termine la ridefinizionedel quadro regolamentare interno sulla materiadella proprietà intellettuale e del trasferimentotecnologico. Nel corso del 2011 è proseguital’attività del gruppo di lavoro composto da rap-presentanti delle varie anime dell’Istituto (diret-tori di sezione, responsabili di esperimenti eprogetti speciali, universitari associati alle attivitàdell’Istituto), che si è consolidato nel 2010 in unComitato per il Trasferimento Tecnologico con ilcompito di promuovere e coordinare tutte le ini-ziative necessarie alla realizzazione degli obiet-tivi definiti sulla materia dal vigente Statutodell’INFN, nonché dai più specifici Regolamentidi settore, e che ha dato avvio a diverse iniziativein materia.
È da sottolineare che la ricerca dell’Istituto ècontraddistinta da aspetti e presupposti che fa-voriscono il processo di trasferimento di cono-scenza e tecnologia verso discipline differenti everso il mondo produttivo:
Su questa base, si sta definendo e implemen-tando una strategia di trasferimento di tecnolo-gia e conoscenza secondo un modello in cui
Istituto e imprese o altre istituzioni conduconoazioni di ricerca collaborativa volte all’innova-zione di prodotto tramite consorzi, laboratoricongiunti di sviluppo, attività in conto terzi edeventualmente aziende di nuova creazione(spin-off company). Ciò è coerente anche con la valorizzazione delfisico come figura professionale in grado di in-serirsi nel mondo produttivo e nella società gra-zie alla sua formazione scientifica di base, allesue competenze specifiche e alla sua capacità diporre e risolvere problemi negli svariati settoriapplicativi (ad es. medicina, sanità, beni cultu-rali, ambiente, energia).
Le azioni alla base del processo possono essereschematizzate come segue:
Queste premesse metodologiche hanno consen-tito all’Istituto di intraprendere azioni positiveper sostenere tale processo.L’INFN, pur dotato di norme che hanno consen-
Il livello di complessità delle attività sperimentaliè tale che la gran parte degli apparati e delletecnologie sono sviluppati dagli stessi ricerca-tori, superando i limiti del know-how pre-esi-stente. Ciò si applica ai sensori e rivelatori, maanche alla microelettronica, alle tecniche di ac-celerazione di particelle, all’engineering di si-stemi complessi e al software.In termini generali, per perseguire i propri finiscientifici, i ricercatori sviluppano strumenti emetodi innovativi ed originali;Gli esperimenti sono imprese internazionali,sviluppate in grandi collaborazioni.Di conseguenza, i ricercatori hanno una natu-rale attitudine allo sviluppo ed all’impiego ditecnologie con caratteristiche di novità e di uni-cità e naturalmente al “lavoro di squadra”, subase competitiva ma collaborativa e dove l’in-dividualità viene valorizzata;Gli esperimenti richiedono impegni internazio-nali, investimenti considerevoli e, sovente, pro-duzioni quantitativamente e qualitativamentesignificative a livello industriale. Ciò implica, daparte delle aziende fornitrici, innovazione diprodotti o servizi e una interazione frequentee costruttiva con i ricercatori.
•
•
•
definizione della normativa inerente le attivitàsvolte in conto terzi, la valorizzazione e ge-stione della Proprietà Intellettuale (pregressae risultante), i meccanismi di incentivazioneal personale e di partecipazione ai progetticollaborativi, la creazione e partecipazionedell’Istituto e dei suoi dipendenti e collabora-tori ad aziende spin-off;attività ricognitiva e formativa presso ogni strut-tura dell’Istituto, per organizzare e strutturarel’offerta collaborativa di strutture e tecnologie eper promuovere le azioni di trasferimento di tec-nologia e conoscenza;attività implementativa, con enfasi sulla ri-cerca collaborativa che origini dalla proprietàintellettuale, dalle infrastrutture ed attrezza-ture dell’Istituto;analisi e partecipazione ai programmi comu-nitari, nazionali e regionali di sostegno all’in-novazione;implementazione di schemi per promuoverelo scambio di personale tra Istituto e imprese; analisi dell’impatto sul mondo produttivo viamodelli macro-economici; analisi dell’impatto sulla società analizzandola mobilità e professionalità del capitaleumano formato all’interno dell’Istituto;sinergia con le attività della comunità inter-nazionale, ad oggi coordinate dal TechnologyTransfer Network dei paesi membri del CERN; adozione di una metrica per la valutazionedell’efficienza ed efficacia del processo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

state previste differenti forme di collaborazioneche l’INFN può prestare alla costituenda società:dal mero conferimento in licenza di conoscenze,con le cautele necessarie a evitare pregiudizi oconflitti d‘interesse con le attività istituzionalidell’Ente, fino alla eventuale partecipazione alcapitale sociale in qualità di socio. Tutto ciò inaccordo con il Decreto Legislativo 27 luglio1999, n. 297, contenente il “Riordino della di-sciplina e snellimento delle procedure per il so-stegno della ricerca scientifica e tecnologica, perla diffusione delle tecnologie, per la mobilità deiricercatori” nonché con il suo regolamento at-tuativo, contenuto nel D.MIUR 8 agosto 2000n. 593 recante “Modalità procedurali per la con-cessione delle agevolazioni previste dal decretolegislativo 27 luglio 1999, n. 297”.A seguito dell’adozione del Regolamento, neldicembre dell’anno trascorso è stato attivato ilprimo Spin-off dell’Istituto e altri due sono infase istruttoria avanzata.
9.4 BREVETTI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
A completamento del processo di revisione delladisciplina interna in materia, si sta procedendoad un riesame del Regolamento per la valoriz-zazione, lo sviluppo e l’applicazione delle cono-scenze dell’INFN (pubblicato nella GU n. 45 del24/2/2004) sia per adeguarlo alla sopravvenutadisciplina interna e statuale, sia per renderlo me-glio rispondente ai sempre differenti e mutevolicontesti sociali ed imprenditoriali cui l’INFN èchiamato a confrontarsi.Con l’auspicio di incrementare il numero di bre-vetti senza svilirne la qualità e le potenzialitàcommerciali, particolare attenzione viene pre-stata ai processi di brevettazione delle cono-scenze sviluppate all’interno delle attivitàistituzionali dell’Ente. L’INFN è infatti attual-mente titolare di 6 brevetti, di cui 4 in compro-prietà con altri Enti pubblici o privati stranieri.Tutti i brevetti trovano tutela in Italia, uno anchein Francia, uno in Europa, tre godono di unaprotezione attraverso un brevetto internazio-nale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty). Losfruttamento economico dei brevetti attraversolicenze commerciali produce annualmente unutile netto di 20.000 Euro all’anno.Nell’anno trascorso il Comitato per il Trasferi-mento Tecnologico ha proceduto ad un riesamedei brevetti valutando, in occasione del paga-mento delle tasse di mantenimento del brevetto
e sentiti gli inventori, se continuare a mantenerela copertura brevettuale o rinunciare a prose-guirla, in relazione allo stato dell’arte e all’inte-resse suscitato dal brevetto : nel 2012 sono trei brevetti che non verranno mantenuti. Paralle-lamente è proseguito l’esame delle richieste per-venute dai ricercatori dell’Istituto che nell’annotrascorso hanno portato all’attivazione delleprocedure per quattro nuovi brevetti; altre tre ri-chieste sono in fase istruttoria avanzata e neiprossimi mesi si tradurranno verosimilmente innuove domande di brevetto.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LEATTIV
ITÀDIIMPATTO
SOCIO-EC
ONOMICHEEDITRAFER
IMENTO
TECNOLOGICO
183

10. IL PIANO DI RIAMMODERNAMENTO GESTIONALE

PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILPIA
NODIRIAMMODERNAMENTO
GESTIO
NALE
188
L’attività del Sistema informativo proseguirà nelprossimo triennio per includere le funzionalitàancora mancanti ed in particolare:
L’evoluzione del sistema informativo verrà rea-lizzata in modo incrementale e per passi suc-cessivi, in modo tale da poter costantementeverificare il livello di miglioramento dell’organiz-zazione e l’efficienza raggiunta rispetto ai risul-tati attesi.Gli elementi principali di sviluppo del sistemainformativo nel prossimo triennio riguardano ilmiglioramento di processi di business, l’auto-mazione dei flussi di lavoro, l’uso pervasivodella firma elettronica nei processi per i quali sirendono necessari specifici livelli autorizzativi edi sicuezza, quali ad esempio:
Si prevede inoltre di rendere disponibili modellidi dati e relativi strumenti che permettano unafacile navigazione dello spazio disponibile nel si-stema informativo INFN.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ ILPIA
NODIRIAMMODERNAMENTO
GESTIO
NALE
187
10.1 IL QUADRO NORMATIVO
L’Istituto è ente pubblico nazionale di ricerca,con autonomia organizzativa, finanziaria e con-tabile ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, del-l’art. 8 della legge 168 /1989 e dell’art. 2 delD.Lgs. 213/2009.Il decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre2009, emanato dal Governo sulla base dellalegge delega del 27 settembre 2007 n. 165,avente per oggetto il riordino degli enti di ri-cerca vigilati dal MIUR, prevede per ciascun entela formulazione di un nuovo statuto, da delibe-rare – da parte degli enti − entro sei mesi dalladata di entrata in vigore del decreto legislativo,che specifichi la missione e gli obiettivi di ricerca,tenuto conto del PNR (Programma Nazionaledella Ricerca) e degli obiettivi strategici fissati dalMinistero e dall’Unione Europea, nonché deifabbisogni e del modello strutturale di organiz-zazione e funzionamento previsti per il raggiun-gimento degli scopi istituzionali e il buonandamento delle attività. La formulazione e ladeliberazione dello Statuto è attribuita, in primaapplicazione, ai consigli di amministrazione (perl’INFN al Consiglio Direttivo), integrati da cinqueesperti nominati dal Ministro.Il decreto contiene una norma specifica perl’INFN (art. 9.4) che dispone la riduzione deicomponenti del Consiglio Direttivo dei due rap-presentanti dell’ENEA e del CNR e il manteni-mento in vigore delle vigenti disposizioni relativealla nomina degli organi statutari.L’Istituto ha dato seguito a quanto previsto daldecreto di riforma adottando il nuovo Statuto,approvato dal MIUR ed entrato in vigore il 1maggio 2011, nonché i Regolamenti di Ammi-nistrazione, Finanza e Contabilità e del Perso-nale, approvati dal Consiglio Direttivo nellaseduta di ottobre 2011 ed attualmente sottopo-sti al controllo da parte dei Ministeri competenti. È in corso di definizione l’elaborazione e l’ap-provazione di alcuni disciplinari che completanoil quadro di riordino dell’Istituto in conseguenzadell’adozione dello Statuto. Nel frattempo, come previsto dallo Statuto, re-stano in vigore i provvedimenti assunti secondoil previgente ordinamento, quali:
Le disposizioni legislative generaliLa natura pubblica dell’Istituto, l’impiego di ri-sorse umane e in generale il fatto di essere in-seriti nella realtà giuridica del Paese,comportano l’obbligo di attenersi: ai principisulla trasparenza e sui tempi certi dei procedi-menti amministrativi (legge 241 del 1990); al-l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche (decreto legislativo165 del 2001); alla tutela dei dati personali (de-creto legislativo 196 del 2003); alla cura della si-curezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo81 del 2008); al controllo della Corte dei Conti(legge 20 del 1994); alle speciali regole in ma-teria di appalti di lavori, servizi e forniture (de-creto legislativo 163 del 2006); alle regole inmateria di ottimizzazione della produttività dellavoro pubblico e di efficienza delle pubblicheamministrazioni (decreto legislativo 150 del2009) nonché a tutte quelle altre disposizionigenerali riferite alle Amministrazioni pubblichee che riguardano le attività svolte dall’Ente.
10.2 IL SISTEMA INFORMATIVO
Il nuovo sistema informativo, entrato in esercizionel 2009, assicura una gestione integrata, effi-ciente, trasparente e ottimizzata dei processiamministrativi dell’Istituto. In linea con gli obiet-tivi del piano triennale 2011-2013, nel corso del2011 il nuovo sistema informativo dell’Istitutoha ottenuto i seguenti risultati:
Regolamento generale delle strutture; Regolamento di amministrazione, finanza econtabilità; Regolamento recante le norme sui concorsiper l’assunzione di personale a tempo inde-terminato;
Regolamento per le associazioni alle attivitàscientifico-tecniche;Regolamento del trattamento dei dati sensi-bili e giudiziari; Regolamento per la valorizzazione, lo svi-luppo e l’applicazione delle conoscenze del-l’Istituto;Regolamento per la prestazione di attività eservizi a favore di terzi; Regolamento sul trattamento di missione delpersonale dipendente dell’INFN sul territorionazionale; Regolamento per i lavori, le forniture e i ser-vizi in economia;Regolamento per l’Attività Negoziale;Regolamento per il Patrimonio;Regolamento sugli spin-off;
Creazione della Direzione Sistema Informa-tivo e il potenziamento del gruppo interno;Attivazione al CNAF della nuova piattaforma
hardware basata su cluster Linux;Definizione della nuova infrastruttura Ana-grafica del Personale;Introduzione del Mandato Informatico e dellafirma digitale;Avvio dell’attività di analisi dei dati con stru-menti di Business Intelligence;Consolidamento della gestione amministra-tiva e contabile; Capillare attività di formazione del personaleper abilitarlo all’uso dei nuovi strumenti in-formatici; Messa in esercizio in tutte le strutture dell’INFNdel nuovo sistema di rilevazione presenze, in-tegrato con il sistema di gestione risorseumane e il sistema della contabilità;Messa in esercizio in tutte le strutture dell’INFNdel Portale Utente e sua completa integrazionenella struttura informatica dell’INFN (autentica-zione, autorizzazione, anagrafiche, ecc.).
Irrobustire il sistema al fine di aumentarne l'ef-ficacia e l'efficienza a beneficio dei processiaziendali interni; potenziare la capacità delgruppo interno a fornire formazione ed assi-stenza agli utenti; accrescere l’autonomia delgruppo interno a produrre tempestivamente inecessari adeguamenti del sistema dettati danuove normative o da nuove esigenze;Realizzare anche attraverso l’uso di strumentidi Business Intelligence, l’Integrazione di tuttele componenti informative attualmente inesercizio nell’INFN, nonché la conservazionedei dati storici proveniente dai precedenti si-stemi contabili, al fine di garantire un sistemamoderno, integrato che possa migliorare l’ef-ficienza nelle sue operazioni e la trasparenzaverso il management e gli organi di controllo;Favorire, sfruttando le potenzialità del nuovosistema informativo integrato, una maggioreefficienza dell’intera macchina amministra-tiva, attraverso una rivisitazione dell’insiemedelle attività e dei processi dell’Istituto; Realizzare un miglioramento sulla qualità deidati ed accrescere la capacità di correlarli traloro per mettere a disposizione del manage-ment dell’INFN un potente strumento di ge-stione al fine di massimizzare la adeguatezzadella azioni correttive minimizzando i tempidi risposta agli eventi;Perseguire la dematerializzazione dei docu-
menti. L’attività già avviata con l’adozione delmandato informatico sarà estesa, attraversopassi successivi, in tutti gli altri processi azien-dali;Perseguire l’adeguamento dell’infrastrutturatecnologica alla base del sistema stesso conil passaggio a release del software di ultimagenerazione.
Gestione e Rendicontazione dei Progetti; Gestione degli ordinativi - approvvigionamenticentralizzati - magazzino - mercato elettronico;Gestione appalti; Gestione patrimonio;Budget e pianificazione;Gestione dei documenti;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11. LA VALUTAZIONE INTERNA

randi: un proseguimento del dibattito su questitemi è auspicabile, in modo da pervenire ad unavalutazione oggettiva dell’Ente che sia funzio-nale agli interessi ministeriali e governativi.Nel seguito saranno illustrati alcuni degli elementiche contribuiscono al processo di valutazionedella ricerca dell’INFN, al fine di esemplificare ilprocesso stesso e di fornire elementi utili all’inter-pretazione di quanto descritto sopra.
11.1 PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA
La ricerca fondamentale è alla base delle attivitàdell’INFN e questo pone l’accento in modo na-turale sulle pubblicazioni scientifiche, quali prin-cipali riferimenti per la produttività dell’Ente.Durante la VTR 2001-2003 il Ministero avevaraccomandato come sorgente dei dati bibliome-trici Web Of Science (WOS), dell’Institute forScientific Information (ISI), database proprietariodella Thomson (consultabile tramite abbona-mento). ISI-WOS è stato ed è quindi tuttora uti-lizzato dai GLV come sorgente di tutti i datiprimari che concernono le pubblicazioni: i criteriutilizzati da ISI-WOS garantiscono anche che gliarticoli appartengano solo a riviste di rango in-ternazionale, i quali vengono accettati solo do -po un rigoroso processo di peer review. ISI-WOSè anche uno dei due database consigliati per ilprocesso VQR 2004-2010.
È tuttavia utile anche ricordare come le pubblica-zioni ISI non siano l’unico canale utilizzato per dif -fondere risultati scientifici nei campi di ricercapropri dell’INFN. Ad esempio, ricercatori INFN con -tribuiscono in modo significativo alla redazione dirapporti per grandi laboratori internazionali comeil CERN e Fermilab, o a progetti editoriali simili,quali le pubblicazioni on-line, sia nel contesto dicollaborazione con colleghi stranieri sia per contodi Organizzazioni Internazionali.
Negli anni a venire, inoltre, la diffusione in for-mato elettronico delle pubblicazioni diventerà ilsistema più utilizzato per la comunicazione di ri-sultati scientifici e le politiche editoriali di open ac-cess avranno un ruolo sempre maggiore. L’INFNsta seguendo da vicino questa evoluzione, in qua-lità di membro dell’iniziativa SCOAP3 (SponsoringConsortium for Open Access Publishing in ParticlePhysics). Il finanziamento attraverso un consorziosembra il modello più promettente per le attivitàdell’INFN. Questo approccio è già operativo per legrandi collaborazioni del Large Hadron Collider(pagamento di una quota da parte dell’Istituto ecorrispondente disponibilità on-line di tutte lepubblicazioni su riviste internazionali di prestigio)e potrebbe modificare ancora più radicalmente ilpanorama globale, se il consorzio do vesse offrirestrumenti addizionali come l’analisi delle citazionio la ricerca di testi.
Nella tabella 11.1 è illustrata la produttività totaledell’INFN nel 2010, divisa nelle cinque linee scien-tifiche e confrontata con il risultato medio deltriennio 2004-2006 e con quelli degli anni succes-sivi. Il totale in ogni colonna eccede la sommadelle singole righe, poiché vi sono ulteriori pub-blicazioni che non sono direttamente attribuibilia una singola CSN, ad esempio perché realizzateda autori di diversa estrazione professionale (e.g.uno teorico e uno sperimentale).Si può notare in particolare il valore molto elevatodel numero di pubblicazioni nel campo teorico(CSN4), dato che riflette l’eccellenza della scuolaitaliana nel settore. Si osserva anche, su un pe-riodo di molti anni, che la produzione scientificadell’Ente è costante, un segno dell’ottimo livello
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LAVALUTAZIONEINTERNA
192
CSN1CSN2CSN3CSN4CSN5CommonINFN
200919523822310993263972478
200825621920611913333342539
200728019226612363251932492
<04-06>29620525511272642762423
Numero di pubblicazioni ISI
Tab. 11.1: Produttività scientifica INFN
CSN1CSN2CSN3CSN4CSN5
20103851505566
20093053445661
20084264516367
20073764535856
<04-06>3675475966
Frazioni di autori INFN (%)
CSN1CSN2CSN3CSN4CSN5
20093.904.402.603.731.96
20083.102.802.803.471.70
20073.652.892.583.621.54
<04-06>3.782.152.603.441.46
Frazioni di autori INFN
Tab. 11.2: Alcuni indicatori di produttività scientifica INFN
20103.804.082.853.731.972010
27725925411833204282721
Dieci anni dopo il lancio della strategia di Li-sbona, l'Unione Europea sta affrontando una si-tuazione economica globale che richiedel'adozione di misure straordinarie per spostarsidalla normale gestione di una crisi a una politicacondivisa di riforme strutturali. L'impegno perl'Europa a diventare "la più dinamica e compe-titiva economia della conoscenza nel mondo"implicava che i Paesi dell'Unione Europea avreb-bero dovuto aumentare gli investimenti nella ri-cerca fino a circa il 3% del loro PIL: purtroppociò non è avvenuto dappertutto nel continente.I recenti avvenimenti fanno crescere la consape-volezza che solo ricerca e sviluppo pongano lebasi per una crescita economica a lungo ter-mine: conseguentemente, l’identificazione deimeccanismi corretti per valutare gli esiti dei fi-nanziamenti alla ricerca è ancora più cruciale. L’INFN è sempre stato focalizzato nel controllodei propri programmi di ricerca, grazie all'esi-stenza di diversi organismi che eseguono la va-lutazione ex-ante, in itinere ed ex-post diesperimenti e iniziative. Insieme con la GiuntaEsecutiva, il Consiglio Direttivo e le CommissioniScientifiche, il nuovo statuto prevede un Consi-glio tecnico-scientifico che supervisioni le deci-sioni riguardanti nuovi progetti su larga scalaproposti dalle Commissioni.Fin dal 1997 l’Ente ha affidato la valutazionecomplessiva delle proprie attività al giudizio diun Comitato di Valutazione Internazionale (CVI),che redige su base annuale un rapporto sullaqualità della ricerca INFN e fornisce indicazionie raccomandazioni per migliorarne la perfor-mance globale. Il CVI è costituito da esperti in-ternazionali della massima autorevolezza, sia neicampi dove l’Istituto conduce le proprie attivitàdi ricerca, sia in settori che sono interessati oconnessi a tali attività, come quello industriale eproduttivo o più in generale quello economico.Nessun ricercatore, dipendente o associatoINFN, è componente del CVI: ciò a garanziadell’imparzialità del lavoro dal Comitato, che èil solo titolato a emettere un giudizio sull’ope-rato dell’INFN.Il CVI incontra il Presidente dell’Ente, la GiuntaEsecutiva e i Presidenti delle Commissioni Scien-tifiche in una riunione di più giorni nella qualevengono passate in rassegna tutte le iniziativescientifiche dell’Istituto e le linee di programma-zione futura. Alla riunione partecipa anche ilCoordinatore dei Gruppi di Lavoro sulla Valuta-zione (GLV), costituiti a partire dall’anno 2000per istruire il processo di autovalutazione se-
condo i criteri raccomandati dal Ministero attra-verso il CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valu-tazione della Ricerca).I GLV, uno per ogni linea scientifica dell’Ente,hanno il compito di raccogliere in modo orga-nico in una relazione inviata al CVI i dati ogget-tivi che descrivano la performance scientificadell’INFN (inseriti se possibile in un contesto in-ternazionale), insieme a elementi utili a mostraresia l’attività di alta formazione dei giovani svoltanell’ambito delle ricerche dell’Istituto, sia l’im-patto socio-economico e inter-disciplinare delleattività dell’Ente.Il CVI è anche punto di riferimento per il MIUR,al quale inoltra ogni anno il suo rapporto finale.Nel caso in cui il Ministero realizzi esercizi nazio-nali di valutazione della ricerca (come nel casodella Valutazione Triennale della Ricerca 2001-2003, gestita dal CIVR o dell’attuale VQR 2004-2010 gestita dall’ANVUR) il CVI è altresìresponsabile della trasmissione al Ministero dellarelazione che descrive la performance scientificadell’Ente e il suo corrispondente impatto, al finedi evitare problemi di auto-referenzialità nel pro-cesso di valutazione.L’approccio utilizzato dall’INFN è quindi basatosu una doppia componente: da una parte datioggettivi espressi attraverso indicatori ricono-sciuti dagli esperti, dall’altra l’analisi globale delloro significato e delle attività scientifiche del-l’Ente in toto da parte di un gruppo di pari. Sa-rebbe infatti controproducente al fine di unacorretta valutazione, in una realtà articolata ecomplessa come l’INFN, ridurre l’intero processoa un mero elenco di indicatori da confrontarecon dati esterni, trascurando la componentestorica degli avanzamenti scientifici (esperimentie ricerche che si trovano in fasi diverse in mo-menti diversi) o il valore aggiunto derivante dallarealizzazione di una grande infrastruttura di ri-cerca, rispetto alla pubblicazione di un articolosu una rivista.Dopo la Valutazione Triennale della Ricerca (VTR2001-2003), il 2011 segna il passo molto attesoverso un esercizio ministeriale più complesso edesigente, che copre i sette anni 2004-2010 (Va-lutazione della Qualità della Ricerca, VQR), ge-stito dalla neonata agenzia ANVUR. L’INFN,tramite i propri strumenti di valutazione interna,sta procedendo alla preparazione del materialerichiesto. Va ricordato in questo contesto che al-cuni parametri presenti nelle Linee Guida per laVQR difficilmente si adattano alla natura dellericerche condotte dall’INFN e al suo modus ope-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LAVALUTAZIONEINTERNA
191

che citate: il dato più appariscente è che il risul-tato eccede in media il contributo INFN, sia fi-nanziario sia di personale, alle Collaborazionisuddette. Questa è una ulteriore dimostrazionedell’alto ruolo scientifico che l’Istituto riveste inambito internazionale ed è un importante rico-noscimento delle capacità scientifiche e mana-geriali dei suoi ricercatori.In questo contesto l’highlight più importante èche nel 2010 tutte e quattro le Collaborazioniinternazionali che operano al Large Hadron Col-lider del CERN a Ginevra sono guidate da scien-ziati di nazionalità italiana, tre dei quali affiliatidirettamente all’INFN e la quarta formatasi an-ch’essa in ambito INFN.
11.2 UNA PROSPETTIVA EUROPEAPER LA VALUTAZIONE
L’INFN è membro di diverse organizzazioni eu-ropee e internazionali e contribuisce alla defini-zione dei corrispondenti piani pluriennali diattività, per quanto attiene alla missione dell’Isti-tuto, nel campo della fisica fondamentale, siateorica sia sperimentale.La European Science Foundation (ESF) è una diqueste organizzazioni, ed è nata sulla spinta didiverse istituzioni e agenzie (ad oggi 80 in 30nazioni) che si sono poste come fine la coope-razione e la collaborazione nella ricerca scienti-fica europea, considerando anche le esigenzedegli erogatori delle risorse finanziarie (stakehol-ders). La ESF agisce in stretta collaborazione conaltre istituzioni a livello europeo, come la Com-missione Europea stessa, ALLEA (ALL EuropeanAcademies) e EUROHORCs (European Heads ofResearch Councils), di cui l’INFN è pure membro,e anche con partner come NSF (National ScienceFoundation) e NIH (National Institutes of Health)negli Stati Uniti e con l’OECD (Organization forEconomic Cooperation and Development).L’INFN fa parte di ESF fin dalla sua fondazionenel 1974 (unica istituzione italiana insieme alCNR): è rappresentato in strutture interne del-l’organizzazione come il Physics and Enginee-ring sciences Standing Committee (PESC) e ilNuclear Physics European Collaboration Com-mittee (NuPECC). Da alcuni anni il ruolo di ESFsi è focalizzato sulla creazione della EuropeanResearch Area (ERA), che dovrà essere caratte-rizzata da una politica scientifica dinamica, dafinanziamenti basati sulla qualità e sul merito,dalla mobilità dei ricercatori, degli studenti edelle risorse finanziarie e dalla realizzazione di
infrastrutture di ricerca adeguate. Per lo studio di una realtà così complessa e perindividuare i principali temi per le azioni future,ESF ha deciso di utilizzare le esperienze e le ideedei propri membri, attraverso l’istituzione di di-versi Fora di discussione. I Fora della ESF sonoinfatti strumenti finalizzati allo scambio delleesperienze nazionali e mirano all’identificazionedi un insieme condiviso di pratiche che possanoanche essere trasferite in realtà diverse.
Il Forum “European Alliance on Research CareerDevelopment” è stato istituito nel 2010, dopola pubblicazione della roadmap EUROHORCs-ESF. Il Forum è costituito da ventuno organizza-zioni membri di ESF provenienti da 17 paesieuropei e altri osservatori dalla Commissione Eu-ropea (EC), dello European Research Council(ERC) ed altre istituzioni europee. Missione delForum è di produrre raccomandazioni solide eattuabili al fine di rendere l'Europa un luogo in-teressante per il lavoro di ricercatore. All'interno del Forum l’INFN partecipa al gruppodi lavoro per identificare le competenze dei ri-cercatori. Esso mira a trovare una definizionecondivisa dei profili professionali dei ricercatorie a fornire una guida per incoraggiare lo svi-luppo professionale continuo dei ricercatori, mi-gliorando la loro possibilità di occupazioneall'interno e all'esterno del mondo accademico.Parte di questo progetto è uno studio di fattibi-lità per valutare l'applicabilità in tutta Europa diun generico quadro per lo sviluppo professio-nale dei ricercatori, basato sul Research Deve-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LAVALUTAZIONEINTERNA
194Fig. 11.1: Il Research Development Framework (RDF) strutturato neiquattro domini
di produttività scientifica e della continuità dell’im-patto delle ricerche INFN in tutti i settori.Il numero delle pubblicazioni è solo uno dei pa-rametri che si possono considerare nella valuta-zione della produttività scientifica. L’utilizzo deldatabase ISI-WOS permette tra l’altro di acce-dere direttamente ad altri indicatori bibliome-trici, come l’Impact Factor (IF, ideato appunto daISI-Thomson), o effettuare analisi più complesselegate al numero di citazioni. Gli Impact Factorsono derivati dal Journal of Citation Reports,edito da ISI e caratterizzano la qualità delle rivi-ste corrispondenti.L’Impact Factor rappresenta infatti la media dellecitazioni degli articoli pubblicati su una determi-nata rivista in un periodo di due anni. In questocontesto quindi può al più essere utilizzato perconfrontare le riviste tra di loro, ma certamentenon per estrarre informazioni sulla qualità di unsingolo articolo pubblicato. Anche nella prima ac-cezione, estrema cautela deve essere utilizzata ne-l’uso dell’IF, soprattutto quando si confrontanodiscipline diverse tra loro, i cui ricercatori pubbli-cano su riviste con politiche editoriali che possonoessere assai variegate.Nella tabella 11.2 sono quindi riassunti alcunialtri parametri utilizzati per esemplificare la qua-lità e le caratteristiche della produttività scienti-fica dell’Ente. Il valor medio dell’Impact Factorrisulta costante negli anni per ognuna delle lineescientifiche: è anche degno di nota che vi sianoalcuni articoli molto significativi pubblicati su ri-viste ad altissimo Impact Factor come Nature oScience. Il valor medio della CSN5 è assoluta-mente tipico delle riviste a carattere tecnologicoe strumentale, rispetto a quelle che raccolgonorisultati di fisica sperimentale e teorica, ed esem-plifica perfettamente il caveat esposto soprasulla necessità di differenziare la valutazione ri-spetto alle caratteristiche del settore scientificodi riferimento. La frazione di autori INFN è indicativa del livello diinternazionalizzazione che caratterizza le attivitàdi ricerca dell’Ente in ogni settore. Anche in que-sto caso, come in quello dell’IF, occorre ricordareche il valor medio è estratto da distribuzioni multi-modali: nel caso della CSN1, ad esempio, esso ri-sulta dal mediare articoli con uno o pochi autoritotali con gli articoli delle Collaborazioni LHC, chehanno circa tremila autori ciascuno.La complessità, la dimensione e la durata tempo-rale dei grandi progetti dell’Ente in fisica nucleare,subnucleare e astro-particellare richiede un co-stante controllo in tutte le fasi degli esperimenti,
dalla costruzione ai test di funzionalità, fino allapresa dati e alla loro analisi. La valutazione dellaricerca svolge qui due importanti ruoli: da unaparte serve a evitare che progetti pluriennali pos-sano incorrere in difficoltà tali da comprometterela buona riuscita dell’esperimento, dall’altra è unostrumento per verificare la rilevanza data ai ricer-catori INFN nel ricoprire ruoli di responsabilità nelleCollaborazioni.Il primo ruolo è implementato attraverso le Com-missioni Scientifiche Nazionali che utilizzano refe-ree anche stranieri per esaminare lo stato di ogniprogetto (tipicamente due volte l’anno). Ogniesperimento, all’atto di sottomettere le richiestefinanziarie per l’anno successivo, concorda con ireferee anche un insieme di milestone da rispet-tare nello stesso periodo.La tabella 11.3 mostra il grado complessivo disoddisfazione per le milestone concordate, neglianni indicati e per le linee scientifiche più rile-vanti in questo contesto: come si vede, unalarga percentuale è rispettata dalle Collabora-zioni e il meccanismo permette in generale diapplicare azioni correttive dove e se necessario.Va anche sottolineato che, proprio per la com-plessità e internazionalità progetti scientifici,ritar di nella rea liz zazione dei propri obiettivi pos -sono essere indotti anche da motivazioni ester -ne all’operato dei gruppi INFN.
Come conseguenza dell’alto livello di interna-zionalizzazione delle attività considerate è inte-ressante considerare quale sia la frazione deiruoli di responsabilità (leadership) che vengonoassegnati a ricercatori INFN all’interno delle Col-laborazioni (la definizione dei ruoli è per lo piùdefinita da accordi approvati dagli organi diri-genziali degli esperimenti). Questo è mostrato,sempre in tabella 11.3, per le tre linee scientifi-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LAVALUTAZIONEINTERNA
193
CSN1CSN2CSN3
2010896384
2009735686
2008796883
2007797084
<04-06>807978
Rispetto delle milestone (%)
CSN1CSN2CSN3
2010205534
2009305745
2008264337
2007263937
<04-06>255139
Ruoli di leadership (%)
Tab. 11.3: Indicatori di performance per le Collaborazioni e i Gruppi di ricerca

documento di riferimento pratico. Se è ovvia-mente applicabile alle situazioni nazionali, il docu-mento mira inoltre a creare integrazione e fiduciareciproca nell'attuazione dei programmi di ricercatransnazionali. Il contenuto della guida è stato pla-smato sull’input dei rappresentanti di più di 30 or-ganizzazioni che hanno partecipato al Forum.Inoltre, un'indagine completa sulle pratiche di peerreview da parte delle organizzazioni aderenti a ESF,come pure di altre organizzazioni chiave, è statacondotta al fine di comparare e identificare lebuone pratiche nel processo di revisione tra pari.Le analisi e le conclusioni dell'indagine sono stateutilizzate nella stesura della Guida e delle racco-mandazioni. I risultati dell'indagine sono disponibiliattraverso il sito web ESF a:www.esf.org/activities/mo-fora/peer-review.html.La guida presenta un insieme minimo di principifondamentali comunemente accettati a livelloeuropeo, compresi quelli del Programma Qua-dro dell'UE. Essa presenta una serie di goodpractices, individuando anche possibili alterna-tive, e si propone di essere utile per la ricerca eu-ropea per un ampio insieme di organizzazioni:di ricerca, di finanziamento, e per fondazioniprivate e associazioni di beneficenza. Si auspicache ciò aiuti l'armonizzazione delle procedure intutta Europa e sia di supporto alla costruzionedello Spazio Europeo della Ricerca, il quale ri-chiede una maggiore cooperazione e integra-zione delle attività a tutti i livelli.
11.3 CONFRONTO INTERNAZIONALE
Come è stato mostrato in precedenti rapporti, nelconfronto tra l’INFN e diversi paesi europei rappre-sentativi, la produzione italiana nella fisica nucleare,sub-nucleare e astro-particellare (spe rimentale eteorica) è ad un livello paragonabile (o superiore),in termini sia quantitativi sia qualitativi. Questo naturalmente deriva anche dal fatto chel’INFN opera in un quadro internazionale, otte-nendo, come abbiamo visto, anche una buona po-sizione nei ruoli di leadership corrispondenti.
Il livello internazionale delle ricerche condottedall’INFN si evince facilmente anche esami-nando il numero di pubblicazioni realizzate incollaborazione con colleghi stranieri.Ciò è mostrato nella tabella 11.4 che mostraper ogni linea scientifica la percentuale di pub-blicazioni in collaborazione internazionale: idifferenti valori per le diverse CSN riflettono ildifferente tessuto sociologico, nonché finan-ziario, delle linee di ricerca.
CSN1 e CSN3 sono esempi di particolare li-vello, per le quali sostanzialmente tutte le pub-blicazioni sono condotte in collaborazioneinternazionale (tali Commissioni infatti con-tengono al loro interno i grandi esperimenti alLarge Hadron Collider), ma anche nel campodella fisica teorica (CSN4) si può notare unsempre più marcato indirizzo verso lavori re-datti in collaborazione con colleghi stranieri.È peraltro interessante conoscere quali siano ipartner più importanti per i lavori pubblicati incollaborazione internazionale. La tabella 11.5riporta il risultato ottenuto considerando tuttele pubblicazioni INFN del 2010 su riviste accre-ditate da ISI.Il ranking globale dell’INFN si riflette approssi-mativamente nelle Commissioni Scientifiche,tuttavia i pesi delle varie nazioni sono diffe-renti, un segno della diversa composizionedelle collaborazioni rispetto anche ai diversi in-vestimenti degli altri paesi nelle varie lineescientifiche.Per CSN4 e CSN5 si può anche notare l’as-senza di una graduatoria evidente, segno chela tipologia della collaborazione con colleghistranieri è geograficamente più distribuita. Unaltro elemento di novità per il 2010 è costi-tuito da una collaborazione più intensa con laCina.L'anno scorso è stato presentato il panoramaeditoriale per le riviste utilizzate dall’INFN nellapubblicazione dei suoi risultati scientifici. La
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LAVALUTAZIONEINTERNA
196
CSN1CSN2CSN3CSN4CSN5
20099664856424
20089668916221
20079564926023
<04-06>9572955720
Tab. 11.4: Percentuale di pubblicazioni INFN in collaborazionecon colleghi stranieri.
20109673936421
USAGermanyFranceSpainRussiaUKSwitzerlandJapanChina
Tab. 11.5: Percentuale di articoli co-firmati per le principali nazionicon cui l’INFN collabora.
INFN393734282625231711
CSN1808375698474734130
CSN2646456502332304111
CSN3404143253725192218
CSN51824137661248
CSN42619191610141155
lopment Framework (RDF) di Vitae (UK) (Figura11.1). RDF è un framework di sviluppo profes-sionale per pianificare, promuovere e sostenerelo sviluppo personale, professionale e di carrieradei ricercatori nelle università e negli istituti diricerca. L’INFN è stato scelto come rappresen-tante per i paesi del Mediterraneo. All'internodi ogni paese dieci ricercatori saranno selezio-nati da un’ampia gamma di esperienze, fasi dicarriera e discipline per utilizzare il frameworkRDF e fornire un riscontro sulle proprie espe-rienze personali attraverso un gruppo locale didiscussione con esperti di Vitae.Il secondo Forum dove l’INFN ha indirizzato granparte degli sforzi è quello approvato l'annoscorso dal Governing Council di ESF su "Valuta-zione: indicatori per l’internazionalizzazione"(“Evaluation: Indicators for Internationalisa-tion”). L’internazionalizzazione sta diventandoun elemento sempre più importante a causadella sua stretta relazione coi processi di globa-lizzazione, l'aumento della competitività tra ri-cercatori per i fondi di ricerca e la necessità dimigliorare la loro reputazione e visibilità. L’inter-nazionalizzazione è una caratteristica intrinsecadella ricerca che interessa tutte le disciplinescientifiche, sia pure a ritmi e passi diversi.Lo scopo è di progettare (con l'aiuto di espertidel settore) e produrre un insieme di indicatoriche potrebbero descrivere l'internazionalizza-zione delle attività europee di ricerca. Questi in-dicatori dovrebbero essere utili sia per leorganizzazioni membri (MOs), al loro interno enei loro rapporti con la Commissione Europea,sia per i governi, per il benchmarking e i criteridi valutazione. L’INFN sta portando avanti questa attività in-sieme a INRA (Francia): al Forum partecipano piùdi 30 MOs, insieme ai rappresentanti della EC edi istituzioni che non appartengono a ESF (comela NSF negli Stati Uniti). Attraverso due wor-kshop, che hanno visto le Organizzazioni affron-tare i problemi con esperti del settore –CNR-CERIS (Italia), OTKA (Ungheria) e Rathenau(Olanda) – è stato definito un elenco di indica-tori dal quale è stato selezionato un insieme piùpiccolo che attualmente viene messo in produ-zione con dati certificati. Gli esperti hanno con-tribuito a definire un quadro concettuale in cuirealizzare l'interpretazione dei risultati prove-nienti da questi indicatori. Il quadro è differenteper Enti di Ricerca o per Agenzie di Finanzia-mento, rispecchiando così la diversità degliobiettivi.
Una storia di successo ha infine coronato le atti-vità del Forum al quale storicamente l’INFN hapreso parte fin dalla sua nascita, quello sul "PeerReview”, con la pubblicazione della “Guida eu-ropea del Peer Review” (figura 11.2).Sia il settore pubblico della ricerca sia quello pri-vato, a livello nazionale e internazionale, affron-tano da sempre la sfida di valutare la qualità e ilpotenziale delle proposte di ricerca tenendo contoanche delle proprie individualità culturali e scien-tifiche. Vi è dunque la necessità di sviluppare si-stemi funzionali per tutte le organizzazionicoinvolte, riducendo al minimo l'onere per i peerstessi e massimizzando la valutazione dell'eccel-lenza scientifica. Raggiungere tale obiettivo ri-chiede la definizione di criteri comuni di qualitàpan-europea per la revisione tra pari. Criteri dipeer review sviluppati a livello europeo secondogli standard internazionali e adottati poi a livellonazionale potrebbero svolgere un ruolo fonda-mentale perché gli scienziati europei si attivino aoperare in un contesto globale.La “European Peer Review Guide” si basa su pra-tiche condivise europee e internazionali nei pro-cessi di peer review e cerca di promuovere unamisura di coerenza ed efficacia nella forma di un
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LAVALUTAZIONEINTERNA
195
Fig. 11.2: Copertina della “European Peer Review Guide“

borazioni internazionali è spesso il risultato diun lavoro collettivo e che può occupare moltotempo. Dalla lista degli autori non è poi sempliceevincere se vi siano stati contributi particolari e diquale entità da parte di singoli ricercatori. In que-ste grandi collaborazioni, a causa dell’elevatis-simo livello di competitività, non è però sempliceneppure ottenere il diritto a presentare i risultatiscientifici ad una conferenza internazionale, chepure è il modo più diretto soprattutto per i gio-vani ricercatori per farsi conoscere nel settore dicompetenza.Per cercare di comprendere quanto venga rico-nosciuto il contributo dei ricercatori INFN all’in-terno delle grandi collaborazioni di cui fannoparte si può prendere come indicatore il rap-porto tra il numero di presentazioni assegnatea loro nelle più importanti conferenze interna-zionali e confrontarlo con quello delle presenta-zioni assegnate ai ricercatori di altre nazioni.Il confronto è riportato in tabella 11.6, mediandogli anni dal 2007 al 2010, e utilizzando un insiemedi conferenze riconosciute dalla comunità inter-nazionale delle tre linee CSN1, CSN2 e CSN3 (eche si tengano con cadenza regolare), normaliz-zando poi il numero di presentazioni alla dimen-sione delle comunità scientifiche di ognuna dellenazioni considerate.
Il risultato mostra che i ricercatori INFN sono par-ticolarmente apprezzati e che l’attività di edu-care, istruire e inserire i giovani nell’ambientescientifico dei grandi esperimenti permette al-l’Istituto di creare una robusta generazione discienziati che saranno gli attori degli sviluppi edelle scoperte future.
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LAVALUTAZIONEINTERNA
198
CSN1CSN2CSN3
Germany101314
France778
UK1034
USA292724
Japan4118
Tab. 11.6: Percentuale di presentazioni a conferenza da parte diricercatori di varie nazioni.
Italy131110
pro duzione INFN (che ammonta a circa 2500pubblicazioni l'anno) si sviluppa su oltre 400pe riodici internazionali, dove i primi dieci inte-grano circa il 40% delle pubblicazioni totali.Ci si può porre la questione della rilevanza diquesti documenti, in particolare in connes-sione con le esigenze derivanti dall'imminenteesercizio di valutazione VQR da parte del Mi-nistero.Dal momento che buona parte della valuta-zione verrà eseguita utlizzando indicatori bi-bliometrici, capire il posizionamento degliarticoli INFN rispetto ad opportune medieprese sull’insieme dei documenti pubblicati inuna rivista specifica può aiutare a valutare laqualità della produzione scientifica dell'INFN.
Un possibile indicatore confronta il numero dicitazioni integrato (fino alla fine del 2010) daarticoli pubblicati con affiliazione INFN sulla ri-vista J nell'anno Y, con il numero medio di ci-tazioni calcolato su tutti i documenti pubblicatisulla stessa rivista nello stesso anno.Nella figura 11.3 questo confronto viene mo-strato per due delle principali riviste dovel’INFN pubblica, Physical Review D e NuclearPhysics B. Il risultato per gli articoli INFN è cer-tamente incoraggiante.
Per avere un'immagine più globale si può con-siderare la media delle stesse quantità su dueperiodi, 2004-2006 e 2007-2009, insieme conil valore estratto nel 2010 (quest’ultimo notocome "Immediacy Index" in ISI) per una serie diriviste rappresentative prese tra i "top ten" dellepubblicazioni INFNI risultati sono mostrati in Figura 11.4 come rap-porto (INFN/Tutti) tra il numero medio di citazioniper pubblicazioni INFN e le medie complessive: irisultati sembrano dimostrare un comporta-mento molto buono per le pubblicazioni INFN,che si collocano quasi sempre al di sopra del nu-mero medio di citazioni. Sembra inoltre chemuovendosi verso anni recenti il divario positivotra i documenti dell'INFN e la produzione globalesia in aumento. Ciò potrebbe essere interpretatocome un segno del contenuto innovativo degliarticoli INFN, che sono immediatamente citati erimangono sulla scena per alcuni anni, prima diessere nuovamente superati da altri documentiscritti da altri ricercatori INFN.Non ci si aspetta ovviamente che la situazionesia la stessa per ogni rivista, quindi un’indaginepiù completa è attualmente in corso e serviràcome input fondamentale nel processo decisio-nale per la VQR 2004-2010.La pubblicazione di un articolo in grandi colla-
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ LAVALUTAZIONEINTERNA
197
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0.00
Fig. 11.3: Media delle citazioni fino a fine 2010 per articoli pubblicatinegli anni 2004-2010 su Physical Review D (sinistra) e Nuclear PhysicsB (destra). Le pubblicazioni INFN sono in bianco, le globali in azzurro
2004 201020072005 2006 2008 2009
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0.002004 201020072005 2006 2008 2009
INFN Altri
INFN Altri
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40NPB NIMBPLBPRL PRD PRC EPJC
Fig. 11.4: Rapporto (INFN/Tutti) della media delle citazioni in diversiintervalli temporali e per alcune riviste rappresentative
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00NPB NIMBPLBPRL PRD PRC EPJC
2007-200 2004-200
2010

INDICE DELLE FIGURE E DELLE TABELLECREDITI ICONOGRAFICI

PIANOTRIENNALE2012-14/ IN
DICEDELLE
FIGUREEDELLE
TABELLE
202
PIANOTRIENNALE2012-14/ IN
DICEDELLE
FIGUREEDELLE
TABELLE
201
Fig.2.1
Fig.2.2Fig.2.3Fig.2.4Fig.2.5Fig.2.6Fig.2.7Fig.2.8Fig.2.9Fig.2.10Fig.2.11Tab.2.1Fig.2.12Fig.2.13
Tab.3.1Fig.3.2
Fig.3.3
Fig.3.4
Fig.3.5
Fig.3.6Fig.3.7Fig.3.8
Fig.3.9Fig.3.10Tab.3.2Fig.3.11
Tab.3.3Fig.3.12
Fig.3.13
Fig.3.14
Tab.3.4Tab.3.5Fig.3.15Fig.3.16Tab.3.6Fig.3.17
Fig.3.18
Tab.3.7Tab.3.8Tab.3.9Fig.3.19Fig.3.20Tab.3.10Tab.3.11Fig.3.21Tab.3.12Tab.3.13Tab.3.14
8
891010101112131415161719
2626
27
27
31
313132
32323436
3638
39
43
444444484951
55
5657575959606163636464
Le strutture dell’INFN. In blu le Sezioni, in grigio i Gruppi collegati, in rosso i Laboratori Nazionali, in verde ilCentro Nazionale per Ricerca e Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche.L’organizzazione manageriale e scientifica dell’INFN secondo il nuovo Statuto.La composizione dell’Universo.La costituzione della materia e la connessione microcosmo-macrocosmo.L’evoluzione dell’Universo.Le particelle fondamentali del Modello Standard.Le interazioni fondamentali e i loro mediatori.L’anello di 27 km del Large Hadron Collider (LHC) al CERN di Ginevra.L“Unificazione” delle forze.L’Interferometro per onde gravitazionali Virgo, nella pianura di Cascina (PI).Ricadute tecnologiche dello sviluppo degli acceleratori di particelle.Principali filoni scientifici e luoghi di ricercaIn rosso, partecipazione delle strutture INFN alla sperimentazione a LHC in ATLAS, CMS, ALICE E LHCb.Evoluzione della frontiera dell’energia per gli acceleratori di particelle.
Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN1.Risultati dell'esperimento CMS sulla ricerca del bosone di Higgs. In funzione della massa del bosone di Higgsviene mostrato il limite al 95% di livello di confidenza sulla sezione d'urto di produzione normalizzato allasezione d'urto attesa dal Modello Standard; valori inferiori a 1 escludono l'esistenza del bosone di Higgs aquella massa con questo livello di confidenza (CERN, 13 dicembre, 2011).Limiti alla massa di squarks e gluini ottenuti dall’esperimento ATLAS (linea arancione) confrontati con i pre-cedenti risultati ottenuti a LEP e al Tevatron (CDF e D0) (HCP, Parigi, Novembre 2011).Misura della differenza di larghezza e della fase di mixing del mesone Bs a LHCb confrontata con i precedentirisultati ottenuti al Tevatron (HCP, Parigi, Novembre 2011).Prima evidenza dell’oscillazione dei neutrini νμ→νe, osservata in Giappone dall'esperimento T2K che vedela partecipazione dell’INFN.Crescita del valore di luminosità integrata di CNGS dal 2008 al 2011.Interazione di un νμ del CNGS osservata dal rivelatore ICARUS al LNGS.Spettro del flusso di protoni e nuclei di elio cosmici, registrato dall’esperimento satellitare PAMELA - in orbitadal Giugno 2006.L’esperimento AMS-02, installato sulla Stazione Spaziale Internazionale nel Maggio 2011.Anisotropia nei raggi cosmici a energie dell’ordine del TeV, osservata dall’esperimento ARGO, in Tibet.Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN2.La carta dei nuclei con indicati i diversi modelli e le loro regioni di applicazione, a partire dalla struttura delnucleone fino alla struttura dei nuclei più complessi.Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN3.Alcuni tra i risultati più interessanti ottenuti da ALICE nel 2011 in interazioni centrali Pb-Pb a 2.76 TeV/nu-cleone. A sinistra (in alto) è mostrata la densità di particelle cariche in funzione della centralità (Phys. Rev.Lett. 106, 032301 (2011)); il grafico di sinistra (in basso) mostra i risultati dell’analisi delle correlazioni HBT:prodotto Rout*Rside*Rlong per kT=0.3 GeV/c (Phys. Lett. B 696 (2011) 328); in entrambi i grafici i risultatidi ALICE sono paragonati con misure a energie inferiori. A destra sono mostrate le misure del flusso di par-ticelle cariche in termini di v2, v3, v4, e v5 in funzione del momento trasverso per tre differenti intervalli dicentralità.Il dimostratore del rivelatore AGATA, che usa la tecnica del tracciamento dell’interazione gamma con la ma-teria, montato ai Laboratori Nazionali di Legnaro.Rappresentazione schematica di un "brane-world", con stringhe (aperte o chiuse) e dimensioni extra (da undisegno del Cern Courier).Distribuzione percentuale degli FTE e numero di Iniziative Specifiche nelle sei Linee Scientifiche della CSN4.Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN4.La sede del Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics ad Arcetri (FI).Immagine tomografica di un fantoccio ottenuta da PRIMA+.Composizione, risorse finanziarie e investimenti per la CSN5.La rete planetaria GRID unisce e utilizza contemporaneamente la potenza di calcolo e la memoria di decinedi migliaia di computer.Schema di IFMIF-EVEDA, il prototipo di acceleratore di deutoni ad altissima intensità per lo studio dei materialiper la produzione di energia da fusione nucleare.Applicazioni delle macchine acceleratrici a uso scientifico.TClassificazione delle ricerche svolte nel progetto strategico NTA.Problematiche e possibili applicazioni studiate in NTA.Schede apeNEXT+.Progetto QUOnG: CPU+GPU con apeNET+.Caratteristiche dei sistemi multi-processore.Finanziamenti del progetto APE.Collaborazione SPES.Costo complessivo delle fasi di realizzazione del progetto SPES.Costo annuo previsto per la realizzazione di ciascun progetto nel triennio 2012-2014.Obiettivi generali (milestones) realizzabili nel triennio per i progetti più rilevanti.
Fig.3.22Fig.3.23aFig.3.23bTab.3.15Fig.3.24Fig.3.25Tab.3.16Fig.3.26
Fig.3.27Fig.3.28Fig.3.29Fig.3.30Fig.3.31
Fig.4.1Fig.4.2Fig.4.3Fig.4.4
Fig.4.5Fig.4.6Fig.4.7Fig.4.8Fig.4.9Fig.4.10Fig.4.11Fig.4.12Fig.4.13Fig.4.14Fig.4.15Fig.4.16Fig.4.17Fig.4.18Fig.4.19Fig.4.20Fig.4.21Fig.4.22a,bFig.4.23Fig.4.24Tab.4.1Fig.4.25Fig.4.26Fig.4.27Fig.4.28Fig.4.29Fig.4.30Fig.4.31Tab.4.2Tab.4.3Tab.4.4
Tab.4.5Tab.4.6Tab.4.7Tab.4.8Tab.4.9Tab.4.10
Tab.5.1Tab.5.2Tab.5.3Tab.5.4Tab.5.5Tab.5.6Tab.5.7Tab.5.8Tab.5.9
6565656771717275
7979797979
90909191
93939595969798105105106106107107108108108108109109110112112115116119119119119121124125
126126126126127127
133133133133133134134134140
Isometrico laboratorio Ciclotrone e layout di trasferimento e selezione del fascio esotico.Sistema ISOL installato a LNL.Ferro del magnete dopo la forgiatura.Tabella riassuntiva – Progetto SPES.Progetti presentati nelle varie tipologie.Tasso di successo nelle varie tipologie.Progetti INFN nelle infrastrutture di ricerca.Analisi di composizione dei pigmenti su una tela del Mantegna alla facility di microfascio esterno a scansionedel Laboratorio per i Beni Culturali di Firenze (LABEC).Controllo dei tumori radio resistenti con ioni di carbonio.Schema del complesso di acceleratori del CNAO e delle linee di trattamento.Vista del sincrotrone.Sala di trattamento (in allestimento).Vista aerea del centro CNAO a Pavia.
Complesso degli acceleratori DAFNE e dei laboratori di luce di sincrotrone.Sala sperimentale dell’acceleratore SPARC. Sono visibili, in primo piano, gli ondulatori.Tipica misura dello spettro FEL in regime di Singola Spike (a) e confronto con le simulazioni (b).Immagine del treno di impulsi prodotto con la tecnica Laser Comb. Sono visibili 4 impulsi da 200 pC in 200fs di lunghezza rms, separati da 1 ps.Microtomografia computerizzata realizzata a X Lab Frascati.Schema delle linee sperimentali di SPARC_LAB.Veduta dei Laboratori esterni del Gran Sasso.layout dei laboratori sotterranei.Gallerie sotterranee dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.L’esperimento Borexino per la rivelazione dei neutrini, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso.Il sistema di criogenia dell’esperimento ICARUS per la rivelazione dei neutrini, ai Laboratori del Gran Sasso.Vista aerea dei Laboratori Nazionali di Legnaro.Risultati recenti di FAZIA.Front-end del bersaglio ISOL.Il modello in alluminio, scala 1:1, dell’acceleratore Fig. 4.12: Front-end del bersaglio ISOL. RFQ per IFMIF.La nuova sorgente ECR.Schema di NBTF.Laboratori Nazionali del Sud.L’acceleratore Tandem Van De Graaff da 15 MV dei Laboratori Nazionali del Sud.Il Ciclotrone Superconduttore K800 (vista dell’esterno).Il Ciclotrone Superconduttore K800 (vista dell’interno).Vista esterna e vista interna del rivelatore di particelle cariche CHIMERA ai Laboratori Nazionali del Sud.Lo spettrometro magnetico MAGNEX ai Laboratori Nazionali del Sud.Particolare della linea di fascio CATANA per la terapia del melanoma oculare.Il piano di sviluppo delle risorse al Tier1.Utilizzo delle risorse di calcolo del Tier1.Caratteristiche spettrali della luce di sinctrotrone prodotta in SuperB nei magneti di piegatura e negli ondulatori.Schema del collisore elettrone-positrone Super-B.Visione artistica della torre di KM3NeT.Schema di posizionamento del cavo sottomarino nel sito di Capo Passero.Foto scattata durante le operazioni di connessione della torre al box di alimentazione alla profondità di 2000 m.Deployment di un prototipo meccanico della torre NEMO.Partecipazione dei paesi in % del budget FP allocato (con l’esclusione di DANTE).Scaletta temporale del progetto SuperB e stima dei costi.Risorse finanziarie totali richieste su un decennio, relative ai sei anni di costruzione e ai successivi di operazionedell’infrastruttura SuperB (in milioni di euro).Scala temporale del progetto.Flusso di spesa.Scala temporale del progetto KM3NeT.Flusso di spesa del progetto KM3NeT.Personale necessario a regime per realizzare gli obiettivi delle unità operative di IGI.Costi di IGI (K€), suddivisi per anno.
Convenzioni con le Università.Convenzioni con Enti Pubblici di Ricerca.Convenzioni con altri Enti.Convenzioni/Rapporti Enti Locali.Medicina.Beni culturali.GRID - ICT.Formazione diffusione Cultura Scientifica.Accordi Internazionali.

PIANOTRIENNALE2012-14/ C
REDITIICONOGRAFIC
I
204
PIANOTRIENNALE2012-14/ IN
DICEDELLE
FIGUREEDELLE
TABELLE
203
p. 1 © CERNp. 5 © CERN/ CMS Collaborationp. 8, 9, 10, 11, 13 © INFNp. 12 © CERNp. 14 © EGO/ Virgop. 15 © Asimmetrie/INFNp. 17 © INFNp. 19 © Asimmetrie/INFNp. 21 © CERN/ CMS Collaborationp. 26, 27 © INFNp. 31 © INFN/Lngsp. 32 © Pamela Collaboration, © Lmes, Lockeed Martin Engeneering Systems p. 32 © INFN/Argop. 36 © INFNp. 38 © INFN/Alicep. 39 © INFN/Agatap. 43 © CERNp. 44 © GGI, Galileo Galilei Institutep. 48 © INFNp. 51 © INFN/Centimetrip. 55 © INFN, CEA, JAEA/ Ifmifp. 59 © INFN/Apep. 63, 65 © INFN/SPESp. 75 © INFN/Labecp. 79 © INFN/Cnaop. 87 © INFN/Lngsp. 90, 91, 93 © INFN/Lnfp. 95, 97 © INFN/Lngsp. 96, 98 © INFN/Simone Schiavonp. 105, 106, 107 © INFN/Lnlp. 108, 109, 110 © INFN/Lnsp. 112 © INFN/Cnafp. 116 © INFN/Centimetrip. 119 © INFN/Nemop. 129 © NASAp. 141 © INFNp. 169 © INFN/UffComp. 171, 172,175, 176 © INFN/UffCom p. 173 © Asimmetrie/INFNp. 179 © INFN
Tab.6.1Tab.6.2Tab.6.3
Tab.7.1aTab.7.1bFig.7.1Tab.7.2,7.3aTab.7.3bTab.7.4
Tab.7.5Fig.7.2aFig.7.2bTab.7.6Tab.7.7Tab.7.8Tab.7.9Fig.7.3Fig.7.4Fig.7.5Tab.7.10Fig.7.6Fig.7.7Fig.7.8
Fig.8.1
Fig.8.2
Fig.8.3Fig.8.4
Fig.8.5Fig.8.6
Tab.11.1Tab.11.2Tab.11.3Fig.11.1Fig.11.2Tab.11.4Tab.11.5Fig.11.3
Fig.11.4Tab.11.6
143144144
149149150152153153
154157157158159159159162162163163163165165
171
172
173174
175176
192192193194195196196197
197198
Sezioni e gruppi collegati INFN.Laureati magistrali e dottorati che hanno svolto attività in ambito INFN, rispetto ai dati totali MIUR.Supporto alla didattica.
Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dei costi relativi, al 31 dicembre 2011.Distribuzione del personale dipendente a tempo determinato e dei costi relativi, al 31 dicembre 2011.Evoluzione temporale della pianta organica e del personale dipendente in servizio.Programmazione delle assunzioni per gli anni 2012, 2013.Programmazione delle assunzioni per gli anni 2014.Numero di posti a concorso per il triennio 2012-2014, per le progressioni economiche e i passaggi a livellosuperiore per il personale tecnico-amministrativo.”Coefficienti per un sistema unico di prezzi riferito all’anno 2010 (Fonte: ISTAT).Evoluzione temporale del personale dipendente a tempo determinato, indeterminato e associato.Evoluzione temporale del numero di dipendenti per “area di impiego”.Profilo di spesa per Ricerca, Personale, Funzionamento, Attrezzature e Servizi.Coefficienti per un sistema unico di prezzi riferito all’anno 2010 (Fonte ISTAT).Profilo di spesa relativo al triennio 2012-2014.Distribuzione del personale associato all’INFN al 31-12-2011.Distribuzione del personale assunto a tempo indeterminato nei diversi profili, separatamente per donne e uomini.Distribuzione del personale per fasce di età, separatamente per donne e uomini, nei diversi profili.Numero di laureandi, dottorandi e assegnisti associati all’INFN, separatamente per donne e uomini (dati 2011).Frazione di donne nelle differenti commissioni scientifiche nazionali, dati dei consuntivi scientifici 2010.Personale universitario a tempo indeterminato con associazioni scientifica, separatamente per donne e uomini.Ricercatori stranieri ospiti presso strutture INFN (FAI) nel 2010 per un totale di 447.Accordi bilaterali in vigore per scambi borsisti.
Installazione di video-arte alla mostra l’’Universo non è più quello di una volta” allestita nell’Ottobre 2011 a Palazzodella Meridiana, Palazzo Ducale e Biblioteca Universitaria di Genova in occasione del Festival della Scienza 2011.Installazioni multimediali alla mostra “Estremo” allestita per la prima volta a Bologna nel Febbraio 2011 inoccasione della manifestazione “Arte e Scienza in piazza”.Le copertine dei numeri 11 e 12 della rivista Asimmetrie.Modellino in scala reale del rivelatore AdA di Frascati (1962) e sefra armillare di Geronimo della Vulparia(1575), esposti nel Maggio 2011 nella sede dell’OMPI a Ginevra, in occasione della mostra ‘’An Italian Historyof Innovation”.Locandine e brochure delle mostre e allestimenti realizzati nel corso del 2011.Un’immagine dell’evento-incontro “Lo strano mondo di LHC” che si è svolto a Dicembre 2011 al MuseoNazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.
Produttività scientifica INFN.Alcuni indicatori di produttività scientifica INFN.Indicatori di performance per le Collaborazioni e i Gruppi di ricerca.Il Research Development Framework (RDF) strutturato nei quattro domini.Copertina della “European Peer Review Guide”.Percentuale di pubblicazioni INFN in collaborazione con colleghi stranieri.Percentuale di articoli co-firmati per le principali nazioni con cui l’INFN collabora.Media delle citazioni fino a fine 2010 per articoli pubblicati negli anni 2004-2010 su Physical Review D (sini-stra) e Nuclear Physics B (destra). Le pubblicazioni INFN sono in rosso, le globali in blu.Rapporto (INFN/Tutti) della media delle citazioni in diversi intervalli temporali e per alcune riviste rappresentative.Percentuale di presentazioni a conferenza da parte di ricercatori di varie nazioni.

APPENDICE

PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
210
1 Executive Summary
This year the CVI had its annual meeting in the National Laboratory of Leg-
naro (LNL). With this meeting we concluded our visits to all four NationalLaboratories and we have a complete picture of the activities of the Insti-tute at both National and International levels. As usual, we reviewed theentire spectrum of INFN performances, scientific, technical and educational,including their socio-economical impact.
• All four Laboratories present a rich research programme, often withimportant projects designed or under construction. The CVI was pleased tosee that in the LNL SPES is progressing according to schedule.
• Before presenting our conclusions we want to emphasise that this was aremarkable year for the activities of the Institute. On the international scenethe year is marked by the excellent performance of the LHC, both the colliderand the detectors, and the shutdown of the Tevatron. The accumulated lu-minosity in every experiment at LHC goes beyond all expectations and thisis expected to continue next year. At the domestic front we witnessed theimportant decision by the Italian Government to approve the establishmentof the Nicola Cabibbo Laboratory and to finance the construction of thesuper-B factory. Both present great opportunities, but also enormous chal-lenges, for INFN. The CVI is confident that they will be successfully metand that they will lead to exciting new Physics and fundamental discoveries.
• Based on all available input, supplemented with our own expertise, wecame to the conclusion that, again this year, INFN, as an Institution,remains at a very high level of scientific and technological ex-cellence and compares favourably with similar Institutions worldwide. Italian teams play often a leading role in international collaborationsand the Italian School of Particle, Nuclear and Astro-Particle Physics is oneof the best in Europe. This excellence has been maintained in spite of thecontinuing difficult situation of the Institute as regards its financial and hu-man resources. The scientific programme remains at a very high level withmany important experiments presenting their final results, running or beingprepared. Furthermore, the performances of the Institute in the fields ofeducation, the dissemination of scientific knowledge, as well as its efforts forthe transfer of front-line technology to industry, are truly exceptional.
• A milestone for the Institute is marked by the approval of the super-Bproject. The CVI fully agrees with the Management’s decision to establish
2
INFN CVI Report 2011
Conclusions of the CVI Meeting on 11-12 October 2011
Members of the CVI Panel:
N. Amodio, Confindustria, Italy (through a teleconference)P. Drell, SLAC, USAE. Fernandez, IFAE, SpainA. Frey, University of Gottingen, GermanyM.N. Harakeh, KVI Groningen, The NetherlandsF. Iachello, Yale University, USAJ. Iliopoulos, LPTENS, Paris, France (Chair)E. Zaninotto, Universita di Trento, Italy
November 5 2011
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
209

PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
212
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
211
a Consortium, with a well separated budget, which will be in charge of theproject’s realisation. This structure should be maintained. It is particularlyappropriate to the attraction of new national and international partnerswhich will allow a speedy completion and meet foreign competition.
• The President presented a clear picture of the global situation of theInstitute. The CVI was surprised to hear that, due to an incredible admin-istrative blunder, a substantial percentage of the budget, the one which isbased on performance, was not given to the Institute for this year. Thiscame in addition to the severe budget cuts accumulated over many yearswhich had already put the Institute under severe stress. It resulted intoa nearly catastrophic situation, forcing the Directorate to act in an emer-gency, engage all the reserves and redirect funds initially marked for newprojects. This situation cannot perdure. The CVI hopes that this errorwill be soon corrected and the lost budget will be fully recovered. This willnot solve the financial problems of the Institute, it will merely change themfrom catastrophic to critical. In the President’s report we see that, since2001, the budget of INFN, independently of this year’s error, has decreasedeffectively by 15.3%. This amounts to a cumulative loss of more than oneyear’s income. To maintain in the long term INFN’s competitive positionin the international scene, a reversal of the recent tendency of constantlydiminishing budget is urgently needed. An equally critical point is thatof human resources. The brain drain, which we have signalled in our lastyear’s report, continues due to the absence of promising career opportunitiesin the Italian Universities and Research Centres. Many among the brightestyoung Italian physicists, who have received an excellent training followingthe programmes sponsored by INFN, leave the country.
• The in-depth evaluation of all research Institutions (V.Q.R.), now span-ning seven years, from 2004 to 2010, which was announced last year, entersits final phase of application. Although the reservations which we had ex-pressed in our previous report concerning the inadequacy of the rules toan Institute like INFN, with such a broad spectrum of activities and largeinternational collaborations, still remain valid, we are confident that the In-stitute will rank among the very best in the country. We hope that thiswill be reflected into a substantial increase in its resources. The CVI hasreviewed and approves the material which the Directorate will present tothe evaluation committee.
• The new rules of Governance, which will be completed by the appoint-ment of a Director for the Administration, are already in place. The CVI
3
expects that they will contribute to easing the administrative burden fromthe Board of Directors which will have more time to concentrate on issuesof scientific strategy.
• The CVI meeting coincided with the change in the Presidency of theInstitute. We wish to express our deepest appreciation to Professor RobertoPetronzio for his inspired and successful leadership during all these years ofgreat economic stress, but also years of new and exciting scientific achieve-ments. We congratulate Professor Fernando Ferroni for his appointmentand we wish him great success in his mission. He can count on our support.
4

The super-B project was approved this year. The CVI was impressed bythis decision of the Italian Government in spite the current difficult financialconditions. For the realisation of this project, new resources have beenallocated and a multi-year funding scheme has been established. It willpresent an enormous challenge for the entire Particle Physics communityin Italy, both at the technical as well as the organisational level. Sinceit is planned to operate as an international facility, the CVI approves theManagement’s decision to establish a separate Consortium. Although atransfer of resources at the level of technical expertise, from INFN to thenew entity, should take place, the CVI strongly advises to keep the twobudgets strictly separated. As the project advances, a process of establishingpriorities should be initiated and the CVI wishes to receive a report on thisissue during its next meeting.
In view of the expected competition with the Japanese project, the timeelement will be of the utmost importance. The Italian Super-B will betechnically superior offering better Physics possibilities, nevertheless its dis-covery potential will decrease if it arrives too late. The possibility of runningas a new state-of-the-art light source is certainly interesting, but it shouldnot result into the transfer of already scarce resources from Particle Physicsto other fields.
The field of Astroparticle Physics in INFN presents a very large varietywith many experiments covering a wide range of subjects. The undergroundlaboratory at Gran Sasso is a world class facility attracting scientists notonly from Italy but from many other countries as well. In addition a greatactivity is being developed in space based experiments, cosmic ray studies,gravitational wave antennas and R&D towards the construction of an un-derwater neutrino detector. All these activities are producing, or promiseto produce, exciting physics results and the CVI worries whether the dimin-ishing resources will allow INFN to make significant advances to all thesefronts.
.
Our visit at LNL gave us the opportunity to have a detailed view of theINFN commitment in Experimental Nuclear Physics. It is the main researchactivity of the Laboratory which attracts many collaborators from Italian, aswell as European, Universities. The star project of LNL is the constructionof the SPES facility which is under way and proceeds on schedule. Togetherwith the radioactive beams it will assure a prominent position of LNL in theEuropean Nuclear Physics landscape.
6
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
214
2 INFN Achievements and Perspectives
This report is based on several input elements:(i) A document on the INFN Scientific Productivity and its Socio-Economic
and Inter-Disciplinary Impact , which we received before the meeting, offer-ing a valuable picture of the profile of the Institute.
(ii) A detailed presentation on the scientific programme of the NationalLaboratory of Legnaro followed by a visit of the facilities.
(iii) The report presented by the INFN President on the scientific andtechnical activities, as well as the questions related to the resources (financialand personnel).
(iv) The comprehensive presentations covering each one of the five sec-tions, as well as the super-B project and a specialised one on the socio-economical impact.
(v) Our own expertise which covers essentially the entire spectrum ofthe INFN activities.
In the following sections we shall review each one of the scientific andtechnical sections of the Institute and we shall highlight the achievementsas well as the difficulties. Here we give a summary of the main conclusions.
As it was the case in previous years, the overall picture is one of prolificactivity combined with scientific excellence. All sections remain at the fron-tier of modern research. In all fields the contribution of the Italian teamsis remarkable, both in the domestic laboratories as well as inside the largeinternational collaborations.
During the last year the Physics of Elementary Particles was dominatedby the long awaited outstanding performance of the Large Hadron Col-lider. All experiments collected a wealth of data beyond expectations. Wehad been through many lean years in Particle Physics and we cannot hideour enthusiasm with the perspective of fundamental discoveries. Since ourmeeting, the first glimpse of a Higgs signal was announced, adding to the ex-citement. INFN physicists had played a major role in the preparation of allimportant experiments and this is recognised by the international commu-nity since the spokespersons of all four major LHC experiments are Italians.LHC is scheduled to continue running during 2012 before a long shutdownfor technical consolidation in the perspective of reaching the designed energyof 14 TeV and luminosity of 1034.
The Tevatron terminated its operation and left a rich harvest of datawhich is still being analysed. In addition the results from the flavour physicsexperiments are in the final phase of publication.
5
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
213

try. All the enormous effort developed by INFN in the training of youngresearchers, which has created one of the best Schools of High Energy andNuclear Physics in the world, profits almost entirely foreign countries. It isincredible how much harm a blind across-the-board cut can cause with solittle effect on public finances.
During our meeting we have reviewed the material which the Instituteintends to present for the seven-year evaluation (VQR). The CVI approvesthe choices of the Direction and we are confident that the evaluation willconfirm INFN’s position as the leading Research Institute in the country.
As with previous years, the GLV report contained an important sectionon the socio-economic activities of the Institute as well as its educationalrole. The CVI judges the Institute in both these areas excellent. In contrast,we lack precise quantitative information on the impact and the results of theTechnology Transfer policy and, as a result, the CVI expresses its difficultyin judging the efficacy of the INFN Technology Transfer activities in 2010.Some practical recommendations to improve this situation are outlined in aspecial section below.
3 CSN1: Experimental Particle Physics with Ac-
celerators
3.1 Physics results
During 2011, the majority of manpower and resources in CSN1 was com-mitted to the LHC experiments, ATLAS, CMS, LHCb and the dedicatedforward physics experiments LHCf and TOTEM. The LHC accelerator hasbeen run very successfully and more than 5 fb-1 of integrated luminosityhave been delivered to the ATLAS and CMS experiments, more than 1 fb-1to LHCb. A successful heavy ion run completed the data taking. WhileATLAS and CMS provided numerous measurements on Standard Modelphysics as well as setting limits on supersymmetry, LHCb is quickly takingthe lead in heavy flavour physics, for instance with the best limit on theBs → µµ branching fraction. Since our meeting the wealth of new resultshas been completed with a most tantalising possible Higgs signal around 125GeV. Fortunately, the long shutdown of the accelerator has been postponedto 2013, so new exciting results are expected for 2012.
The harvest of results from experiments that are no longer taking datarightfully continues. The Tevatron stopped its successful long running period
8
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
216
In our previous reports we had often expressed our appreciation for theItalian School of Theoretical Physics. It remains at the highest level andcovers a large variety of fields from mathematical physics to phenomenology.In some of these areas, as for example, in the physics of disordered systems,or that of Elementary Particles, it is one of the best in the world. We werepleased to learn this year that a cluster computing facility has been installedin Pisa to allow for large scale numerical simulations. Although it is not asubstitute for the state-of-the-art super-computer system whose absence wedeplored last year, it will allow some groups to remain competitive.
The Galileo Galilei Institute continues to be a success story with nu-merous high level research workshops and training schools being organisedevery year.
In each one of our reports in recent years we have repeatedly presentedgraphs showing the constant decrease of the INFN budget. In our last year’sreport we showed the loss of budget in real terms, i.e. at constant 2009prices. No improvement seems to come. In addition this year, as a resultof an unfortunate mistake in the application of an administrative rule, theInstitute lost a substantial part of its budget, the one which is linked toperformance. We emphasise that this loss is not due to an evaluation whichfound INFN un-performing, but to a mere mechanical change in the rules.We assume that it was not meant to penalise the Institute and we expectthis part of the budget to be restored. This restoration should occur veryrapidly for the dammage to be repaired.
Independently of this blunder, the constant pauperisation of the Insti-tute cannot continue indefinitely and requires drastic measures in all fronts.First, no effort should be spared to recover, at least partly, the lost budget.The very capacity of the Institute to continue its performance or to launchnew initiatives is at stake. Second, the decision making process should berevised. Looking at the budget evolution of the various Sections, we seethat the cuts were almost equally distributed among them. This uniformpolicy cannot be sustained and the CVI encourages the Direction to elabo-rate a long term strategy and establish priorities, both among the scientificSections as well as inside each one of them.
An even more critical and recurrent problem is that of human resources.The absence of new recruitments at all levels, both in the INFN person-nel, as well as the associated Universities, has already caused irreparabledamage to all Italian science. The absence of career opportunities forcesthe most talented among the young Italian physicists to leave the coun-
7
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
215

science area.The project has been moving quickly since approval, with a site compe-
tition resulting in the selection of the Tor Vergata site next to the INFN lab-oratory at Frascati. The development of a governance structure has started.While INFN was the host to start the project, the Super-B project has nowmoved outside of INFN and is managed by a consortium made up of Uni-versity and INFN partners. The Cabibbo Laboratory, which will host theproject, has been founded and a director general will be appointed and adirectorate formed by the end of the year 2011. The goal is that CabibboLab will be eventually managed as a European Research Infrastructure Con-sortium (ERIC). The definition of the work packages and responsibilities forthe project is underway. Negotiations with foreign partners are starting.
The funding for Super-B, as a flagship project of the Italian government,will not come from the normal Particle Physics budget, but from specific al-locations of the Italian Government. Of the roughly 500ME needed to buildthe project, it is anticipated that 100ME will come from foreign partnersand roughly 15ME/year will come in co-financing from INFN. The projectis in the process of developing a detailed project cost and schedule that canbe reviewed by external experts for validation. We believe this is a very im-portant step to establish the credibility of the project time line and sciencedelivery.
As the time schedule for the planned Super-KEKB upgrade at KEK/Japanis not so different with a start-up in late 2015, the fruitful and healthy com-petition between the B factories will open a new chapter in this decade.The Super B project has additional advantages in the unique possibilities ofbeam polarisation and of running at the tau/charm threshold.
4 CSN2: Astroparticle Physics
The Astroparticle Physics area includes several distinct activities, distributedin six sectors, namely i) Neutrino Physics using both accelerator-producedbeams and natural neutrino sources, ii) Searches for Rare Processes, such asneutrinoless double-beta decay and direct dark-matter detection, iii) Studyof Cosmic Rays in Ground-Based Detectors, including cosmic neutrinos withunderwater detectors, iv) Study of Cosmic Rays in Space, v) Search forGravitational Waves, both in ground- and space-based detectors, and vi)General Physics, mainly gravity and quantum vacuum studies. The numberof personnel in CSN-2 has been stable during the last few years, with 650FTE (about 820 persons) in 2010, only second in size to CSN-1 among the
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
218
finally in 2011, with many publications still forthcoming. BaBar and ZEUSare finalising their analyses. In the flavour sector, in addition to LHCb andthe Super-B preparation, INFN owns a world-class facility with the soonupgraded DAFNE machine and the KLOE experiment. INFN also playsimportant roles in the construction of NA62 as well as BES-III. The searchfor lepton flavour violation continued at MEG, the collaboration presenteda new measurement and rules out LFV at a limit of 10−12.
Excellent R&D contributions for future experimentation have alwaysbeen a strong asset in INFN’s outstanding and varied research program.The CVI is impressed by the near future perspectives, namely the upgradeprograms of ATLAS, CMS and LHCb, a planned upgrade of the MEG ex-periment, resulting in an improved sensitivity by two orders of magnitude,the planned Mu2E experiment at Fermilab, an upgrade of COMPASS as wellthe UA9 R&D effort that is looking into beam bending with crystals. Whileall these proposals offer excellent scientific prospects, INFN with its limitedbudget will clearly have to make choices, in particular in light of Super-B.The CVI encourages strongly a long-term strategic planning study, in orderto maintain INFNs very strong position in the research covered by CSN1.
As emphasised in last years report, the visibility of INFN physicists inthe competitive LHC environment is outstanding (e.g. spokespersons of allfour large LHC experiments are Italians), underlining the appreciation bythe particle physics community of the excellent contributions to the detectorhardware, commissioning and physics analyses.
3.2 The super-B project
A most significant event in the past year, impacting INFN as a whole andCSN1 in particular, was the approval of the flagship project Super-B bythe Italian Ministry of Research and Education in April 2011. A financialallocation of 250 Million Euro for the superb flavour factory has been madewith 19ME allocated in 2010 and another 40ME expected for 2011. It isa triumph for INFN that the project has been approved. The outgoingINFN President should be commended for his dedicated efforts to securethis project.
The Super-B project builds on the successful operations of the first gener-ation B-factories (the BaBar detector operating at PEP-II in the US and theBelle detector operating at KEK-B in Japan) to develop a versatile flavourphysics experiment that can probe new physics observables in a wide rangeof heavy flavour decays. If the facility performs as claimed within the time-frame outlined, it will deliver world leading capability in this important
9
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
217

In the study of gravitational waves Italy hosts one of the more advanceddetectors in the world, the VIRGO interferometer located near Pisa, whichis now being upgraded to Advanced Virgo. This improvement will multiplyby 1000 the effective volume explored. The AURIGA and Nautilus anten-nas will also continue operations. The INFN is also involved in the LISAPathfinder mission, and in the LISA studies.
Overall the INFN contribution to the field of Astroparticle Physics isimpressive. In some areas, some of the leading experiments in the world arelocated in Italy, namely at the LNGS, and this attracts a large internationalcommunity to collaborate with the Italian groups. The Committee notesthat, during the next two to three years some major efforts will be completedwhich will open opportunities for new initiatives. As in other areas, theexperiments in Astroparticle Physics are growing in complexity and thecommittee encourages the INFN to plan the future within the framework ofthe international planning effort taking place in Europe and elsewhere.
5 CSN3: Experimental nuclear physics
During the past year the research lines of experimental nuclear physics per-formed excellently, as evidenced by the large number of papers producedand of invited talks to international conferences and workshops. In addi-tion, these lines fulfilled their objectives by realising almost completely thescientific and technical milestones foreseen for the past year. However, apoint of concern is the small number of PhDs granted in CSN3 relative tothe total number granted by INFN. A larger effort should be made to attractPhD students at least if the positions are available and also to open newresearch positions in Nuclear Physics. This, of course, will be more difficultto achieve if the perspective of a steadily decreasing budget is not reversed.Nevertheless, CSN3 should be applauded for keeping vibrant lines of re-search resulting in many highlights in the last year in spite of the financialdifficulties.
In line 1, Quarks and Hadron Dynamics, many experiments have beenperformed at JLAB (USA), MAMI (Mainz), ELSA (Bonn) and DAFNE(Frascati). Also, research and technical developments have continued forthe approved upgrade to 12 GeV of the JLab facility and for the PANDAdetector at FAIR/GSI. Interesting results have been obtained on two-photonexchange contribution to elastic lepton-proton scattering through a precisecomparison of positron-proton and electron-proton elastic scattering. Prob-ing the strange sea in the nucleon has been made through the measurement
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
220
INFN Commissions. As in other commissions, the budget has decreasedwith respect to previous years and further decreases are foreseen until 2014.Both the number of publications and their impact factor have been steadilyincreasing during the last few years.
The Neutrino sector has reached a mature state: all experiments areproducing results and two of the major ones, OPERA and ICARUS, bothat the Gran Sasso Laboratory (LNGS) using the CNGS beam from CERN,will be completed in the next two to three years. An unexpected resultshowing that the neutrinos from CERN could possibly travel at a speedlarger than the speed of light had been announced by OPERA prior to ourmeeting. Since then, new investigations by the same collaboration seem toindicate the resolution of the puzzle. BOREXINO, also at the LNGS, hasmeasured precisely the Be-7 solar neutrinos, providing independent evidencefor the Large Mixing Angle, matter-effect enhanced, oscillation hypothesis.
In the search for neutrinoless double-beta decay, two of the largest exper-iments in the world, GERDA and CUORE, are being assembled at LNGSand should be completed within the next three years. On the direct dark-matter searches the LNGS hosts four leading experiments, three of whichhave strong INFN participation: DAMA/LIBRA, WArP and XENON100.DAMA/LIBRA is running under very stable conditions with an improveddetector. XENON100 has shown the potentiality of the technique withmuch improved results over those obtained previously, and will be extendedto XENON1T (one tone of liquid Xenon).
Ground-based cosmic-ray experiments include ARGO (in Tibet) for thestudy of very high energy charged cosmic rays and gamma rays, the MAGICTelescopes (La Palma) for very high energy gamma rays and the AUGERArray (in Argentina) for extremely high energy charged cosmic rays. Allthese experiments are producing many and very interesting results. On theunderwater neutrino telescopes the INFN participates in the ANTARES12-string detector, which is actually running, in the NEMO demonstratorproject and in the KM3-NET Collaboration. NEMO is contributing to theKM3-NET, aiming at a full TDR for an underwater Mediterranean detector.
Cosmic rays in space are studied with the Fermi LAT detector, whichhas now been in orbit for two years running stably, with the AGILE andPAMELA satellites and, since the summer of this year, with the AMS-2detector. AMS-2 was launched in May on board of the Shuttle to the ISS,and shortly afterwards was able to detect and identified the ions of severalnuclei. All these experiments have produced significant results this year.Fermi in particular has discovered more than 1500 new sources and thecollaboration has already published more than 100 scientific papers.
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
219

and expands to a larger size at freeze-out as compared to lower energies.The development of the Tier2 centres is continuing and ALICE upgrade hasbeen going on, in particular with the installation of the transition radiationdetectors (TRDs) and the electromagnetic calorimeter. Several other up-grades of ALICE are planned for the shutdown period and beyond. INFN isstrongly involved in one of them, i.e., the inner tracking upgrade in whicha 2nd generation vertex detector will be installed with excellent capabilitiesto study production of heavy flavour baryons.
In line 3, Nuclear Structure and Reaction Mechanisms, research at theINFN national laboratories LNL and LNS and the large European researchinfrastructures GSI and GANIL addressed mainly two themes: 1) the studyof single-particle and collective degrees of freedom in nuclear excitations inorder to understand the evolution of shell structure and nuclear propertiesas function of proton-to-neutron ratio, N/Z, and 2) the study of the nuclearequation of state (EOS) and its isospin dependence (symmetry-energy term)through nuclear reactions with heavy ions. The first theme profited from thepresence of the AGATA demonstrator at LNL till the end of 2011. This wasused in combination with Si arrays for light-ion detection and the PRISMAspectrometer for heavy-ion detection. The AGATA demonstrator lived upto the expectations and the energy resolution of γ-rays emitted by recoilingnuclei could be strongly improved by its tracking capabilities. Lifetimes oflevels could be precisely measured with AGATA coupled to a differentialplunger. At GSI, g-factor measurements were performed using the γ-rayarray RISING. The second theme was pursued using the CHIMERA set-upat LNS with light radioactive beams to study isospin effects at the Fermienergy. CHIMERA was later used in conjunction with the LAND detectorat GSI at high beam energies to study isospin dependence of EOS. This willeventually help in understanding neutron-star formation, the fission processand dynamics of heavy-ion reactions. The groups in this line of researchare involved in R&D within international collaborations towards developingnovel and state-of-the-art detection systems for high-energy γ-rays and forneutrons. LaBr3 crystals backed by NaI ones will form the units for thePARIS array for detection of high-energy γ-rays and have demonstratedexcellent properties of high efficiency and excellent time resolution. TheFAZIA collaboration has shown important progress in particular with thebeam tests performed at different facilities with prototypes of the detectioncells which provided impressive results concerning the performances of thenew silicon detectors. Both identification techniques based on standardE-∆E measurements and pulse-shape analysis with a single detector showoutstanding resolutions in charge and mass. Most of the results obtained
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
222
of the polarisation in semi-inclusive deep inelastic scattering. The precisemeasurement of the ratio of the electromagnetic factors of the proton hasbeen extended to Q2
∼ 8.5GeV 2 allowing better discrimination between the-oretical models. Tensor correlations were precisely measured in 3He(e,epp)nfor a large momentum-transfer range. In the MAMBO experiment at Bonnand Mainz, which studies baryonic and mesonic resonances between 1.5GeV - 3 GeV, progress has been made through first measurement of thecircular beam asymmetry in the γp → π0ηp reaction and identifying smallcontributions from positive-parity resonances via interference terms with thedominant D33 amplitude. Hypernuclei and kaonic atoms have been studiedin the FINUDA and SIDDHARTA experiments at LNF. In addition to thehypernuclear spectroscopy in p-shell nuclei, a highlight of the measurementsat FINUDA is the non-mesonic decays of the Λ hypernuclei with contribu-tions from correlated two-nucleon pairs. SIDDHARTA delivered a precisemeasurement of the energy of the 1s level for the hydrogen kaonic atom.The opportunities to participate in the large international projects, the 12GeV upgrade for JLab and PANDA, triggered a large number of technicalactivities. Among these for JLAB12 are development of a neutron detec-tor for CLAS, simulation and construction of the forward tagger, and thedesign of a ring-imaging Cherenkov detector for CLAS12, development ofa hybrid tracker based on Si and GEM for Hall A. For PANDA, the R&Dconcentrates on development of the micro-vertex detectors and tracking de-tectors using straw tubes. There is also strong involvement in experimentsat COSY, Jlich to study the mechanism of polarisation build-up, which isof great importance for obtaining polarised antiproton beams at PANDA.
In line 2, Phase Transitions in Nuclear Matter, the ALICE Collaborationprofited from the operation of the experiment for the full 2010. Data wereobtained for p − p collisions at 7 TeV colliding beams, and for Pb-Pb at2.76 TeV per nucleon pair colliding beams. Data analyses with full involve-ment of the INFN groups have progressed fast yielding exciting results onproduction of resonances, π0 and γ, charm (D mesons), J/Ψ in the dimuonand dielectron channels and jets, which are important observables for thequark-gluon plasma (QGP). In the measurements, charged particles wereidentified at low, intermediate, and high transverse momentum. Charged-particle multiplicity measurements and two-pion Bose-Einstein correlationswere performed for both p − p and Pb-Pb collisions. The remarkable high-lights resulting from these measurements are i) the jet quenching observedas suppression of hadrons at high-pT in Pb-Pb collisions as compared to p-pcollisions and ii) the indication from two-pion correlations that the fireballformed in nuclear collisions at high energies at LHC is hotter, lives longer,
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
221

accelerator and its shielding.
6 CSN4: Theoretical Physics
Theoretical Physics continues to be an important component of INFN activ-ities. It covers a very large spectrum from Theoretical High Energy Physicsand Theoretical Nuclear Physics to Astro-Particle Physics and Cosmology,Mathematical Physics and Statistical Physics. Although most of the seniorresearchers in these areas are University Professors, essentially all groupswith a significant scientific activity are financed by INFN. In this respectthe Italian model of organisation is exemplary. It is one of the rare casesin which both experimentalists and theorists covering essentially all funda-mental Physics belong to the same Institution. This is probably one of thefactors which made the Italian School in this area one of the best in theworld.
Among the groups supported by INFN several are of world class. In The-oretical Particle Physics Italy has a leading role in Europe and many Italiantheorists are holding senior positions at CERN as well as many Europeanand American Universities. In Statistical Physics, and especially the Physicsof disordered systems, the Italian School is probably the best worldwide.
Last year we had noted with regret the fact that the financial difficultiesof the Institute had forced the Direction to abandon the project of acquiringa state of the art super-computing system to perform large scale numericalsimulations. The Italian community could no more stand the competitionfrom the US, other European countries, or Japan. This year we were gladto hear that a cluster facility has been installed and is already running inPisa. Although it is not a substitute for the large system many had hopedfor and it will not be used for the most demanding projects, such as largescale lattice QCD simulations, it will certainly help in many other problems.It is already fully booked.
The record of CSN4 in training young scientists has always been im-pressive. It counts for half of the PhDs awarded in INFN related subjects.In our last year’s report we had expressed our satisfaction with the pro-gramme developed by CSN4 in collaboration with CSN1 in preparing youngtheorists for the analysis of the LHC results. We are glad to see that thiseffort continues and has already brought significant results. Italian teamsare among the leaders in the theoretical studies related to LHC Physics,such as background computations, expected signal estimates etc.
The critical situation which resulted from the freezing of positions in the
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
224
during the R&D phase have been published. The NEDA neutron wall isan important addition to the γ-ray detection arrays and will be used in thefuture in experiments with AGATA. The construction of the SPES ISOLfacility at LNL is progressing well. The driver cyclotron is expected to beinstalled in 2013/14 and will deliver 200 µA of proton beam at 40 MeV (8kW). R&D on the UCx target and radioactive ion beam is performed in theframework of an international collaboration and is well on track althoughmore resources are needed in the near future.
In line 4, Nuclear Astrophysics and Interdisciplinary Research, nuclearreactions at stellar energies are studied in order to have a good understand-ing of nucleosynthesis at different stellar environments. Direct capture mea-surements (LUNA at LNGS) require very low beam energies in the regionof the Gamow peak, e.g., the study of the d(αγ)6Li reaction at around 100keV needed to resolve the discrepancy between observed 6Li abundance andexpected one on basis of Big Bang Nucleosynthesis. Indirect capture mea-surements (Trojan Horse method) are pursued (ASFIN2 at LNS) and inter-esting results have been obtained recently in the study of the 17O(p, α)14Nreaction. The neutron capture studies for astrophysics and reactor appli-cations are pursued at n TOF at CERN. Recently interesting results onneutron capture on 186Os and 187Os were obtained. These reactions arestudied in order to determine the s-process abundance of 187Os at the timeof formation of the solar system because of its importance for the cosmicclock. Also, precise data obtained on fission of 237Np induced by neutronsat high energies differed significantly from earlier evaluations. This couldhave important consequences for accelerator-driven systems.
To conclude, the INFN-CNS3 programme has performed exceedinglywell in the last year profiting largely form the full operation of ALICE atCERN and the extensive running campaign with the AGATA demonstratorat LNL. The quality of research in all lines of CSN3 is excellent and INFNscientists are often leading collaborations in Europe. The SPES project atLNL is part of the INFN Road Map for Nuclear Physics, and the CVI ispleased to know of the strong commitment of the INFN presidency to thisproject, which has been reiterated during the meeting. Progress has beenmade with the construction of this facility and also on R&D of some ofthe critical components to produce the radioactive beams. The momentumshould be maintained for a timely realisation of this facility with its fullpotential to have impact on European and even international level whenthe large radioactive-ion beam facilities are fully operational. In addition,the plans for a few MV accelerator, LUNA-2 at LNGS, in the future haveentered the phase of a feasibility study of the site and the installation of the
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
223

tivities have been carried out according to the usual sectors of i) AcceleratorPhysics, ii) Detectors, Electronics and Computing, and iii) Interdisciplinaryresearch.
The total CSN5 Budget was roughly flat from 2010 to 2011. However,larger shifts in budgets and numbers of personnel between the sectors areobserved, in particular, between sectors (i) and (iii), indicating reasonableflexibility in assignment of human and financial resources. This is essentialwhen having projects of short duration of up to three years as is the casefor CSN5.
The scientific production in terms of ISI publications remains strong,showing the great interest of the researchers for new developments, par-ticularly in multi- and inter-disciplinary activities. Excellent examples offorefront research are evident in all three thrust areas of the section. Muchof the R&D has direct synergy with future INFN programs. Several out-standing examples are the detector and accelerator R&D for the Super-Bproject, R&D on new detectors for future astroparticle physics initiatives inCSN-2, and accelerator and detector R&D supporting activities in CSN-3.However, there is also R&D that is focused on technologies that can be ap-plied well outside of the INFN mission such as for applications in medicine,archaeology, cultural heritage, environment and nuclear energy.
CSN5 has an excellent track record of scientific and technological achieve-ments. Some of the relevant and successful projects have been discussed inour earlier reports. In the following, we would like to mention a few exam-ples of recent projects that have the high potential to benefit major INFNscientific programs as well as R&D that benefit society.
Accelerator-related are IMCA (Innovative Materials and Coatings forAccelerators) and HELIOS. HELIOS, a pan-European project to improvebeam brightness of next generation ion sources, has made significant progressin the understanding of the fundamental process of plasma heating by RFand the influence of different ion-source parameters. The results are veryencouraging as potentially higher currents of multiply charged ions may beproduced by Electron Cyclotron Resonance Ion Sources (ECRIS) benefit-ting many labs worldwide and hadron-therapy facilities that use heavy-ionbeams.
Projects to develop detectors, electronic devices and software and hard-ware facilities have been initiated and/or made progress in the last year(e.g. ORIONE, XDXL, and VIPIX). ORIONE has the aim of synthesizingand characterizing polysiloxane organic scintillators, which are promisingfor detection of fast and thermal neutrons in harsh environments. Theycould be widely used in experimental setups as well as for various applica-
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
226
Italian Universities has severely damaged all INFN activities and even moreso those of CSN4 due to its more significant dependence on such positions.Professor Lerda in his annual report notes:
“Unfortunately the number of INFN and University staff is rapidly de-creasing and the average age...is steadily increasing.”
In our last year’s report we stated “...the brain drain is no more a dangerbut a fact. The question is now how to prevent its effects from becomingirreversible. Indeed, it takes generations to build a world class School ofTheoretical Physics, but a few years may be sufficient to destroy it.” Takinginto account the small number of positions involved compared to the entirepublic sector, we believe that a more flexible application of the rules wouldhave an enormous beneficial effect to the country’s Universities and ResearchCentres.
We were pleased to see that the CSN4 Committee has established rigor-ous and meritocratic rules to distribute the Institute’s support among thevarious research teams. This will lead to increased efficiency and should beencouraged. However, as Professor Lerda points out, “....all our efforts mayfail if the total CSN4 budget keeps decreasing...”. Last year we had pointedout, among other dangerous effects related to the budget decrease, the prob-lem of travel funds, so essential to maintain international collaborations. Itis again due to a blind application of some administrative rule and we regretto see that the problem has not yet been solved.
A very successful initiative of INFN and CSN4 is the Galileo GalileiInstitute in Florence. Established a few years ago it has reached now the ageof maturity. It organises every year several workshops, mini-Conferences orspecialised meetings in various “hot” subjects in Theoretical Physics. Theybring together in Tuscany the best specialists in these fields for the greatestbenefit of the Italian, but also the International, scientific community. TheInstitute compares favourably with similar Institutions worldwide, such asthe Newton Institute in the UK, the Henri Poincare Institute in France, orthe Kavli Institute in Santa Barbara in USA. The CVI wants to reiterateits congratulations to the members of the Scientific Committee.
7 CSN5 : Technological and Inter-Disciplinary re-
search
CSN-5 serves an important role in developing technologies, designing and re-alizing facilities and tools, as well as experimental methods addressed both tofundamental research and a variety of interdisciplinary applications. Its ac-
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
225

property associated with the R&D that they are doing. In this respect, aclear policy on patents should also be worked out to define INFNs intellec-tual rights when cooperating with industries on research projects, and/orwhen certain INFN inventions find direct commercialization by industry.
While these suggestions may be too specific we encourage INFN manage-ment to think along these lines and articulate whatever investment strategythat they feel will best serve their mission. We also encourage them to bebold in taking decisions on high-potential but risky research. The existenceof metrics, for example, should not result in a risk adverse R&D investmentstrategy. It should always be acknowledged up front that the investmentsin CSN-5 are high risk, high reward in nature!
8 Technology Transfer
The 2011 report on the INFN Scientific Productivity and its Socio-Economicand Inter-disciplinary Impact rightly opens mentioning that ten years afterthe launch of the Lisbon Strategy, the European Union is facing a globaleconomic crisis requiring the adoption of extraordinary measures. The com-mitment for Europe to become the most dynamic and competitive knowledgeeconomy in the world implied that EU countries were asked to increase theirinvestment in research up to about 3% of their GDP: unfortunately this hasnot happened throughout the continent.
In our report last year we had noticed that INFN had shown the rightsensitivity by working out a more accurate Technology Transfer (TT) policy.Since mid 2009 a specific Committee made up of 15 people with differentexperiences had been set up with the aim to prepare rules for collaborationand TT with industries and Institutions (including an appropriate patentstrategy) and rules for starting spinoff companies for INFN staff. The set ofrules had been finalised and we were presented with some interesting exam-ples of their applications. Therefore, this year we were quite disappointednot to see any detailed follow up in the report. We know that INFN hasdeveloped a strategy towards a more efficient TT policy, but we lack anyquantitative information on the impact and the results of this policy. As aresult, the CVI expresses its difficulty in providing an accurate judgment ofthe INFN Technology Transfer activities in 2010. The section on the purelyscientific production is well documented in terms of publications, citationsand impact factors but contains little information on patents and resultsapplicable to industry.
The CVI wishes to have a detailed presentation on this issue in its next
2
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
228
tions outside the realm of physics. The XDXL project, aiming to improvethe performance of large-area silicon drift detectors, achieved surprisinglyexcellent results that it became at the basis of various proposals and wasselected by ESA for further study.
Medical imaging is pursued by different groups within CSN5 using noveltechnologies and methods such as proton computed tomography in theframework of the PRIMA project and diagnostic radiology with tunablemonochromatic X-ray beams. Both are excellent techniques for high-resolutionimaging and are very promising for cancer-treatment planning.
With the eye on the future, CSN5 unfolded, together with CSN1, CSN2,CSN3 and INFN-NTA, a strategy to work on different projects benefittingthe future scientific programs pursued by these sections. Some of the re-markable items include R&D on accelerator components and detectors forSuper-B, and laser plasma acceleration including plasma acceleration of pro-tons for use in medical applications.
The research funds in CSN-5 are awarded on the basis of peer reviewedproposals and typically the awards are for 2-3 years. Given the tight fiscalconstraints developing within INFN and the critical importance of this R&Dto INFNs future, we have several suggestions in case the section is faced withthe need to make increasingly difficult prioritizations in the coming years.
Much of the R&D in section 5 is driven bottom up by the individualinvestigators with exciting new ideas. This must always be encouraged asfundamentally this will always be the best source for innovation. However,INFN might want to consider some top down strategic direction to focus theR&D efforts, specifically giving more resources in certain areas of R&D mostrelevant to INFN future directions. The breadth of the CSN5 R&D efforts isquite staggering and it is hard to imagine that significant successful effortscan blossom in so many diverse areas in times of very constrained funding.
We also suggest that it might be valuable to have an internal process de-veloped to define and measure the success (or failure) of the individual R&Dinvestments. One clear measure of success would be the fraction of R&Dinvestments leading to new detectors that then are deployed in new projectsby INFN, or that research results find direct applications to societal issuesor in industry. However, we believe it should also be considered a successif INFN R&D results in new technologies deployed in non-INFN projects inthe international community. Another suggestion is to ensure that in areasof R&D that are outside the direct mission of INFN, such as medical appli-cations, there be some process to ensure that the R&D is focused on solvinga problem that the external customer actually needs solved. Finally, weencourage INFN to utilize strategies to develop and exploit the intellectual
1
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
227

tive options. Currently this happens only in few cases: in general researchplans seem to be driven by the curiosity of research groups that apply forfunds. This is a traditional approach, that encourages exploration. But,in front of severe budget cuts, this attitude should be balanced by a moredirective approach, aimed at defining and reinforcing the strengths of eachCommittee. We would like to see the CSNs present, in future, not simplya list, but a strategy of research, based on the competences they have andmaking use of a clear analysis of strengths and weaknesses. In case of furtherbudgetary cuts, this would guide the reallocation more rationally than justhaircutting. The same strategic attitude should be adopted also for bud-getary decisions taken by central bodies of INFN. History based budgetingcan be highly inefficient, especially when funds are decreasing. Allocationsbased on performance (scientific results, timing of projects) can provide in-centives to the Committees to reach the goals stated by the National bodiesof the Institute. We invite the President and the Giunta to make an effortof defining priorities, and designing an incentive based method of budget al-location aimed at aligning the programme of each CSN to the general goalsof the Institute. The Direction has already implemented a sophisticatedsystem of performance measurement, so it should not be very difficult touse it for budgetary management, once the goals are clearly stated. A finalsuggestion is about the necessity to present a multi-year plan for the renewalof laboratories. Plant and machinery renewal has to be carefully planned,and enter year by year in the budget of the Institute. Otherwise, the risk isthat, when facing budgetary cuts, renewals are postponed and laboratoriesbecome obsolete and no more attractive.
9.2 Human resources
Human resource management faces similar problems. On one side, the CVIhas highly appreciated the new regulation for personnel and the introductionof a carrier track policy: this can be highly beneficial for human resourcemanagement, as it has proved effective in several research Institutions. Onthe other side, the CVI is extremely worried about the ageing of researchersand its impact on productivity. From the figures presented, we were in-formed that in five years, between 2003 and 2008, the modal age of re-searchers increased by five years, from 40-44, to 45-49. At the same time,the negative relationship between age and research productivity is a wellestablished fact, and is confirmed also in INFN. Ageing researchers shouldbe devoted to management and research organisation tasks, while juniorresearchers have to breed new ideas.
2
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
230
meeting. It underlines the necessity to integrate in the report detailed infor-mation on the results of applications, patents, partnerships with enterprisesand any other technology transfer activities carried out by INFN. Further-more, it recommends to dedicate more attention to TT activities and topartnerships with Italian and international industries both in the researchand education activities. Some simple steps to improve Technology Transferactivities, as well as the information concerning them, could be:
-To draw a map of INFNs infrastructures and competences that couldbe used as a base to develop partnerships with enterprises.
-To develop partnerships with industrial associations (Confindustria forexample ) for the purpose of promoting partnerships with enterprises inresearch and education activities.
-To better organise the TT part of the web site with updated data.
9 Budgetary issues and human resources manage-
ment
9.1 Budget
In the last nine years, INFN’s budget decreased of about 15% in real terms.Given that an important part of the budget is allocated to fixed costs forpersonnel, the reduction of the share of budget available for research projectis even more pronounced, reaching a total of 324 million euros between 2001and 2009. Moreover, in the last year, the share of budget assigned on perfor-mance basis was not transferred by the Ministry to INFN. It is still not clearwhether the payment has been postponed to the next year, or this will bea permanent budget cut. In the first case, INFNs budget would stay in thecoming two years 2012-2013 on a figure of around 270 M. The CVI expressesits worries in two respects. First, INFN already faced a severe budget cut.Had it to suffer new cuts, this would put the Institute in an emergencysituation, so to cut important research programs. The second issue is theuncertainty the Institute is facing, that makes difficult to put up rationalprograms of adjustment. CVI understands the problems that Italian publicfinances are currently facing. Were budgetary restrictions unavoidable, itwould be important at least to design them rationally and give the Institutethe time and a sure budgetary frame under which to act, given the very longtime-horizon for research in Nuclear and Particle Physics. On the other sideCVI suggests also some measures to improve the planning procedures ofINFN. CSNs have to learn how to act strategically in order to guide selec-
2
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
229

the Institute and we praise his leadership, often through difficult conditions.We welcome Professor Fernando Ferroni as the new President and we wishhim a most successful term. We would like to ask them to transmit to allthe personnel our appreciation for the work done. We would also like tothank them together with the members of the Executive Board, the chair-persons of the scientific sections and the Direction of LNL for organisingsuch a successful meeting as well as for the warm hospitality extended to us.
2
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
232
This has important implications. One is that, given the uneven agedistribution of researchers, keeping fixed the number of personnel, just re-placing retirements with a nil net turnover, would imply ageing and, byconsequence, a slowdown of scientific productivity. A good practice wouldbe to hire new people at a constant rate, targeting a long term equilibrium.The consequence would be a positive turnover in the next 10 years, anda negative one in the future. This is clearly incompatible with budgetarylimits imposed by the Italian Government. It must be added that the Gov-ernment imposed even stricter limits to turnover: at present only 20% ofpeople leaving for retirement can be replaced. This puts the Institute in avery delicate position, that can jeopardise the huge capital of competencesand reputation accumulated by INFN. We urge the Ministry to considercarefully the risks of this policy: it would be better to target a lower longterm personnel equilibrium and act accordingly with a plan of hiring juniorresearchers (through the career track programme designed by the new regu-lation), than simply postpone the replacement of retirements. A last remarkis devoted to gender issues. Despite the gender policies activated by the In-stitute, the ratio of women over the total working force is low, particularlyamong researchers. Some member of the CVI noted that such low figuresare customary among research Institutes in physics, even in countries lessgender discriminating than Italy. On the other hand, however, the numberof women who obtained their PhD at INFN is higher than that of men.This can be a hint pointing to real career obstacles for women. The CVI,while appreciating gender policies put in action by INFN and the compara-tively good figures presented, asks to carefully evaluate the efficacy of thosepolicies. The present system of entry with temporary contracts can lead todiscrimination if it does not take into account the average age of maternity.The new personnel regulation, and the career track system, should protectfemale workers against this risk implicit in the use of temporary contracts.
10 General conclusions and Acknowledgements
All CVI panel members who participated in our meeting last October, unan-imously declare that our visit to Legnaro was a most instructive and enjoy-able experience. We learnt about new and exciting projects and we had thepleasure to see many scientifically interesting new results. INFN is a researchInstitution of the highest quality and we can only wish it is given the meansto continue its road of success. We acknowledge a fruitful collaboration withProfessor Roberto Petronzio during all the years he served as President of
2
PIANOTRIEN
NALE2012-14
/ APPENDICE
231