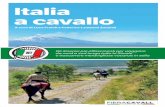Pellegrino in luoghi sperduti. Note su alcuni toponimi rari del De situ Terrae Sanctae di Teodosio...
-
Upload
edoardo-scarpanti -
Category
Documents
-
view
99 -
download
0
description
Transcript of Pellegrino in luoghi sperduti. Note su alcuni toponimi rari del De situ Terrae Sanctae di Teodosio...
VOL. XLIII-XLIV
2002 e 2003
ATTIdel
Sodalizio Glottologico Milanese
MILANO
2006
(omissis)
E. SCARPANTI, Pellegrino in luoghi sperduti. Note su alcuni toponimi rari del De situ Terrae Sanctae di Teodosio (VI sec. d.C.) Il testo latino tardo conosciuto come De situ Terrae sanctae si presenta come una vera e propria guida per il pellegrinaggio in Terra Santa, redatta attorno allanno 530 e stesa in un linguaggio scarno ed essenziale, privo di pretese letterarie, ma in grado di costituire, da un punto di vista linguistico, un utilissimo esemplare di latino volgare1.1. Ledizione critica qui seguita quella curata da Geyer, pi volte adottata e ristampata praticamente senza variazioni in successive raccolte a partire dal 1898: Theodosius De situ Terrae Sanctae, ed. P. Geyer, in Itinera Hyerosolymitana saeculi IIII-VIII (CSEL 39), Vindobonae 1898, pp. 137-150; rist. anastatica: New York-London 1964; rist. con correzione di alcuni refusi in Itineraria et alia geographica (CC 175), Turnholti 1965, pp. 114-125; rist. in PLS 4 (1967), coll. 1456-1463. Cito dunque da tale edizione di Geyer, riportando sia la numerazione per pagine del CSEL 39 (1898), sia, dopo un segno [=], quella basata sulla suddivisione in 32 capitoli come compaiono nel pi recente volume di CC 175 (1965). In mancanza di una traduzione italiana, si possono consultare quelle in lingua inglese, tedesca e francese: J. Wilkinson, Jerusalem
169
Lopera, attribuita da un singolo manoscritto2 a un misterioso personaggio di nome Teodosio, riveste per altro anche una notevole importanza storica: insieme al successivo Itinerarium Antonini Placentini essa rappresenta, di fatto, lultimo resoconto che ci possa dare unidea della situazione della Gerusalemme bizantina prima delle conquiste arabe e delle crociate3. La finalit eminentemente pratica di questo scritto, che ne ha del resto favorito la sopravvivenza nel corso dei secoli, lo rende interessante anche per il notevole numero di luoghi geografici citati, spesso corredati nel testo da brevissime annotazioni di storia sacra. proprio fra questi luoghi che si nascondono in alcuni casi, in mezzo ai nomi familiari di Gerusalemme e di Gerico, di Cafarnao e di Emmaus, alcuni toponimi inconsueti o altrove non testimoniati, i quali possono talora serbare traccia di antiche tradizioni. Potrebbe essere utile, dunque, citare in questa occasione alcuni di tali toponimi, scelti fra gli altri a titolo di esemplificazione. 1. Matzi Un primo interessante esempio ci fornito da un passo nel quale lautore descrive il Monte degli Ulivi:De monte Oliueti ascendit Domnus in caelis et ibi prope est spelunca, quae dicitur Matzi, quod interpretatur discipulorum, ubi Domnus, quando praedicabat in Hierusalem, requiescebat (145, 1-4 = 17, 1-4).
Nel testo si parla, dunque, di una caverna, sul Monte degli Ulivi, allinterno della quale Ges avrebbe trovato riposo durante il suo
pilgrims, Warminster 1977, pp. 63-71; H. Donner, Pilgerfahrt ins Heilige Land, Stuttgart 1979, pp. 199-225; P. Maraval, Rcits des premiers plerins chrtiens au proche-orient: (IVe-VIIe sicle) textes choisis, prsents, traduits et annots par Pierre Maraval, Paris 1996, pp. 186-201. 2. Si tratta del codice Vaticanus latinus 6018 (IX sec.). Gli altri testimoni del testo del De situ non ne riportano lautore, tranne il solo manoscritto Parisinus latinus 1065 (IX-X sec.), che lo attribuisce erroneamente a Girolamo. 3. Notizie su Teodosio si possono reperire, fra gli altri, in G. Auletta, Pellegrini e viaggiatori in Terrasanta, Bologna 1963; F. Mian, Gerusalemme citt santa. Oriente e pellegrini d'Occidente, Rimini 1988; E. Menest, Relazioni di viaggi e di ambasciatori, in Lo spazio letterario del medioevo. Il medioevo latino, I/2, Roma 1993; K. Frank, Theodosius Archidiaconus, in Lexikon des Mittelalters, VIII, Mnchen-Zrich 1997, pp. 646.
170
ministero pubblico a Gerusalemme, conosciuta al tempo del De situ Terrae Sanctae con il nome di matzi4. La tradizione cristiana ha generalmente individuato sulla parte pi elevata del monte due differenti luoghi santi: nel primo di questi, sul culmine della collina, veniva collocata lAscensione del Signore; si tratta del sito dove oggi si trova la moschea dellAscensione e che Teodosio qui esplicitamente ricorda con le parole: de monte Oliueti ascendit Domnus in caelis. Nel secondo luogo, invece, posto leggermente pi in basso rispetto al precedente (ibi prope), si colloc in un primo momento la stessa Ascensione di Ges, nel punto dove, sopra unantica caverna, limperatrice Elena aveva fatto costruire la basilica dellEleona: , chiaramente, il luogo che ci interessa. Solo successivamente, con lo spostamento pi a monte del ricordo dellAscensione, in questo sito si inizi a collocare il magistero del Signore nei confronti degli apostoli e, in particolare, linsegnamento della preghiera del Padre Nostro. Della caverna, in precedenza, aveva del resto ampiamente trattato anche la pellegrina Egeria, che infatti la menziona proprio in rapporto con la basilica dellEleona, dicendo ecclesia () quae est in Eleona, id est in monte Oliueti, ubi est spelunca illa in qua docebat Dominus5. Gli altri itineraria coevi, invece, non fanno particolari accenni a tale luogo. La tradizione secondo la quale Ges ed i discepoli avrebbero utilizzato il monte degli Ulivi come luogo di riposo durante la predicazione a Gerusalemme si rifaceva, del resto, direttamente alle parole dellevangelista Luca: erat autem diebus docens in templo, noctibus uero exiens morabatur in monte qui uocatur Oliueti (Lc 21, 37). Nellambito di questa tradizione sin qui piuttosto varia, il contributo originale della versione riportata dal De situ Terrae Sanctae, che merita in questo caso di essere illustrato, dunque rappresentato in particolare dalla curiosa denominazione della spelonca: matzi, appunto, termine che compare soltanto in questo testo. Per quanto con-
4. Il termine appare nella forma matzi nel codice pi importante, il Parisinus latinus 4808 (VIII sec.), nel Monacensis 22053, nel Parisinus 1065 e in tutti i codici successivi, mentre una lezione mazi testimoniata dal solo manoscritto Guelferbytanus 4183, dellVIII-IX secolo. 5. Itin. Eg. 30, 19-21; altre occorrenze in 33, 7; 35, 24-25; 39, 20; 43, 42-43; cfr. Itinerarium Egeriae, ed. E. Franceschini R. Weber, CC 175 (1965), pp. 29-102; sul toponimo matzi cfr. anche D. Baldi, Enchiridion locorum sanctorum, Jerusalem 1955, p. 396.
171
cerne questo toponimo, lo stesso Teodosio sembrerebbe fornirci una soluzione, specificando immediatamente: matzi, quod interpretatur discipulorum. Gildemeister, sulla scorta della precisazione fatta da Teodosio, propose dunque di vedere nellespressione matzi nientaltro che una lezione scorretta del greco , (grotta) dei discepoli6. Se ci fosse vero, Teodosio avrebbe riportato il nome della caverna cos come lo sentiva pronunciare, non identificandolo personalmente come greco, ma trascrivendone poi linterpretazione che ne veniva correntemente data: quod interpretatur discipulorum. Lo stesso Gildemeister, inoltre, dedusse da questo presunto fraintendimento di Teodosio lipotesi che il nostro autore non conoscesse il greco, suscitando in tal modo ulteriori discussioni sulla sua possibile identificazione storica. Tutto ci pu essere senzaltro vero, ma alcuni fatti potrebbero forse invitare a non trarre troppo affrettate conclusioni: in primo luogo infatti, la forma matzi richiederebbe la caduta e la totale scomparsa, rispetto al supposto termine originario math tn, dellintera desinenza del genitivo plurale -n cos come della stessa consonante terminale del tema nominale math t-; del resto, anche se un parlante non greco avesse utilizzato, al posto del genitivo, la forma del nominativo plurale math ta (pronunciata come mathit), il troncamento finale parrebbe ancora eccessivo. lecito dunque, probabilmente, sospettare una derivazione diversa per il nostro termine. In secondo luogo, il digramma presente in matzi sembrerebbe poco adatto a rappresentare il suono del greco : tale suono infatti nel VI secolo d.C. doveva essere ormai quasi certamente fricativo dentale sordo [ ], come negli esiti bizantini e neo-greci7, e soprattutto continuava ad essere comunemente trascritto nellalfabeto latino
6. Theodosius De situ Terrae Sanctae, ed. J. Gildemeister, in Theodosius De situ Terrae Sanctae im chten Text und der Breviarius de Hierosolyma, Bonn 1882, pp. 1-33. 7. Sulla pronuncia di theta in questepoca, cfr. W.S. Allen, Vox graeca. A guide to the pronunciation of classical Greek, Cambridge 19873, pp. 18; 23-25; V. Pisani, Manuale storico della lingua greca. Con unappendice di C. Milani sul greco miceneo, Brescia 19732, pp. 52-53; 225; L. Palmer, The Greek language, London Boston 1980, p. 208; G. Horrocks, Greek: a history of the language and its speakers, London New York 1997, p. 112; ma largomento era gi stato parzialmente trattato in E. Schwytzer, Griechische Grammatik, I (= Handbuch der Altertumswissenschaft, II, I, 1), Mnchen 1938, 19593, p. 205;
172
con . Teodosio conosceva bene lesatta trascrizione nei caratteri latini della theta, trascrizione che egli utilizza frequentemente nel testo, come in Bethsaida, Therebintum, Nazareth, Theodosius, Golgotha, Matheum (sic), Aethiopia ecc., ma per matzi stranamente sembrerebbe fare uneccezione, utilizzando un segno grafico che sarebbe pi adatto a rappresentare unaffricata. Dunque, allorigine di matzi potrebbe realmente non esserci math tn, ma un termi-ne differente. Infine, sembra strano che un autore forse non greco o non di madre lingua greca, ma certamente buon conoscitore del Nuovo Testamento, non sapesse individuare, sebbene eventualmente storpiato, un termine biblico cos comune come math tn nel momento in cui lo sentiva pronunciare, essendo per altro a conoscenza delle tradizioni che legavano la grotta sul monte degli Ulivi proprio alla presenza dei discepoli. Esistono, in effetti, altri vocaboli che potrebbero forse avere qualche attinenza con il termine matzi: dimostrarne scientificamente il legame con il toponimo in questione , evidentemente, impossibile, ma credo ugualmente che tale rapporto non sia negabile a priori e che, in alcuni casi, la dipendenza da termini simili non presenti maggiori difficolt della ricostruzione tradizionale proposta sopra. Pu essere interessante citare in tale prospettiva, anzi tutto, un sostantivo ebraico, il comunissimo (ma h) pane non lievitato. Lipotesi di una grotta del pane sarebbe forse, in questo caso, degna di nota, in riferimento alla collocazione in tale luogo dellultima cena di Ges, operata da una parte minoritaria della tradizione. In seconda istanza, il fatto che il monte degli Ulivi fosse ricco di grotte naturali utilizzate anche per la raccolta e per la spremitura delle olive ci potrebbe forse far prendere in considerazione proprio larea semantica concernente latto dello spremere (ebr. m- -h, ar. ma awa), cui apparten(m ) spremitura e laramaico metsiyy frangono ad esempio 8 toio, spremitura . Del resto, nellAntico Testamento nominato il toponimo Mots (Gios. 18, 26), oggi Qal ny a nord-ovest di Ge
O. Hoffmann A. Debrunner, Geschichte der griechischen Sprache, II, Berlin 1953, pp. 105-106. 8. J. Clines, The dictionary of Classical Hebrew, Sheffield 2001, s.v.; G. Dalman, Aramisch neuhebrisches Handwrterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch, Frankfurt a. M. 1922, s.v.; P. Reymond, Dizionario di Ebraico e Aramaico biblici, Roma 1995, s.v.
173
rusalemme, derivato probabilmente anchesso dalla medesima radice. La soluzione tradizionale, dunque, potrebbe non essere lunica plausibile: forse possibile, infatti, che in una caverna gi conosciuta come grotta del pane (con o senza riferimento allistituzione delleucaristia), oppure grotta del frantoio o simili, siano stati successivamente collocati dalla stessa tradizione cristiana eventi quali lAscensione, lUltima Cena (solo per una piccola parte della tradizione), e, infine, il riposo del Signore con i discepoli durante la predicazione a Gerusalemme. In seguito, lantica denominazione della spelonca avrebbe potuto essere mantenuta nelluso corrente ma non pi intesa in senso originario, quanto piuttosto reinterpretata come grotta dei discepoli, forse anche grazie allassonanza fra il toponimo originario (qualunque esso fosse) ed il termine greco per discepoli; tale circostanza spiegherebbe bene lannotazione del testo: interpretatur. Cos, accettando questa ricostruzione, potremmo intendere il passo pi o meno in questo modo: una caverna che viene chiamata con il nome matzi, che si interpreta come se fosse mathitn, cio dei discepoli. Se le cose stessero effettivamente cos, il toponimo matzi ci potrebbe tramandare i resti di una forma antica, forse semitica ma di difficile identificazione definitiva, successivamente riletta e reinterpretata dai cristiani bizantini del VI secolo a partire dalla loro fede e dal loro bagaglio lessicale di matrice greca. 2. Myrmidona In un altro passo del De situ Terrae Sanctae lautore, descrivendo la costa settentrionale dellAsia che si affaccia sul Mar Nero, cita una curiosa quanto inquietante leggenda relativa agli abitanti di Sinope:De Cersona usque in Sinope, ubi domnus Andreas liberauit domnum Matheum euangelistam de carcere () Quae Sinope illo tempore Myrmidona dicebatur, et omnes, qui ibi manebant, homines pares suos comedebant; nam modo tanta misericordia ibi est, ut ad stratas sedeant per peregrinos suscipiendos (144, 1-6 = 13, 1-6).
A parte la presunta antropofagia degli antichi abitatori del luogo (homines pares suos comedebant...), ci interessa in questo caso il toponimo Myrmidona, che viene qui presentato come antico nome della cittadina di Sinope e per il quale la testimonianza di Teodosio sa-
174
rebbe, stando ai commentatori del De situ Terrae Sanctae, apparentemente esclusiva9. Lunico termine che sembrerebbe avvicinarsi, per semplice assonanza, con il nostro, potrebbe essere il celebre etnico greco omerico (lat. myrmid nes), indicante il popolo tessalico che avrebbe partecipato alla guerra di Troia al comando di Achille. In effetti, una delle versioni del mito della fondazione di Sinope chiama in causa proprio gli abitanti della Tessaglia. Il nome Myrmidona potrebbe forse, in questo caso, non essere altro che la trasposizione dellantico etnico dei fondatori tessalici della colonia, i myrmidnes. Potrebbe essere utile approfondire, a questo scopo, la possibile origine della leggenda relativa agli antropofagi che sarebbero vissuti in citt: sebbene sia effettivamente poco probabile che il semplice ricordo del grande valore bellico dei Mirmidoni abbia potuto trasformarsi nella leggenda dei cittadini antropofagi, tuttavia un passo dellIliade avrebbe forse potuto fornire lo spunto per una fantasiosa rielaborazione della figura dei Mirmidoni come mangiatori di uomini: infatti, nel poema omerico si dice che essi, che erano philoptlemoi amanti della guerra, durante lo scontro per il cadavere di Patroclo correvano (...) come lupi divoratori di carne, che sbranano sui monti un gran cervo ramoso e tutti hanno il muso rosso di sangue (Il. XVI, 155ss.). Una tale rielaborazione di una fonte classica, tuttavia, difficilmente avrebbe potuto essere opera di un semplice compilatore come Teodosio: esiste infatti una fonte, sino ad ora mai citata a proposito del testo del De situ Terrae Sanctae, che parla della citt degli antropofagi (senza per menzionare il toponimo Myrmidona). Si tratta degli apocrifi Atti di Andrea e Mattia nel paese degli antro
9. La forma Myrmidona appare senza varianti in tutti i codici del De situ Terrae Sanctae, con leccezione del solo manoscritto Guelferbytanus 4183 che testimonia la variante Mermidona; nella sua edizione Gildemeister suggeriva per congettura di leggere Myrmiciona: cfr. Theodosius, De situ Terrae Sanctae, ed. J. Gildemeister, in Theodosius De situ Terrae, cit., Bonn 1882. In realt, il particolare del nome della citt in questione ci fornito sia dal monaco Epifanio, che ne parla come Sinope, sia dal testo dello pseudo-Abdia, che usa proprio il toponimo Myrmidona (cfr. Epiphanius, Vita Andreae apostoli, PG 120, pp. 217-224; Acta Apostolorum apocrypha, ed. C. Tischendorf, Leipzig 1851, pp. 48 ss.; cfr. anche Acta sanctorum mensis Februarii, III, Lutetiae Parisiorum 1885, pp. 431-454).
175
pofagi10, databili fra il IV ed il V secolo. In questopera si narra delle imprese di Andrea, inviato in una citt dellAsia Minore per liberare Mattia dal carcere e per convertire gli antropofagi di quel luogo, sino al martirio dello stesso Mattia (sebbene oggi si discuta sullesatta identificazione dellapostolo: Mattia oppure Matteo). Infine, uno dei manoscritti degli Atti di Andrea e Mattia, il Parisinus graecus 1313, riporta per due volte il nome della citt nella quale si sarebbero svolti i fatti descritti, con una forma per altro non del tutto dissimile dalla nostra: Smyrmn (f. 131v) e Myrmn (f. 159r). In ultima analisi, perci, il toponimo Myrmidona potrebbe derivare proprio dal nome del popolo dei Mirmidoni e comparire nel testo di Teodosio sulla scorta degli Atti apocrifi di Andrea e Mattia. Cos, il dato veramente originale di Teodosio sarebbe a questo punto lesplicita identificazione fra i due toponimi (Sinope illo tempore Myrmidona dicebatur), la cui presenza ci conferma, dunque, come nel De situ Terrae Sanctae sia possibile rinvenire materiale linguistico e letterario pi antico, in qualche modo stratificato, prezioso proprio perch non conservato altrove. 3. Buzana Un terzo nome infine, un interessante oronimo, appare esclusivamente nel testo di Teodosio, in un passo nel quale si descrive un itinerario che dalle mura di Gerusalemme si snoda verso occidente:De porta Purgu usque ubi pugnauit Dauid cum Golia in monte Buzana, quod interpretatur lucerna, milia XV (138, 13-14 = 3, 1-2).
Il nome Buzana senza dubbio inconsueto, mentre la localizzazione del luogo dellepisodio biblico in questa zona ad ovest di Gerusalemme concorda con quanto affermato nel testo dellAntico Testamento11. Fra gli itineraria coevi, lepisodio compare anche nellItinerarium Burdigalense, che ha questa breve annotazione: ciuitas Isdradela () ibi est campus ubi Dauid Goliat occidit (Itin. Burd. 586, 4-6). Il problema, dunque, resta quello di chiarire loronimo Buzana. Al riguardo, Wilkinson annota semplicemente come lintero capitolo
10. Acta Apostolorum apocrypha, ed. C. Tischendorf, cit., pp. 132-166. 11. Cfr. 1 Sam 17, dove lepisodio situato tra le alture di Azeka (oggi tell c Azeqa, a circa 20 km da Gerusalemme) e di Soco (tell Shuweika).
176
terzo del De situ Terrae Sanctae sia, di fatto, un coacervo di materiali provenienti dalle fonti pi disparate e come sia possibile, di conseguenza, che il termine in questione non fosse stato originariamente riferito allepisodio biblico di Davide e Golia; esso, inoltre, avrebbe potuto non essere altro che una variante del toponimo Zanawa o Zannoua, testimoniato in quellarea (ad es. khirbet Zanu, magari attraverso qualcosa come *beth-Zana(wa) o altro)12. Un interessante indizio, tuttavia, ci potrebbe venire dalla lettura dellItinerarium Antonini Placentini, che ci parla della stessa localit e la indica con un altro toponimo:In monte Gelbue, ubi occidit Dauid Golia. () Ibi enim iacet Golias in media uia, aceruum ligneum (ovvero: ingentem) ad caput. Congeries petrarum, mons excelsus, ita ut ad milia XX lapis mobilis non inueniatur, quia consecratio est quanticumque uel quotiescumque transierit, ternas lapides portantes et super ipsum tumulum iactantes. Nam in ipsis montibus numquam pluit, et nocturnis horis secretum sic: uidentes spiritua inmunda (ovvero: uidentur spiritu inmundo) uolui oculata fiet (fide?) tamquam uellera lanae aut certe undas maris13.
Tale testo ci descrive dunque, in un tenebroso luogo abitato nelle ore notturne da inquietanti fantasmi, la tomba di Golia, una sorta di grande tumulo che viene fatto oggetto, da parte dei pellegrini di passaggio, di un lancio di pietre rituale, come in segno di disprezzo. Ebbene, proprio lindicazione fornitaci dallItinerarium Antonini Placentini relativamente a questo gesto di esecrazione potrebbe rivelarsi particolarmente utile, specie se consideriamo il toponimo Buzana (e la variante Bizina del codice Guelferbytanus 4183) alla luce della radice ebraica che significa disprezzare e del sostantivo (bizz yn) disprezzo. Cos, il toponimo Buzana potrebbe forse spiegarsi come (tumulo del) disprezzo, sul quale il pellegrino cristiano continuava a perpetuare un antico gesto di esecrazione nei confronti delle spoglie del gigante filisteo, in qualche modo simile allanalogo gesto rituale compiuto ancora oggi dal fedele musulmano durante il pellegrinaggio alla Mecca.
12. J. Wilkinson, Jerusalem pilgrims, cit., p. 153; cfr. anche Eusebius Caesariensis, Onomasticon 92, 13 ss. 13. Itiner. Antonini Placentini 31, 1-4; per ledizione critica e per lillustrazione dei notevoli problemi testuali di tale opera, cfr. C. Milani, Itinerarium Antonini Placentini. Un viaggio in Terra Santa del 560-570 d.C., Milano 1977.
177
Resterebbe in ogni caso ancora oscura lannotazione esplicativa aggiunta da Teodosio al toponimo in questione: quod interpretatur lucerna. Di fatto, lItinerarium Antonini Placentini parla di misteriose apparizioni notturne che avvenivano in quel luogo, come fiocchi di lana o spuma del mare, forse luci che apparivano nelle tenebre, magari come fiaccole o lucernae, appunto. Ma lindizio resta decisamente assai labile. In conclusione, gi evidente dalla semplice analisi di tre toponimi tratti dal testo del De situ Terrae Sanctae come sia forse possibile ipotizzare e, talvolta, dimostrare la presenza nellopera di Teodosio di materiale lessicale che testimonia una notevole stratificazione linguistica, particolarmente evidente proprio nel caso dei toponimi stessi. Dunque, anche da questo punto di vista un testo che risulta oggettivamente povero sul piano prettamente letterario ed artistico, potrebbe invece rivelare uninsospettata utilit in campo storico-antichistico e, in particolare, linguistico.
(omissis)
178