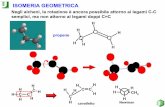Parte II Ottica Geometrica - link.springer.com978-88-470-5744-9/2/1.pdf · 130 Cenni storici: da...
-
Upload
trinhquynh -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Parte II Ottica Geometrica - link.springer.com978-88-470-5744-9/2/1.pdf · 130 Cenni storici: da...
Cenni storici: da Empedocle a Huygens
Gli albori
Il fenomeno della riflessione era noto fino dai tempi preistorici e gli specchi fu-rono il primo dispositivo ottico ad essere realizzato: antichi specchi metallici, ormai corrosi, possono ancora essere visti nei musei archeologici. Già nell’VIII secolo a.C. gli specchi di bronzo di Corinto e di Atene erano famosi per la finezza e l’ori-ginalità della lavorazione. Le prime citazioni scritte le troviamo poi nel libro dell’Esodo (38,8), dove si dice che Bezaleel utilizzò il rame degli specchi delle don-ne per il piedistallo e la conca per le abluzioni dell’Alleanza sinaitica, e nel libro di Giobbe (37,18), dove si paragona la lucentezza del cielo d’estate con quello degli specchi di metallo fuso (di bronzo lucidato). Anche le lenti erano note nell’antichità: l’ateniese Aristofane (480–388 a.C.), nella sua opera Le nuvole (424 a.C.), allude ad un cristallo limpido e trasparente venduto nelle botteghe e comunemente usato per accendere il fuoco. Lo storico Plinio (23–79 d.C.) racconta che i romani posse-devano vetri ustori; diverse sfere di vetro sono state trovate negli scavi archeologici, compresa una lente piano convessa a Pompei. Inoltre Seneca (3a.C. – 65 d.C.) notò che un globo di vetro riempito d’acqua poteva essere usato per ingrandire.
I primi sviluppi teorici si ebbero nell’antichità greca. Il punto di partenza per gli antichi filosofi greci era l’uomo stesso ed i suoi sensi. Ecco allora che non c’era la separazione netta che ora facciamo tra psiche e realtà esterna. Più che la natura della luce, interessava il processo della visione ed i fenomeni luminosi erano interpretati in modo globale, secondo una concezione sincretica della natura, nel tentativo di stabilire relazioni tra due elementi individuati come fondamentali: l’occhio e la cosa vista [Bevilacqua e Ianniello 1982].
La luce era parte integrante del senso della vista, fino al punto che questa usciva dagli occhi per vedere le cose, così come con il tatto le mani si usano per toccare le cose. Questa, in estrema sintesi, era l’idea di fondo, la metafisica, di una delle scuole di pensiero dell’antichità greca, che risale a Pitagora ed ebbe per sostenitori Euclide, Erone e Tolomeo. L’occhio era considerato come un punto da cui sono emessi dei raggi, immaginati ciascuno come una sorta di “tentacolo visuale”, i quali si aprono a forma di “cono” o di “piramide” con base sulla cosa vista. Eppure fu una linea di pensiero molto prolifica poiché aveva come principio regolatore il dato della pro-pagazione rettilinea della luce: da essa si svilupparono la prospettiva e l’ottica geo-metrica. Euclide (~ 330–260 a.C.) nel suo libro Ottica per la prima volta strutturò l’ottica della visione e della prospettiva in assiomi e teoremi. Vi troviamo la legge di propagazione rettilinea dei raggi visuali, le condizioni per cui le cose possono essere visibili o no ed implicitamente anche l’idea del potere risolutivo dell’occhio, per cui cose troppo piccole o lontane possono sfuggire all’osservazione, mentre «quelle cose che si vedono sotto più angoli, si vedono più distintamente». In Catot-
130 Cenni storici: da Empedocle a Huygens trica dimostrò per via geometrica la legge di riflessione, per la quale «i raggi visuali si riflettono ad angoli pari», sia per gli specchi piani sia per quelli curvi. 1
Anche Erone Alessandrino (tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C.) nel suo Catot-trica si occupò della riflessione, di specchi sferici e cilindrici e dei vari trucchi ottici che si possono fare con questi. Erone fu tra i primi a notare un’analogia tra la rifles-sione e l’esempio meccanico di un proiettile sopra una superficie. Se questa è sof-fice, il proiettile si ferma, analogamente i raggi visuali sono riflessi dalle superfici lucide piuttosto che da quelle ruvide. Erone riteneva che le superfici lucide, al con-trario di quelle ruvide, siano così compatte da non permettere ai raggi di cadere entro delle fessure. Invece il vetro e l’acqua riflettono la luce solo parzialmente poi-ché essi consisterebbero sia di parti compatte che riflettono i raggi che vi giungono, sia di parti porose che lasciano passare gli altri. Non soddisfatto dalle affermazioni geometriche di Euclide, Erone cercò una ragione più profonda per la propagazione rettilinea dei raggi e la legge di riflessione. Egli per primo ricondusse entrambe queste leggi al principio teleologico della minima distanza, che si è dimostrato di grande portata euristica nello sviluppo della scienza e che ora interpretiamo come principio variazionale. In comune con gli altri filosofi della sua scuola, riteneva che la velocità di propagazione dei raggi fosse infinita. Erone ne dà una splendida di-mostrazione: «quando, dopo aver chiuso gli occhi li apriamo e guardiamo il cielo, il raggio visuale non ha bisogno di tempo per raggiungere il cielo. Infatti vediamo le stelle nello stesso istante in cui le guardiamo, sebbene la distanza sia, per così dire, infinita».
La rifrazione fu studiata da Cleomede (~ 50d.C.) e poi da Tolomeo (~ 90 – ~168) che nel suo libro Ottica trattò le relazioni tra luce ed occhio, le condizioni di visibi-lità rispetto alla forma, colore e moto dei corpi, spiegò perché vediamo una sola immagine pur avendo due occhi, infine studiò la riflessione e la rifrazione. Oltre a provare sperimentalmente la legge di riflessione, ne cercò anche una spiegazione con l’esempio meccanico di una sfera lanciata contro una parete, notando che questa si oppone al movimento della sfera nella direzione perpendicolare alla parete, ma non a quello tangenziale. Tolomeo finalmente misurò con buona precisione gli an-goli di incidenza e di rifrazione tra aria ed acqua, aria e vetro, acqua e vetro, misure che i posteri interpretarono a torto come una relazione lineare tra i due angoli. Tut-tavia l’assoluta costanza delle differenze seconde delle sue tavole (0.5 per tutti e tre i casi!), con un passo di 10 per l’angolo di incidenza, fa pensare che abbia voluto accomodare le misure con una legge parabolica, che d’altra parte si accorda molto bene con i dati reali. Come per la riflessione egli confrontò la rifrazione con un esempio meccanico, quello del passaggio di un proiettile da un mezzo ad un altro di differente densità. Tolomeo fu un importante astronomo, autore dell’Almagesto, e discusse la rifrazione atmosferica sottolineando che solo allo zenit la posizione delle stelle coincide con quella apparente.
Altre scuole erano attive. Una era quella degli atomisti, come Leucippo (~ 480–
1 Alcuni pensano che Catottrica non sia di Euclide ma che sia invece stata scritta molti secoli dopo.
Gli albori 131 ~ 420 a.C.), Democrito (~ 460 – ~ 360 a.C.), Epicuro (340–270 a.C.) e Lucrezio (97–55 a.C.), che precorrono l’ipotesi corpuscolare. Essi sostenevano che ogni sen-sazione ha luogo in virtù di un contatto, ma dato che la nostra anima non esce per andare a toccare i corpi esterni bisogna che questi vengano a toccare la nostra anima, ma siccome neppure i corpi ci vengono incontro occorre che essi inviino alla nostra anima delle immagini che li rappresentino. Così nella loro teoria un flusso di scorze ( ), o simulacri, si stacca dai corpi conservandone la forma ed il colore, ed investe gli occhi determinando la visione, in analogia ai corpi che emettono suoni ed alle sostanze odorose che emettono particelle che colpiscono l’olfatto. Democrito riteneva che i colori fossero solo apparenze: nella sua concezione gli atomi sono individualmente privi di qualità come il colore, mentre le sostanze composte pre-sentano un colore che dipende dalla disposizione in cui sono arrangiati i loro ele-menti; le apparenze del colore si presentano poi sotto quattro specie: bianco, nero, giallo e rosso. Lucrezio in una bella pagina del suo De rerum natura (IV, vv. 379-461), dove tratta le illusioni ottiche, è tra i primi a notare la differenza tra realtà e la rappresentazione che ne fa la nostra psiche, affermando che «gli occhi non possono conoscere le leggi della natura: non imputare alla vista l’errore dello spirito» (IV, 385-386).
La scuola di Empedocle (~ 490 – ~ 435 a.C.) e di Platone (427–347 a.C.), allievo di Socrate, sosteneva poi l’ipotesi di una doppia emissione che combinava le due precedenti teorie; Platone espresse la necessità che la visione fosse determinata dall’incontro di un agente esterno, il chiarore che parte dall’oggetto e produce il colore, con il fuoco visuale che è dentro di noi, emesso dagli occhi: in questo modo poteva spiegare l’impossibilità di vedere al buio ed anche i sogni, come effetto del fuoco interno. Aristotele (384–322 a.C.), a sua volta allievo di Platone, considerava invece la luce non una sostanza corporea ma una modificazione del mezzo (il dia-fano) indotta dai corpi, precorrendo l’idea di un etere, di cui l’occhio percepisce il “movimento”. Diversamente da Empedocle, questa modificazione era concepita da Aristotele come una qualità che tutto il mezzo acquisisce simultaneamente, e dun-que egli fu tra i primi a sostenere che la luce si propaghi istantaneamente. Tutte queste scuole convissero per molti secoli ed in ciascuna di esse possiamo ritrovare idee che, purificate dal tempo, ancora sopravvivono nelle moderne teorie.
Come applicazione di un dispositivo ottico è poi da citare che (secondo gli storici romani) Archimede (287–212 a.C.) mise in pratica una delle affermazioni di Euclide della Catottrica (la 31a), per la quale si può accendere un fuoco con uno specchio concavo opposto al Sole, ed usò degli specchi ustori per mandare a fuoco le navi romane che assediavano Siracusa. Ancora oggi parliamo di piani focali e di mettere a fuoco! Le fornaci solari termiche funzionano con la stessa disposizione degli spec-chi di Archimede.
Vi è un aspetto della filosofia antica che deve essere considerato per le sue gravi conseguenze nello sviluppo della scienza: Platone in particolare insisté a fondo sulla considerazione che i sensi sono imperfetti e quindi ingannevoli; dunque il “mondo apparente” rappresentato dalla psiche non dà garanzia di corrispondere al “mondo reale”. Questo modo di ragionare, condiviso da tutti i filosofi antichi, ebbe due ef-
132 Cenni storici: da Empedocle a Huygens fetti importanti. Il primo fu di stabilire una gerarchia di affidabilità tra i sensi. Al tatto era riconosciuta la fiducia maggiore, mentre la vista era considerata il senso più fallace. Qualsiasi strumento posto tra l’occhio e la cosa vista, a “complicare le cose”, fu trattato con disprezzo. Il secondo effetto fu più sottile: l’unico strumento affidabile che rimaneva disponibile per la comprensione del mondo era la mente; la speculazione astratta, ed in particolare l’idealizzazione matematica, perfetta, ebbe fino al Rinascimento un’esagerata considerazione dai dotti rispetto all’osservazione e alla ricerca sperimentale [Ronchi 1983].
L’aver ridotto l’occhio ad un punto aveva costituito una buona schematizzazione per lo sviluppo della prospettiva con l’efficace idea dei raggi visuali. Tuttavia fu di ostacolo per la comprensione del meccanismo intimo della visione. Il successivo salto di qualità fu fatto da un medico, Galeno di Pergamo (129–200), il quale iniziò un processo di separazione concettuale tra processi fisici e fisiologici. Egli studiò l’anatomia dell’occhio e dette corpo all’idea platonica di un doppio flusso: un pneuma luminoso proveniente dal cervello scorre lungo il nervo ottico e la retina per interagire con la luce che dall’esterno raggiunge l’occhio. Da questa interazione si producono allora le immagini nel cristallino che vengono infine trasmesse indie-tro al cervello tramite la retina ed il nervo ottico.
Il periodo arabo
Dal mondo greco romano la fiaccola della cultura passò al mondo arabo e nel IX e X secolo fiorì a Bagdad una scuola medica importante. Un settore particolarmente sviluppato fu lo studio delle malattie degli occhi ed i medici arabi tradussero in arabo le opere di Galeno e si occuparono della struttura del globo oculare e dell’ap-parato visivo.
Un grande scienziato che si occupò di fondare una teoria della visione su basi fisico-fisiologiche fu Abu Ysuf Yaqub ibn Is-haq (~ 813 – ~ 873), che visse a Basra ed a Bagdad. Egli fu noto in occidente col nome di Al-Kindi e delle sue opere tra-dotte in latino sono da menzionare il De radiis stellatis ed il De aspectibus. La prima è essenzialmente un’opera astrologica che tratta degli influssi stellari sul mondo terrestre. Qui Al-Kindi introdusse l’idea della “propagazione rettilinea” delle forze: egli riteneva che il Sole, le stelle, i magneti, il fuoco, il suono irraggiassero sugli oggetti circostanti un potere che in qualche modo li modifica. Queste forze potreb-bero perciò spiegare i fenomeni naturali. Concordemente nel De aspectibus Al-Kindi afferma che la visione non avviene mediante simulacri o raggi visuali, ma per effetto di raggi rettilinei emessi da ciascun punto dei corpi illuminati e capaci di agire sull’occhio. Questa ultima assunzione finalmente liberava la luce dalle conce-zioni greco romane per cui le cose erano considerate visibili solo globalmente, tra-mite un cono di raggi, oppure come l’ingresso nell’occhio di un flusso di forme coerenti, nell’ipotesi atomistica che ancora non aveva dato alcun frutto.
Circa un secolo più tardi Ibn al-Haythan al-Hazin (~ 965–1039), noto col nome
Il periodo arabo 133 di Alhazen, eseguì molte osservazioni di carattere sia fisico che fisiologico, tra cui un’accurata anatomia dell’occhio, e giunse alla conclusione che la luce sia un agente esterno che penetra negli occhi e che si propaga in linea retta, asserendo che il mo-vimento della luce richiede un tempo finito, anche se impercettibile. A lui dobbiamo la prima descrizione di una camera oscura con un forellino che utilizzò per osservare le eclissi di Sole. Egli dunque respinse il compromesso platonico di un doppio flusso e finalmente operò una sintesi tra l’idea di luce come entità esterna e l’idea di raggio. Rovesciando le concezioni prospettiche, il flusso luminoso ha ora per vertice i punti dell’oggetto luminoso e per base la pupilla. Ma di questo cono Alhazen considerava il solo raggio principale, normale alla superficie dell’occhio, ed individuava nel cri-stallino la sede di formazione delle immagini come corrispondenza punto a punto con l’oggetto. Tuttavia parlava ancora della luce come costituita da forme prove-nienti dagli oggetti visibili che poi raggiungendo l’occhio “si fissano” alla superficie del cristallino. Egli conosceva il principio della camera oscura e con ciò probabil-mente voleva evitare il problema del rovesciamento dell’immagine che si produce sulla retina [Ronchi 1983]. Il nervo ottico era poi individuato come il canale che porta al cervello il segnale luminoso. Tra l’altro spiegava il fenomeno della visione binoculare assumendo che i segnali dei due occhi siano ricongiunti in un nervo vi-suale. Egli poi descrisse le illusioni ottiche che derivano da una falsa interpretazione di una figura da parte della mente umana e della sua immaginazione.
Alhazen si occupò anche di riflessione, correggendo l’errore dei greci riguardo alla posizione delle immagini generate da specchi curvi, e della rifrazione con sfere di vetro. In particolare egli riprese i concetti meccanici di Erone e Tolomeo sulla riflessione attribuendo ai corpi riflettenti la proprietà di una forza di repulsione o di opposizione che è maggiore per i corpi lucidi rispetto a quelli ruvidi. Come Erone, egli ne notò l’analogia con i corpi duri o soffici ed attribuì alla compattezza e non alla rigidità la responsabilità della riflessione, affermando però che alcuni corpi ru-vidi diffondono la luce poiché sono composti di piccole parti lucide variamente orientate, mentre i pori tra le parti compatte dei corpi ruvidi permettono ad una parte della luce di penetrare nei corpi senza poi riemergere fuori. Di Tolomeo sviluppò le considerazioni di natura meccanica con l’esempio di una sfera di ferro o rame che colpisce uno specchio di ferro: la riflessione viene spiegata da Alhazen con la de-composizione del movimento in una componente tangenziale ed in una perpendico-lare alla superficie riflettente. Mentre la componente tangenziale non viene modifi-cata, quella perpendicolare viene prima annullata nell’urto con lo specchio e poi il movimento opposto è acquistato dalla forza di repulsione, per cui il corpo riflettente agisce come una molla. In questo modo spiegava come la luce è riflessa ad angoli eguali sul piano di incidenza, ortogonale allo specchio. Più complesso è il caso della rifrazione. Alhazen assunse che la velocità della luce fosse una proprietà del mezzo e che in particolare questa velocità fosse maggiore nei corpi rarefatti rispetto a quelli densi: a causa della loro densità tutti i mezzi trasparenti resistono al movimento della luce e più densi sono più grande è la resistenza che offrono. Nella rifrazione egli portò come esempi un proiettile, lanciato contro una tavola, ed una spada che incida su di un pezzo di legno, notando che l’effetto di rottura maggiore si ha quando
134 Cenni storici: da Empedocle a Huygens il moto è ortogonale alla superficie. Egli dunque assunse che nella rifrazione il mez-zo offra una resistenza maggiore nella direzione parallela alla superficie, per cui la luce viene deviata verso la direzione normale.
Due filosofi arabi, Avicenna (980–1037) e Averroé (1126–1198), iniziarono il dibattito sulla distinzione tra lumen e lux [Bevilacqua e Ianniello 1982]. Avicenna distinse infatti la lux, o “brillantezza”, che si vede negli oggetti luminosi, come il fuoco od il Sole, dal lumen, o “splendore” che sarebbe l’effetto della lux sul mezzo e sui corpi illuminati. Egli inoltre sottolineò gli aspetti psicologici della lux e ridusse quelli fisici del lumen a forme o species materiali, stimolando la ripresa della teoria atomistica dell’emissione di simulacri da parte degli oggetti, lasciando però da parte i dettagli della natura dei simulacri stessi. La relazione tra lux e lumen implicava però una modifica delle concezioni aristoteliche per cui la luce era uno stato del mezzo, mentre ora veniva concepita come una qualità degli oggetti luminosi che è percepita tramite il lumen. Sorse dunque il problema di definire la natura del lumen e del colore nel mezzo. Già abbiamo visto che per Alhazen il lumen fu concepito come forma della lux. Averroé distinse invece tra esistenza spirituale ed esistenza corporea della luce e dei colori: nell’anima avrebbero un’esistenza spirituale, nei corpi trasparenti un’esistenza intermedia tra la spirituale e la corporea. Con una lunga evoluzione, il lumen venne assumendo il significato di agente fisico ogget-tivo, esterno, della visione, mentre nella lux rimangono gli aspetti soggettivi, psico-logici, come ad esempio il colore, di un processo che gli autori antichi considera-vano come unitario. Mentre il primo termine divenne il campo di studio della fisica, specialmente dal 1600 in poi, il secondo rimase per molto tempo appannaggio dei filosofi che inserirono il dibattito sulla lux in quello della “metafisica della luce” alla quale prima di Averroé aveva dato impulso in particolare Sant’Agostino (354 –430). Invece le scorze, che avevano preso il nome di species, ed il lumen furono oggetto di discussione soprattutto per stabilire se si trattava di “sostanze”, “acciden-ti” o “qualità”.
Il Medioevo
Tra il 1100 ed il 1200 furono tradotte in latino molte opere arabe. Anche le fon-damentali opere greche, che gli arabi avevano custodito, vennero ritradotte dall’a-rabo e restituite all’occidente, dove riaccesero il dibattito filosofico. Nacquero le prime Università, come quelle di Bologna, Parigi ed Oxford, che inizialmente do-vevano servire per l’educazione del clero. Tra i vari pensatori che vi lavoravano, possiamo ricordare l’opera di Roberto Grossatesta e dei francescani Ruggero Ba-cone e John Pecham. In Oxford Grossatesta (1175 1253), che fu vescovo di Lin-coln, acquisì dalla cultura araba la concezione, quella di Al-Kindi in particolare, di un universo dominato da species che si propagano nello spazio e che sono causa di ogni fenomeno: nella sua concezione metafisica la lux è la forma corporea fonda-mentale ed il principio del moto, da cui l’universo si è formato. Egli dunque assegnò
Il Rinascimento 135 all’ottica geometrica il ruolo di scienza principale della natura. Grossatesta ebbe anche il merito di scrivere un libro sull’arcobaleno, De Iride, in cui finalmente si faceva l’ipotesi che l’arco colorato derivi dalla rifrazione della luce solare in una nuvola, proprio come i colori si formano quando la luce passa attraverso una caraffa d’acqua [Hall e Hall 1979]. Bacone (1214–1294), discepolo di Grossatesta ed erede della tradizione neoplatonica e matematizzante, riprese l’opera di Alhazen, di cui difese l’idea di una velocità finita della luce, contro l’opinione di Aristotele ed Al-Kindi. Bacone identificò le forme di Alhazen con le species neoplatoniche ed uni-ficò la tradizione euclidea con quella aristotelica e galenica. In particolare riteneva che le species emesse da ogni punto dei corpi visibili raggiungessero l’occhio dell’osservatore adattandosi alla superficie del cristallino con lo stesso ordine spa-ziale dei punti che le avevano generate. Sostenendo la necessità di sperimentare, egli studiò la formazione delle immagini in una camera oscura, la rifrazione, l’ar-cobaleno, di cui diede un valore quasi esatto per l’angolo tra il Sole, il centro del-l’arcobaleno e l’occhio dell’osservatore e ne associò i colori a quelli prodotti da un prisma, scoprì l’aberrazione sferica degli specchi e fece esperimenti con specchi parabolici e lenti piano-convesse. Pecham (m. 1292), arcivescovo di Canterbury, scrisse un testo che costituì la base per la prospettiva pittorica rinascimentale. Uno studio particolareggiato dell’arcobaleno, con i suoi archi primario e secondario, venne fatto anche da un domenicano tedesco, Teodorico di Freiberg (m. 1292), nella scia della tradizione aristotelica. Egli portò diversi esperimenti a sostegno che l’ar-cobaleno sia causato da due rifrazioni ed una riflessione sulla superficie di gocce sferiche, e della sua spiegazione, ripresa da Averroé, che i colori provengano da varie misture di luce e oscurità.
Ma il principale mediatore degli studi di Alhazen fu il matematico polacco Erazm Ciolek (1230–1275), molto più noto come Vitellione o Witelo, che visse e studiò in Italia. La sua opera fu molto studiata nel medio evo, dapprima in edizioni mano-scritte e poi pubblicata nel 1533. Tra i suoi contributi vi furono la spiegazione dei colori dell’arcobaleno, come originati dalla rifrazione e dalla riflessione nelle gocce d’acqua, e la proposta di uno specchio parabolico per focalizzare la luce del Sole. Come Alhazen e Bacone egli riteneva che i mezzi trasparenti resistano alla propa-gazione della luce in funzione della loro densità, e diede una spiegazione della ri-frazione analoga a quella di Alhazen. Finalmente nel 1572 il manoscritto di Alhazen fu tradotto in latino e pubblicato in un volume in folio, seguito dai 10 libri di Vitel-lione.
Il Rinascimento
Dopo quelli di Alhazen e Bacone i contributi di maggior rilievo non vennero però dai dotti, ma dagli artigiani. All’inizio in modo casuale e confuso e poi in modo sempre più sistematico e preciso, essi svilupparono tecniche e strumenti che saranno una delle cause principali alla rivoluzione scientifica. In particolare le lenti, le len-
136 Cenni storici: da Empedocle a Huygens tecchie di vetro, riscoperte e probabilmente importate dall’Islam, si diffusero in oc-cidente. Verso la fine del XIII secolo, furono inventati gli occhiali per correggere la presbiopia, ma il loro inventore, più probabilmente un pisano, è rimasto sconosciuto [Rosen 1966]. Con lo sviluppo dell’arte vetraria veneziana gli occhiali iniziarono ad essere prodotti e commerciati già dal 1301 ed il primo pittore a rappresentarli fu Tommaso da Modena in un dipinto del 1352, Il cardinale Ugo di Provenza, conser-vato nel seminario vescovile di Treviso. Il modo di funzionare delle lenti metteva in crisi le teorie dei dotti tardo-medievali, ancora alle prese con le species (eredi dei simulacri) od i raggi visuali. Essi anzi le osteggiavano ritenendo che le lenti produ-cessero illusioni ottiche, ai margini della magia, in un periodo storico dove questo era estremamente sospetto per una scienza della visione così legata alla filosofia ed alla teologia.
Il più illustre tra gli artigiani fu Leonardo da Vinci (1452–1519), che fece una serie di osservazioni, principalmente di ottica fisiologica, connesse allo studio della prospettiva. Tra queste egli notò che la pupilla si dilata nell’oscurità e discusse come gli occhiali possano aiutare la vista. La sua idea di luce era quella di species che si propagano in linea retta e che sono emanate dai corpi illuminati, e si occupò di fo-tometria descrivendo un apparato per confrontare tra loro sorgenti luminose, in base alle ombre prodotte da un ostacolo comune. Con questo concetto Leonardo associò esplicitamente il funzionamento dell’occhio a quello della camera oscura: egli portò a paragone la formazione delle immagini che si producono su di uno schermo per la luce che attraversa un piccolo forellino, e fece anche notare che queste immagini sono rovesciate. In base ai suoi studi anatomici Leonardo suppose che nell’occhio i raggi fossero focalizzati due volte, prima dalla cornea e poi dal cristallino, a cui assegnò il compito di raddrizzare le immagini che si sarebbero formate sulla “sen-sitiva”, cioè sulla retina. Egli disegna il cristallino come se avesse una forma sferica, per via della deformazione che gli occhi subivano con i suoi trattamenti di bollitura, e ciò non gli poteva consentire di comprendere il reale cammino dei raggi.
Leonardo si occupò anche di lenti e specchi. Nei suoi manoscritti vi è il progetto di una macchina per molare specchi concavi, la discussione della produzione di lenti da occhiali, la descrizione di come usare una singola lente per osservare ingranditi oggetti lontani, e nel codice F, folio 25, sembra che ci sia pure la descrizione di un telescopio a due lenti di tipo galileiano [Argentieri 1939]. Tuttavia queste sue note rimasero nascoste e sostanzialmente senza effetto nello sviluppo dell’ottica.
Nel Rinascimento italiano sono anche da ricordare i dotti Giovanni Rucellai (1475–1525), Gerolamo Cardano (1501–1576) e Daniele Matteo Alvise Barbaro (1514–1570). Rucellai, per primo utilizzò uno specchio concavo come microscopio semplice e lo usò per osservare le api. Cardano descrisse i “colori dell’arcobaleno” prodotti da prismi di vetro alla luce del Sole, e per la prima volta cita l’applicazione di una lente al foro di una camera oscura, per osservare immagini «di ciò che accade sulla strada». Ma è Barbaro che fece la più accurata descrizione delle immagini prodotte da una lente convergente proiettate su di uno schermo bianco, proponen-done l’uso nell’arte pittorica della prospettiva.
Ma seguendo la regola generale per cui la scienza procede ogni qual volta viene
Il Rinascimento 137 introdotto un nuovo strumento che dimostri valore ed utilità pratica, in questo caso le lenti e poi il telescopio, una vera rivoluzione sconvolse gli ambienti accademici, e questo avvenne per opera di persone di grande ingegno, alcune delle quali osarono perfino sfidare quell’infamia che fu il tribunale dell’inquisizione.
Giovan Battista della Porta (1535–1615) passò buona parte della sua vita giro-vago in Europa ad intervistare dotti ed artigiani alla ricerca di «maraviglie» ed at-trazioni naturali. Nel 1589 pubblica la Magia Naturalis, una miscellanea di feno-meni e credenze singolari d’ogni tipo, e ne dedica un intero capitolo ai dispositivi ottici ed alle lenti, descrivendo anche l’applicazione di una lente al foro della camera oscura e riconoscendone l’analogia con l’occhio. Tra le molte cose, sulla traccia dei trucchi di Erone, descrive come usare gli specchi piani, concavi e cilindrici per ot-tenere qualche effetto sorprendente, la combinazione di specchi piani ed i molteplici usi delle lenti: per la vista, come microscopi semplici, per accendere fuochi, e la «composizione» di una lente positiva e una negativa per migliorare la vista. Egli decisamente contrastò la tradizione che considerava la vista un senso ingannevole e le lenti degli ordigni fallaci, ed anzi sostenne che le lenti sono utili e perfino neces-sarie alla vita umana. Le lenti infatti si erano già molto diffuse, sia per correggere la presbiopia che la miopia, ed i dotti accademici non potendone spiegare il funzio-namento con le teorie di ottica correnti a quel tempo, si limitavano ad ignorarle. Della Porta rese invece evidente questa lacuna ad un vasto pubblico, a riprova del filone “magico” alla diffusione del metodo sperimentale. Dunque queste teorie do-vevano essere riformate e, sebbene in modo confuso e sostanzialmente errato, egli fu il primo a tentare una trattazione teorica di lenti e specchi pubblicandola nel suo De Refractione nel 1593. Quando Galileo rese pubbliche le sue scoperte astronomi-che, Della Porta cercò di rivendicare a sé la priorità dell’invenzione del telescopio, che gli fu del resto accreditata dai membri dell’Accademia dei Lincei, di cui faceva parte. Ormai vecchio e malato iniziò a scrivere un libro sul telescopio, ma nel ten-tativo di spiegarne il funzionamento incontrò tanta difficoltà da sconfortarlo pro-fondamente. Il manoscritto fu smarrito ed è stato ritrovato solo in epoca recente nella biblioteca dell’Accademia dei Lincei e pubblicato a cura di V. Ronchi.
Di straordinario valore scientifico, purtroppo a lungo nascosto ai suoi contempo-ranei, fu il contributo di Francesco Maurolico da Messina (1494–1574), un padre francescano che ben doveva conoscere il lavoro di Alhazen, essendo figlio di un medico esule da Bisanzio. Tra l’altro il ritrovare le opere scientifiche del passato fu una delle sue preoccupazioni: a lui dobbiamo l’aver raccolto quanto è sopravvissuto delle opere di Archimede, di Teodoro, di Apollonio di Perga, ecc. Precedendo di 50 anni Keplero, egli risolse o perlomeno impostò quasi sempre correttamente molti problemi di ottica e della visione. In particolare egli definì i raggi come emessi con-tinuamente in tutte le direzioni da ogni punto di un corpo luminoso. Li considerò dotati di diversa “densità” e ne fece subito applicazione riguardo all’intensità del-l’illuminazione prodotta da fasci di diversa densità ed inclinazione. Studiò le ombre, i diaframmi, la rifrazione, la riflessione da specchi piani e sferici, arrivando final-mente a spiegare la formazione delle immagini da specchi sferici, notando che do-vevano avere diametro piccolo rispetto al raggio di curvatura e che in generale i
138 Cenni storici: da Empedocle a Huygens raggi provenienti da un singolo punto formano delle caustiche. Sviluppò l’anatomia dell’occhio ben oltre le conoscenze di Galeno e di Alhazen: egli attribuì al cristallino il compito di rifrangere i raggi in analogia con le lenti, spiegò la miopia e la pre-sbiopia attribuendola ad un’errata curvatura del cristallino rispetto alla profondità dell’occhio, e finalmente considerò la retina come sede di formazione delle imma-gini, ma diritte!, nonostante avesse ben compreso che queste immagini si formano non solo per il raggio principale, ma per la convergenza di tutti i raggi raccolti dalla pupilla e rifratti sulla retina, in corrispondenza di ciascun punto della cosa osservata. Egli stesso portava occhiali per correggere la sua presbiopia e ne spiegò corretta-mente il funzionamento, sebbene solo intuitivamente, insieme a quello delle lenti divergenti per correggere “la vista corta” dei giovani. I sui manoscritti Photismi de lumine et umbra ad perspectivam, et radiorum incidentiam facientes e Diapha-norum libri portano come ultima data il 1555 ed il 1554 rispettivamente, ma furono purtroppo pubblicati postumi solo nel 1611.
La scienza nuova
Il Rinascimento italiano non è da ricordare solo per le arti, ma anche per la cul-tura. Le Università italiane del XVI secolo superavano tutte le altre per il livello e l’originalità degli insegnamenti, richiamando molte personalità anche dall’estero. Padova primeggiava per la medicina e per la ricerca sulla logica della scienza spe-rimentale. Bologna era invece famosa per l’astronomia e là in particolare vi studiò Nicolò Copernico (1473–1543). Il sistema astronomico tolemaico dei cicli ed epi-cicli, impregnato della concezione gerarchica aristotelica, stava cominciando a mo-strare i suoi difetti: era complicato e le sue previsioni si scostavano anche di setti-mane dalle osservazioni. Lo stesso papato aveva stimolato la ricerca di un nuovo sistema per rettificare gli errori del calendario, da cui dipendeva il calcolo della data della Pasqua. La previsione esatta dei fenomeni astronomici stava divenendo anche un fatto cruciale per la determinazione della longitudine nella navigazione oceanica e nell’esplorazione geografica. Tra i vari tentativi, quello di Copernico ebbe suc-cesso e le sue tavole furono poi usate per la riforma del calendario di papa Gregorio XIII introdotta nel mese di ottobre del 1582. Mentre Tolomeo si limitava a dare la posizione apparente degli astri visti dalla Terra, Copernico voleva determinare an-che le distanze ed ottenere quindi il moto effettivo dei pianeti. Guidato da una con-cezione di armonia del mondo di tipo platonico egli trovò che ponendo il Sole al centro del sistema si aveva una semplificazione delle orbite dei pianeti e soprattutto che i loro periodi orbitali formavano una progressione regolare con le distanze dal Sole. Tuttavia considerò solo orbite circolari e non tutti gli epicicli furono eliminati (anche il Sole ne aveva uno, concentrico con l’orbita terrestre). Il passo successivo fu compiuto da Keplero con la scoperta che le orbite erano ellittiche. Mancava però ancora una prova convincente che il nuovo ordine astronomico fosse reale, e non solo un artifizio geometrico. Questo compito toccò a Galileo.
La scienza nuova 139
Nel 1590, artigiani sconosciuti, probabilmente occhialai, costruirono il primo cannocchiale di cui si abbia notizia, giusto un anno dopo la pubblicazione di Magia Naturalis, dove Della Porta faceva un’oscura considerazione sulla combinazione di una lente convergente con una divergente. Secondo un documento del 1634 uno di questi primi esemplari fu composto in Italia e portato in Olanda, dove nel 1604 fu riprodotto da Zacharias Jansen (1588–1632) e diffuso in commercio dagli artigiani olandesi [Ronchi 1968; Herzberger 1966]. In particolare dagli archivi di Den Haag risulta che Hans Lippershey (1587–1619) chiese un brevetto sul cannocchiale il 2 ottobre 1608. Ma questi strumenti, fatti con lenti da occhiali, erano affetti da forti aberrazioni ed il loro ingrandimento era limitato a tre: non lo si poteva aumentare senza che le immagini viste apparissero confuse. Con una qualità così scarsa ed un ingrandimento così basso questi primi telescopi erano quasi inutili, per cui ottennero un’accoglienza poco favorevole dal pubblico. Ma nel 1609 questa novità venne a conoscenza di Galileo Galilei (1564–1642) che a quel tempo era lettore alla Uni-versità di Padova. Là aveva impiantato una fiorente officina dove produceva stru-menti scientifici molto richiesti in Europa, tra cui il suo “compasso geometrico e militare”.
Galileo s’appassionò talmente al cannocchiale che se ne costruì presto un esem-plare e poi molti altri. Egli si rese subito conto che la “bontà” delle lenti era un fattore cruciale e ne andò selezionando le migliori, giungendo rapidamente a risul-tati considerevoli. In poche settimane costruì un telescopio dapprima con sei e poi con otto ingrandimenti. Galileo si rese conto d’avere in mano un oggetto rivoluzio-nario e che avrebbe dovuto vincere le ostilità del mondo accademico. Molto abil-mente aggirò questa situazione rivolgendosi direttamente ai potenti del tempo. Prima scrisse al Doge di Venezia, Leonardo Donato, sostenendo di aver costruito uno strumento utile in campo militare, e presentò il suo cannocchiale da otto ingran-dimenti al senato di Venezia. Sebbene il Doge non desse seguito ad una produzione militare del telescopio, Galileo raggiunse il suo scopo: la sua fama si diffuse e dal Doge ebbe la conferma a vita della sua cattedra a Padova con un ottimo stipendio ad personam. Ma questo fece esplodere in modo violento la reazione degli altri ac-cademici, che per di più ritenevano che tanto prestigio derivasse da un imbroglio. Galileo non si fermò: nei mesi successivi costruì cannocchiali sempre migliori, fino a venti ingrandimenti, e li usò per osservare la Luna e gli astri. Per giungere ad un così buon risultato Galileo era giunto alla conclusione di usare degli obiettivi grandi e poi diaframmarli opportunamente secondo le loro caratteristiche individuali. Ga-lileo si rese conto di aver trovato un tesoro nelle osservazioni astronomiche. Con la scoperta dei satelliti di Giove portò un colpo mortale alle concezioni di quel tempo sull’Universo: quegli stessi satelliti rappresentavano un piccolo sistema coperni-cano all’interno di quello solare, le fasi di Venere dimostravano poi che quel pianeta veniva a trovarsi rispetto alla Terra a volte più vicino, a volte più lontano del Sole, e questo già bastava a falsificare il sistema tolemaico, La Luna mostrava montagne come quelle terrestri. Ma le ostilità degli accademici, le implicazioni teologiche, la rottura con la tradizione tomista ed aristotelica, erano talmente gravi che la prote-
140 Cenni storici: da Empedocle a Huygens zione del Doge non doveva bastare. Desiderando tornare nella sua terra d’origine2, egli dunque prese contatto con i Medici di Firenze e con il loro benestare presentò i satelliti di Giove col nome di Medicea Siderea nel suo Sidereus Nuncius. Inviò una copia di questa pubblicazione ed un esemplare dei suoi cannocchiali al Granduca Cosimo II dei Medici, che era stato suo allievo nell’estate del 1605, e tramite il Granduca li fece pervenire anche a vari principi europei, affinché fossero i loro esperti a dare un giudizio sullo strumento e sul contenuto del libro. Nell’aprile del 1610 Galileo si recò a Pisa per presentare il suo telescopio al Granduca ed agli ac-cademici di quella Università. A settembre dello stesso anno lasciò Padova per sta-bilirsi a Firenze e volle ed ottenne oltre al titolo di Matematico anche quello di Fi-losofo. L’opposizione dei cattedratici intanto stava estendendosi a tutti gli atenei, ma il giudizio favorevole alle osservazioni di Galileo espresso da Keplero, alla fine del 1610, e dai Padri del Collegio Romano, nell’aprile del 1611, segnarono nel tempo la vittoria di Galileo e dell’ottica nuova che stava nascendo.
D’altra parte le obiezioni che venivano mosse erano metodologicamente rile-vanti. Di fronte all’evidenza sperimentale proclamata da Galileo si obiettava che il problema era di carattere teorico, dato che in base alle teorie di quel tempo il can-nocchiale non poteva essere considerato uno strumento valido poiché costruito con lenti che “deformano” la realtà. Una teoria che spiegasse il funzionamento del can-nocchiale ancora non esisteva e Galileo evitò di ribattere sul piano teorico, dal mo-mento che aveva lavorato solo empiricamente. Per di più, almeno nelle questioni di ottica geometrica, egli utilizzò le concezioni medioevali delle species e dei raggi visuali dei suoi avversari e non volle nemmeno rispondere alle sollecitazioni che gli venivano dall’amico Sagredo, che non credeva all’esistenza ed all’utilità di questi raggi e che da autodidatta divenne più esperto di ottica geometrica dello stesso Ga-lileo.
Ma il contributo di Galileo fu soprattutto di metodo: egli comprese che occorreva ripartire dalla matematica per capire il mondo e sosteneva che le leggi della natura sono di tipo matematico, uguali in tutto l’universo, e che da queste si potevano de-terminare le quantità, non solo le qualità. Vero padre del metodo scientifico mo-derno, ipotetico-deduttivo, comprese che occorreva iniziare da problemi semplici, ponendosi sperimentalmente in condizioni opportune con approssimazioni ragione-voli, come quella di minimizzare l’attrito. La sua invenzione di esperimento ideale consentiva inoltre di stabilire delle conclusioni anche senza eseguire l’esperimento stesso.
Coerentemente con la sua concezione meccanica ed atomistica del mondo, Gali-leo riteneva che la luce fosse composta da un flusso velocissimo di quanti conside-rati come le ultime particelle indivisibili in cui la materia potrebbe essere suddivisa dal calore o da altri mezzi. Nella Giornata Prima dei Dialoghi delle nuove scienze
2 Questa scelta di tornare a in Toscana fu poco felice: I Medici erano poco più che dei vassalli del dominio papale e l’inquisizione aveva il controllo del territorio. D’altra parte Galileo era appassionatamente sicuro della verità delle sue scoperte e voleva incontrare i cardinali e convincerli che la Nuova Scienza era, oltre che vera, utile alla Fede.
La scienza nuova 141 del 1638 (noto anche come Discorsi), Galileo descrive il suo tentativo di misurare la velocità della luce in cui due persone, distanti circa un miglio tra loro, vanno coprendo e scoprendo una lanterna, l’uno in risposta dell’altro. Per la brevità del percorso il ritardo percepito, tra andata e ritorno del segnale, era troppo piccolo per essere stimato e Galileo arrivò alla conclusione che la propagazione della luce, se non è istantanea, deve essere velocissima.
Galileo fu anche uno degli inventori del microscopio composto [Vavilov 1965]. Egli aveva presto notato che gli oggetti vicini potevano essere osservati con un te-lescopio semplicemente allungandolo, e che l’ingrandimento aumentava. Così, già nel 1610, usò il cannocchiale anche come microscopio, tuttavia questo strumento era molto lungo e poco pratico. In seguito, nel 1624, Galileo costruì un microscopio completamente nuovo (l’occhialino) con distanze focali delle lenti molto piccole, per cui il tubo ne risultava molto accorciato, e con una regolazione fina della posi-zione dell’obiettivo. Con spiccato senso degli affari Galileo non solo mise in com-mercio il telescopio per rispondere a tutte le richieste che gli venivano da ogni parte d’Europa, ma anche il microscopio. Di queste notizie ne è rimasta traccia in varie lettere, anche se non pubblicò niente sul microscopio. Così come col telescopio ini-ziò una nuova era in astronomia, con il microscopio iniziò una nuova era nelle scienze biologiche e già nel 1625 Francesco Stelluti pubblicò un libro sulle api in cui riporta le osservazioni anatomiche fatte con un microscopio di Galileo.
Galileo riteneva che la fisica può risolvere i misteri della natura con ragiona-menti, osservazioni ed esperimenti accessibili a chiunque. Egli aveva sperimentato personalmente l’amarezza di non essere creduto e la necessità che altri ripetessero le osservazioni. Egli fu un vero uomo di fede che credeva che la verità fosse una sola e che dunque non ci poteva essere contraddizione tra religione e scienza. Nella bellissima lettera che scrisse nel 1615 a Madama Cristina di Lorena3 egli espose il programma scientifico della sua Nuova Scienza, sostenendo la relazione di comple-mentarità che deve esistere tra scienza e fede ed il perfezionamento che la fede può ricevere dalle scienze naturali, poiché la Natura è «osservantissima essecutrice de gli ordini di Dio». Rispondendo alle accuse che gli venivano mosse di confutare le Sacre Scritture, egli offre una soluzione teologicamente ineccepibile e modernis-sima: la Bibbia non va presa alla lettera, ma va invece correttamente interpretata nel contesto storico, sociale e religioso del tempo in cui fu scritta4. Mirando «alla salute
3 Questa lettera era implicitamente diretta al cardinale Bellarmino, l’inquisitore che nell’anno 1600 aveva fatto bruciare sul rogo Giordano Bruno. 4 Galileo fece uso di questa sua intuizione di come interpretare la Sacra Scrittura per sostenere la teoria Copernicana e per salvaguardare la libertà di ricerca, ma limitato dai condizionamenti del suo proprio tempo non poté andare oltre. Occorrerà attendere fino al Concilio Vaticano II per veder finalmente sancito il saldo nucleo di verità che questa intuizione ermeneutica contiene [Card. Martini 1996]. D’altra parte, leggendo la Bibbia (Giosuè 10, 1-43), si comprende che il redattore, nell’episodio del Sole e della Luna fermi nel cielo dove attribuiva a Dio la volontà di sterminare «ogni essere che respira», uomini donne, bambini e perfino gli animali, che già abitavano il sud della Palestina, intendeva solo ricordare agli ebrei i benefici che Dio aveva concesso loro. Questo episodio lo hanno preso alla lettera, anche se di certo non è stato Dio né a commettere né a volere
142 Cenni storici: da Empedocle a Huygens delle anime» è naturale che nella Bibbia «l’intenzione dello Spirito Santo essere d’insegnarci come si vadia al cielo e non come vadia il cielo», frase che Galileo sentì dal cardinale Baronio. Che dire invece degli uomini che lo vollero condannato al confino per paura che le nuove scoperte compromettessero il loro potere, col quale immensamente tradivano la Fede ed il comandamento cristiano della Carità?
Con Galileo sono anche da ricordare il suo amico, Giovanfrancesco Sagredo (1571–1620), che mentre selezionava le lenti per Galileo trovò la legge di compo-sizione della distanza focale per le lenti sottili; il suo artigiano Ippolito Francini, detto Tordo, che in Firenze gli produceva gli obiettivi e che introdusse una macchina di politura con un asse verticale, ancora in uso oggi; ed il suo ultimo allievo, Evan-gelista Torricelli (1608–1647) che lo assisté negli ultimi tre mesi della sua vita. Alla morte di Galileo, Torricelli fu nominato Matematico della corte del Granduca di Toscana per continuare i suoi studi e passò gli ultimi anni della sua breve vita a perfezionare la tecnica di molatura e politura delle ottiche, con notevoli risultati [Molesini 2010].
Nello stesso periodo di Galileo, tra il 1608 ed il 1620, il microscopio fu inventato e costruito indipendentemente in Olanda dallo stesso Jansen, che come Galileo lo aveva derivato da un telescopio, e da Lippershey, Mezius e Gans, infine in Inghil-terra da Drebbel nel 1621. Col progredire delle tecniche di lavorazione ottica, dal 1650 circa iniziarono a svilupparsi sistemi ottici a lenti multiple e strumenti ottici di precisione. In particolare il microscopio si diffuse tra i medici ed i biologi deter-minando un impulso notevole alle loro discipline, però specialmente grazie al mi-croscopio semplice, che continuò per molto tempo a dare prestazioni superiori a quello composto. In particolare Antony van Leeuwenhoek (1632–1723), un sem-plice usciere olandese degli Stati Generali, ebbe molto successo nella costruzione di microscopi semplici con lentine di corta distanza focale ( 2 mm), con cui si dedicò a numerose osservazioni.
La svolta che doveva finalmente rivoluzionare l’ottica in senso moderno avvenne grazie a Johannes Kepler (1571–1630), ossia Keplero, con la soluzione del proble-ma della visione. Egli fu assistente di Tycho Brahe nell’istituto alchimistico-astro-logico di Praga. Nel 1604 pubblicò il libro Paralipomena ad Vitellionem (“conti-nuazione di Vitellione”), dove riprese e superò la tradizione di Alhazen e di Bacone. Keplero analizzò la natura ed il comportamento della luce ed i processi formazione e di localizzazione delle immagini, sia a livello fisico-fisiologico che psichico. In primo luogo, come aveva già detto Maurolico, affermò che da ogni punto dell’og-getto partono raggi di luce in tutte le direzioni. Questi raggi non hanno però una consistenza fisica, ma sono come le traiettorie di corpi in movimento. Come Alha-zen, utilizzò delle analogie meccaniche per spiegare la riflessione (con la scompo-sizione dei moti) e la rifrazione. Per Keplero la luce in sé stessa è incolore, ma acquista colore nella riflessione con i corpi colorati o nel loro attraversamento, inol-tre viaggia a velocità infinita. Misurò poi la rifrazione nel vetro arrivando a stabilire
tale sterminio. Così pure l’inquisizione giustificava l’assassinio degli “eretici” e la gerarchia vaticana la guerra dei 30 anni in corso contro i protestanti.
La scienza nuova 143 una legge di proporzionalità, approssimata per piccoli angoli, tra l’angolo d’inci-denza e quello di rifrazione, come ancora si fa con l’ottica parassiale. Tuttavia, se-condo Herzberger (1966), non arrivò a formulare la legge di rifrazione perché si lasciò fuorviare da alcune tavole errate di Vitellione. Keplero spiega la visione con l’idea di un doppio cono di raggi: ogni punto oggetto è il vertice di un cono con base la pupilla; con la rifrazione attraverso le tuniche trasparenti dell’occhio si forma un secondo cono con vertice sulla retina. Su questa si forma quindi un’immagine rove-sciata della scena osservata ed il nervo ottico, con le sue numerose fibre, ne trasporta i segnali al cervello. È poi la psiche a ricostruire e localizzare nello spazio apparente, correttamente orientati, i fantasmi delle cose viste.
Il passo fondamentale di Keplero, che gli consentì di considerare la formazione di immagini nitide sulla retina, fu quello di attribuire alla pupilla il compito di ri-durre a calotte sferiche le superfici della cornea e del cristallino. In questo modo poté spiegare come evitare la formazione di una caustica che era allora ben nota ed osservata con sfere di vetro. Rimaneva il problema della percezione della profon-dità, cioè della distanza a cui si trovano le cose. Keplero la risolse con il concetto di triangolo distanziometrico avente per vertice il punto osservato e per base un dia-metro della pupilla: egli ritenne che la psiche fosse in grado di percepire l’apertura angolare di questo triangolo e quindi la sua lunghezza. In base a questi concetti Keplero fece un’importante distinzione tra picturae, cioè immagini viste su uno schermo, e imagines rerum, che sono rivelate direttamente dagli occhi e che com-prendono in particolare le immagini virtuali di oggetti che sono visti attraverso spec-chi e lenti: finalmente questi non erano più ordigni fallaci che deformano la realtà. Notevole è la somiglianza con l’opera di Maurolico, che venne pubblicata solo dopo i Paralipomena. Keplero non lo cita e non vi è alcuna prova che ne possedesse un manoscritto, mentre invece elogiò Della Porta.
Nei Paralipomena Keplero non diede molto spazio alla trattazione delle lenti, ma in seguito venne chiamato a dare un giudizio sul cannocchiale di Galileo. Dap-prima rimase neutrale, ma quando venne in possesso di uno dei cannocchiali di Ga-lileo, di quelli che, tramite il Granduca di Toscana, erano stati inviati all’Elettore di Colonia, lo esaminò, ne rimase impressionato e ripeté con esso l’osservazione dei satelliti di Giove; nel settembre del 1610 pubblicò una relazione molto favorevole allo strumento. Una situazione simile si verificò anche con i padri del Collegio Ro-mano, quando anch’essi ricevettero un buon cannocchiale costruito ed inviato loro da Antonio Santini di Venezia.
Presto Keplero riprese i suoi studi di ottica e nel 1611 pubblicò la Dioptrice, dove abbiamo la prima moderna trattazione teorica delle lenti e del telescopio. In questo libro Keplero presenta il fenomeno della riflessione totale, mentre per piccoli angoli assume una legge di proporzionalità tra angolo di incidenza ed angolo di rifrazione e determina la lunghezza focale delle lenti. Con ciò sviluppa le leggi dell’ottica al primo ordine per le lenti sottili e le loro combinazioni, arrivando a proporre un nuovo telescopio realizzato con due lenti positive, che porta il suo nome.
Con Keplero, dopo aver finalmente risolto il problema della visione, lux e lumen vennero identificati ed il loro studio si separò in scienze distinte, l’ottica psicologica
144 Cenni storici: da Empedocle a Huygens da un lato e l’ottica fisica dall’altro. Sul versante fisico l’interesse si rivolse verso la natura fisica, oggettiva, del lumen, che col tempo, impropriamente, è venuto a chiamarsi luce nel linguaggio scientifico oltre che in quello comune, nonostante secoli di dibattito per distinguere i due termini latini. Del lumen ci stiamo occupando in questo nostro studio, ma non dobbiamo dimenticarci le implicazioni fisiologiche, psicologiche ed anche spirituali della lux. In fondo il nostro senso della vista ci dà il meglio di sé, ma non ci può rappresentare tutta la realtà del mondo, non per ora almeno.
La legge di rifrazione e la velocità della luce
La ripresa della sperimentazione permise a Thomas Harriot (~ 1560–1621) di migliorare le tavole di Tolomeo degli angoli di rifrazione e di individuarne la legge in termini geometrici, ma non ne pubblicò i risultati. Circa nello stesso periodo Wil-lebrord Snel (1591–1626), più noto come Snell, professore di fisica a Leiden in Olanda, scrisse un libro di ottica contenente la legge di rifrazione, che egli aveva trovato empiricamente e che gli sviluppi della trigonometria gli avevano consentito di esprimere come rapporto di cosecanti. Questa scoperta rimase però confinata a Leiden. Anche René Descartes (1569–1650), ossia Cartesio, deve essere conside-rato come uno degli scopritori della legge di rifrazione. Egli infatti aveva suggerito l’uso di lenti piano-iperboliche per focalizzare la luce di un fascio collimato tre anni prima di visitare Leiden nel 1630; comunque attribuì a se stesso la scoperta e pub-blicò la legge del rapporto dei seni nel suo libro Dioptrique nel 1637. Siccome la legge di rifrazione era stata determinata sperimentalmente, Cartesio considerò que-sta situazione insoddisfacente e non scientifica in quanto la legge non era inserita in un contesto teorico e quindi non era deducibile da assiomi più generali. Egli riuscì a darne una derivazione utilizzando un’analogia meccanica ed un principio di cau-salità quale la conservazione della quantità di moto. Più tardi Fermat derivò la stessa legge da una differente base concettuale ed in particolare da un principio di finalità quale il principio variazionale del tempo minimo.
Cartesio, pur avendo dato importanti contributi alla matematica, come il metodo delle coordinate per descrivere la posizione di un punto geometrico, riconducendo la geometria all’algebra, si limitò a descrivere i fenomeni fisici solo qualitativa-mente mediante analogie. Egli si costruì un’intera fisica ed un’intera cosmologia puramente meccanicistiche, nel senso che considerava azioni solo per contatto, e concepiva il moto dei pianeti come trascinati da un vortice di particelle microsco-piche in perenne collisione tra loro. Di Galileo disprezzò la cinematica poiché, se-condo lui, non aveva capito il significato della gravità o del movimento. Respinse anche la fisica celeste di Keplero poiché la riteneva filosoficamente errata. Invece Cartesio chiese alla metafisica di fondare e giustificare la scienza e per prima cosa ricercò degli assiomi indubitabili: la certezza della propria esistenza e di quella di Dio, e dato che Dio ha creato sia la nostra ragione sia le cose, ne ricavò un principio
La legge di rifrazione e la velocità della luce 145 di verità per cui le cose che sono colte in modo chiaro e distinto sono vere, la defi-nizione di materia come pura estensione spaziale, infinitamente divisibile, la non esistenza del vuoto, la costanza della “quantità di moto” dell’universo. Per Cartesio estensione e movimento sono le sole realtà fisiche primarie, altre come il colore, il gusto, l’odore, sono secondarie. Oltre queste si estende la regione della passione, della volontà, dell’amore e della fede, che rimangono inaccessibili alla fisica. La sua era dunque una scienza necessaria, deduttiva, dimostrativa e razionale, secondo l’ideale Aristotelico, in cui si doveva procedere deduttivamente da considerazioni a priori, che costituivano per lui i princìpi generali di tutte le spiegazioni fisiche, men-tre gli esperimenti erano relegati ad un ruolo secondario di conferma delle conclu-sioni teoriche. Egli sostituì la ragione pragmatista di Aristotele con la ragione ma-tematica. Ma il mondo che Cartesio derivò dai suoi assiomi era ancora un mondo di carta ed il suo programma scientifico, puramente deduttivo, era giusto l’opposto di quello induttivo di Francis Bacon, ed in contrasto con quelli di Galileo, Mersenne e Pascal. Però ebbe un’influenza grandissima tra gli studiosi ed alcune sue afferma-zioni sono state profetiche.
Dal principio metafisico che il movimento sia l’unico potere esistente in natura e procedendo per analogie, Cartesio derivò la sua concezione sulla natura della luce. Nella Dioptrique egli formulò l’ipotesi che la luce sia una «tendenza al movi-mento», «un’azione», una pressione, che si trasmetta «in una materia sottilissima che riempie i pori di tutti i corpi» (l’etere, anche se non usò questa espressione) e diede il colpo finale alla teoria delle forme di Alhazen e di Vitellione ed a quella delle specie di Grossatesta e di R. Bacone. Tra i suoi princìpi postulò anche che la luce si propaghi istantaneamente (come avevano già fatto molti suoi predecessori con le poche eccezioni prima citate), sentendosi confortato dal fatto che le eclissi di Luna appaiono giusto quando i tre astri, Sole Terra e Luna sono ben allineati: questa è una variante su grande scala dell’esperimento di Galileo con le lanterne. Nono-stante il suo temperamento dogmatico, egli eseguì esperimenti con sfere di vetro riempite d’acqua (descritti in De Iride, in Principia Philosophiae) per studiare i co-lori prodotti dall’arcobaleno, con i suoi archi primario e secondario, trovando che questi erano causati dalla rifrazione e che una sola rifrazione bastava, come verificò con un prisma di vetro. Interpretò poi i colori associandoli ad un moto rotatorio impresso alle particelle della materia sottile nel colpire la superficie rifrangente: contrariamente ai suoi predecessori che ritenevano i colori dovuti ad una distinta combinazione di luce e di buio o di un numero finito di colori “primari”, Cartesio fu il primo a riconoscerne il valore individuale dei colori dello spettro, facendoli corrispondere ad una particolare velocità di rotazione. Fece anche esperimenti con occhi umani ed animali osservando che un’immagine nitida degli oggetti di fronte all’occhio si poteva formare sulla retina aggiustando una lieve pressione sull’occhio e che dunque l’occhio può accomodarne la messa a fuoco. Dalla legge di rifrazione determinò la forma della superficie di separazione tra due mezzi trasparenti diversi che può dare un’immagine puntiforme di un punto oggetto assegnato. Questa su-perficie si chiama ora ovale di Cartesio di cui l’iperboloide costituisce un caso spe-ciale per un punto oggetto all’infinito.
146 Cenni storici: da Empedocle a Huygens
Il caso della legge di rifrazione è esemplare per come concezioni metafisiche completamente diverse possano portare alla stessa espressione logico-matematica e contemporaneamente a previsioni diverse, come in questo caso per la velocità della luce. La spiegazione che Cartesio diede di questo fenomeno è ricavata da un’analo-gia meccanica col moto di una palla, seguendo una tradizione che da Erone fino a Keplero si era andata consolidando. L’ipotesi di partenza è che la velocità di propa-gazione sia diversa nei due mezzi, con un rapporto n assegnato: vT = nvI. Secondo Cartesio si doveva conservare la componente di velocità parallela alla superficie di separazione tra i due mezzi, pertanto vT sin T = vI sin I, da cui la legge di rifra-zione per l’angolo d’incidenza, I, e l’angolo di trasmissione, T, è immediata-mente trovata. Rispetto all’esempio balistico, Cartesio annotò che per una palla la velocità nel mezzo più denso diminuisce, mentre la forza o la facilità con cui la luce si propaga dovrebbe invece aumentare per accordarsi con l’esperienza: Cartesio non parla di aumento della velocità della luce, dato che per lui era infinita. Anche di questo riuscì a trovare una giustificazione ricorrendo ad un’analogia con una palla che “rotola meno facilmente su di un tavolo ricoperto con un tessuto [paragonato all’aria] che su di uno levigato”.
Prima ancora che la Dioptrique fosse pubblicata, Mersenne inviò a Pierre de Fer-mat (1601–1665) i Discours de la méthode di Cartesio, chiedendogli un parere. E già nel settembre del 1637 Fermat rispondeva ritenendo la sua decomposizione mec-canica del moto della luce arbitraria ed anche contraddittoria con l’altra ipotesi di Cartesio che la luce dovesse propagarsi istantaneamente. Nella lunga disputa tra i due intervenne anche un equivoco sui termini usati. Infatti Cartesio utilizzò il ter-mine determinazione del moto, con il quale egli intendeva il concetto di vettore. Invece Fermat lo interpretò come direzione, per cui le dimostrazioni di Cartesio gli apparivano assurde.
La svolta che portò Fermat a formulare una sua propria idea sulla rifrazione della luce avvenne nel 1657, quando ricevette dall’amico Marin Cureau de la Chambre un suo libro dal titolo La Lumière, pubblicato in quell’anno. Riprendendo l’ipotesi di Erone, che risultava corretta anche per la propagazione rettilinea della luce, La Chambre vi spiegava la riflessione con un principio metafisico, cioè il principio teleologico per cui la natura raggiunge i suoi fini nel modo più semplice ed econo-mico, che nel caso della luce veniva interpretato come il cammino più corto. Ma La Chambre era anche turbato da due obbiezioni: la prima era che in certe situazioni con specchi concavi la luce percorre invece il cammino massimo, la seconda era che questo principio non si applicava alla rifrazione. Fermat iniziò allora a rielabo-rare questa idea giungendo alla conclusione che il principio di economia andasse interpretato non come la via più corta, ma come quella di minore resistenza. Ossia, accettando che la luce si propaghi con velocità finita, questo equivale a cercare il cammino che richiede il minor tempo. Nel caso della rifrazione i calcoli sarebbero stati un po’ complicati, e Fermat prese tempo promettendo di farli quando all’amico piacerà.
L’applicazione di questo principio variazionale conduce per la rifrazione alla conservazione delle componenti parallele all’interfaccia del vettore s/v, dove s è il
Il dibattito sulla natura della luce 147 versore del raggio e v la velocità di propagazione e quindi alla relazione sin I/vI = sin T/vT . Con linguaggio moderno, è la componente parallela alla superficie del vettore d’onda che si conserva nella rifrazione e non quella della velocità. La legge di rifrazione che ne risulta è la stessa, ma le velocità sono nel rapporto inverso. Il primo a stupirsi di questa coincidenza fu lo stesso Fermat, come lui stesso raccontò nel resoconto [Fermat 1894] che scrisse nel 1664 ad un corrispondente ignoto (M. de ). Fermat, infatti, aveva sostenuto la validità del principio teleologico, ma non aveva poi proceduto nei calcoli, tanto più che essendo la legge di Cartesio verificata dall’esperienza, gli «sembrò inutile tentare di trovarne un’altra per mezzo del suo principio». Fu solo per le «insistenze» dell’amico de la Chambre che nel 1662 portò avanti la sua analisi ottenendo la stessa proposizione di Cartesio, quando invece aveva sperato di ottenerne una che desse risultati simili, ma non identica (eccetto il rapporto inverso tra le velocità). Anche M. de gli aveva mostrato un contro-esempio al suo principio di minimo per cui si poteva avere riflessione da una superficie concava con un cammino massimo: nella stessa lettera Fermat gli rispose con lo stesso argomento usato per tranquillizzare La Chambre, ossia che quello che conta è che il cammino sia minimo rispetto ad un piano tangente alla superficie! Nella sostanza oggi sappiamo che, per determinare il cammino di un raggio, ciò corrisponde a ricercare non necessariamente un minimo ma un estremo, che era proprio il risultato della tecnica che lui introdusse precorrendo il calcolo differenziale.
Fermat infine ritenne di aver trovato la vera dimostrazione della legge di rifra-zione, lasciandone il merito della scoperta a Cartesio. Ma questa posizione non fu accettata dai cartesiani i quali invece lo accusarono di condurre dimostrazioni non causali e lo ignorarono. Così l’idea che la velocità della luce dovesse aumentare nei mezzi più densi dominò le ricerche di ottica per due secoli. Tra i pochi a considerare valido il principio di Fermat vi fu Huygens: all’inizio ne diffidò, ma poi, rifatti i calcoli, lo accettò senza più riserve come uno strumento utile alla ricerca.
Il dibattito sulla natura della luce
Sempre più s’impose la questione se il lumen fosse materia o movimento: la prima ipotesi condusse a ritenere il lumen come costituito da corpuscoli, mentre la seconda ebbe come sbocco la teoria ondulatoria. Tuttavia all’inizio queste due con-cezioni estreme non erano ben definite ed anzi non veniva esclusa una certa “com-plementarità”, come a modo loro la concepirono Grimaldi e Newton. Francesco Maria Grimaldi (1618–1663), padre gesuita del Collegio di Bologna, si impegnò seriamente alla soluzione di questo dilemma e per la prima volta mise alla prova il postulato della propagazione rettilinea della luce, nel tentativo di stabilire le dimen-sioni di un raggio luminoso [Ronchi 1983]. Egli invece scoprì un fenomeno nuovo, che non era riconducibile ad una trattazione di tipo geometrico, e gli diede il nome di diffrazione. Il suo studio venne purtroppo pubblicato solo postumo nel 1665 con
148 Cenni storici: da Empedocle a Huygens il titolo Phisico-Mathesis de lumine, coloribus et iride. Esso consiste in un proemio e di due libri, e nelle sue 535 pagine contiene la descrizione accurata dei suoi nu-merosi esperimenti e le conclusioni cui via via stava pervenendo. Lo stile è quello di un dialogo dove l’ipotesi che il lumen sia una sostanza viene difesa contro altre ipotesi, tra cui quella ondulatoria. Egli inizia subito con gli esperimenti sulla diffra-zione, dove utilizza una camera oscura con un forellino molto piccolo da cui penetra la luce del Sole. Nel cono di luce che si forma egli inserisce vari oggetti e ne osserva l’ombra su di uno schermo bianco, notando che il bordo non è composto dalla sola penombra che ci si può attendere per le dimensioni finite del foro, ma che anzi l’ombra appare dilatata ed intorno a questa ci sono tre series lucidae, cioè tre frange luminose e colorate, azzurrognole verso l’ombra e rossastre verso l’esterno, che se-guono fedelmente il bordo degli ostacoli. Egli nota pure che dietro a corpi stretti e lunghi, immersi nel cono di luce, in certe condizioni vi sono delle frange iridate anche nella zona d’ombra, che variano di numero e di caratteristiche (oggi sappiamo che queste sono essenzialmente frange di interferenza per la luce diffratta dai due bordi). In un’altra serie di esperimenti egli interpone nel cono di luce solare un altro diaframma con un forellino. Sullo schermo bianco, adesso la traccia del fascetto di luce prodotto dalle due aperture è molto più grande di quella prevista dall’ottica geometrica: la parte centrale è bianca e gli orli sono colorati di rosso e di azzurro. Nei due casi fece molte prove, variando la posizione dello schermo bianco e cam-biando la forma, il colore, la sostanza e la disposizione degli ostacoli o del dia-framma. Egli nota che le series lucidae «non stanno né sopra una linea retta passante per il foro e tangente all’ostacolo nel cono di luce, né sopra una retta condotta dal foro al punto dello schermo su cui si osservano» e che esse rimangono invariate «qualunque sia il corpo opaco inserito nel cono di luce, sia denso, sia rarefatto, sia liscio e lucido, sia ruvido e irregolare, sia duro, sia molle». Egli esclude che le frange siano dovute a luce diretta, poiché progrediscono in modo strano al variare della posizione dello schermo; esclude anche che siano dovute a luce rifratta o riflessa, poiché non dipendono dalla sostanza dell’ostacolo né si muovono al ruotare dell’o-stacolo intorno al suo bordo. Quindi si deve trattare di un fenomeno nuovo, la dif-frazione! Nel tentativo di spiegare questo comportamento egli paragona la luce ad un fluido che si muova velocissimo, e come l’acqua forma delle onde intorno ad una pietra che ne ostacoli il cammino, così pensa che si formino le frange nell’ombra di un ostacolo immerso nel cono di luce. Grimaldi infine ammette che la luce si propaghi «almeno qualche volta anche ondulatamente» nei corpi trasparenti. Già Leonardo, riferendosi alle onde sull’acqua, aveva scritto che «il moto del-l’impressione fia solamente accompagnato dall’impeto e non dal moto della mede-sima acqua». Per Grimaldi invece il moto ondulatorio del fluido luminoso accom-pagna quello nella direzione di propagazione con traiettorie «sinuose crispatae» e non periodiche ed a questo fluido riconosce la necessità di una velocità finita di propagazione.
Grimaldi passa poi ad esaminare le proprietà del lumen e le sue interazioni con la materia in varie situazioni: nei corpi diafani ed in quelli opachi, nella rifrazione, riflessione e diffrazione, nella visione, e quello che è più interessante, nella colora-
Il dibattito sulla natura della luce 149 zione. L’opinione generale di allora, a parte quella di Cartesio, era che la luce fosse bianca e pura, mentre i colori fossero una proprietà dei corpi e questi colori venivano detti permanenti. Ma v’erano anche dei colori misteriosi, come quelli che si vedono nell’arcobaleno e nelle bolle di sapone che siccome non erano dovuti ad una materia colorata, venivano detti apparenti. Supposta l’esistenza di un lumen bianco, Gri-maldi descrive numerosi esperimenti con cui si ottiene una luce colorata e ne con-clude che il colore deve essere una proprietà del lumen stesso. In particolare, a lui dobbiamo la realizzazione di spettri ottenuti per diffrazione da superfici finemente striate e da strutture reticolari come i tessuti. Nel suo libro scrisse: «la modificazione del lumen, per cui esso si colora permanentemente e apparentemente, o meglio si rende sensibile con la qualifica di colore, non improbabilmente si può dire che sia una certa ondulazione minutissimamente fluttuante, come un tremito di diffusione, con una certa oscillazione finissima, che con una determinata applicazione stimola il sensorio». Egli dunque afferma che i colori sono differenziati dalla natura e dalla velocità del moto ondulatorio e nella figura con cui descrive questo moto, l’oscilla-zione viene rappresentata da una linea zigzagante in senso trasversale. Come esem-pio porta il suono, che dà tanta varietà di toni con altrettante vibrazioni diverse. Tra i colori ne definisce alcuni semplici: il rosso, il giallo e l’azzurro, e gli altri li con-sidera una combinazione di questi. Mentre nel primo libro aveva difeso con vigore la tesi che il lumen fosse una sostanza, nel secondo libro torna a dare legittimità scientifica all’ipotesi accidentale, ma anche in questo caso considerò definitiva-mente acquisito che il colore derivi da una modificazione del lumen.
Anche La Chambre aveva dato battaglia per unificare in seno alla luce, i colori permanenti, i colori apparenti e le immagini: rifiutando l’idea che i colori fossero generati da miscugli di luce con l’oscurità o con l’opacità, egli aveva invece ritenuto che essi siano una tonalità della luce, analoga ai toni gravi o acuti di un suono.
Nel ‘600 il rinnovato interesse per la scienza condusse alla formazione di società scientifiche con lo scopo di rendere possibile una rapida comunicazione delle idee e delle scoperte, di favorire lo sviluppo tecnico ed anche di ottenere il finanziamento delle ricerche. Il merito di questo sviluppo va anche a Francis Bacon (1561–1626), filosofo della nuova scienza, che si adoperò per liberare l’esperimento dal dubbio contesto in cui era stato relegato per farlo diventare la base indiscutibile della spie-gazione scientifica; da intellettuale democratico qual era comprese che solo lo sfor-zo collettivo di molti avrebbe potuto penetrare la complessità della natura e sollecitò la formazione di istituzioni scientifiche. Già l’abate Marin Mersenne (1588–1648) era stato l’infaticabile corrispondente di tutti gli scienziati europei del suo tempo, tra cui svolse il compito di raccogliere e scambiare lettere e manoscritti. Le prime associazioni scientifiche furono l’Accademia dei Lincei di Roma (1603–1630) e l’Accademia del Cimento di Firenze (1651–1667), che tra l’altro ritentò l’esperi-mento di Galileo per la misura della velocità della luce. Queste società, che furono creazioni di mecenatismo privato, ebbero una vita breve, a causa dell’atavica eterna insipienza dei governanti italici. Maggiore fortuna trovarono invece la Royal Soci-ety di Londra (1662) e l’Académie Royale des Sciences di Parigi (1666) che diven-nero il luogo deputato per rendere pubblico il lavoro e le scoperte dei ricercatori.
150 Cenni storici: da Empedocle a Huygens
Segretario e curatore degli esperimenti della Royal Society fu Robert Hooke (1635–1703) che nel 1665 pubblicò un libro intitolato Micrographia, nella quale riportò le sue osservazioni microscopiche, inclusa la scoperta delle cellule. Egli fu principalmente interessato a trovare una spiegazione al fenomeno dei colori e nel corso di queste osservazioni egli s’interessò particolarmente della colorazione delle lamine sottili che si formano sull’acciaio dopo essere stato arroventato, dell’iride-scenza delle bolle di sapone e del vetro soffiato in foglie finissime, delle frange che si osservano su fogli sottili di mica o tra due vetri pressati insieme con un liquido interposto di varia natura. Egli fu il primo a fare un’indagine sistematica di quelle che oggi vengono chiamate frange di uguale spessore, od “anelli di Newton”! Ne dedusse diverse circostanze che sono considerate valide ancora oggi, tra cui che la colorazione appare sempre con una lamina sottilissima di materiale trasparente de-limitata da mezzi di rifrangenza diversa da quella della lamina. Che inoltre la colo-razione è uniforme se anche lo spessore è uniforme, mentre se non lo è la colora-zione può assumere l’aspetto di anelli concentrici di vario colore, come nel caso di una lamina con superfici sferiche; o di linee, come nel caso di due lastre inclinate per formare un cuneo nel mezzo interposto; od infine è irregolare se lo spessore varia casualmente. Nel caso dei vetri pressati insieme nota poi che le frange si muo-vono se si varia la pressione. Egli nota anche che lo spessore della lamina deve essere compreso tra un massimo ed un minimo: se lo spessore è eccessivo si vede solo un’illuminazione uniforme e bianca. Tuttavia ammette di non essere mai riu-scito a misurare lo spessore delle lamine e che l’esistenza di lamine sottili su sub-strati come l’acciaio è solo una sua ipotesi, dato che le ha cercate con i suoi più potenti microscopi senza poterle osservare.
Seguendo Cartesio e quindi violando una delle regole della Royal Society che vietava il dogmatismo, Hooke cercò di spiegare le proprietà della luce tramite l’a-zione di una materia sottile che riempie tutti i corpi e lo spazio. Ma riesaminando le assunzioni cartesiane e mettendone in evidenza le difficoltà, egli riuscì a proporre delle congetture più plausibili con le quali fece progredire la teoria dell’etere. In particolare, invece di un moto circolare, egli assunse un moto vibratorio per le par-ticelle della materia sottile. Hooke non asserì esplicitamente che la velocità della luce debba essere finita, ma di fatto favorì questa idea sostenendo che le vibrazioni dell’etere si propagano nello spazio in linea retta ed a velocità costante in un mezzo omogeneo, generando delle onde sferiche analoghe a quelle che si possono osser-vare su di una superficie d’acqua lanciandovi un sasso; tuttavia non si pronunciò sulla periodicità delle vibrazioni o delle onde. Piuttosto considerava queste vibra-zioni come degli impulsi, ed in questo non si discostava poi tanto dalla tradizione meccanicistica che aveva condotto ai quanti di Galileo od ai corpuscoli di Newton. Pensando alle onde egli si atteneva all’eccesso opposto di quello cui siamo abituati ad usare noi con le onde monocromatiche! Ciononostante, poiché i suoi impulsi erano delimitati temporalmente ma non spazialmente, Hooke introdusse il concetto di fronte d’onda, perpendicolare alla direzione di propagazione e lo applicò alla ri-frazione assumendo come valida la legge dei seni, e suppose che la velocità di pro-pagazione fosse maggiore nei corpi più densi, in accordo con la posizione di Carte-
Il dibattito sulla natura della luce 151 sio. La costruzione che ottenne è analoga a quella che poi usò Huygens, con la dif-ferenza che nell’onda rifratta il fronte d’onda non è più perpendicolare alla direzione di propagazione. Di Cartesio non accettò la teoria dei colori, trovandola in contrasto con le sue esperienze sulle lamine sottili: per Cartesio infatti questa colorazione si sarebbe dovuta osservare solo in corrispondenza del passaggio tra luce ed ombra, inoltre nel passaggio attraverso una lamina, con le sue due successive rifrazioni, la seconda avrebbe cancellato il moto rotatorio impresso dalla prima alle particelle di etere, e dunque si sarebbe annullata ogni eventuale colorazione. Invece Hooke tentò di spiegare i colori prodotti dalla rifrazione con i fronti d’onda obliqui del suo mo-dello: se il fronte non è inclinato si genera la sensazione di luce bianca, mentre nel caso di un fronte obliquo riprese uno dei concetti meccanici di Cartesio per attribuire una differente “forza” ai due estremi del fronte, per cui se la parte debole di un impulso di luce precede quella debole si ha una luce blu e nel caso contrario una luce rossa. Infine gli altri colori prodotti dalla rifrazione dovevano corrispondere ad una “diluizione” del rosso o del blu o ad una loro combinazione. Nella sua interpre-tazione dei colori delle frange delle lamine sottili Hooke attribuisce uguale impor-tanza alla riflessione dalla prima e dalla seconda faccia della lamina: gli impulsi riflessi dalle due facce si sarebbero “combinati” insieme con un ritardo temporale dipendente dallo spessore della lamina. Se la lamina è molto sottile i due impulsi si ritroverebbero sovrapposti e nessun colore sarebbe evidente all’occhio dell’osser-vatore, tuttavia per uno spessore maggiore, il secondo impulso essendo un poco più “debole”, combinandosi col primo avrebbe dato luogo ad un singolo impulso la cui parte più forte precede e quella più debole segue, dando la sensazione di giallo. Aumentando ancora lo spessore i due impulsi si separerebbero di più, dando la sen-sazione di rosso. Infine, per spiegare la periodicità delle frange, ipotizza che la suc-cessione degli impulsi sia periodica! Quindi, quando l’impulso debole riflesso dalla seconda faccia si trovasse tra due impulsi forti riflessi dalla prima faccia, si avrebbe la sensazione di luce purpurea, ed aumentando ancora lo spessore avremmo un im-pulso debole che precede e si combina con uno forte, dando la sensazione di blu, e così via. In questa sua interpretazione dei colori delle frange, Hooke fu dunque solo ad un passo dall’esprimere il principio di interferenza, come gli fu riconosciuto poi da Young, il quale scrisse che se non fosse arrivato a questo principio da solo, l’idea di Hooke «lo avrebbe condotto prima ad una simile opinione».
In seguito alla sua lunga disputa con Newton sulla “composizione” della luce bianca, Hooke riconsiderò la sua teoria dei colori e fu il primo ad esprimere per la luce il principio di sovrapposizione delle onde: se ad ogni colore corrisponde un moto vibratorio particolare, la luce bianca può essere immaginata in senso matema-tico come la combinazione di migliaia di questi moti ed essere ancora un moto “uni-forme”5. Tuttavia, rimanendo fedele alla sua teoria dualistica del colore, Hooke considerò questa ipotesi come non necessaria e rifiutò quella più rozza di Newton.
Qualche anno dopo il padre gesuita Ignazio G. Pardies (1636–1673) sviluppò
5 Questa intuizione trovò finalmente una formulazione matematica solo nel 1886 con M. Gouy, il quale vi applicò il teorema di decomposizione spettrale di Fourier.
152 Cenni storici: da Empedocle a Huygens delle considerazioni analoghe a quelle di Hooke nel seguire il tentativo di Cartesio di spiegare le proprietà della luce. Egli utilizzò ancora come dato di fatto la legge dei seni, arrivando però alla conclusione che il fronte d’onda rimanga perpendico-lare alla direzione di propagazione anche dopo la rifrazione, e che, in accordo con Fermat, la velocità della luce sia minore nel mezzo più denso. Con questa costru-zione geometrica Pardies anticipò Huygens, tuttavia non sembra che fosse riuscito a dare una propria dimostrazione della legge di Snell-Cartesio del tipo di quella di Huygens (il suo manoscritto sulla rifrazione è andato perduto). A sua volta Huygens studiò con interesse il lavoro di Pardies e di Hooke e ne rimase influenzato.
Un fenomeno nuovo, la doppia rifrazione da parte di cristalli di spato di Islanda (la calcite), venne scoperto nel 1669 da un professore danese di matematica, Rasmus Bartholin (1625–1698), che descrisse con diversi esperimenti le proprietà fisiche, chimiche ed ottiche di questi cristalli ottenuti da un marinaio che li aveva raccolti in Islanda. Egli notò che essi hanno la forma di parallelepipedi obliqui e che quando un piccolo oggetto veniva osservato attraverso due facce opposte del cristallo, l’im-magine dell’oggetto appariva sdoppiata. Egli attribuì questo comportamento allo sdoppiamento di un raggio incidente sulla prima faccia del cristallo in due raggi. Egli descrive come uno di questi raggi si comporta in modo ordinario, seguendo le normali regole della rifrazione, mentre l’altro no. In particolare egli annotò che ruo-tando il cristallo parallelamente alle due facce attraverso cui si guarda, la prima immagine dell’oggetto rimane immobile mentre la seconda si muove seguendo la rotazione. Come era nelle intenzioni di Bartholin quando pubblicò le sue osserva-zioni, questa scoperta stimolò l’immaginazione dei ricercatori ed Huygens in parti-colare riuscì ad inserire la doppia rifrazione nella sua teoria delle ondine.
Nel 1676 il danese Olaf Römer (1644–1710), che era stato allievo di Bartholin e ne aveva poi sposato la figlia, divenuto professore di matematica in Francia, comu-nicò all’Académie des Sciences la sua “dimostrazione” che la luce si propaga con velocità finita e dette la sua stima di questa velocità. Nell’ambito delle ricerche per la determinazione della longitudine in mare, egli aveva osservato le eclissi del primo satellite di Giove per diversi anni, con l’italiano Giovanni Domenico Cassini ed altri membri dell’Académie, trovando che le eclissi si ritardavano quando la Terra si al-lontanava da Giove e si anticipavano nel caso opposto. Cassini fu il primo a sugge-rire nel 1675 che questo poteva essere dovuto ad una velocità finita della luce, ma poco dopo cambiò idea [Sabra 1981]. Römer invece calcolò che per spiegare queste irregolarità la luce doveva impiegare 11 minuti per percorrere una distanza pari ad un raggio dell’orbita terrestre, ossia una velocità di circa 214000 Km/sec.6 Ma que-sta misura, che era un “effetto secondario” di una ricerca dedicata a sviluppare un metodo per la determinazione della longitudine, non fu subito accettata da tutti, dato che le irregolarità avrebbero potuto derivare da qualche altro effetto e che gli altri satelliti di Giove non sembravano presentare lo stesso comportamento.
Nella seconda metà del ‘600 due nuovi personaggi si inserirono nel dibattito sulla
6 La differenza con la determinazione attuale è in buona parte dovuta al fatto che Römer non aveva considerato lo spostamento di Giove nel periodo di osservazione [Bevilacqua e Ianniello 1982].
Il dibattito sulla natura della luce 153 natura della luce: Newton e Huygens. Ad essi generalmente si attribuiscono due teorie opposte, quella corpuscolare e quella ondulatoria. Tuttavia la differenza più profonda tra loro fu relativa al metodo di indagine scientifica, che per Newton do-veva essere puramente induttivo, senza assumere nessuna ipotesi a priori, secondo la presunzione già implicita nel metodo di Francis Bacon per cui la “verità” poteva essere raggiunta in modo “certo” mediante l’uso di experimentum crucis. Invece Huygens riteneva di poter usare il metodo ipotetico-deduttivo di Galileo, più vicino al metodo cartesiano, ma depurato dagli eccessi di questo, per cui le ipotesi e le loro conseguenze vengono confrontate con i dati dell’esperienza sulla base di un con-cetto di verosimiglianza o di probabilità. D’altra parte Newton non fu affatto esente dal fare ipotesi a priori come invece sosteneva ed anzi, con i suoi pregiudizi corpu-scolari, viziò gravemente le sue “induzioni”.
Christiaan Huygens (1629–1695) nacque a Den Haag in Olanda da una famiglia di classe media. Suo padre Constantijn era un diplomatico ed un latinista che fu amico e corrispondente di vari intellettuali di quel tempo, incluso Cartesio, che qual-che volta visitò la sua casa. Huygens presto dimostrò la sua inclinazione per la mec-canica, il disegno e la matematica e nel 1645 entrò all’Università di Leiden, dove studiò matematica e legge. In seguito acquisì una fama europea come matematico ed astronomo: grazie ai miglioramenti che aveva introdotto nella molatura e nella lucidatura delle lenti per i telescopi, nel 1655 scoprì un satellite di Saturno, nel 1656 distinse le componenti stellari della nebulosa di Orione e nel 1659 scoprì la vera forma degli anelli di Saturno. Nel 1656 la necessità di avere un buon dispositivo per la misura del tempo lo spinse a costruire un orologio a pendolo con un movimento cicloide isocrono. Egli continuò i suoi studi di meccanica a cui diede importanti contributi come l’idea generale della legge di conservazione dell’energia, i concetti di momento di inerzia e di forza centrifuga e le leggi della collisione. Huygens de-scrisse infine questi studi nel 1673 nel suo libro Horologium Oscillatorium. Nel 1666 divenne uno dei membri fondatori della Académie des Sciences e visse a Parigi fino al 1681, dove poi per motivi politici non poté più tornare.
Insieme all’astronomia ed alla meccanica, Huygens si occupò di ottica e scrisse due libri su questo argomento: Dioptrica e il suo famoso Traité de la Lumière. Il primo fu pubblicato postumo nel 1703 ed il secondo fu pubblicato solo nel 1691, dodici anni dopo averlo scritto e comunicato alla Académie des Sciences nel 1679, aggiungendo alla pubblicazione solo la parte sulla birifrangenza. Egli trattò solo alcuni aspetti specifici dell’ottica, non considerando la diffrazione e occupandosi ben poco del colore.
Dioptrica è un libro di ottica geometrica in cui Huygens introdusse dei notevoli progressi nella comprensione della formazione di immagini ottiche. Esso fu scritto a più riprese ed è diviso in tre parti. La prima, scritta nel 1653, si occupa in dettaglio della rifrazione prodotta da diottri e da lenti con spessore finito, della grandezza apparente degli oggetti visti attraverso un sistema ottico, ed infine del telescopio. Nella seconda parte, scritta nel 1666, si occupò delle aberrazioni. Infine nella terza, scritta tra il 1685 ed il 1692, tornò a trattare il telescopio ed il microscopio. I concetti fondamentali dell’ottica Gaussiana vi sono già presenti, tra cui il fatto che se in un
154 Cenni storici: da Empedocle a Huygens sistema ottico si scambiano occhio ed oggetto, questo viene ad avere la stessa di-mensione apparente e la stessa orientazione di prima: come dire, in termini moderni, che il prodotto tra indice di rifrazione, ingrandimento laterale e ingrandimento an-golare è costante attraverso il sistema ottico. Nello studio delle posizioni reciproche di oggetto ed immagine, Huygens trovò prima di Newton la legge di proporzionalità inversa per le distanze, quando queste sono misurate dai rispettivi piani focali. Nello studio delle aberrazioni ricavò una formula approssimata per determinare la forma di una lente con la minima aberrazione sferica.
In Traité de la Lumière Huygens indagò invece la natura della radiazione. Egli riprese la concezione di Cartesio secondo cui le spiegazioni in fisica devono essere date in termini geometrici di grandezza, forma e moto e che tutte le azioni debbano avvenire per contatto diretto: egli accettò l’idea di Newton dell’estensione della gra-vità all’intero sistema solare, ma solo come conseguenza della intermediazione di una materia sottile impercettibile che riempia tutto l’universo e non come azione a distanza. A questa materia sottile, che chiamò etere, attribuì il compito sia di giusti-ficare la gravità sia di propagare i segnali luminosi. Distinguendosi da Cartesio e riprendendo il lavoro di Hooke e Pardies, Huygens concepì la luce come un moto effettivo delle particelle di etere e non come una tendenza al moto. Infatti non si spiegava altrimenti come una particella potesse avere una “tendenza” al moto in due direzioni opposte, quando due raggi di luce procedono contemporaneamente in senso contrario. D’altra parte non accettò la teoria corpuscolare ritenendo che nell’intersezione di due sciami di corpuscoli, questi si diffonderebbero per le loro mutue collisioni. Nella sua concezione l’etere era il sostegno meccanico della luce, un po’ come l’aria è quello del suono. Ma mentre l’aria trasmette il suono per com-pressioni e rarefazioni, l’etere era concepito con delle proprietà alquanto singolari: doveva permeare tutti i corpi trasparenti e riempire anche il vuoto da poco scoperto da Torricelli ed indagato da Robert Boyle (1626–1691). Questo vuoto aveva mo-strato la capacità di trasmettere la luce ma non il suono. Il modo con cui Huygens concepiva l’etere era piuttosto complicato [Sabra 1881] ma nelle considerazioni sulla luce lo assume come un fluido costituito da particelle identiche perfettamente elastiche tutte in contatto tra loro, come nel caso di una fila di sfere, dove un impulso impresso alla prima si trasmette all’ultima sfera della fila senza uno spostamento delle sfere intermedie. In queste condizioni la velocità del segnale luminoso doveva essere finita, e contemporaneamente Huygens spiegava perché questa velocità fosse comunque molto più grande di quella del suono. Invece Hooke (a cui tra l’altro dobbiamo il concetto di modulo d’elasticità!) immaginava un etere composto da particelle rigide, per cui la velocità di propagazione sarebbe risultata infinita. Quan-do Römer pubblicò i suoi risultati, Huygens li considerò semplicemente una con-ferma delle sue idee e capì anche che la prova portata da Cartesio con le eclissi lunari era irrilevante per velocità così grandi.
Per Huygens le onde luminose erano longitudinali, essendo l’etere un fluido, e non periodiche: su questo non aveva torto, trattando la radiazione di sorgenti natu-rali. Piuttosto le immaginava costituite da una successione casuale di impulsi. Per spiegare la propagazione rettilinea della luce, egli pensava, come Hooke e Pardies,
Il dibattito sulla natura della luce 155 che dalla sorgente luminosa questi impulsi si propagassero formando un fronte d’onda principale. Siccome poi ciascuna particella di etere, eccitata dall’arrivo di un impulso, è in contatto con tutte le circostanti, essa diviene sorgente di un’ondina secondaria. A questo punto Huygens introdusse il suo famoso principio per cui le ondine prodotte in tutti i punti del fronte divengono efficaci rinforzandosi mutua-mente solo nell’inviluppo delle loro superfici, dando quindi luogo alla propagazione del fronte principale. La parola “inviluppo” tuttavia non rende bene il senso di ciò che Huygens intendeva dire [de Lang 1992]: egli in realtà parla di una regione, e non meramente di un punto di tangenza, dove la composizione delle ondine diviene efficace; egli dunque definisce in senso moderno un raggio fisico di luce come una sottile regione intorno al raggio geometrico, anche se non ne indica l’effettivo spes-sore. Inoltre, in una costruzione puramente geometrica si ha una superficie d’invi-luppo delle ondine anche nella direzione retrograda! Per risolvere questa difficoltà Huygens fece appello ad un principio fisico, ossia all’analogia meccanica delle sfere, per cui se queste sono tutte uguali, l’impulso si può propagare solo in avanti, senza generare una dispersione del segnale nelle altre direzioni. Il fattore d’obliqui-tà, invocato da Fresnel quasi un secolo e mezzo più tardi, ebbe qui il suo primo abbozzo.
Colpisce il fatto che Huygens non si occupò di diffrazione [Ronchi 1983]. Seb-bene il concetto di fase e di interferenza cominciasse vagamente ad affiorare sia negli accessi del modello di Newton, il quale aveva esaminato anche l’interferenza delle onde sull’acqua, sia nel concetto di composizione di Huygens, mancavano ai due studiosi gli strumenti matematici per poter valutare quantitativamente gli effetti dell’interferenza ed in particolare mancava loro il concetto di interferenza distrut-tiva. Non si era infatti ancora sviluppata quella distinzione che noi troviamo naturale tra campo ed intensità: solo quest’ultima veniva considerata nei ragionamenti. Ecco allora che Newton considerava il modello ondulatorio del tutto incompatibile con la propagazione rettilinea della luce, per cui riteneva che le onde si sarebbero dovute espandere in tutte le direzioni al di là di un’apertura, come avviene per il suono.
Viceversa Huygens riteneva che là dove non c’è un inviluppo ben definito, ossia, come lui stesso ha scritto, dove le ondine «non concorrono allo stesso istante per comporre un’onda», la luce avrebbe un’intensità del tutto trascurabile e si irrigidì sul concetto di propagazione rettilinea, senza definire mai se la zona di inviluppo, dietro un ostacolo, termina in modo continuo o discontinuo. Per comprendere la frase di Huygens, noi dobbiamo lasciare da parte quella scorciatoia costituita dalla decomposizione spettrale in onde armoniche, con cui di solito trattiamo la radia-zione, per ragionare invece nel dominio del tempo; egli infatti considerava la luce come costituita da impulsi brevissimi: dunque le differenze nei tempi di arrivo gio-cano lo stesso ruolo della differenze di fase tra onde armoniche che interferiscano [de Lang 1992].
Il maggior successo di Huygens fu quello di riuscire a spiegare in modo semplice le leggi di riflessione e di rifrazione. Il confronto tra il suo modello e l’osservazione portava a concludere in accordo con Fermat che la propagazione sia più lenta nei mezzi più densi, ma ora la legge dei seni veniva spiegata in modo causale e non
156 Cenni storici: da Empedocle a Huygens secondo un principio di finalità. Inoltre, mentre Pardies assumeva che nella rifra-zione il fronte d’onda si mantenesse perpendicolare alla direzione di propagazione, questo ora risultava come una conseguenza dell’inviluppo delle ondine. Tra l’altro con la sua costruzione Huygens poteva dare una ragione anche al fenomeno della riflessione totale, dato che in questo caso non si ha alcun inviluppo delle ondine rifratte. Ma se gli aspetti geometrici del modello quadravano bene, quelli fisici pre-sentavano delle difficoltà. Infatti, come si può spiegare in modo meccanico il feno-meno della riflessione parziale? E perché la propagazione è più lenta nei mezzi più densi? Huygens cercava una spiegazione a livello microscopico che risulta difficile e complicata anche con le moderne teorie. Ad esempio, egli riteneva che la rifles-sione interna fosse prodotta dalle particelle d’aria fuori, ma riconobbe che questa spiegazione non si poteva dare nel caso di un tubo in cui si faccia il vuoto.
Un altro importante successo Huygens l’ottenne nel 1677 con la spiegazione della doppia rifrazione nello spato d’Islanda. Egli suppose che il raggio ordinario si propaghi nell’etere presente nel cristallo con ondine sferiche, mentre quello straor-dinario venisse trasmesso sia dalle particelle di etere che da quelle del cristallo. Ma la struttura macroscopica del cristallo gli suggerì che queste particelle fossero di-sposte in modo ordinato ed anisotropo, come possiamo osservare dalle figure che riportò nel Traité de la Lumière. Egli quindi ritenne che il segnale straordinario si debba propagare con velocità diversa nelle diverse direzioni associate agli assi del cristallo. Tra le tante possibili forme che si potevano ipotizzare per le ondine straor-dinarie, egli scelse quella di un ellissoide di rotazione, che per sua ammissione era il caso più semplice da considerare dopo la sfera. L’applicazione del principio dell’inviluppo delle ondine alla rifrazione conduce così a due distinte direzioni di propagazione: una che segue ancora la legge dei seni e l’altra no. Huygens verificò le conseguenze della sua idea con l’esperienza, trovando un accordo che egli stesso chiamò “meraviglioso”. Nel corso di queste sue indagini osservò un fenomeno inat-teso: disponendo due cristalli separati in successione sul cammino di un fascetto di luce, in modo che le loro facce risultassero parallele, nel primo abbiamo la solita suddivisione del fascetto in due, ma ciascuno di questi non subisce un’ulteriore di-visione nel secondo cristallo. Questa suddivisione riappare, dando luogo a quattro fascetti di luce di intensità variabile, se i due cristalli sono ruotati tra loro, per scom-parire ogni 90 . Huygens pensò che questo fosse dovuto ad una qualche proprietà acquistata dalla luce nell’attraversare il primo cristallo (che ora è nota come la po-larizzazione delle onde) per cui quando la luce incontra il reticolo del secondo cri-stallo in una certa posizione è ancora in grado di muovere i due differenti tipi di materia che danno luogo alle due rifrazioni, mentre per un’altra posizione ne può muovere solo una.
Huygens scrisse che «per dire come questo accada, non ho ancora trovato niente che mi soddisfi». Ma scrisse anche che «sebbene finora non sono stato capace di trovarne le cause, per questa ragione non voglio desistere dal descriverli, con lo scopo di dare ad altri l’opportunità di indagarli. Sembra che sarà necessario fare altre supposizioni oltre quelle che ho fatto; tuttavia queste non cesseranno di man-tenere la loro verosimiglianza dopo essere state confermate da così tante prove».
Letture consigliate 157 Noi siamo gli eredi di questo desiderio di scoprire i misteri della Natura: coraggio, fantasia e ipotesi radicalmente nuove saranno necessarie, ma da buoni figli non di-menticheremo la preziosa eredità dei nostri padri.
Letture consigliate
Le notizie storiche di questi cenni sono ricavate dai seguenti testi: Argentieri A., L’ottica di Leonardo, nel volume Leonardo da Vinci, Edizione curata della
mostra di L. da Vinci, 1939, p 405. Bernal John D., Storia della Scienza, di Editori Riuniti, Roma (III ed., 1969). Bevilacqua F. e Ianniello M.G., L’ottica dalle origini all’inizio del ‘700, Loecher ed., Torino
(1982). È un’antologia commentata di vari autori, da Platone a Newton, con l’intento riunificare storicamente l’ottica delle varie discipline (fisica, fisiologica e psicologica) in cui oggi la suddividiamo e di mostrare il nesso tra fisica e metafisica, modelli con-cettuali, principi regolativi e risultati sperimentali.
de Lang H., Christiaan Huygens, originator of wave optics, in "Huygens’ principle 1690-1990, theory and applications", Ed. da H. Blok, H.A. Ferweda, H.K. Kuiken, North-Holland Elsevier Science Publishers B.V. (1992).
Drake Stillman, Galileo, Ed. Il Mulino, Bologna (1988). È una precisa biografia cronologica di Galileo, in cui viene ricostruito l’itinerario intellettuale di questo grande scienziato e le vicende delle persone che gli furono accanto.
Fermat Pier de, Euvres, P. Tannery e C. Henry ed., Paris (1894), II, pp. 485-89. Hall A.R. e Boas Hall M., Storia della scienza, Ed. il Mulino, Bologna (1979). Herzberger Max, Optics from Euclid to Huygens, Applied Optics 5, 1383 (1966). È un sunto
dei contributi salienti di autori di ottica dai tempi antichi a quelli moderni, con un’in-teressante bibliografia.
Lenoble R., Le origini del pensiero scientifico moderno, Universale Laterza ed., Bari (1976). Racconta in modo vivace la storia dello sviluppo del pensiero scientifico e dei perso-naggi che vi contribuirono nel secolo dove la filosofia della scienza e la scienza mo-derna iniziarono finalmente ad influire profondamente nella storia dell’umanità.
Martini Card. Carlo Maria, L’ira di Dio, Ed. Euroclub, Longanesi & C., Milano (1996). Molesini G., Telescope lens-making in the 17th century: The legacy of Vangelista Torricelli,
Optics & Photonics News (April 2010), p. 26-31. Molesini G. e Greco V., Galileo Galilei: Research and development of the telescope, in
Trends in Optics, Reasearch, Development and Applications, ed. da Anna Consortini, ICO, Vol. 3, p. 424-438, Academic Press, London (1996). Sulla base dei documenti storici discute la realizzazione dei telescopi di Galileo e riporta le analisi fatte su di un obiettivo originale di Galileo per stabilirne la qualità ottica.
Polvani Giovanni, Storia delle ricerche sulla natura della luce, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma (1934). Dopo un breve cenno agli autori antichi, descrive la storia dell’ottica tra il 1600 ed il 1900 ed in particolare le ricerche sull’etere.
Ronchi Vasco, Storia della luce, da Euclide a Einstein, Laterza ed., Bari (1983); questa è l’ultima edizione ampliata di Storia della luce, di Vasco Ronchi, N. Zanichelli ed., Bo-logna (1939), che riporta molte belle illustrazioni purtroppo omesse nella nuova edi-zione. È un libro denso di notizie e di critica appassionata sulle concezioni, le idee innovative e gli errori degli autori antichi e moderni, ma che si legge d’un fiato. Scritti di Ottica, Edizioni il Polifilo, Milano (1968). È una ponderosa antologia commentata di vari autori italiani, da Lucrezio ad Amici. Storia del Cannocchiale, Pontificia Acca-
158 Cenni storici: da Empedocle a Huygens
demia delle Scienze, Città del Vaticano (1964). Rosen Edward, The Invention of Eyeglasses, J. of the History of Medicine and Allied Sci-
ences 11, 13-46; 183-218 (1956). Sabra A.I., Theories of Light, from Descartes to Newton, Cambridge University Press, Cam-
bridge (1981). Questo libro analizza passo dopo passo il lavoro degli scienziati del ‘600 che, con la loro eredità dagli autori precedenti, con le loro concezioni filosofiche e con le loro controversie, contribuirono alle teorie sulla natura della luce e le sue proprietà.
Vavilov S.I., Galileo in the history of optics, Soviet Phys. Usp. 7, 596 (1965). Oltre a discu-tere in dettaglio l’attività di Galileo in ottica riporta anche la storia dei suoi precursori.
Wolf Emil, The life and work of Christiaan Huygens, in “Huygens’ principle 1690-1990, theory and applications”, Ed. da H. Blok, H.A. Ferweda, H.K. Kuiken, North-Holland Elsevier Science Publishers B.V. (1992).