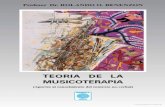Musicoterapia e Coma
-
Upload
alessio-carrus -
Category
Documents
-
view
11 -
download
6
description
Transcript of Musicoterapia e Coma

Dario Benatti
MUSICOTERAPIA E COMA Il primo approccio del Musicoterapeuta al post - comatoso in stato vegetativo o di minima risposta
Questo scritto è dedicato a coloro che si vogliono avvicinare con maggior consapevolezza al mondo del post-comatoso con sindrome da incoscienza prolungata e desiderano aumentare le proprie possibilità di essergli di sostegno ed aiuto nel lungo percorso riabilitativo.
L’esperienza che descriverò si basa sul lavoro degli ultimi 12 anni nell’ambito di una équipe che si occupa della riabilitazione dei pazienti post-comatosi: l’équipe ARICO (Associazione per la Riabilitazione dei Comatosi) [1]. Il gruppo è la parte operativa di una associazione fra operatori ed utenti, creata nel 1989 a Milano e diretta dalla Prof.ssa Cecilia Morosini ed è composto da medici fisiatri, rianimatori, terapisti della riabilitazione, neuropsicologi, musicoterapeuta, logopedisti, psicologi, persegue l’obiettivo di realizzare un trattamento intensivo e globale, generalmente in un ambiente extra-ospedaliero, del paziente post-comatoso.
Al fine di poter avere una maggior comprensione globale del lavoro, descriverò, seppur in grandi linee, la situazione del tutto particolare e propria del post-comatoso (il paziente che, superata la fase acuta rianimativa, ovvero il coma profondo, è entrato in quella che possiamo definire la fase acuta riabilitativa) ai vari livelli neurologico, intellettivo e relazionale. Seguirà la bozza di una programmazione generale con aspetti metodologici ed obiettivi generali e particolari della musicoterapia.
Il lettore tenga però sempre presente che quanto scriverò nelle parti che riguardano l’ intimo del post-comatoso, la sua situazione psichica e la sua percezione del mondo interno ed esterno è, sì basato su una lunga esperienza e su studi approfonditi da parte di molti esperti, tuttavia i dati non sono generalizzabili in toto: ognuno di noi è unico e diverso nella salute e ancor di più nella malattia. Un occhio alla descrizione, quindi, e l’altro al proprio paziente o conoscente per giudicare al meglio la sua effettiva situazione. Un altro invito all’attenzione prima di cominciare: la difficile situazione a livello neurologico, come vedremo più avanti, difficilmente permette al paziente di esprimere in modo comprensibile qualcosa di sé, e se non si hanno grande esperienza e ancor più grande prudenza, si rischia di interpretare in modo sbagliato quello che egli manifesta.
DESCRIZIONE DEL PAZIENTE NELLA FASE ACUTA RIABILITATIVA Il paziente ha superato la fase acuta rianimativa, i parametri vitali si sono stabilizzati, respira autonomamente e le sue funzioni cardio-circolatorie sono stabili. Gli occhi sono generalmente aperti, segno che convenzionalmente contrassegna l’uscita dal coma; è il segno della ripresa della vigilanza (crude consciousness) e del tono di base dell’attività cerebrale sostenuto dalla sostanza reticolare attivante ascendente. Non è ancora accessibile il contenuto di coscienza che, si può ipotizzare, dipenda dalla integrazione delle connessioni cortico-sottocorticali.

Il quadro neurologico è spesso quello di una tetraplegia conclamata (paralisi dei quattro arti), nella quale un’asimmetria di tono e di posture può essere uno dei segni prognostici favorevoli.
Questa prima fase è di regressione ontogenetica globale (alcuni autori parlano di regressione anche pre-ontogenetica). Sul piano motorio si ritorna ai quadri caratteristici della motricità neonatale. Prevale un’attività riflessa primitiva, mancano le reazioni di raddrizzamento e di equilibrio. Compaiono i riflessi orali arcaici, che, se precoci, sono segni prognostici favorevoli. In questa fase di transizione, all’inizio possono essere ancora presenti reazioni neurovegetative massive, che possono manifestarsi anche in relazione con momenti significativi (la vicinanza di figure parentali, ad esempio).
Sul piano intellettivo in questa fase il fenomeno più eclatante sembra essere la dispercezione eccessiva. Gli stimoli esterni ed interni invadono, senza selezione, senza filtro, senza controllo, il cervello e la mente.
Apparentemente non c’è più ordine né strutturale, né funzionale, il paziente congelato è immerso nella violenza degli impulsi visivi, tattili, uditivi, in un caos senza tempo né spazio, dove probabilmente non riconosce né sé stesso né gli altri.
L’attenzione è esauribile, la dispercezione manda in tilt i suoi processi ancora scarsi di focalizzazione, fino ad una possibile reazione psicogena transitoria. La dissoluzione del pensiero è influenzata da questa attenzione labile, ma, viceversa, anche l’attenzione è influenzata dalla dissoluzione del pensiero.
La memoria non è solo dissolta ma anche caotica: il paziente ha perso parte del suo passato e quindi la collocazione di sé nella storia personale e collettiva. Non può ancora imparare il futuro, vive in un presente che non è suo, in una mente e in un corpo che non riconosce come suoi. È probabile che la memoria torni ad essere eidetica come quella dei bambini: una memoria a-temporale per immagini, odori, suoni, sovrapposizioni confuse di eventi. Il passato si è ridotto ad un puzzle rotto, con i pezzi rimasti integri che roteano, separati, nello spazio e che invadono, in modo probabilmente terrificante, la mente in una rapida successione di input senza possibilità di controllo.
Un’altra grande difficoltà del nostro paziente sta nel comunicare con gli altri. Sul piano affettivo e relazionale da una parte lo scarso controllo che ancora ha del proprio corpo, dall’altra parte la mancanza di autocoscienza fanno regredire le sue capacità di comunicazione-relazione a livello primitivo. È bloccato, confuso e contratto ed è difficile capire cosa vuole, se sta bene o male, se ha un dolore o semplicemente vuole essere lasciato in pace perché le sue manifestazioni-reazioni sembrano sempre le stesse.
Solo con grande, grandissima attenzione e tanto tempo a disposizione si riescono a cogliere quei dettagli del movimento, del tono o dei suoni emessi che differenziano le emozioni espresse. Di solito è la mamma del paziente, quando consapevole e non in preda di emozioni troppo forti, che per prima riesce a comprendere qualche suo messaggio nel mezzo del movimento caotico e

distonico o nella quasi immobilità dei micro-movimenti di suo figlio; la guidano il suo istinto materno e la conoscenza profonda dell’essenza del suo comportamento fin dalla gravidanza.
La situazione psicofisica globale del nostro paziente è quindi molto compromessa, dominata dal caos, dalla dispercezione. Il tempo e lo spazio, il corpo stesso hanno perso dimensioni misurabili, egli vive ogni esperienza in modo frammentario e confuso con alla base un senso di impotenza e sofferenza. «Come in un incubo che continua al risveglio, tutti gli interventi esterni appaiono invasivi e terrificanti». [2]
L’angoscia del paziente è anche quella dell’ambiente circostante familiare, sanitario, causata soprattutto dall’impossibilità di comunicare per mezzo dei canali e strumenti consueti, in qualche modo sembra che i suoi sintomi, diluiti, si trasmettano a coloro che lo circondano: difficoltà a comunicare, tendenza alla chiusura, percezione alterata primi fra tutti. Vedremo in seguito come le attività di riabilitazione possono contribuire anche all’evoluzione in positivo di tutto l’ambito familiare.
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI
QUALITÀ E QUANTITÀ DEGLI STIMOLI Nella prima fase del risveglio, è ottima regola ed uso comune che il paziente riceva stimolazioni sensoriali, visive, tattili, acustiche per permettergli un graduale e sempre migliore contatto con l’ambiente. Purtroppo però, in questo periodo, si può incorrere in gravi errori di misura e qualità degli stimoli che possono provocare l’effetto contrario, eccitando nel paziente primordiali istinti di difesa e chiusura.
È quindi opportuno che queste siano costantemente monitorate e regolate il più possibile sulla base dei feedbacks del paziente, oltre che, naturalmente, sulla consapevolezza che in questa fase la dispercezione diffusa e l’instabilità del sistema nervoso impongono che ogni stimolo proposto debba essere mirato e breve e debba essere seguito da un periodo di riposo. Al grido «tutti i canali sensoriali devono essere sollecitati» potrebbero venire infatti, più o meno inconsciamente, messe in atto vere e proprie torture, (tremende anche per un soggetto sano...) come essere interpellati ad alta voce a dieci centimetri dalle orecchie, dover ascoltare musica per ore, ricevere la visita giornaliera di decine di persone, essere piazzati davanti al televisore per tutto il pomeriggio, etc.
Nelle nostre attività, come vedremo, teniamo quindi in grande considerazione la ricerca di
un ottimale contatto con l’ambiente a livello qualitativo, lo riteniamo un obiettivo trasversale, il suo perseguimento comporta cioè, nella nostra ottica, un fondamentale aiuto per il raggiungimento di tutti gli altri obiettivi della nostra programmazione riabilitativa.

OBIETTIVI PRIMARI GENERALI Gli obiettivi di un programma di riabilitazione sono innumerevoli. In grandi linee, riguardano da una parte gli aspetti medici, come l’eliminazione dei sintomi, la diminuzione della sofferenza, il limitare l’insorgenza di danni secondari o terziari, dall’altra parte quelli psicologici e neuropsicologici che si prefiggono lo scopo di condurre il paziente verso l’evocazione e lo sviluppo delle sue potenzialità residue e il riequilibrio del proprio rapporto col mondo esterno con sempre maggiore autonomia e autosufficienza.
Da tutti questi obiettivi possiamo dedurre quello che forse può rappresentare lo scopo primario di ogni relazione di aiuto e che nel nostro specifico caso risulta assolutamente imprescindibile: la ricerca di una migliore qualità della vita o in altre parole del massimo benessere bio-psico-sociale.
Nella fase acuta che il nostro paziente sta percorrendo, pensiamo che per lui il migliorare la
qualità della vita significhi principalmente essere accolto il meglio possibile nel paese straniero nel quale di colpo si è ritrovato.
In seguito al coma, come abbiamo visto, le modalità di input, a livello di schemi sensoriali-
percettivi, di elaborazione dei dati e di output manifestazione-espressione di sé (Feuerstein), si trasformano. Il paziente assume di conseguenza un diverso e personalissimo modo di vedere e sentire ciò che lo circonda e di rapportarsi con esso. Ridisegna così la sua mappa del mondo e acquisisce un nuovo modo di pensare, o almeno di mettere assieme ed associare brandelli di pensiero e nuovissime, neonate premesse epistemologiche entrano subito all’opera nel formare, nello strutturare, un primo abbozzo della sua nuova personalità.
Abbiamo anche visto come lo stato di coscienza del paziente sia così lontano dai livelli
standard della persona sana, così alterato, che è difficilissimo, anche solo parzialmente, raggiungerlo ed intravederne qualche contenuto.
Eppure, e qui sta un punto basilare del nostro approccio terapeutico: pensiamo che la
prima cosa da fare, la prima fra tutte le metodologie, sia quella di ricercare un contatto empatico (Rogers) più profondo possibile col nostro paziente e, consci naturalmente di tutti i limiti e le problematiche che la situazione contingente ci pone, soffermarci ad ascoltarlo, entrare temporaneamente nei suoi panni per avvicinarci il più possibile a questo suo nuovo modo d’essere e di manifestarsi [3].
Questo contatto empatico ci è indispensabile poter stabilire un programma, porsi degli
obiettivi, individuare delle metodologie, il più possibile assieme al paziente. In questo modo, siamo sicuri che i percorsi di nuova crescita, di sviluppo, ricevono un suo grande contributo in consapevolezza, motivazione ed energia, che in riabilitazione rappresentano i punti cardine di ogni risultato [4].

Il contatto profondo si basa principalmente sulla disponibilità a mettersi in ascolto: non si tratta certo di semplice ascoltare, ma di un aprirsi ad una condivisione del sentire, —in un’unità dinamica attraversata e modificata dalle reciproche influenze..— [5] con attenzione profonda a tutto ciò che nell’altro è manifestarsi, emozione, espressione di sé, a tutti i livelli. Non un ascolto passivo, quindi, ma un essere presente totalmente, con tutto il proprio essere, con il proprio, autentico tono di rappresentazione, la propria maniére d’etre là, come la descrive F. Veldman [6] nella ricerca di una profonda comunicazione-relazione con l’altro:
«Nell’offerta della sua persona, nella -presentazione-di-sè, e nel modo di rendersi presente egli (colui che contatta) rivela la dirittura e la veracità delle sue intenzioni: essere lì per l’altro, nella completa accettazione , senza partito preso, senza pregiudizi, senza prevenzione né parzialità, trasparente e chiaro.»
METODOLOGIA GENERALE A livello metodologico, come premessa e sostegno alle attività riabilitative legate da una parte alla terapia, dall’altra parte alla riorganizzazione delle abilità comunicativo-relazionali (funzioni tutorali di framing o di scaffolding; Bruner, Vygotsky), il nostro programma iniziale prevede quindi, in modo trasversale, la ricerca di un ottimale matching: incontro-accoglienza-accettazione incondizionata del paziente nella totalità del suo essere in quel momento.
In primo luogo, cerchiamo di fare in modo che tutti coloro che si avvicinano al paziente in questa fase assumano atteggiamenti e comportamenti che, pur nelle diverse e personali modalità di approccio, abbiano come denominatore comune estrema delicatezza e rispetto.
In qualsiasi nostra attività, ad esempio, noi cerchiamo di agire in modo facilitante,
accettante, mirante ad instaurare un ideale rapport (Programmazione neurolinguistica). Modalità comunicativo-relazionali efficaci tra l’altro, per esteso, anche per instaurare un rapporto positivo con tutti i malati e le persone con difficoltà a vario livello.
Ad esempio, tra i possibili atteggiamenti, troviamo perfetti quelli ricordati da Mauro
Scardovelli S [7]:
o rispetto, stima, fiducia positiva incondizionata nella persona e nelle sue potenzialità; o ascolto, attenzione, ricettività empatica; o considerazione positiva del tempo e dell’attesa; o congruenza, trasparenza; o flessibilità; o accettazione incondizionata della persona nel suo stato attuale; o creatività.

Tra gli atteggiamenti negativi cerchiamo, viceversa, di evitare: chiusura, rigidità, impazienza, fretta, attaccamento ad un ruolo, distanza emotiva, incongruenza, scarsa autenticità, interpretatività fantasiosa.
A livello tecnico-strumentale, come vedremo più avanti in dettaglio, fra le varie tecniche
riabilitative e rieducative del nostro centro trova posto anche una particolare tecnica di trattamento che prevede l’associazione di musicoterapia, neuropsicologia e comunicazione psicotattile.
Le potenzialità della neuropsicologia vengono qui integrate dalle modalità di approccio
psicotattili ricche di benessere, in quanto basate su livelli di contatto affettivo-confermante molto elevati, e dalle eccezionali proprietà della musica in quanto a motivazione e bellezza.
In effetti la fusione di queste discipline non è affatto casuale o forzata: il musicoterapeuta, se
da una parte ricerca nel suo lavoro un contatto col paziente che crei un clima empatico, creativo e piacevole, dall’altra parte si basa su fondamenti metodologici e programmatici simili a quelli del neuropsicologo. Parimenti il neuropsicologo deve tenere conto degli aspetti emotivi legati al trauma del disordine cognitivo e quindi trovare nuove vie (come nel nostro caso) che gli permettano di affrontare queste problematiche con strumenti efficaci. PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI DI MUSICOTERAPIA NEUROPSICOLOGICA [8] NELLA FASE ACUTA RIABILITATIVA POST-COMA
OBIETTIVI SPECIFICI
a. Favorire la ristrutturazione della coscienza del sé (dalla percezione di sé alla ricostruzione dell’immagine di sé e dello schema corporeo);
b. rieducare i tempi e i modi dell’attenzione per favorire la ristrutturazione dell’orientamento spazio-temporale in modo che il paziente ritrovi un senso in ciò che accade dentro ed attorno a sé nel tempo e nello spazio;
c. favorire la ricostruzione di una reazione di attaccamento per ottenere una buona sicurezza emotiva nei confronti del mondo circostante (famiglia, operatori, ambiente in generale) in modo tale da migliorare comunicazione e relazione.
Tratterò in dettaglio i primi due punti chiedendo di considerare le metodologie riguardanti il terzo obiettivo, come comprese nella trattazione dei primi due punti.
A. FAVORIRE LA RISTRUTTURAZIONE DELLA COSCIENZA DEL SÉ In questa prima fase post-coma, come abbiamo visto, il paziente non ha più la propria normale capacità di percepire e farsi un’immagine del proprio corpo, ne ha perso i confini, non è consapevole della linea di delimitazione tra il proprio corpo e l’ambiente e tra il proprio corpo e il corpo degli altri.

Una delle caratteristiche che rendono il recupero complesso e difficile è che pare che il coma causi contemporaneamente, da una parte, una regressione ontogenetica globale, dall’altra parte un parcellizzarsi frammentario e disorganizzato della memoria e della coscienza.
È dunque evidente che in questa situazione una ristrutturazione della coscienza di sé necessita per “prendere corpo” dell’integrazione di due diversi percorsi paralleli reciprocamente influenzantisi: l’uno che segue il naturale cammino evolutivo biologico e tende alla ristrutturazione dello schema corporeo come nel normale percorso di sviluppo ontogenetico, l’altro che origina dalla riorganizzazione dei dati ancora a disposizione nella memoria dei vissuti del corpo.
Naturalmente il nostro paziente è già al lavoro in questa direzione e possiamo senz’altro dire che possiede già una sua primitiva organizzazione che va tenuta in conto con estrema attenzione alle sue prime manifestazioni.
SOTTO OBIETTIVI
o Diminuire l’intensità delle dispercezioni corporee attraverso una attenta modulazione delle stimolazioni sensitive (diremmo più volentieri “proposte” sensoriali) e una particolare cura della transmodalità.
o favorire la percezione del corpo, il formarsi dell’immagine di sé e dello schema corporeo.
METODOLOGIA Sappiamo che lo schema corporeo è il risultato di un continuo processo di destrutturazione-ristrutturazione al quale contribuiscono più forze: dalle percezioni e loro integrazione, alla sfera affettiva-relazionale, alla maturazione cognitiva (che però va oltre la semplice somma di questi). Sappiamo però anche che sono i processi emotivi positivi quelli che costituiscono la forza e la sorgente di energia dei processi costruttivi e che li dirigono. Nel coma la regressione porta l’individuo a ricomporre in termini drammatici l’integrità raggiunta prima dell’evento traumatico. Egli sembra a tratti riacquisire i suoi contenuti mentali attraverso la dimensione affettiva, e come nelle prime fasi di vita, gli eventi esterni si animano e sono animati secondo un valore emozionale. I percorsi esperienziali proposti sono quindi sempre permeati da emozioni positive, modulate con gradualità, ecologiche (per il sistema-paziente, ma anche per il sistema paziente-operatore-setting), al fine di contribuire ad una sana ristrutturazione dei confini e dello schema del corpo.
Nella programmazione dei percorsi esperienziali ci sono di grande aiuto gli studi di F. Veldman, che ha elaborato la suddivisione particolareggiata delle varie modalità di rappresentazione del corpo. Secondo l’autore ognuno di noi si rappresenta in:
o un corpo sostanziale (le corps), termine che rappresenta, in senso stretto, il substrato dell’insieme dell’individuo vivente, l’insieme delle cellule che lo compongono. Il puro e semplice corpo;
o un corpo funzionale (le corporel), ovvero la manifestazione delle caratteristiche individuali, determinate anatomicamente e fisiologicamente, che si esprimono nelle funzioni biologiche vitali e che sono influenzate dalle caratteristiche del modo di vivere e

dell’esperienza. Possiamo definirlo semplicemente il corpo che si manifesta nelle sue funzioni vitali: il battito cardiaco, il respiro, il sistema neurovegetativo;
o un corpo espressivo (la corporalité), che racchiude e completa i primi due esprimendo il modo di essere del tutto personale ed unico, (maniére d’etre) soggettivo nella autentica manifestazione del sé: il corpo rivestito di anima, o, per citare la Prof.ssa Cecilia Morosini, Direttrice dell’ARICO: «il corpo colorato dal sé».
Trovo estremamente utile questa distinzione (anche se, come anche Veldman conferma, in una visione olistica della persona non è pensabile considerare le tre parti disgiunte) per le nostre attività, ad esempio nelle fasi di calibrazione e rispecchiamento, in quanto ci consente di considerare con più attenzione i livelli corporei più profondi della espressività della persona intesa anche semplicemente come manifestazione della vita. Ad esempio, è prassi comune ad ogni nostra seduta che l’operatore ascolti e faccia momentaneamente propri la postura, il tono muscolare, il respiro del proprio paziente e che in ogni attività egli tenga conto di questi come elementi base tonici, ritmici, energetici sui quali costruire un progetto condiviso di lavoro.
STRUMENTI E TECNICHE Le attività si basano principalmente su vissuti del proprio corpo e del mondo esterno che portino gradatamente alla ricostruzione globale dell’immagine di sé (e quindi contemporaneamente alla definizione dello schema corporeo) attraverso le varie modalità rappresentazionali:
o cenestesica; o tattile; o labirintica; o uditiva; o visiva; o (non le sviluppiamo in questa sede ma si utilizzano anche le modalità olfattiva e gustativa).
Non mi sembra superfluo ricordare che il paziente vive per la maggior parte del tempo il suo
corpo come fonte di dolore e come porta aperta alle intrusioni; diventa quindi importante, appena possibile e in un’ottica di ristrutturazione neuropsicologica, scegliere esperienze gratificanti e ricche di benessere, piene di accettazione e di empatia. In questo modo fra le persone coinvolte si crea un clima positivo, base sicura per l’emergere di energia e motivazione e il paziente ha la possibilità di accogliere positivamente, nel percepirsi come fonte di benessere, una rinnovata rappresentazione di sé.
Ogni contatto col paziente mirante all’acquisizione dell’immagine di sé e dello schema
corporeo è fatto attraverso le modalità psicotattili. Una metodologia che tiene contemporaneamente conto degli aspetti psicologici e neurologici della percezione tonico-tattile. Nel contatto infatti si tiene conto di quanto la pelle abbia il ruolo di contenimento psichico (oltre che fisico di barriera anti-stimolo) e di coesione del sé.
Alla comunicazione psicotattile si associa il suono, la musica, in modo da vivere col paziente un
processo di integrazione di esperienze sensoriali capaci di condurlo a momenti della sua esistenza

estremamente ricchi di benessere come quelli prenatali (il paradiso perduto di Fornari [9]). La modalità ideale per ottenere il raggiungimento di questo obiettivo è "un vissuto partecipe in comunione di anima e corpo". Durante ogni intervento, l’operatore è presente ancor più che nel ruolo di terapeuta, in quello di "compagno di viaggio". I due si lasciano attraversare e modificare dalle reciproche influenze tonico-energetiche, vivono assieme ogni momento, anche situazioni pregne di emozioni, in un dialogo senza soluzione di continuità che comprende tutti i possibili canali e quindi tutte le possibili manifestazioni dell’essere vivente, coi loro livelli di contenuto e di relazione (il livello di relazione, secondo la terminologia della "Pragmatica della comunicazione umana" di Watzlawich, è quello che traspare, autentico, nei messaggi non verbali, un livello che riguarda le questioni vitali di accettazione e conferma di sé e dell’altro).
È comunque importante tenere in considerazione che chi vuole affrontare queste attività di
contatto empatico con pazienti gravi o gravissimi, se da una parte ha bisogno di una preparazione molto approfondita nel proprio specifico campo di competenza, dall’altra parte deve prepararsi adeguatamente a saper sopportare, ma ancora di più, oserei dire, a saper vivere come momenti di grande consapevolezza, compassione (nel senso di con-passione) e crescita personale le esperienze, altrimenti terribili, della sofferenza estrema o della morte (è comunque utile ricordare la grande importanza di avere sempre a disposizione uno scudo di protezione e la capacità di porsi in posizione meta quando necessario).
Note [1] L’ARICO è divenuta fondazione nel 2004, ora è chiamata “Fondazione Morosini” [2] Morosini, De Angelis, Atti del congresso ARICO, Milano 1986). [3] E’ una modalità di approccio, quella basata sull’ascolto empatico, che presenta diverse difficoltà, una delle più importanti è quella legata al dolore e alla sofferenza, sentimenti che inevitabilmente entrano in scena nella rappresentazione dei sentimenti del paziente: fanno molta paura e tutti noi, naturalmente, tendiamo a evitarne il contatto. E’ normale, umano e in più socialmente accettato, lo possiamo osservare ogni giorno e dovunque che la sofferenza è sfuggita, è emarginata. Diviene quindi estremamente difficoltoso raggiungere uno stato di empatia pieno con lui: avremo la tendenza a non entrare che parzialmente nel "suo mondo", a porre dei limiti di accettazione, a vivere in modo "contratto" i nostri sentimenti. Se vogliamo un vero contatto empatico con il nostro paziente dovremo quindi prepararci adeguatamente a saper sopportare, ma ancora di più, oserei dire, a saper vivere come momenti di grande consapevolezza, compassione (nel senso di con-passione) e crescita personale le esperienze della sofferenza. e della paura. [4] Non vi nascondo le difficoltà di questo tipo di approccio che mira alla compartecipazione. Ad esempio, è molto più facile per noi operatori, agire subito, operando sulla base di tecniche ben sperimentate e riconosciute, sostenuti da salde linee teoriche sulla riabilitazione, piuttosto che soffermarsi, magari a lungo, a condividere il lavoro e ad ascoltare in modo profondo il nostro paziente, con tutte le sue difficoltà di ordine neurologico e psicologico. La pazienza dell’attesa e la capacità di accogliere sono veramente indispensabili quando si sta con lui! Spesso, ad esempio, è lentissimo nelle poche risposte che sa dare (per avere un semplice "si", codificato nel movimento di una palpebra che si chiude, a volte è necessario attendere a lungo o ripetere più volte la domanda) e, se non si vuole solo operare su di lui, bisogna, ripeto, saperlo aspettare ed ascoltare. Solo in questo modo, gradatamente e col tempo, potremo scoprire, riconoscere e fare nostri, anche se momentaneamente ed in modo parziale, i suoi bisogni, le sue istanze e desideri più reconditi. Anche per gli amici e i parenti è molto più semplice basarsi su una visione della vita e del benessere socialmente condivisi, a livelli di coscienza "normali" (tipo "bisogna essere efficienti", "il tempo è denaro", e cose del genere) che ascoltare, riconoscere e, per quanto possibile, rispettare idee e motivazioni magari diametralmente opposte alle nostre ("oggi non ho voglia di fare niente", "preferisco non vedere nessuno" ecc.). [5] Aureli Tiziana, L’osservazione del comportamento del bambino, Il mulino editore [6] Veldman Frans, Haptonomie, science de l’affectivité, PUF Parigi [7] cardovelli Mauro, Musica e trasformazione, Borla [8] ho coniato il termine “musicoterapia neuropsicologica” per definire in senso stretto gli studi e le nuove tecniche di musicoterapia che ho sviluppato negli ultimi 15 anni e che hanno come specifici obiettivi quelli della riabilitazione neuropsicologica. [9] Fornari Franco, Psicoanalisi della musica, Longanesi Mi, 1984

COMA, LA MUSICA FAVORISCE IL RISVEGLIO Anche le note e le canzoni possono aiutare a uscire dalla condizione di non coscienza
L'ascolto di canzoni può facilitare il risveglio dal coma
Il coma è una condizione di non coscienza diagnosticabile come tale in chi ha gli occhi chiusi, non esegue alcun comando e non dice nessuna parola comprensibile. Per misurare se sia più o meno profondo, a seconda delle reazioni a determinati stimoli, ci si avvale della scala di valutazione di Glasgow: il punteggio, da 3 a 15, sale a mano a mano che il malato recupera responsività. I centri specializzati dispongono anche di una tecnica diagnostica innovativa, la risonanza magnetica funzionale, per sondare l'attivazione cerebrale del paziente con disturbi di coscienza, in risposta a stimolazioni esterne.
L'EVOLUZIONE Dopo tre-quattro settimane, tutte le persone in coma riaprono gli occhi. Li aspetta un bivio: o si risvegliano oppure si avviano allo stato vegetativo, che è una condizione di incoscienza a occhi aperti. IL RECUPERO «Ci sono fattori e dati clinici che consentono di fare una prognosi», dice Rita Formisano, primario dell'unità post coma dell'ospedale di riabilitazione Santa Lucia a Roma. «Per esempio, hanno maggiori probabilità di recupero i giovani e chi conserva movimenti spontanei. Anche la causa del coma può incidere sulla prognosi, che è in genere più favorevole nei casi di trauma cranico mentre lo è meno in quelli di ipo-ossigenazione cerebrale dovuta ad arresto cardiocircolatorio». La maggioranza dei pazienti potrebbe recuperare la coscienza entro un anno dall'evento acuto, nei casi traumatici, e sei mesi in quelli da altre cause. Ci sono recuperi tardivi avvenuti oltre l'anno ma

il passare del tempo non gioca a favore del malato. È comunque un campo in cui la scienza medica non dispone ancora di certezze e ci sono molte più domande che risposte. LE TECNICHE PIÙ NUOVE «Oggi esistono nuove tecniche terapeutiche che possono sollecitare il risveglio», spiega Formisano, «come la stimolazione magnetica transcranica, l'applicazione di stimolatori cerebrali profondi, o anche farmaci quali lo zolpidem o i dopaminergici. Senza dimenticare altri approcci da tempo in uso e spesso efficaci (al di là della difficoltà di dimostrazioni scientifiche), quali la riabilitazione in acqua o la musicoterapia».