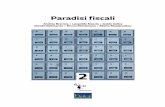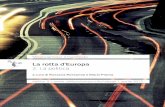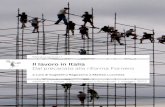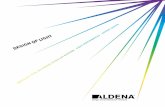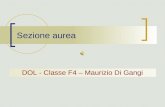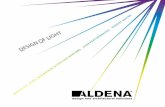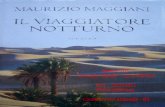militare Il nano -...
Transcript of militare Il nano -...
«Si può dimostrare che, an-che se potessimo abolire laguerra, il commercio esteroindurrebbe a relazioni di di-pendenza e di influenza.Definiamo questo l’effettoinfluenza del commercioestero» ( Albert O. Hirsch-man. "Potenza nazionale ecommercio estero". Il Muli-no, 1987). Certo assai diffu-
sa era l’apologia della divi-sione internazionale del la-voro e del commercio inter-nazionale, ma (e cito Key-nes, pag.339 di "Occupazio-ne, interesse e moneta")«erano mossi da buon sen-so e da una corretta intelli-genza dell’andamento rea-le delle cose quegli uominidi stato i quali ritenevano
che se un paese vecchio e ric-co avesse trascurato la lottaper i mercati, la sua prosperi-tà sarebbe andata discenden-do fino a svanire».
Insomma, per riprende-re Hirschmann, anche senon ci sono soldati e non sispara, la guerra continuasotto il nome virtuoso diconcorrenza internaziona-
le, che provoca fallimenti,disoccupazione e miserianei paesi più deboli, anchese hanno prodotti di otti-ma qualità. Nella nostraItalia il caso Fiat ci dicequalcosa. E con l’euro è tut-to più facile. Il commerciointernazionale non si puòabolire, ma con il capitali-smo rimane guerra.
Il nanoARMATO
Larilettura
AlbertHirschman e le armi del commercio
Uno scambio di battute tra i leader dei due paesi eu-ropei più impegnati nelle questioni di difesa – ilbritannico David Cameron e il francese François
Hollande – illustrano meglio di tante spiegazioni lo statodella politica di sicurezza e di difesa comuni della Ue. Lascena ha avuto luogo al Consiglio europeo dello scorsodicembre, dedicato per la prima volta da anni alle que-stioni della difesa. «Bloccherò ogni iniziativa che miri adotare le istituzioni europee di reali capacità militari», haaffermato Cameron. «Nessuno prevede la creazione diun esercito europeo», ha ribattuto Hollande. Eppure iltrattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009,
aveva ripreso agli articoli 42-46 la politica di sicurezza edi difesa comuni del trattato di Maastricht (titolo V), cheprevedevano la realizzazione di una politica estera e di di-fesa comuni, con la specificazione, comunque, che nonsi sarebbe sostituita alla Nato.
Da allora nulla o quasi si è mosso. Molti stati evoca-no la mancanza di denaro per giustificare la paralisidella difesa comune. Ma, complessivamente, gli statidella Ue spendono il 40% di quanto facciano gli Usa,
con capacità operative però pari soltanto al 10% diquelle statunitensi. Viene invocata la priorità data alsoft power in Europa rispetto alla potenza militare.Ma gli stati europei non sono programmaticamentepacifisti. Questa sarebbe una scelta politica chiara.Sono invece preda dei vecchi nazionalismi, ognunoper sé, con le ex grandi potenze che pensano di poteragire ancora da sole nello scenario internazionale –Francia e Gran Bretagna - cercando una alla voltal’appoggio degli Usa, e la Germania che mantieneuna posizione reticente, pur non disdegnando la pro-duzione e l’export di armi. CONTINUA |PAGINA II
Il complessomilitare
Sbilanciamo l’Europa
Anna Maria Merlo
L’Inghilterra dice no all’esercito continentale, la Francia invia le proprie truppe in Africa, l’Italiasi accoda alla Nato e acquista bombardieri e portaerei. L’Europa non ha una politica di difesacomune. L’alternativa pacifista: un servizio civile comune e corpi di pace nelle aree di conflitto
Leopoldo Nascia
M atteo Renzi si è accortoche tra i tagli possibili cisono i cacciabombardieri
F35 americani. Ma l’annuncio, co-me nel suo stile, è durato lo spa-zio di una dichiarazione. Nessunpericolo per la Lockheed Martin eper i generali italiani. Eppure gliF35 sono la sintesi di tutti gli erro-ri possibili, d’Italia e d’Europa.Con la spesa in bilancio nel 2014si potevano mettere in sicurezza1500 scuole. Hanno costi enormie gli stessi vertici Usa ne denun-ciano i problemi tecnici non risol-ti. Sono già stati cancellati o ridi-mensionati da vari paesi, ma l’Ita-lia è determinata ad andare avan-ti. Riflettono il monopolio milita-re americano e il fallimento del-l’integrazione europea nella dife-sa. Mettono l’integrazione delle ar-mi in ambito Nato davanti a quel-la europea.
L’Europa è sempre più "nanopolitico", ma le sue armi continua-no a crescere, al servizio del pote-re americano, degli interessi geo-politici dei paesi più ambiziosi –Francia e Gran Bretagna innanzitutto, le due potenze nucleari delcontinente - e degli apparati mili-tari-industriali di ciascun paese.
Il "nano politico" si è visto al-l’opera in Ucraina: subalterno al-le ambizioni della Nato, con unapolitica estera ridotta agli accor-di commerciali, ma trascinatopoi – era già avvenuto nell’ex-Ju-goslavia – nei conflitti innescatida frammentazione politica, de-clino economico e nazionalismi.Ancora peggio è andata in Siria oin Libia: divisioni europee, pres-sioni sbagliate per interventi mili-tari, nessuna soluzione politicacapace di costruire stabilità e de-mocrazia.
Manca – in Europa come in Ita-lia – la politica: l’idea che la sicu-rezza possa essere assicuratanon dalle armi ma dalle relazio-ni politiche, economiche e socia-li tra diversi – tra stati e all’inter-no degli stati.
Incapace di accrescere la suastatura politica, il "nano" si ar-ma: l’industria militare ha risen-tito meno di altre della crisi, leesportazioni verso i conflitti delsud del mondo continuano a cre-scere, nel suo momento piùdrammatico la Grecia, che stavatagliando tutto, ha confermatol’acquisto dalla Germania di inu-tili sottomarini militari. Così ve-diamo una spesa militare chequasi ovunque non è stata ferma-ta dall’austerità: in Italia si stabi-lizza mentre cadono le spese so-ciali, le missioni militari all’este-ro – nuova vocazione nazionale– si moltiplicano, alla ricerca diruolo internazionale e nuovi affa-ri. Intanto, nei paesi emergentila tentazione delle armi si diffon-de, il sistema militare si rafforzae con esso instabilità e conflitti.
Un’alternativa all’impotenzadella politica e al potere del com-plesso militare-indistriale c’è:una politica più disarmata e piùcapace di affrontare i conflitti.Al posto degli F35 ci voglionocorpi di pace e servizio civile eu-ropeo. Al posto della liberalizza-zione commerciale, accordi persostenere uno sviluppo sosteni-bile nei paesi vicini all’Europa,all’est come nel Mediterraneo ein Africa. Al posto del cortocir-cuito mediatico tra poteri autori-tari e conflitti violenti, la praticadi più democrazia.
Valentino Parlato
VENERDÌ 14 MARZO 2014 WWW.SBILANCIAMOCI.INFO - N˚8 SUPPLEMENTO AL NUMERO ODIERNO
La Francia gendarmedi un’Europa senza esercito
A nalizzando i dati più recenti forni-ti dal Sipri – Stockholm internatio-nal peace research institute - si
può riscontrare come le politiche di ri-sanamento di bilancio, negli ultimi an-ni, abbiano influito sensibilmente sul-l’andamento delle spese militari. A cau-sa della crisi finanziaria la maggior par-te dei paesi dell’Unione Europea fa re-gistrare quote di spesa inferiori rispet-to al 2011 e in decremento rispetto atutto il decennio 2003-2012.
Il Sipri e la maggior parte degli enti diricerca nel settore considerano la spesamilitare come la somma di una serie dispese in conto capitale riguardanti leforze armate, incluse quelle preposte al-le operazioni di peacekeeping. A que-ste si aggiungono poi altre macro vocidi costo come quelle relative ad altreagenzie ingaggiate in progetti della di-fesa, ma anche le forze paramilitari(purché ritenute disponibili per atti-vità militari). Altre voci disaggrega-te attinenti alla spesa per il perso-nale in servizio militare e civile,per le operazioni di manutenzio-ne, per la ricerca e lo sviluppo ditecnologia militare e per gli aiutimilitari completano il quadro.
Se guardiamo ai paesi del-l’Ue, sulla base dei dati relati-vi al 2012, si riscontra un pri-mo gruppo di stati la cui spesa com-plessiva si attesta attorno ai 30 miliar-di di dollari. Si tratta di Francia, Re-gno Unito, Germania e Italia. Vi è poiun secondo gruppo, costituito dallamaggioranza degli stati dell’Unione,compreso nella fascia tra i 56 milionidi dollari di Malta ai circa 12 miliardidella Spagna. Considerando la confi-gurazione futura dell’Ue, ad aprire ilsecondo gruppo troveremmo la Tur-chia, con una spesa militare di17,9 miliardi di dollari.
La Spagna rientra nel gruppo di pae-si europei la cui spesa è di molto infe-riore ai 30 miliardi di dollari. Secondo idati Sipri, negli ultimi cinque anni si èclassificata come il settimo esportatoremondiale di tecnologia bellica. Comenel caso italiano però, anche le spesesostenute da Madrid si sono ridotte acausa della crisi finanziaria, passandodai 18,5 miliardi di dollari del 2008 aicirca 12,2 miliardi del 2012. Nel 2004,anno del ritiro della Spagna dalla mis-sione internazionale in Iraq a seguitodegli attentati di Madrid, la quota di bi-lancio destinata agli armamenti e alladifesa era superiore a quella attuale.
Altro caso emblematico tra i Piigs èquello della Grecia. Il pesante piano dirientro imposto ad Atene dalla troika
non ha risparmiato nemmeno ipiani di aggiornamento e moder-
nizzazione delle forze armate.Le importazioni di armi so-
no crollate e la Greciadal quarto posto
nella classificamondiale tra il2003 e il 2007 èprecipitata poial quindicesimo
nel 2012. Un an-damento che segue
quello dei fondi stan-ziati per la difesa: pri-ma una drastica im-pennata da 8 a 11,5 mi-
liardi di dollari fra il2003 e il 2009, poi unanetta flessione nel trien-nio successivo, fino ai 7miliardi circa del 2012.Una cifra che, rapporta-ta a una popolazione di
appena 11 milioni di abi-tanti, comporta una spe-sa pro-capite di 616 dol-
lari, più alta persi-no di Italia eGermania.
L’industria bellicamarcia verso OrientePer la prima volta dal 1998, le vendite calano dello 0,4%. Il baricentrosi sposta da occidente a est. Cresce la Cina, che entra nella top fivedi esportatori. Nonostante i trattati, troppe armi nucleari in giro
DALLA PRIMA PAGINAAnna Maria Merlo
A CAUSA DELLA RECESSIONE, LA SPENDINGREVIEW DEI PIIGS HA COLPITO ANCHE IL SETTOREDIFENSIVO. NON ACCADEVA DAL 2003. HANNOPESATO ANCHE IL RITIRO DELLE TRUPPE DALL’IRAQE LA FINE DELL’«EMERGENZA TERRORISMO»
Nei fatti, la Francia decide da sola gli interventi esterni,salvo poi rivolgersi alla Ue per chiedere appoggio e finan-ziamenti, mentre la Gran Bretagna non si smuove dalla
centralità della Nato, rifiuta la difesa europea e si limita a firmareaccordi bilaterali. Gli altri paesi stanno a guardare, con alcuni epi-sodi velleitari decisi qui e là da governi che vogliono mostrare imuscoli.
Mentre l’abbandono della presenza in Afghanistan è già in pro-gramma, un paese europeo è impegnato in due interventi milita-ri: la Francia di Hollande è in Mali da un più di anno e dal 5 di-cembre scorso interviene in Centrafrica (era anche pronta ad agi-re in Siria, se Obama non avesse rinunciato). Nel 2011 la parteci-pazione all’intervento in Libia era stata decisa da qualche paese,sulla scia di Francia e Gran Bretagna, come partecipazione nazio-
nale. Sul Mali e il Centrafrica Parigi ha deciso da sola e agisce insolitudine. La Francia vorrebbe però che venisse creato nella Ueun fondo permanente destinato a finanziare le operazioni milita-ri esterne. Ma Hollande precisa: «Non vogliamo essere la forza ar-mata e non chiediamo di essere pagati, non siamo dei mercenariné i gendarmi dell’Europa». La Francia fa valere però ilf atto chein Sahel e in Centrafrica difende la sicurezza europea contro il ter-rorismo jihadista e che quindi sarebbe necessario «condividere ilfardello» finanziario. Ma Hollande non ha chiesto niente ai part-ner prima di intervenire e nel caso di una missione esterna dellaUe è richiesta l’unanimità dei paesi membri. Anche i battlegroups europei (la Forza di reazione rapida), che esistono sullacarta dal 2007, non sono mai serviti, anche se è stato deciso di in-viare 500 uomini in Centrafrica, ma la data non è ancora stata de-finita, per coadiuvare i 1600 militari francesi presenti (altri 400 do-vrebbero essere inviati a breve, in un paese a rischio di pulizia et-nica e di partizione). Per ora, l’Ue partecipa a minima all’opera-zione Sangaris in Centrafrica, con 50 milioni di euro a favore del-la Misca (missione africana) e altrettanti in aiuti umanitari. In Ma-li c’era stato un minimo appoggio logistico ai francesi di alcunistati membri, ma molto inferiore a quello concesso dagli Usa al-l’operazione Serval (aerei di rifornimento, trasporto e intelligen-ce, oltre alla vendita a Parigi di due droni, tecnologia non ancorasviluppata dall’industria dell’armamento francese).
Sergio Andreis
Mattia Ciampicacigli
La spesa militare globale nel2012, l’anno per il quale sonodisponibili i dati più recenti
pubblicati dal Sipri, è stimata a1.756 miliardi di dollari, il 2,5 percento del prodotto interno lordomondiale, circa 249 dollari per ogniabitante del pianeta. Il totale in ter-mini reali è diminuito dello 0,4 percento circa rispetto al 2011, la primaflessione dal 1998, ma comunque su-periore a quello di un qualunque an-no dalla fine della seconda guerramondiale al 2010. La distribuzionedella spesa militare nel 2012 eviden-zia i primi segnali di uno spostamen-to del baricentro dall’Occidente ver-so altre parti del mondo, in particola-re Europa orientale e paesi in via disviluppo.
Per quanto riguarda la produzio-ne di armamenti, i dati più recenti -il Sipri Top 100, che ordina le mag-giori imprese produttrici (esclusa laCina) in base al volume delle lorovendite di armi - sono stati resi notilo scorso 31 gennaio e si riferisconoal 2012. Segnalano che le vendite to-tali vengono quantificate in 395 mi-liardi di dollari, meno 4,2 per centoin termini reali rispetto al 2011; sitratta della seconda diminuzione an-nuale consecutiva, ma il totale restadel 29 per cento maggiore rispetto aquello del 2003; l’industria mondialedegli armamenti continua ad esserefortemente accentrata, con le primedieci industrie produttrici, tre quartidelle quali hanno le proprie sedi inNord-America o nell’Europa occi-dentale, che coprono il 52,1 per cen-to delle vendite totali di armi.
Sul versante del commercio inter-nazionale di armi, il volume dei tra-sferimenti internazionali di arma-menti convenzionali maggiori tra il2003-2007 e il 2008-2012 è cresciutodel 17 per cento. I cinque più grandifornitori del periodo 2008-2012 - Sta-ti Uniti, Russia, Germania, Francia eCina – sono stati responsabili del 75per cento del volume delle esporta-zioni. È la prima volta dalla fine dellaguerra fredda che la Cina figura tra icinque maggiori esportatori di arma-menti, che in precedenza erano uni-camente Stati Uniti e paesi europei.
Infine, senza voler aggiungere learmi chimiche, biologiche, batterio-logiche e i materiali dual use, quelleproduzioni che possono avere usisia civili che militari, la situazione
delle testate nucleari: nonostante lasottoscrizione, l’8 aprile 2010, a Pra-ga, da parte di Usa e Russia del Nuo-vo, dopo quello del 1991, TrattatoStart, per ulteriori riduzioni dei ri-spettivi arsenali nucleari, ogni otti-mismo sarebbe fuori luogo. All’ini-zio del 2013 otto stati si trovavano inpossesso approssimativamente dicirca 4.400 armi nucleari operative,di cui quasi duemila tenute in statodi elevata prontezza. Se si contanotutte le testate - operative, di riserva,immagazzinate (attive o meno) e inattesa di smantellamento - Stati Uni-ti, Russia, Regno Unito, Francia, Ci-na, India, Pakistan e Israele sono inpossesso complessivamente di circa17.270 armi nucleari. Un mondo so-vrarmato. Da disarmare.
VENERDÌ 14 MARZO 2014SBILANCIAMO L’EUROPAN˚8 - PAGINA II
La crisi rallental’industria militarenel sud EuropaLa Grecia riduce le spese, che però rimangonopiù alte, in proporzione, di Italia e Germania.Solo la Spagna rimane sotto i 30 miliardi di dollari
UNA BANDIERA DELLA PACE GARRISCE AL VENTO /FOTO REUTERS
D alla caduta del muro di Berlino,la transizione del modello di di-fesa dell’Italia (al pari del siste-
ma politico) è perennamente incom-piuta, rapsodica, contraddittoria. Da 20anni ad oggi si sono alternati documen-ti di vario tipo (studi, dossier, program-mi, proposte di legge, ecc.) che hannotentato di ridisegnare il modello di dife-sa italiano sulla base delle nuove strate-gie della Nato - dopo la fine del bipolari-smo - e del cambiamento delle relazio-ni internazionali del nostro paese e deisuoi impegni con le missioni all’estero,enormemente incrementate a partiredagli anni ’90.
Per molto tempo le nostre forze arma-te sono state prigioniere di alti livelli diburocrazia, di inefficienza, di sovradi-mensionamento funzionale, di sprechi(anche le gerachie delle forze armate so-no una specie di casta) che hanno ca-ratterizzato un livello alto delle spesemilitari, tendenzialmente e concreta-mente in crescita in questi ultimivent’anni. E non solo per le spese altedel personale e del funzionamento or-dinario del sistema delle Forze Arma-te, ma anche per una serie di investi-menti nei sistemi d’arma, in alcuni ca-si inutili e sovradimensionati rispettoalle esigenze: e che servono, come pergli F35, solo a fare la guerra e qualcheaffare a Finmeccanica. Un esempio pa-radigmatico è quello della portaerei Ca-vour, per la quale abbiamo speso 1 mi-liardo e 700 milioni di euro, rimastainutilizzata e che risponde solo a ragio-ni di status e di prestigio nazionale.L’Italia non poteva non avere una por-taerei per non sfigurare davanti ai suoialleati europei e della Nato.
Con la legge delega 244 del 2012 diriordino dello strumento della difesa(in pratica uno degli ultimi provvedi-menti del governo Monti, ad opera delministro della Difesa, l’ammiraglio Di
Paola) siamo entrati - con la successivaemanazione dei decreti attuativi avve-nuti in questa legislatura - in una fasenuova. Assistiamo così a un salto diqualità adel nostro sistema della Dife-sa, il cui senso è riassunto in uno scam-bio tra riduzione del personale e inve-stimenti dei risparmi ottenuti nei siste-mi d’arma, a partire dagli F35, dalle fre-gate Fremm e dai sommergibili U-212.Si parla di difesa per modo di dire, per-ché il ruolo delle nostre Forze Armate -accanto al tradizionale ruolo di difesadella patria, da contestualizzare dentrola costruzione della casa comune euro-pea - è offensivo, tutto rivolto all’ester-no («fuori area», in gergo) con la parte-cipazione alle missioni militari interna-zionali. Che in parte, come in Libano,sono "missioni di pace" e in parte - co-me in Iraq e in Afghanistan - sono mis-sioni di lotta al terrorismo internaziona-le, di controllo del territorio e in defini-tiva hanno una natura bellica. E il qua-dro con cui le Forze Armate si confron-tano è quello delle nuove minacce glo-bali - dalla lotta al terrorismo ai rischiderivanti dalle nuove aree di tensioni
in Medio Oriente, in Africa, nell’Europadell’Est - rispetto alle quali il ruolo del-l’Italia è completamente subalterno al-la Nato e agli interessi americani, comeanche in questo caso la vicenda degliF35 ci incarica di dimostrare.
Recentemente si sono conclusi i lavo-ri di una indagine conoscitiva (origina-ta dalle mozioni della Camera di giu-gno del 2013 sugli F35) della Commis-sione Difesa sui sistemi d’arma che hasostanzialmente confermato la sceltadel riarmo da una parte e dall’altral’opzione della riduzione (ancora mo-desta) degli organici, pachidermici eormai non funzionali alle nuove esi-genze delle Forze Armate italiane. Latendenza è quella di una ulteriorie pro-fessionalizzazione della struttura, disempre maggiori investimenti nei si-stemi d’arma, di una maggiore integra-zione nella Nato dentro il quadro di in-terventi rapidi di gestione delle aree dicrisi. E la centralità concreta della Na-to fa venire meno il processo di inte-grazione europea - anche sul piano mi-litare - in una direzione autonoma e«sufficiente» con l’obiettivo della co-struzione della sicurezza comune conun ruolo più significativo dell’Osce edelle Nazioni Unite.
Si tratterebbe di voltare pagina conconvinzione. L’Italia potrebbe tranquil-lamente ridurre di un buon 20-30% lesue spese militari e ridurre di almenoaltri 50 mila unità gli organici delle For-ze Armate. Dovrebbe rinunciare agliF35 (aerei da guerra) e ad altri sistemid’arma, che niente hanno a che farecon un’idea di difesa «sufficiente». Do-vrebbe rinunciare all’interventismo mi-litare all’estero e fare la scelta convintadell’Onu con una azione costante dellaprevenzione dei conflitti e della costru-zione della pace. Dovrebbe finalmenteattuare l’articolo 11 della Costituzione.Eppure il premier Renzi, che ha fatto lasua tesi di laurea su Giorgio La Pira,queste cose dovrebbe saperle. Ma forsese l’è dimenticate da tempo.
Francesco Vignarca
VENERDÌ 14 MARZO 2014SBILANCIAMO L’EUROPA
N˚8 - PAGINA III
Tra le spese pubbliche datagliare che in questi gior-ni sarebbero finite secon-
do alcuni giornali sotto la scuredel governo Renzi, pare che sia-no rientrati anche i caccia F-35.Non sappiamo se queste antici-pazioni e questi retroscena tro-veranno poi una concretizzazio-ne ma la loro stessa esistenza cifornisce, fin da ora, un’indica-zione politica interessante eche val la pena sottolineare. Lespese per acquisto di armamen-ti forse non sono più intoccabi-li. Da cosa nasce questa idea al-l’apparenza strampalata e nonrealistica? Dal fatto molto sem-plice che, per la prima volta,un’ipotesi di taglio di questa na-tura non sia stata avanzata solodalle campagne pacifiste e nonabbia visto un’immediata leva-ta di scudi, reazione invece si-cura per un passato abbastan-za recente.
Intendiamoci: ciò non signifi-ca che siano cresciute esponen-zialmente le probabilità di unconcreto taglio del programmaF-35 o che ci sia un cambiamen-to reale e innovativo nella politi-ca di spesa militare dell’Italia.Ma stiamo comunque parlandodi una modifica di scenario nonbanale. Pare davvero che la poli-tica, grazie anche all’azione del-le campagne disarmiste, stia se-guendo l’opinione pubblica nelcomprendere come gli investi-menti armati possano costituireun fardello piuttosto che un’op-portunità di crescita per il no-stro Paese. Certamente in talepresa di coscienza, che si sta ma-nifestando gradualmente, hagiocato un ruolo preminente lacrisi economica attuale. Ma nonbasta questa evidenza per spie-gare tutto come si trattasse diuna causa unica: in altri tempianche un’acuta sofferenza eco-nomica diffusa non avrebbe dicerto comportato critiche cosìampie e accettate alle spese ar-mate. Partire da questa consape-volezza ci permette di coglierecon un significato più profondoanche i numeri relativi al pro-gramma Joint Strike Fighter. Nu-meri, dati, analisi che recente-mente sono stati rilanciati dal la-voro informativo della campa-gna «Taglia le ali alle armi».
Ma prima di entrare in un cer-to dettaglio, occorre completareil ragionamento più di scenarioche abbiamo iniziato. Perché ilprogramma di acquisto dei cac-ciabombardieri d’attacco F-35possiede risvolti molteplici che
non ne permettono la chiusurain una questione tecnica margi-nale, che al massimo può riguar-dare solo i pacifisti. In questapartita sono in gioco anche ilmodello di Difesa del nostro Pa-ese e le sue politiche complessi-ve di spesa militare, e più in ge-nerale l’impostazione strategicache guida le scelte economico-fi-nanziarie del governo e l’impie-go delle risorse pubbliche inuna fase di crisi economica e so-ciale drammatica e che sta col-pendo la gran parte dei cittadiniitaliani. Ma non solo. Le riper-cussioni di questa scelta impat-tano in maniera strategica sulposizionamento internazionaledel nostro Paese. Non per nulladiverse critiche sono state avan-zate verso il progetto F-35 e allasua valenza divisiva in ambitoeuropeo, in particolar modo daambienti con caratterizzazioninon certo pacifiste o disarmiste.
C’è poi l’aspetto dell’impiegodelle risorse, ed è ovvio comeciascuna componente acquista-ta di un F-35 sottragga alle cassepubbliche fondi che potrebberoessere utili per affrontare le verepriorità del Paese. Quelle con lequali i giovani, gli studenti, i di-soccupati, i lavoratori in cassaintegrazione, gli abitanti di terri-tori abbandonati all’incuria siconfrontano ogni giorno: man-canza di occupazione, disagioabitativo, servizi sociali insuffi-cienti, territori a rischio idrogeo-logico. Secondo le più recenti sti-me di «Taglia le ali alle armi»con lo stanziamento medio an-nuale previsto per i prossimi treanni (650 milioni di euro annua-li) si potrebbero ad esempio cre-are 26000 posti di lavoro qualifi-cati, o mettere in sicurezza circa600 scuole all’anno oppure nontagliare ma aggiungere risorsein più al Servizio Sanitario Na-zionale rafforzando anche i ser-vizi di medicina territoriale H24.
In fin dei conti quindi quelloche è più urgente e necessariofare è cambiare paradigma. Perquesto, al di là e oltre gli F-35, ilgoverno Renzi avrebbe subitoun bel gruzzolo di risorse damettere a disposizione delle pro-prie politiche attive: nel rappor-to Sbilanciamoci per il 2014 ab-biamo evidenziato la facile indi-viduazione di circa 4,5 miliardidi minor spesa. Come? Con ri-duzioni di privilegi ormai obso-leti del personale delle Forze Ar-mate, tagli drastici agli acquistimilitari e cancellazione dellemissioni all’estero di chiara va-lenza aggressiva. Soldi disponi-bili subito: perché non farci unpensiero?
Status e prestigio,le ragioni fortidell’Italia armataGli aerei e la portaerei Cavour servono soloa non sfigurare davanti agli alleati e a favorireFinmeccanica. Una Difesa sovradimensionata
Rinunciando ai cacciambordierie tagliando benefit e supercompensisi potrebbero recuperare 4,5 miliardi
Giulio Marcon
IL MODELLO ITALIANO DALLACADUTA DEL MURO DI BERLINOÈ DIVENTATO OFFENSIVO:NON PIÙ LA PROTEZIONEDEI CONFINI, MA LAPARTECIPAZIONE ALLE«MISSIONI DI PACE» IN MEDIOORIENTE, AFRICA, BALCANI EALLA «LOTTA AL TERRORISMO»
F35 e non solo,una «casta»intoccabile
Licio Palazzini
Giulio Marcon
VENERDÌ 14 MARZO 2014SBILANCIAMO L’EUROPAN˚8 - PAGINA IV
Servizio civile,un’alternativaconcreta per l’UeUn modello non violento, fondato sulla partecipazione.Una possibile risposta al populismo e all’antipolitica
Corpi di pacecontro le guerreSono la soluzione antagonista all’interventoarmato. Ma è necessaria una legge
VOLONTARIATOINTERNAZIONALEE IMPEGNOPACIFISTA RADICALENEI TEATRI BELLICIPER LA«GENERAZIONESCHENGEN»: UNARISPOSTA CIVICA EUNO SBOCCO PER IMOVIMENTI SOCIALI.L’IMPORTANTEÈ NON ESSERE«EMBEDDED»AGLI ESERCITI
Per la prima volta i Corpi civili dipace entrano nella legislazioneitaliana, grazie a un emenda-
mento approvato nella legge di stabili-tà 2014-2016. Per tre anni 500 giovaniparteciperanno a iniziative d’interpo-sizione nonviolenta, prevenzione deiconflitti, costruzione della pace. È ilsogno di generazioni di pacifisti,obiettori di coscienza e attivisti non-violenti: dimostrare che è possibile,senza armi, affrontare in modo diver-
so conflitti e guerre, con azioni di di-plomazia dal basso, di riconciliazio-ne, di solidarietà. È quello che è statofatto dalle attività dei "caschi bian-chi" in Africa e in Centramerica; dalConsorzio Italiano di Solidarietà neiterritori dell’ex Jugoslavia; dall’Asso-ciazione per la pace e da Action for Pe-ace in Medio Oriente. In queste attivi-tà si sono spesi negli ultimi 30 anni,decine di migliaia di persone, che so-no stati esposti anche a gravi rischi.
Secondo l’emendamento approvatonella legge di stabilità, sarà l’Ufficio Na-
zionale per il Servizio Civile a gestire inmodo sperimentale (in base alla leggen˚64 del 2001 sul servizio civile naziona-le), l’organizzazione dei progetti dei Cor-pi civili di pace, in attesa che sia appro-vata una legge organica sui corpi civilidi pace, proposta depositata circa unmese fa da una trentina di deputati di di-verse forze politiche che aderiscono algruppo dei parlamentari per la pace (te-sto dell’emendamento e della legge so-no scaricabili da www.parlamentariper-lapace.it). Va ricordato che l’Ufficio Na-zionale per il Servizio Civile ha già speri-mentato l’organizzazione di progetti diservizio civile all’estero (che hanno coin-volto molte centinaia di giovani), comegià previsto dalla legge n˚ 64.
In questi anni la Nato e i governi oc-cidentali, dalla guerra in Kosovo inpoi, hanno cercato di strumentalizzarel’azione civile e umanitaria come co-pertura di un interventismo militarebelligerante: la componente e la finali-tà umanitaria propagandata da questiinterventi è stata la copertura di guerreche hanno violato il diritto internazio-nale ed i diritti umani, come in Afgha-nistan ed in Iraq. Si è anche teorizzatocon la Cimic (Civil Military Coopera-
tion) della Nato un rapporto organicotra componente militare e umanitarianelle nuove guerre.
I Corpi civili di pace sono diametral-mente alternativi a questa visione: nonrappresentano la componente civiledell’intervento militare, ma sono unasoluzione radicalmente opposta allasoluzione armata e violenta dei conflit-ti. Sono il nucleo di una visione diversadelle relazioni internazionali, fondatesulla prevenzione nonviolenta, il nego-ziato, la cooperazione tra i popoli, ildialogo, la riconciliazione. È quello
che hanno auspicato in questi anni –inascoltate - le Nazioni Unite che han-no avanzato proposte, sperimentato al-cune iniziative, elaborato documentipuntuali su come organizzare dei Cor-pi di pace.
In Europa, dei Corpi (europei) civilidi pace si parla da tempo. Un modoper "sbilanciare l’Europa" sarebbequello di abbandonare ogni idea di"fortezza" e di superpotenza armata,privilegiando le politiche di pace e dicooperazione. De Corpi di pace in Eu-ropa a occuparsene per primo fuAlex Langer che – sull’onda dellagrande mobilitazione pacifista in exJugoslavia - riuscì nel 1995 a far ap-
provare dal Parlamento europeouna prima risoluzione, che è sta-
ta seguita nel decennio succes-sivo da altri documenti, studidi fattibilità altre risoluzioni.Alex Langer, a proposito del-l’intervento nonviolento inex Jugoslavia, parlò di «pacifi-
smo concreto». I Corpi civilidi pace in Italia sono un esem-pio di come quel pacifismo con-
creto è diventato legge e poli-tica dello stato.
La proposta di dare vita a un servi-zio civile europeo, di recente rilan-ciata da diverse personalità, euro-
pee e italiane, ha attraversato la storiadel ‘900. Nata dopo la Prima GuerraMondiale per spinta dei pacifisti non-violenti francesi e tedeschi, da cui nac-que il Servizio Civile Internazionale, èstata ripresa dopo la Seconda GuerraMondiale, è istituzionalizzata oggi dal-
l’Accordo intergovernativo fra Germa-nia e Francia e raggiunge alcune centi-naia di giovani ogni anno.
Come frutto dei Trent’anni d’oro,l’idea è migrata a due dimensioni dellapace, l’istruzione e la mobilità. I pro-grammi Erasmus e Servizio VolontarioEuropeo hanno inverato questa nuovadimensione fondativa.
Questo quadro ha subito con la se-conda metà del decennio passato unadoppia sfida. Da una parte non semprei due programmi sono stati in grado di
essere inclusivi delle diverse figu-re e realtà giovanili dei diversiPaesi e dentro i Paesi stessi. Dal-l’altro lato non erano attrezzatiper rispondere alla crescentecrisi di legittimazione delle isti-tuzioni comunitarie.
Una crisi di troppa selettivitàproprio mentre esplodeva la disoc-cupazione giovanile, l’impoverimen-to materiale drammaticamente stri-dente con un accesso all’informazio-ne senza precedenti.
Questa miscela è uno dei propellen-ti dell’adesione giovanile ai movimen-ti ecologici, sociali ma anche aimovimenti xenofobi, violenti. Edè ben magra consolazione rilevare chese i movimenti civici mobilitano in mo-do pacifico e pubblico decine di miglia-ia di giovani, i numeri dei giovani neimovimenti violenti sono inferiori. Nellasocietà della comunicazione non è il nu-mero che fa la differenza.
Poi, come sempre, c’è la gran parte digiovani che vorrebbero metter su fami-glia, lavorare, avere tempo libero per di-vertirsi, viaggiare, ascoltare musica lon-tano dalla politica.
In questo contesto sono emersi i ri-chiami al servizio civile europeo, comeesperienza concreta di partecipazionecivica su scala europea, richiami iniziaticon il manifesto apparso su diversi gior-nali europei a prima firma di Cohn Ben-dit nel 2012, poi rilanciati da diverse
personalità, sia del mondo universita-rio che del sindacato e della politica, co-me di alcuni organi di informazione.
Da alcuni attori sociali è stato rilan-ciato il servizio civile europeo come pro-cesso parallelo alla costruzione della di-fesa militare comunitaria, riprendendoquindi l’originario impianto culturaledi costruzione in modo nonviolento del-la gestione e soluzione dei conflitti.
Un primo indicatore, che può essereutile per passare dalla fase del richiamoa quello della proposta di attuazione, ri-guarda l’esistenza di dispositivi legislati-vi (internazionali, comunitari, naziona-li, regionali, comunali) disponibili neiPaesi dell’Unione. In Italia ci sono alcu-ne leggi di servizio civile regionale cheprevedono l’impegno aperto anche a
cittadini stranieri, e che non dicono nul-la sul possibile invio all’estero dei giova-ni.
Per quanto riguarda la legislazionenazionale, in ambito comunitario Fran-cia e Germania hanno già oggi dispositi-vi che possono permettere, a condizio-ni di reciprocità, di fare il servizio civilenell’altro Paese. Soluzione simile in Lus-semburgo. La legislazione italiana pre-vede l’invio all’estero ma non l’acco-glienza di giovani stranieri. Dopodichèci sono programmi che dal punto di vi-sto delle finalità e/o dell’organizzazio-ne sono simili ai servizi civili ma sono li-bere iniziative delle formazioni sociali.
Non è un caso quindi che molti di co-loro che hanno rilanciato il servizio civi-le europeo, almeno in Italia, non abbia-mo fatto cenno all’esistente Servizio Ci-vile Nazionale.
Può essere la spinta alla legittimazio-ne delle istituzioni comunitarie e allacostruzione di un civismo multiplo, cheaggiunge alla dimensione locale e nazio-nale, anche la dimensione europea, unpropellente politico talmente potenteda iscriverlo nell’agenda di Bruxelles?
Ci sono oggi queste condizioni nellegrandi famiglie politiche europee chehanno governato il Parlamento e forma-to le Commissioni? La risposta dovreb-be essere scontata, soprattutto di fronteal populismo e all’antipolitica (non allanuova politica) che emerge sempre piùprepotente.
È lecito avere molti dubbi, visto chele impostazioni economiche di reazio-ne alla crisi economico-sociale sono di-verse e che alle proposte avanzate da al-cuni intellettuali di riforma delle istitu-zioni comunitarie si è risposto con il fi-scal compact e altre misure che hannomortificato i Parlamenti e le società civi-li nazionali.
Eppure serve una nuova mobilitazio-ne che, facendo base sulla generazioneSchengen dia subito il segno che il servi-zio civile europeo è fattibile. Come? In-troducendo anche nel Servizio civile na-zionale italiano l’accesso agli stranieri ela previsione che nell’anno di servizioin Italia sia possibile trascorrere qual-che mese in altri Paesi dell’Unione.