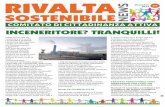Lo psicologo nel trattamento del gioco d’azzardo patologico
-
Upload
sonia-bertinat -
Category
Healthcare
-
view
36 -
download
1
Transcript of Lo psicologo nel trattamento del gioco d’azzardo patologico

AP Incontra
31 marzo 2015
Golem Bookshop
Dott.ssa Sonia Bertinat – SC Sert, ASL TO 3

Cos’è il gioco d’azzardo?
Per essere così definito devono
essere presenti 3 caratteristiche:
1. L’individuo mette in palio
denaro o oggetti di valore
2. Questa posta è irreversibile
3. L’esito del gioco dipende
principalmente o totalmente
dal caso
Da Capitanucci, AND

Cos’è il CASO?
•Tutti gli eventi hanno uguale
probabilità di essere estratti
•Ogni evento è indipendente dal
precedente e dal successivo
•E’ impossibile controllare o
prevedere l’esito degli eventi
Da Capitanucci, AND

Quali giochi?

Probabilità di vincita
ROULETTE (Rosso e Nero)
ROULETTE (Numero)
LOTTO (Terno)
TOTOCALCIO (13)
LOTTERIE (Primi Premi)
SUPERENALOTTO (5+1)
SUPERENALOTTO (6)
(Tratto da “Sport e Scommesse” 2/4/2000)
1 SU 2.05
1 SU 37
1 SU 11.748
1 SU 1.594.323
1 SU 4.441.470
1 SU 103.769.105
1 SU 622.614.630

Tutti i giochi d’azzardo producono un’attesa di guadagno negativa per il giocatore.
Tenuto conto che la motivazione principale è vincere denaro, le persone dovrebbero evitare questo tipo di giochi.
Ciò chiaramente non avviene.
(da Capitanucci- AND)

Perché il giocatore spesso incorre in
veri e propri
Vediamo in cosa consistono…

Abilità
• Più mi esercito e migliore sarà la mia
performance
• Più ricevo feedback, migliore sarà la mia
performance
• La pratica aumenta la fiducia in me stesso
Nel gioco d’azzardo non conta la quantità di
pratica o gli sforzi fatti: la mia performance
non potrà comunque mai migliorare!!!

Interpretazione emotiva
della statistica Durante il gioco, la maggioranza di noi
(se non tutti) dimentichiamo, neghiamo
o non realizziamo che l’esito del gioco
è basato sulla nozione di AZZARDO e
CASO.
Questo accade per numerosi motivi tra
cui il ruolo attivo del giocatore, la
percezione di competizione, la velocità
del gioco, la complessità (apparente)
del gioco.


L’illusione di controllo
Spesso i giocatori mettono in atto comportamenti o
attivano pensieri atti a controllare il gioco.
Secondo Ladouceur, questo si spiega in un solo
modo
Mentre si gioca tutti cercano di PREDIRE il
risultato!!!
Essendo il gioco però, come si è visto, dipendente
dal caso, l’errore cognitivo consta nel voler creare
legami tra eventi totalmente indipendenti.

“Sbagliando si impara” ci hanno
sempre insegnato, “studia!” e altri
incentivi che sottendono una sola
cosa: se crei legami tra un evento
passato e uno futuro quello futuro sarà
governabile o imitando quello del
passato se positivo o modificandolo se
negativo.
Questo però nel gioco non vale!!!

Alcuni esempi
• Scelta personale (scegliere il biglietto)
• Gradazione del gesto fisico (lancio dadi o
colpo sul tasto)
• Superstizione (amuleti)
• Near miss (la sensazione di “esserci
andati vicino” e quindi che basti poco
sforzo per centrare l’obiettivo)
• Equilibrazione della serie (dopo 5 testa
“deve” uscire croce)
• Esagerato peso mnemonico sulle vincite e
minimizzazione delle perdite

• Inferenza arbitraria sui piccoli numeri
(ritardatari)
• Personalizzazione della macchina come
se avesse memoria (è tanto che non
paga) o emozioni (è tanto che non MI
paga, me lo deve)
• Strategie per battere la macchina
(osservare gli altri, carpirne i segreti
meccanismi)

• Leggere ovunque segni del destino come
numeri da giocare
• Sentirsi colmo di ispirazione che sicuro ci
guiderà verso la macchinetta giusta o la
puntata giusta
• Controllo cognitivo (se mi concentro
vinco)
• Controllo del comportamento (triplicare la
posta)
• La fortuna come un’onda da cavalcare
• Non comprensione delle probabilità

• Chasing (rincorsa della vincita o delle
perdita)
• Contingenze erronee (gioco solo di sera)
• Errori di attribuzione (se cambio tavolo, o
macchina perderò)
• Errori di memoria (vinco più a quella
macchinetta)

Cosa pensa in sintesi il
giocatore • Se gioca e vince penserà di poter vincere ancora
e continuerà
finchè non perderà tutto
• Se gioca, vince e riesce a smettere di giocare in
pari o in vincita penserà che sia un buon modo
per fare soldi e tornerà a giocare
finchè non perderà tutto
• Se gioca, vince e rigioca le vincite, si dirà che la
prossima volta riuscirà a smettere in tempo. Ma
tornerà a giocare
finchè non perderà tutto.

• Se gioca e perde, vorrà allora recuperare
il denaro perduto. Si ricorderà solo dei
colpi di fortuna, e continuerà a giocare,
finchè non perderà tutto.
• Se gioca e perde, si dirà che la prossima
volta sarà quella buona. Tornerà a
giocare
finchè non perderà tutto.
Il giocatore quindi, non solo è sempre
perdente, ma in realtà il suo fine non è la
dichiarata vincita ma il GIOCARE!

Vediamo ora gli aspetti diagnostici, le teorie e il
decorso della patologia.
Il DSM V, rispetto al DSM IV_R sposta
(nominandolo in tal modo) il Gambling Disorder dal
“Disturbi del Controllo degli impulsi non classificati
altrove” ai “Disturbi da dipendenza e correlati
all'uso di sostanze”.
Innanzitutto perché è considerato una
dipendenza?

Caratteristiche dipendenza
Individuiamo quattro caratteristiche fondamentali
1. Craving: la brama irrefrenabile verso un
oggetto o l’impulso di svolgere un
comportamento.
2. Perdita del controllo (lack of control): presunta
capacità di poter smettere, senza riuscirci nella
realtà.
3. Astinenza (withdrawal): nervosismo, ansia,
tremori se si tenta di smettere.
4. Tolleranza: bisogno di sempre più sostanza (o
più gioco) per ottenere lo stesso livello di
eccitamento.

Criteri diagnostici Sindrome di dipendenza
(Adattato da ICD – 10 Classificazione Internazionale delle Malattie -
1994)
• Si tratta di una condizione caratterizzata da un insieme di
fenomeni comportamentali, cognitivi e fisiologici che si
manifestano dopo l’uso ripetuto di una sostanza o la pratica
continuativa di un comportamento, e che tipicamente inducono:
- un forte desiderio di assumere la sostanza
o praticare un comportamento
-una difficoltà nel controllarsi nell’uso/comportamento
- la persistenza nell’uso/comp. nonostante le conseguenze
dannose
- un’aumentata tolleranza e talora uno stato di astinenza fisica.
- una priorità attribuita all’uso/comp. rispetto alle altre attività e
obblighi

Criteri diagnostici DSM IV-R: F-63
1. eccessivo assorbimento nel gioco d'azzardo
2. bisogno di giocare con quantità crescenti di denaro per raggiungere
l'eccitazione desiderata
3. ripetuti tentativi infruttuosi di controllare, ridurre o interrompere il gioco
4. irrequietezza o irritabilità nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco
d'azzardo
5. gioco come fuga dai problemi o alleviamento di un umore disforico
6. ritorno al gioco per recuperare le perdite del giorno prima (rincorsa delle
perdite)
7. menzogne ai famigliari, al terapeuta o ad altri per occultare l'entità del
proprio coinvolgimento nel gioco
8. azioni illegali per finanziare le proprie attività di gioco
9. perdita o compromissione di una relazione significativa o di lavoro per via
del gioco
10. affidamento su altri per reperire il denaro necessario a risolvere una
situazione finanziaria disperata a causa del gioco

Criteri diagnostici secondo il DSM-V
A. comportamento da gioco d’azzardo problematico ricorrente e persistente che porta stress o a un
peggioramento clinicamente significativo, come indicato dalla presenza nell’individuo di 4 (o più) dei
seguenti sintomi per un periodo di almeno 12 mesi:
1. necessità di giocare una quantità crescente di denaro con lo scopo di raggiungere l’eccitazione
desiderata;
2. è irritabile o irrequieto quando tenta di ridurre o interrompere il gioco d’azzardo,
3. ha effettuato ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o interrompere il gioco d’azzardo;
4. è spesso preoccupato per il gioco d’azzardo (per esempio, ha pensieri persistenti di rivivere
esperienze passate del gioco d’azzardo, di problematiche o di pianificazioni future, pensando come
ottenere denaro con cui giocare);
5. spesso gioca quando si sente in difficoltà (per esempio, assenza di speranza, in colpa, ansioso,
depresso);
6. dopo aver perso soldi al gioco, spesso torna un altro giorno (perdite inseguite);
7. racconta bugie per nascondere il coinvolgimento nel gioco d’azzardo:
8. ha messo a repentaglio o ha perso una relazione significativa, il lavoro, lo studio o un opportunità di
carriera a causa del gioco d’azzardo;
9. si basa su altri per cercare denaro per alleviare le disperate situazioni finanziarie causate del gioco
d’azzardo.
B. Il comportamento da gioco d’azzardo patologico non è meglio descritto da episodio maniacale
Specificare se:
• episodico
• persistente
Specificare se:
• in remissione precoce
• in remissione continua
specificare la gravità attuale:
• media: soddisfatti 4-5 criteri
• moderata: soddisfatti 6-7 criteri
• grave: soddisfatti 8-9 criteri

Teorie psicologiche (da Capitanucci, AND)
• Teorie psicoanalitiche: desiderio inconscio di perdere. Il gioco
costituisce un’attività proibita, carica d’una tensione nel contempo
gradevole e dolorosa, che suscita colpevolezza, e che stimola
dunque il bisogno d’infliggersi una punizione per un intenso
sentimento di colpevolezza legato ad un’ostilità inconsapevole
nutrita verso le figure d’autorità, spesso verso i suoi genitori, che
gli avrebbero imposto regole e restrizioni durante la sua infanzia..
(Bergler)
• Teorie fisiologiche: predisposizione per insufficienza dei processi
d’inibizione che si traduce in una difficoltà a controllare i loro
comportamenti o a dominare i loro impulsi. Si ipotizzano anche
deficit di serotonina, deficit nella neurotrasmissione di beta-
endorfina. Ipotesi più recenti presumono che esista una base
fisiologica comune tra problemi di dipendenza e certi disturbi
dell’impulso legata al circuito della dopamina, che è un
neurotrasmettitore che ha un ruolo importante nella sensazione di
piacere d’un soggetto. La deregolamentazione del sistema di
gratificazione legato al piacere predisporrebbe alcune persone a
forme di dipendenza.

• Teorie comportamentali: il problema di gioco esiterebbe da un
apprendimento. Il fatto di vincere una somma di denaro importante nel
corso delle prime esperienze di gioco oppure durante un periodo
determinante nella formazione delle abitudini di gioco creerebbe una
predisposizione a giocare in eccesso oppure la vincita occasionale in
denaro funzioni da rinforzo intermittente favorendo il mantenimento del
comportamento di gioco stesso. Anche l’eccitazione o le stimolazioni
provocate dal gioco sarebbero ulteriori rinforzi che favorirebbero lo
stabilirsi ed il persistere delle abitudini di gioco. In questa prospettiva, lo
stato di eccitazione percepito dal giocatore è il risultato d’una reazione a
parecchi avvenimenti che accadono durante la sessione di gioco ed è
associato ad un’attivazione fisiologica. Anche l’osservazione di
comportamenti di gioco potrebbe influire.
• Teorie cognitive: partono dall’analisi di tutti gli errori cognitivi descritti e
dalle modalità della mente del giocatore di affrontare il gioco.

• Teorie cognitivo-comportamentali: uniscono i due aspetti. Le vincite
intermittenti, in particolare, alimentano la credenza che possano capitare
anche vincite sostanziali. Queste vincite finiscono con il rafforzare alcune
cognizioni erronee circa il gioco favorendone così la persistenza.
l’attivazione fisiologica, le cognizioni legate al gioco), e i fattori esterni (le
situazioni, i luoghi e i tempi). Il giocatore diventa una vittima del suo
desiderio di giocare, specialmente se non è in grado di tenere sotto
controllo le sue cognizioni erronee: allora, non riuscendo a rimandare a
più tardi la sua decisione di giocare, non riesce ad affrontare la soluzione
dei suoi problemi. Alla perdita di denaro si sommano anche altre perdite
riguardanti i differenti ambiti di vita del giocatore come il lavoro, le
relazioni amorose, gli amici, ecc. Queste conseguenze, lungi dal diminuire
l’ardore del giocatore, concorrono piuttosto a mantenerne il problema di
gioco.

DECORSO CLINICO DEL G.A.P. (Custer e Milt 1985)
1) FASE “VINCENTE” (3-5 anni?):
a) sensazione di vincite frequenti; pensiero magico
b) eccitazione legata al gioco
c) gioco sempre più frequente
d) aumentano somme giocate
e) grossa vincita (in relazione all’immesso)
2) FASE “PERDENTE” (5 anni o più?):
a) gioco solitario e perdite
b) negazione del problema e menzogne
c) tentativi di controllo (di solito fallimentari)
d) problemi familiari
e) forti prestiti e incapacità a risarcire i debiti

DECORSO CLINICO DEL G.A.P. (Custer e Milt 1985)
3) FASE DELLA DISPERAZIONE:
a) marcato aumento del tempo impiegato e del
denaro dedicato al gioco
b) pensiero polarizzato sul gioco
c) allontanamento dalla famiglia e dagli amici
d) panico e azioni illegali
4) FASE DEL CROLLO:
a) pensieri e tentativi di suicidio
b) arresti, divorzi, alcol
c) crollo emotivo, sintomi di ritiro

(Ladouceur, 2004)
Giocatore sociale:
• Colui che gioca per divertirsi
• Colui che accetta di perdere il denaro puntato
• Colui che non torna a giocare per rifarsi
• Colui che gioca secondo le sue possibilità
Giocatore patologico:
• Colui che gioca più denaro del previsto
• Colui che gioca più a lungo del previsto
• Colui che gioca più spesso del previsto
È colui che avendo perso il controllo sulle sue attività di gioco,
sperimenterà problemi sociali (finanziari, giuridici, familiari,
lavorativi), psichici (distimie, disturbi autostima, ansia, abuso alcool
e droghe) e somatici (gastrite e ulcera gastrica, cardiopatie
ischemiche, alterazioni immunitarie) ....

Tipologie di giocatori patologici (Guerreschi, 2000)
Il GIOCATORE “D’AZIONE” CON SINDROME DI
DIPENDENZA
• Giocare d’azzardo è la cosa più importante nella
vita, l’unica cosa che li mantiene in “azione”, che
dà un senso alla vita.
• Sono centrali le emozioni forti, e la ricerca di
sensazioni intense.

Tipologie di giocatori patologici (Guerreschi, 2000)
Il GIOCATORE “PER FUGA” CON SINDROME DI
DIPENDENZA
• Giocare d’azzardo serve a trovare alleviamento
alle sensazioni di ansietà, depressione, rabbia,
noia o solitudine.
• Il gioco provoca un effetto analgesico invece che
una risposta euforica.

Tipologie di giocatori patologici (Blaszczynski, Lower 2002)
Il GIOCATORE “CONDIZIONATO COMPORTAMENTALMENTE”
• Non mostrano comportamento impulsivo, non abusano di
sostanze
• La patologia al gioco sembra il risultato di ragionamenti
irrazionali o di strategie scadenti per la presa di decisioni
• La depressione consegue (e non precede) il gioco
Trattamento
• Sono i soggetti più motivati (compliance
elevata)
• Possono risultare efficaci trattamenti di
counseling e supporto psicologico

Tipologie di giocatori patologici (Blaszczynski, Lower 2002)
Il GIOCATORE “VULNERABILE EMOTIVAMENTE”
• Anche in questo caso la patologia al gioco sembra il risultato di ragionamenti
irrazionali o di scarse strategie di probelm solving e decision making
• In aggiunta, vi sono condizioni di premorbidità all’ansia e alla depressione
(che precedono e non conseguono il gioco), storia di povertà nel far fronte
alle difficoltà, background familiare negativo, uso di sostanze…
• Il gioco parrebbe motivato dal desiderio di modulare stati affettivi
indesiderati, ma si rivela un boomerang perché i soggetti sono fragili a
mantenerlo sotto controllo
Trattamento
Questi soggetti richiedono trattamenti mirati
• al fronteggiamento dello stress,
• alla tolleranza alla frustrazione,
• ad aumentare le abilità di problem solving,
l’autostima, l’immagine di sé,
• e alla risoluzione dei conflitti intrapsichici

Tipologie di giocatori patologici (Blaszczynski, Lower 2002)*
Il GIOCATORE “CON CORRELATI BIOLOGICI” O “PATOLOGICO IMPULSIVO
ANTISOCIALE”
•Parrebbero presentare una vulnerabilità biologica e tratti di impulsività. In questi soggetti
l’impulsività precede il gioco e ne sarebbe in un certo senso indipendente
•E’ possibile una familiarità al gioco d’azzardo e ad altre dipendenze; presentano
esperienze negative nello sviluppo, tratti di personalità nevrotica, premorbidità all’ansia e
alla depressione, dipendenza da sostanze, tendenza alla fuga o ad aggressività passiva.
•Il ricorso al gioco risponderebbe al bisogno di raggiungere uno stato di fuga attraverso
della dissociazione, alterazione dell’umore e restringimento dell’attenzione.
•Evidenziano una marcata propensione a trovare attività gratificanti, incapacità di
posticipare la gratificazione e diminuita risposta alla punizione. Per questo, il decorso
inizia presto e cresce rapidamente di intensità e severità
Trattamento
•Questi soggetti sono poco motivati al cambiamento, presentano bassa
compliance e rispondono poco alle varie forme di terapia
• L’intervento deve essere fortemente interdisciplinare e multimodale e deve
considerare anche in simultanea i problemi correlati all’attenzione, alla labilità
emotiva, all’intolleranza allo stress e al problem-solving
*Tratto da: Croce M. et Al., 2005; “Quando il td o l’ad è anche giocatore”, Dal fare al dire

MODELLO TRANSTEORICO DEGLI
STADI DEL CAMBIAMENTO (Prochaska e Di Clemente)
Il modello prevede un processo ciclico legato alla motivazione
e composto da varie fasi:
• Precontemplazione. E’ la condizione patologica che non
viene riconosciuta dal soggetto portatore. Sono le persone
accanto ad esso che sollevano il problema ma la persona
che si trova in questo stadio non è consapevole, negando
in modo assoluto che ci sia un problema.
• Contemplazione. La persona sa di avere un problema ma
non riesce a decidersi per la sua soluzione. E’ lo stadio
caratterizzato da una forte ambivalenza dove prevale a
volte la voglia di cambiare e a volte la paura di non farcela.
• Determinazione. In questo stadio il soggetto ha deciso per
il cambiamento facendo prevalere le ragioni razionali per
affrontare il problema che lui riconosce . Dura poco perché
si passa subito allo stadio successivo dell’Azione,
altrimenti si torna indietro.

MODELLO TRANSTEORICO DEGLI
STADI DEL CAMBIAMENTO (Prochaska e Di Clemente)
• Azione. E’ la concretizzazione della decisione di cambiare.
Si inizia un percorso, si entra in un programma terapeutico
per seguire un adeguato trattamento.
• Mantenimento. Rappresenta la consapevolizzazione del
cambiamento, riducendo o eliminando i comportamenti
disfunzionali che avevano creato il problema di
dipendenza. Ci si avvia all’uscita definitiva, anche se è
sempre alto il rischio di ricaduta.
• Ricaduta. Il soggetto occasionalmente o definitivamente
riprende i comportamenti disfunzionali. La ricaduta è
comunque considerata un fenomeno fisiologico nel campo
delle dipendenze.

Lo stato italiano promuove il gioco d’azzardo pur
essendo tuttora in vigore un Decreto Regio n. 773
del 1931 che lo identifica come illegale.
L’artificio sta nel dire che se il gioco è controllato
dallo stato è legale (addirittura sicuro secondo
molte pubblicità).
Purtroppo aumentano i giochi e le concessioni per
la gestione dei giochi.

Il Decreto Balduzzi del 2012, tra le altre
cose, impone a tutti i concessionari di
esporre un documento (preparato da
ciascuna ASL) in cui si avvisa dei pericoli
del gioco, le caratteristiche di rischio che
devono allarmare e l’elenco dei servizi a cui
rivolgersi.
Il Decreto prevedeva anche una percentuale
delle entrate dal gioco da devolversi alle
attività di cura (come viene fatto in altri stati
e in atto ad esempio nel famoso Nevada)
Bene!
No… non c’era copertura finanziaria e
hanno eliminato quella voce.

Quanto si è speso al gioco negli
anni
85.4 mld di euro corrispondono circa al 4 per cento del pil
14,3
25,6
61,4
85,4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2000
2004
2010
2013
Fatturato del gioco
2000
2004
2010
2013


Gli aspetti sanitari
Da un’analisi di Libera si stima in una cifra
compresa tra i 5,5 e i 6,6 miliardi di euro annui i
costi sociali e sanitari che il gioco d'azzardo
patologico comporta per la collettività.
Studi internazionali stimano che i giocatori siano tra
l’1 e il 5% della popolazione. In Italia si aggirano sul
2-3%. Tale percentuale aumenta in caso di
comorbidità psichiatrica o con altre dipendenze fino
anche al 12%.

Nel 2004 in Piemonte i Servizi ASL per le
Dipendenze che già si occupavano di GAP in
modo limitato si uniscono nel Coordinamento
Regionale dei Servizi sul GAP.
Un coordinamento informale suddiviso in vari
gruppi di lavoro di cui uno, il Gruppo Tecnico,
otterrà negli anni successivi il riconoscimento
di Gruppo regionale con fondi assegnati.
Dopo le Regionali del 2010, tale Gruppo non
viene confermato a livello regionale ma
continua ad oggi il lavoro del Coordinamento.

Coordinamento regionale
I fondi regionali ottenuti in passato dalla
Regione, hanno permesso l’organizzazione
di due convegni (2006 e 2009), la creazione
di un sito dedicato e una campagna di
sensibilizzazione pubblica, il GAP Tour.
Attualmente continuano a lavorare i gruppi
di lavoro, tra cui il Gruppo Prevenzione che
si occupa di interventi nelle scuole.

Ricerche
Le prese in carico nei servizi
ovviamente non corrispondono alla
popolazione con problemi di GAP.
Due ricerche fatte sul biennio 2006/7 e
sul biennio 2011/2012 hanno visto un
incremento del 400% sui nuovi
trattamenti nei servizi piemontesi.
Ad oggi tutte le ASL hanno un Servizio
per il Trattamento del GAP associato ai
Sert (Servizi per le Dipendenze)

I trattamenti erogati
In base ad una ricerca svolta dal
Gruppo Clinico e pubblicata sull’Italian
Journal of Addiction sono stati
evidenziati dei trattamenti
sovrapponibili nelle diverse Asl.
Questo dato parrebbe esitare anche
dal ruolo del coordinamento che mira
proprio ad uniformare la tipologia dei
servizi erogati

Trattamenti psicologici
A farla da padrone sono i trattamenti
psicologici, elettivi a livello di
letteratura per il trattamento del GAP.
-Psicoterapie individuali
-Psicoterapia di coppia
-Psicoterapia di gruppo
-Sostegno psicologico

Trattamenti socio/educativi
•Tutoraggio economico
Pianificazione economica
Pianificazione debiti
Controllo economico
•Sostegno ai familiari
Supporto informativo sul gap
Gestione economica
Supporti legali (come tutelarsi)
•Supporto legale
Amministrazione di sostegno
Problemi giuridici/penali

Trattamenti
medico/farmacologici
Sono messi in atto in presenza di:
•Disturbi psichici quali ansia, disturbi
dell’umore, siano essi causa o
conseguenza del comportamento di
gioco
•Disturbi fisici quali problematiche
cardiocircolatorie, gastrointstinali,
disturbi del sonno

Trattamenti residenziali e
semiresidenziali Sono risorse alternative al trattamento
ambulatoriale
• Comunità terapeutiche
• Percorsi semiresidenziali
• Ricoveri in Clinica Privata per
disassuefazione (effettuabili anche
attraverso il medico di base)

Supporti non ASL
Sono risorse che si trovano sul
territorio che non richiedono il
passaggio dall’ASL per accedervi e
quindi strumenti in mano a chiunque si
trovi ad avere in cura un giocatore.
• Gruppi AMA
• GA – Giocatori Anonimi (per
giocatori)
• Gam – Anon (per famigliari)


Ovviamente no come si è visto!

I nostri primi anni di vita si formano
attraverso il gioco e la componente
ludica è fondamentale anche
nell’uomo adulto.
Un giocatore patologico perde la sua
capacità di giocare in modo sano, di
divertirsi.
L’attivazione data dal gioco si trova in
pochissime attività della vita
quotidiana e il giocatore senza il gioco
diventa abulico.

La parte più importante, e protettiva
rispetto alle ricadute, del trattamento
del giocatore patologico non sta nel
condurlo all’astensione, alla
consapevolezza e correzione dei suoi
pensieri erronei, al riaquistare il senso
del denaro, in una prospettiva più
profonda, la risoluzione delle
motivazioni che lo hanno portato alla
patologia ma al
RITROVARE IL PIACERE NELLA
VITA DI TUTTI I GIORNI

Altra Psicologia Piemonte
http://www.altrapsicologia.it/piemonte/
https://www.facebook.com/altrapsicologia.piemonte
Seguici per scoprire cosa facciamo e le prossime iniziative!
Dott.ssa Sonia Bertinat
http://identingabbia.blogspot.it