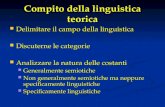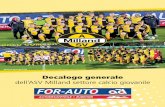linguistica "il registro giovanile"
-
Upload
marco-bortoli -
Category
Technology
-
view
10.940 -
download
1
description
Transcript of linguistica "il registro giovanile"

RECENSIONE AD ALCUNI SAGGI CHE HANNO COME ARGOMENTO LA LINGUA DEI GIOVANI.
POSIZIONAMENTO DEL "LINGUAGGIO GIOVANILE" NELLA "LANGUE".
Il rapporto tra la competenza linguistica e l'età del parlante è scontato, dipende dal grado e modalità di acquisizione e produce degli esiti diversi. Il linguaggio dei giovani apporta naturalmente un'innovazione al sistema linguistico dell'Italiano, si tenta qui di comprendere quali siano i modelli di questa varietà e quali siano i risultati sulla lingua neo standard. Il passaggio dalla lingua infantile alla "lingua adulta" avviene perlopiù in un'età compresa tra gli 11 e i 20 anni, periodo fortemente caratterizzato dallo spostamento dei modelli di riferimento dal nucleo familiare al gruppo di coetanei, dalla scoperta della sessualità e dalla costruzione dell'identità del sé. Come evidenziato da Coveri (1977) la lingua dei giovani risente molto di questi processi e delle forti pulsioni costruttive e distruttive che innervano questi anni. Si vedrà in questo articolo come gli estremismi verbali espressi soprattutto sotto forma di giudizi di valore (quella persona è: un "roito", un "cesso", un "figo", un "grande"), siano uno dei tratti più caratteristici delle comunicazioni tra coetanei. Tratterò inoltre di alcuni ambiti e argomenti di conversazione, come le droghe e l'abbigliamento, a cui i giovani, più di altri parlanti, sembrano dedicarsi con più ricadute sul linguaggio. Più che di un linguaggio giovanile Cortellazzo (1994) consiglia di parlare di uso linguistico dei giovani in quanto si tratta di una gamma: comprende infatti le espressioni brachilogiche dalla sintassi spezzata della pubertà come il parlato più complesso e ricco di prestiti da lessici specialistici dei teenagers. Altro motivo per preferire uso linguistico a linguaggio è che questa varietà "globale" dei giovani non diventa un linguaggio alternativo e indipendente dall'italiano standard ma piuttosto una varietà adottata in determinate situazioni comunicative. La struttura sintattica della lingua parlata dai giovani presenta meno subordinate e denota una scarsa pianificazione, confermata da numerosi incisi disambiguanti e ripetizioni. La lingua dei giovani, come studiata fino ad oggi, è la lingua parlata tra giovani in situazioni da pari a pari ed è quindi caratterizzata da una maggiore libertà verso le oscenità e da una gran uso di "hapax legomena". In concreto si può ritrovare questa lingua aggregante nelle compagnie di amici e nelle classi delle scuole medie e dei licei. La lingua giovanile dunque si rifà ai gerghi storici in quanto tende a confermare l'identità di gruppo ma perde in parte la componente criptica. La nascita di questa lingua è, più o meno consciamente, imputabile ad un desiderio di allontanamento dalla lingua comune degli adulti e avviene attingendo ai gerghi storici, coniando numerosi neologismi, suffissando o prefissando parassitariamente, facendo proprie espressioni nate con altri scopi (anche specialistici) e affidandosi solo secondariamente ad espressioni dialettali (quindi alle caratteristiche dialettali diatopiche della lingua).
Secondo Radke (1993) l'uso linguistico dei giovani è caratterizzato dalla presenza di cinque elementi, con un dosaggio variabile nelle diverse realtà socioculturali:
una base di italiano colloquiale informale, scherzoso, uno strato dialettale, uno strato gergale tradizionale, uno strato gergale innovante, un strato proveniente dalla lingua della pubblicità e dei mass media;
a questi Cortellazzo aggiunge:
uno strato di inserti di lingue straniere europee e americane,

numerosi lessici specialistici o pseudo-specialistici. (Un esempio nell'ambito socio/psicologico, come effetto del grande successo mediatico di esperti di queste discipline, è rappresentato da "disagio sociale" e "che disagio!/che disagiato!" il primo usato come intercalare nelle situazioni di stallo dovuto all'incompetenza di qualcuno, il secondo per riferirsi a persone problematiche o incompetenti. Da notare come anche gli amori per i lessici specialistici siano passeggeri nei giovani "disagiato" e "caso umano" infatti stanno riempiendo il vuoto lasciato da "handy" -handicappato- termine caduto ormai in disuso con molte altre voci gergali dei paninari.
L'uso linguistico dei giovani è quindi una miscela di elementi.
OSMOSI TRA ORALITÀ E SCRITTURA NELLA LINGUA DEI GIOVANI.
Gli studiosi più allarmisti sulle attuali condizioni delle lingua dei giovani parlano di neoanalfabetismo e propongono questi come vassalli dell'italiano popolare. Tra le cause di questo giudizio il fatto che le varietà giovanili sospendono le differenziazioni tra comunicazione formale e informale portando tutti ad un vicinanza comunicativa tipica delle situazioni familiari, private, e dell'emotività. Il "tu" e "ciao" indistinto a giovani e anziani segnano la scomparsa del "lei "e del "buongiorno" fenomeno altresì riscontrabile nelle comunicazioni tra e con extracomunitari giustificata in quel caso dall'assente o scarsa scolarizzazione linguistica. Niente di cui stupirsi: la lingua dei giovani, percorrendo un processo di semplificazione, ha solamente fatto un passo in più rispetto alla lingua standard nella quale si è passati dal sistema a tre elementi (Voi, Lei, Tu) a quello a due (lei/voi). Chi scrive ritiene che questa tendenza sia in atto nella lingua dei giovani quanto in quella delle nuove generazioni di adulti che negli uffici si chiamano col nome di battesimo. Quindi più che essere i ragazzi a modificare in questo senso la lingua si può dire che siano nati sotto il segno del "tu" come sono nati nell'era di internet. De Mauro (1990) appare particolarmente comprensivo nei confronti delle produzioni linguistiche dei giovani: ne evidenzia le caratteristiche innovative e stigmatizza l'improprietà di certe espressioni a favore di un'ottica di crescita per tentativi ed errori. Vediamo quali sono invece i tratti tanto temuti dai linguisti. Oltre ad abusare di parole pass-partout quali "cosa/o"e "roba/o" la lingua dei giovani si appella nell'interazione con gli adulti, sopratutto in ambito scolastico, ad avverbi usati come connettivi di "captatio benvolentiae". Esempio del parlare semicolto sono i frequentissimi "praticamente" (con frequente refuso in praticalmente), "sostanzialmente" e "fondamentalmente" percepiti dal parlante non esperto di retorica come tratti che possono innalzare il livello della performance. La necessità di parole-salvagente è talvolta imputabile alla velocità del parlato giovanile in cui il flusso di parole ("flow" nello slang americano del rap) non sempre ha la chiarezza e correttezza come obbiettivo. Ecco quindi che in situazioni più formali il giovane parlante ricorre a "beh","niente" e "cioè" per prendere tempo prima di formulare una frase.
In ogni discorso sui giovani tenuto da psicologi, educatori o giornalisti non manca un riferimento agli sms e a come questi influenzino la scrittura di forme che non richiedono e tollerano né l'eccesiva brevità né l'informalità. É già stato altresì notato che la stessa brachilogia è stata adottata dai giornali gratuiti che tendono a trasmettere le notizie come giungono in redazione dalle agenzie di stampa. Quello che non è stato ancora studiato approfonditamente è che alcuni espedienti della scrittura compressa in 160 caratteri degli

sms in certi casi sono riciclati nell'oralità. Sono infatti diffusi nel parlato (sopratutto dei nati dopo il 1988) alcuni acronimi, abbreviazioni, e fusioni di parole sia nei saluti come in formule frequenti che esprimono noncuranza. TVB, TAT, TVUCDB che un venticinquenne magari scrive ma si sentirebbe ridicolo a esprimere a voce sono invece usati nella comunicazione orale dei più piccoli. Oltre a questo caso riscontrato in conversazioni tra innamorati e amici sono emersi negli ultimi anni il "C" /tsc/ sostitutivo di "ciao", "cisi" saluto abbreviativo di "ci si vede alla prossima", "chìssene!" per "chi se ne frega" (trasformazione di una interrogativa diretta in un'esclamazione), e "stica", per "'sti cazzi" (sinonimo scurrile di "nemmeno per sogno"). "Oc" /ok/ e "o-kappa" sono due esiti orali dell'inglese "OK". Per concludere questa serie di esempi ne riporto uno che riguarda profondamente la mia generazione. Gli studenti, condizionati dalle url dei siti delle università italiane composti dall'abbreviazione uni. più la sigla della provincia (es:univr, uniud etc...), e dalle tante iniziative denominate uni-cinema, uni-versiadi etc... oggi scrivono e parlano più frequentemente di "Uni" che di Università.
UN LINGUAGGIO SEMPRE MENO DIATOPICO CHE GUARDA ALLE METROPOLI.
Il linguaggio giovanile è in continua evoluzione. Nutre e attinge allo stesso tempo ai testi a loro destinati ma anche a prodotti diretti ad adulti con ragazzi protagonisti. Le creazioni sono estemporanee e diventano desuete più velocemente rispetto alla lingua standard. Un uso della lingua che risente fortemente di mode provenienti dalle grandi aree urbane, italiane e mondiali. De Mauro (1992) è convinto che il contributo che i giovani apportano all'italiano informale sia decisivo: "I giovani sono senz'altro i pionieri del processo dell'italianizzazione, il loro italiano è sempre meno marcato a livello regionale e sociale". Si tratta sicuramente di un linguaggio privo di normatività e quindi più flessibile nell'acquisizione e nell'abbandono di lemmi ed espressioni: si pensi al "fare una vasca" "passeggiare lungo la via principale per farsi notare" fortunatissimo dagli anni '60, permane come eco delle precedenti generazioni negli anni '90 diventando totalmente desueto nel 2000. Gli studiosi ritengono che il linguaggio giovanilistico sia nato prima nel nord Italia e si sia diffusosi poi nel sud con intento emulativo. Tendenzialmente le mode linguistiche partono da Milano e da Roma e si irradiano nella provincia supportate anche dalla dislocazione in questi due centri della maggior parte delle emittenti televisive nazionali. L'esempio tipico del prestito da nord a sud è quello del lemma "erba"con significato di "marijuana" che si è esteso dalla Lombardia fino alla Sicilia. Ha seguito la stessa linea di diffusione "fumo" che sempre nell'ambito delle droghe leggere designa in primo luogo l'hashish ma anche qualsiasi altra sostanza stupefacente che mischiata al tabacco si possa fumare. Per quello che riguarda i lemmi più innovativi vale questa tendenza di diffusione dai centri nevralgici del centro nord, rimane però altrettanto forte la spinta alla provincializzazione linguistica. Si ricorda che l'Italia ha visto fiorire negli anni '60 un mare di radio libere e che i giovani hanno più affinità con questo media che con la televisione. Alla radio solitamente gli speakers parlano un italiano corretto ma non disdegnano l'uso di espressioni locali negli intercalari espressivi come consapevole condimento folkloristico che piace molto ai dialettofoni: "forse è il caso che te la smeti de farte i canòni" (dice il disk-jockey, scivolando dall'italiano al dialetto, ad un ascoltatore ventenne evidentemente svampito. Radio Adige-provincia di Verona). Questo esempio tra tanti non è casuale in quanto mi permette di ricollegarmi al lessico delle sostanze stupefacenti. La nomenclatura, gli effetti e le modalità di consumo delle droghe è stato ritenuto da diversi linguisti come uno degli ambiti più interessanti per cogliere la specificità gergale dei giovani. In questo ambito si fa sentire la necessità di dare un nome alle cose senza far capire agli esterni di cosa si parli. Riporto di

seguito una parte della voce "marijuana" proposta da wikipedia (vedi sitografia) corredandola dalle espressioni adottate in gergo giovanile per esprimere le sensazioni del momento: gli effetti indotti dall'uso di marijuana sono svariati, hanno differente intensità a seconda del soggetto, dalle circostanze psico-fisiche in cui la si assume, e dell'assuefazione del consumatore; i principali effetti possibili sono:
* attenuazione della reattività fisica e mentale "essere in fissa"- avere un pensiero fisso, "impaccarsi"- soffermarsi a lungo su un dettaglio di un oggetto/persona,
* temporaneo abbassamento della pressione sanguigna "avere uno svarione",
* tendenza all'ilarità con lieve effetto euforizzante "essere presi bene", "essere in scimmia", (ridere come scimmie)
* aumento dell'appetito, soppressione della sensazione di sazietà (comunemente detta "fame chimica") "essere in chimica",
* se assunta in ingenti quantità, nei soggetti predisposti, può provocare stati d'ansia e nausea. "essere presi male", "andare in para/paranoia","sverdare". stare molto male a causa di droga, alcool, etc. ed essere in uno stato davvero pietoso, infatti "sverdare" deriva da "essere/ diventare verdi in faccia".
"Preso bene/preso male" per indicare il benessere e senso di euforia o malessere con tendenza depressive che le cosiddette droghe leggere producono sull'organismo hanno soppiantato lo "sballo" dei consumatori di allucinogeni a cui si riferiscono nel 1980 Manzoni-Dalmonte. Di quello "sballo" decisamente desueto gli eredi più probabili sono "che storia/che viaggio/che trip" o il pass-partout scurrile "che figata". "Sballo" non viene menzionato nel dizionario on-line più aggiornato dello slang giovanile http://www.bruttastoria.it/. Interessante all'interno delle conversazioni tra coetanei il caso della domanda: "Sei un fumatore?" la cui risposta riguarderà il solo fumo di sigaretta, rispetto al " Fumi?" in cui chi riceve la domanda penserà dapprima all'uso di stupefacenti e solo secondariamente, in base alla situazione comunicativa, provvederà a chiedere chiarimenti per disambiguare la domanda e rispondere. Il suddetto caso dipende dal tabù delle droghe: non si può chiedere "fumi marijuana?" senza destare l'attenzione di estranei o intercettazioni. Per una lista davvero ampia dei sinonimi di fumo, spinello e particolari modi di consumare queste droghe si rimanda a Slangopedia http://espresso.repubblica.it/dettaglio-archivio/400221 .
RAPPORTO CON I DIALETTI.
L'uso giovanile della lingua italiana è attestato in Italia soprattutto nella seconda metà degli anni '60, con qualche avvisaglia dal secondo dopoguerra, al contrario di altre lingue come il Tedesco in cui troviamo attestazioni (di comunicazione in gergo tra studenti universitari) risalenti al '700. Le prime tracce di linguaggio giovanile/gergale italiano sono state rintracciate da Renzi nel 1967 nella parlata militaresca. Il linguista nota che in quest'ambito di convergenza di parlanti di aree dialettali non confinanti, diversa istruzione ed estrazione

sociale era sorto, con intento ludico e aggregativo, un gergo che si sottraeva alla standardizzazione linguistica. Secondo l'analisi di Giovanardi (1993) la varietà giovanile dimostra una regionalizzazione maggiore là dove predomina un allontanamento del linguaggio giovanile dall'asse diafasico verso quello diastratico, che va in perfetta congruenza con una maggiore dialettalità. Sostenevano del resto la stessa tesi gli studi di Coveri/De Nardis (1977) che analizzano un gruppo di ragazzi genovesi di bassa estrazione socioculturale, operai della provincia, con limitata competenza dell'italiano standard, i quali si affidavano al dialetto per le comunicazioni affettive tra coetanei piuttosto che al lessico giovanile. A partire da questa tesi ho riscontrato che alcune espressioni dialettali particolarmente forti, sempre nell'ambito delle trasgressioni giovanili, hanno impedito la diffusione del termine italiano corrispondente (anche indipendentemente dalla diastratia). Ad esempio: scendendo da nord a sud "marinare la scuola" si dice: "attaccare" in Lombardia,
"fare berna" in Veneto
"bigiare e fare forca" a Firenze
"fare sale", "fare salina" oppure "salare" in Toscana
"fare fuga" in Emilia Romagna
"fare chiodo", "fare sega" tipicamente di Roma
"fare filone" a Napoli
fino a "caliare" in Sicilia. Sono sicuramente molte altre le possibili variabili tra cui "tagliare" e "fare lippa" di cui però non sono riuscito a trovare una localizzazione precisa.Difficilmente un giovane userà l'espressione italiana o conoscerà il significato delle altre varianti dialettali non diversamente dal caso delle "compagnie".Si attesta ad esempio nella provincia Veronese anche tra parlanti non avvezzi allo switch code l'utilizzo dell'allocutivo "butei" che designa il gruppo, la compagnia di amici ("Con chi esci questa sera?" "Vado allo stadio con i butei del bar"). Questo "butei" al plurale (letteralmente ragazzi) si può considerare quasi un pluralia tantum del lessico giovanile veronese dato che la voce al singolare "butel" non viene usata perché sentita come troppo provinciale. Attorno a questa questione è bene aggiungere che un parlante che dica "i ragazzi/amici del bar" si posiziona ad un livello diastratico molto più alto che risulta "stonato". Uscendo dallo stile giovanile di una singola provincia alla ricerca della koinè italiana giovanile ci si accorge che l'utilizzo della lingua dei giovani non dipende strettamente dalla collocazione città/campagna e neppure dal quadro sociale di appartenenza ma piuttosto dalla situazione comunicativa. Come suggerito da alcuni linguisti si può quindi intendere la variazione giovanile come una variabile diafasica. La varietà giovanile si può inoltre considerare come un esempio di "Italiano informale colloquiale" e ancora meglio una modalità espressiva che scivola tra il polo del linguaggio colloquiale e quello del gergo stretto. Il linguaggio giovanile non si può ritenere autonomo nemmeno rispetto alla lingua standard: solo una parte del lessico è alternativa alle parole cuore dell'Italiano. La dose di componente innovativa dipende dallo scopo o dal livello di clandestinità della conversazioni che i suoi parlanti devono mantenere. Radtke (1990) ipotizza che "le varietà giovanili si diffondano nella misura che i dialetti regrediscono". Solitamente coloro che oltre a parlare italiano sono dialettofoni utilizzano la lingua locale come veicolo dei messaggi più espressivi o nelle situazioni informali. Termini

che nascono con una connotazione sessuale (intendo"cazzo" e "figa") diventano le più frequenti interiezioni del parlato colloquiale e informale trascurato. Giacomelli (1992) si riferisce a questi intercalari come al tratto più marcato della lingua giovanile e allo stesso tempo come a una moda lanciata dai giovani che porterà col tempo al decadimento dell'uso primo (quello di riferirsi volgarmente ai genitali). Non si riscontra nessuna discriminazione dei generi nel parlare aggressivo: il passaggio dal maschile al femminile avviene fluidamente da "figo" a "figa" e da " a "gnocca" a "gnocco" e indica la disinvoltura o il bell'aspetto nel primo caso e la sola fisicità nel secondo. Sono entrambe voci che il linguaggio giovanile ha mutuato dal dialetto e ha contribuito a diffondere.
LA LINGUA, TRA MUSICA, MODA E I COSTUMI CHE CAMBIANO.
Una maggiore attenzione viene riservata ai giovani nella società dei consumi: la varietà giovanile influenza sempre di più la lingua informale in quanto i modelli proposti dai media escono tra l'altro dai numerosi teen-movie e da romanzi per adulti che hanno però adolescenti come protagonisti e quindi riproducono lo stile informale tipico del parlato di questi. Talvolta si nota una iper-caratterizzazione della parlata giovanile in prodotti mediatici di finzione di scarsa qualità, l'effetto ottenuto è pseudo-giovanilistico. Si presuppone che la varietà parlata dai giovani tra loro non rappresenti l'unico registro linguistico conosciuto dai giovani ma che si tratti piuttosto di una variabile diafasica. Chi tra gli autori di fiction calca la mano e riempie i dialoghi dei giovani di "fico" e "giusto" sarebbe meglio che prima ascoltasse un po' meglio i modelli a cui si ispira, forse noterebbe che la lingua si adatta alla situazione comunicativa tanto per gli adulti quanto per i giovani. Più che un linguaggio quello analizzato è pertanto uno "stile di comunicazione" adottato soprattutto nelle conversazioni in cui si ritiene più appropriato in base all'interlocutore e al tema.
Il senso di appartenenza al gruppo di amici si acquisisce anche tramite la conformità nell'aspetto, in particolare nell'abbigliamento nel trucco e parrucco, che talvolta rende indistinguibili uno dall'altro mentre in altri casi i manifesta con azzardi frutto del bisogno di mostrare tutta l'estrosità posseduta. Troviamo così: la/il giovane "stilosa/o" cioè che sceglie i capi non seguendo rigidamente la moda del momento ma affidandosi al gusto personale o ispirandosi a modelli non convenzionali, mentre chi è attento ai suggerimenti delle griffe è un "fighetto" una persona che solitamente cura molto l'aspetto senza lasciare niente al caso, in gergo "si tira" (a malta fina), e solitamente il suo atteggiamento una volta pronto sarà quello di "tirarsela" ossia mantenere un'aria distaccata e superba. Lo stesso significato è veicolato da due prestiti: uno invariato e uno italianizzato "fashion" e "scicchettoso". Allo stesso modo sono utilizzati molti altri aggettivi inglesi per descrivere il look dei teenagers che spesso viene imitato dai trentenni: trendy, street, urban. L'atteggiamento contrario al "tirarsela" è quello di chi "sta morbido", "in scialla": cioè rilassato fino ad essere sciatto nell'aspetto. Lo stesso atteggiamento noncurante e menefreghista si ritrova nell'imperativo "mollami!" traducibile con un "lasciami stare, non farmi pressioni!". L'ultima moda, che non si può tralasciare in un testo sulla lingua dei giovani, è quella degli "emo". Il termine "emo", negli anni 80 si riferisce ad un genere musicale compreso all'interno del punk rock, è diminutivo di emotional, emotivo. Diventa nell'uso odierno dei giovani un aggettivo/sostantivo che indica ragazze e ragazzi tendenti al sentimentalismo che amano stare in solitudine per comporre canzoni e poesie. Gli Emo, nonostante la grande introspezione che li contraddistingue, sono anch'essi caratterizzati da un aspetto standardizzato consistente in pantaloni aderenti, scarpe da ginnastica allstar, magliette e felpe stampate con fantasie di stelle, cuori o piccoli teschi e

capelli tinti di nero con frangia stirata in avanti a coprire il viso. La lingua mostra come la conoscenza della diversità si stia diffondendo anche grazie a molti blog e trasmissioni che si rivolgono a pubblici diversi. In particolare la fortuna di alcune trasmissioni televisive come "Will and Grace" e una vita privata vissuta più facilmente allo scoperto anche da parte di molti teenagers, ha reso diffuse soprattutto tra le nuove generazione alcune espressioni molto incisive usate negli ambienti omosessuali. Queste espressioni posseggono la stessa capacità sintetica o la lapidarietà di "sfigato", "giusto" "rockettaro" e "discotecaro". Dallo slang gay arrivano "camion/camionista" che indica una donna lesbica molto maschile nell’atteggiamento, "sciampista" è un ragazzo dai modi femminili e almeno in apparenza superficiale (una versione edulcorata del più dispregiativo "checca") , al contrario "orso" sta per uomo dalla corporatura molto robusta e villosa senza attitudini modaiole mentre "melochecca" si usa per un omosessuale dai bei modi, appassionato d'opera.
GLI STRUMENTI E LE FONTI.
Coveri consiglia una serie di testi letterari che possono colmare la scarsità di raccolte di termini del linguaggio giovanile (Lanza 1974 e Manzoni Dalmonte 1980), in cima alla lista alcuni libri del mio autore preferito Raymond Queneau nella traduzione di due grandi autori Italiani. Raymond Queneua inizia ad esempio "Zazie sul metro" con una battuta della piccola protagonista, che tradotta da Italo Calvino, suona pressappoco così: "Macchepuzzachefà". É Una registrazione, non filtrata dalla scrittura, della lingua orale di una ragazzina della provincia, senza porsi alcun freno nel rappresentarne anche le espressioni più oltraggiose. Allo stesso tempo il romanzo presenta numerosi forestierismi con grafia che riproduce la fonetica "ginz" per "jeans" e diverse espressioni dialettali, ingloba inoltre il linguaggio della pubblicità, e altri lessici specialistici usati con la leggerezza di un teenager. Con grande umorismo il romanziere annulla le diversità di genere ed età dimostrando un rispetto eccezionale verso tutti senza rinunciare ad essere pungente e denunciando le debolezze di ciascuno. Altro esempio utile per un'analisi sociolinguistica, che evidenzia senza dogmaticità le sfumature diastratiche, diafasiche, diatopiche, e diamesiche che si possono conferire ad un testo letterario sono "Gli esercizi di stile" sempre dello stesso autore; questa volta resi in Italiano (con salti mortali linguistici) da un ispiratissimo Umberto Eco. Queneua dimostra come un episodio molto banale possa essere raccontato in molti modi, usando diversi stili, registri e forme testuali. Coveri richiama poi il "Il Giovane Holden" di Salinger soprattutto per una questione lessicale ma anche come archetipo del romanzo di formazione generazionale. Per una lista completa rimando all'articolo "Lingua ed Età" in bibliografia.
Michele Cortellazzo oltre all'osservazione partecipante ritiene utile, soprattutto nell'analisi diacronica dell'uso del linguaggio dei giovani, registrare i fenomeni annotati nelle autobiografie linguistiche come quella di Giovanni Nencioni. I commenti linguistici riportati parallelamente alle abitudini sociali e convenzionali sono una fonte davvero ricca. In particolare ci può aiutare a capire che la libertà acquisita da parte dell'uomo della strada dell'uso di "cazzo" e altri termini riferiti alla sessualità in generale è un caso piuttosto recente La lingua italiano standard degli anni venti era ben diversa da quella del 2008 ma ancora più radicale è la differenza che intercorre tra la lingua usata dai giovani negli anni ruggenti e la lingua giovanile odierna: soprattutto in termini di radicalità ed enfasi.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
Coveri, Lorenzo, Lingua italiana e giovani leve operaie. in Simone/Ruggiero 1977, pp. 235-272
Coveri, Lorenzo, Lingua ed età, in Lexikon der Romanistischen Linguistik, pp 231-236
Cortellazzo, Michele, Il parlato Giovanile, in Serianni/Trifone, Storia della lingua italiana, Torino, Einaudi, 1994 pp. 291
Giacomelli, Roberto, Linguaggio dei giornali giovanili, in Linguaggio del giornalismo, a cura di Mario Medici e Domenico Proietti, Milano, Mursia, 1992
Lanza, Cesare, Il mercabul. il controlinguaggio dei giovani, Milano, Sugar, 1974
Manzoni e Dalmonte, Pesta duro e vai tranquilo. Dizionario del linguaggio giovanile, Milano, Feltrinelli, 1980
Nencioni, Giovanni "Autodiacronia linguistica, un caso personale 1982
Radtke, Edgar, Varietà giovanili, in Sobrero, Alberto, Introduzione all'italiano contemporaneo, Bari, Laterza, 1993
La sezione dedicata al linguaggio dei giovani dell'Università degli studi di Padova http://147.162.119.4/linguagiovani/
Slangopedia inchiesta online del quotidiano La Repubblica http://espresso.repubblica.it/dettaglio-archivio/400221
Il lessico più completo e chiaro sulla lingua dei giovani http://www.bruttastoria.it/
la voce di wikipedia relativa alle droghe http://it.wikipedia.org/wiki/Marijuana