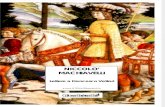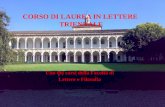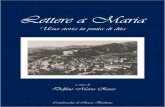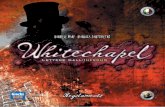Lettere - Marsilio Editori · 2021. 2. 12. · Lettere Sì, la Pediatria dì famiglia (PdF) può...
Transcript of Lettere - Marsilio Editori · 2021. 2. 12. · Lettere Sì, la Pediatria dì famiglia (PdF) può...

Lettere
Sì, la Pediatria dì famiglia (PdF) può farlo e lo sosteniamo da sempre.
Nel 1997 è stato pubblicato un documen-to che, a circa 10 anni di distanza dall'idea iniziale di ricerca in Pediatria ambulatoria-le', sì prospettava come una sorta di manife-sto che cercava di dare una voce organizzati-va, oltre che di priorità di contenuto, su cui lavorare nell'ambito delle Cure primarie2. In questi anni ci sono stati tanti esempi di lavo-ri sul campo fatti dalla "rete" allargata (re-gionale, nazionale) dei PdF. E ne esiste una chiara e importante documentazione3. Alcu-ne cose sono ancora in corso di lavoro.
Ma la mia impressione è che l'entusiasmo in iziale si stia perdendo. Non ci sono più pro-tocolli ideati e condotti in primis dalla rete dei PdF. Paradossalmente la cartella compu-terizzata, che poteva essere uno strumento informatizzato pragmatico di rilievo, non è stata utilizzata in pieno rispetto alle infor-mazioni che potrebbe fornire.
Ma le informazioni nascono da idee, da obiettivi da raggiungere. E i quesiti (non solo clinici) a cui dare risposta, anche in un con-testo delle Cure primarie, sono ancora tanti. Il tempo dedicato per la comunicazione rapi-da, quella dei Forum, dei social, dei gruppi WhatApp è preponderante, anche a discapito di una sana lettura, di approfondimenti te-matici, di prospettive su cui investire ener-gie, di protocolli di lavoro.
Eppure, già nel 2001 lo si diceva, esìstono alcuni bisogni rilevanti della popolazione pediatrica che non hanno finora trovato ade-guato approfondimento, e in tale ambito la PdF può rappresentare un importante osser-vatorio e un'interfaccia tra Servizi sanitari e sociali, Scuola, Centri specialistici4.
Possiamo ancora crederci con l'entusia-smo sperimentale e pratico invocato da Raf-faella de Franchis?Attendiamo intanto i ri-sultati dello studio che, come accade in chi partecipa a progetti di ricerca sul campo, avrà nel frattempo modificato in positivo al-cune pratiche (anche) sulla gestione dello svezzamento.
Bibliografìa
1. Tamburlini G. Ricerca epidemiologica in Pe-diatria di base. Prospettive in Pediatria 1989;19: 207-12. 2. Gangemi M (a cura di). Ricerca nell'area delle Cure primarie del bambino. Medico e Bambino 1997;7:31. 3. Reali L, Lo Giudice M, Cazzato T, Bianchini C. Picca M. La ricerca nelle cure primarie pedia-triche: i contributi italiani nella letteratura inter-nazionale. Prospettive in Pediatria 2017;47 (185):18-32. 4. Marchetti F. Ricerca in Pediatria di famiglia. Medico e Bambino 2001;20(5):293-301.
Federico Marchetti
I bambini di Asperger: la scoperta dell 'autismo nella Vienna nazista
Edith Sheffer, Autrice del libro Ibambi-ni di Asperger. La scoperta dell'autismo nel-la Vienna nazista (Marsilio editore, 2018), storica di professione e mamma di un bambino autistico, ripercorre la storia del-la Pediatria a Vienna negli anni Trenta e Quaranta. Il volume è interessante per i medici e per i pediatri perché segue l'evo-luzione della Pediatria e della Neuropsi-chiatria infantile in funzione del mutare dei Governi.
Hans Asperger lavora come pediatra a Vienna durante il periodo nazista. L'espul-sione di tanti medici ebrei (tra cui Anne Weiss) lascia via libera a lui e ad altri pe-diatri e neuropsichiatri nazisti. Dopo la pri-ma guerra mondiale, alcuni pediatri uma-nisti, come Lazar e von Pirquet, avevano concepito la cura del bambino come un in-tervento sociale, rendendosi conto che all'alimentazione e all'igiene dovevano as-sociare l'educazione. Avevano così inven-tato la "Pedagogia curativa" e concepito una rete di assistenti sociali che individua-vano nel territorio i bambini più poveri o deboli per offrire percorsi di cura mirati. Questo sistema di uielfare con il cambiare del Governo e dei medici che lo avevano concepito si rivelò una tragica trappola.
La diagnosi delle situazioni psichiche di autismo che noi definiamo Asperger fu fatta tra i primi da Anne Weiss, sempre a Vienna, che li descriveva con toni empati-ci: "Nei bambini come Gottfried che risul-tano a prima vista strani ed originali si pos-sono riscontrare dei talenti speciali che, anche se di entità limitata, spesso vanno oltre le capacità dell'uomo medio". Insiste-re su questi tratti positivi potrebbe aiutarli a sentirsi realizzati nel corso della vita "esperti di date, risoluzione di puzzle, arti-sti della memoria, dotati di grande assi-duità e affidabilità, bravi nell'ordine e nella classificazione".
Asperger utilizza gli studi della Weiss e del dottor Tramer che lo precedettero ma, invece di porsi il problema della realizza-zione individuale di questi bambini, è spin-to dalla nuova cultura dominante a porsi il problema della loro utilità sociale, affer-mando, nel 1944, che molti di loro "aveva-no interessi bizzarri senza alcuna utilità pratica, difficili da integrare nel Volk, nella comunità, nel popolo", cari al Nazismo.
Le testimonianze e i documenti gettano una luce inquietante sulla figura di Asper-ger e sulla sua frenesia di "classificare" i bambini "asociali". Asperger e i suoi colle-ghi, classificando i bambini diversi e pro-ponendo il loro ricovero, decisero consa-pevolmente quali vite fossero indegne di
essere vissute. Nello Spiegelgrund, la Cli-nica pediatrica di Vienna, venne realizzato, tra il 1939 e il 1945, il noto programma di eutanasia infantile.
L'Autrice ha accesso alle cartelle clini-che dello Spiegelgrund e racconta le storie di tante piccole vittime, descrive le diagno-si, i trattamenti, le modalità con cui sono stati condotti alla morte. Il 70% dei minori uccisi non aveva invalidità fisiche degne di nota. I medici formulavano giudizi sogget-tivi su presunte "ridotte abilità cognitive" "imbecillità", al 10% non era stato diagno-sticato niente di specifico.
Quanto emerso dalle cartelle, dalle te-stimonianze dei sopravvissuti e dai docu-menti (la bibliografia e la consultazione degli Archivi è notevole) non può essere dimenticato. L'adesione all'ideologia nazi-sta fu alla base del suo successo professio-nale, della sua precoce nomina a primario e del destino dei suoi bambini.
Dopo la guerra, la diagnosi di psicopa-tologia autistica Asperger fu infatti consi-derata con inquietudine dai medici tede-schi e non più utilizzata finché fu ripropo-sta nel 1981 da una psichiatra inglese. Asperger comunque continuò a lavorare come molti altri medici austriaci e tede-schi, le cui responsabilità vennero ricono-sciute molto lentamente negli anni con l'a-pertura di tutti gli Archivi.
Di fronte al nuovo sforzo in corso, in ambito neuropsichiatrico, per individuare precocemente questi bambini e aiutarli e al forte incremento delle diagnosi, potrem-mo domandarci: in che misura una diagno-si sia prodotto di una determinata società? Il medico ha un patto etico con il suo pa-ziente o con il Sistema Sanitario Nazionale in cui opera? Forse, inoltre, come propone il DSM-5, sarebbe il momento di parlare di spettro autistico e togliere dalla nostra pra-tica clinica il nome di Asperger.
Federica Scrimin IRCCS Materno-lnfantile "Burlo Garofolo"
Trieste [email protected]
Su questo numero di Medico e Bambino, a pag. 377, l'articolo sul bambino troppo intel-ligente parla anche della vecchia dizione di sindrome di Asperger e, come dice la dotto-ressa Scrimin, nel DSM-5, la nuova defini-zione non utilizza più l'eponimo, ma si parla di "disturbo dello spettro autistico, senza compromissione intellettiva associata e sen-za compromissione del linguaggio associato". Il racconto della storia del nome da sempre usato (anche a sproposito) è molto istruttivo e noto a pochi. Ne facciamo tutti sicuramente tesoro.
Medico e Bambino
3 5 2 Medico e Bambino 6/2020 352