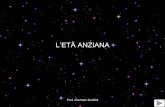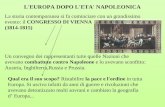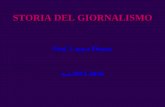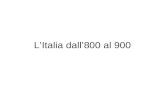l'Eta' Giolittiana
description
Transcript of l'Eta' Giolittiana

L’ETA’ GIOLITTIANAGIOLITTI E L’INSERIMENTO DELLE MASSE NELLA VITA POLITICAUna svolta: l’età giolittianaGiovanni Giolitti, che era già stato al governo nel 1892-1893, venne rieletto presidente del consiglio nel 1903 e mantenne la carica fino al 1914: questi anni furono definiti “età giolittiana”.Giolitti si pose l’obiettivo di inserire gradualmente le masse nell’attività politica in modo da non provocare sconvolgimenti nel sistema liberale. Per Giolitti nella politica la concretezza prevaleva nettamente sugli elementi ideologici.Il programma politico di GiolittiGiolitti si mostrò sempre contrario alla repressione: in un discorso nel 1901, si schierò a favore della libertà delle organizzazioni sindacali che lottavano per migliorare le condizioni di lavoro e i salari. Sul piano politico cercò quindi di trovare un accordo con le forze socialiste per le riforme mentre sul piano sindacale adottò una linea di non intervento nei conflitti tra imprenditori e lavoratori.L’istruzioneLa scuola fu uno strumento fondamentale sia per inserire le masse nella vita politica che per riuscire a fondere le diverse culture regionali. Nel 1901 venne constatato che in Italia l’analfabetismo era ancora molto diffuso (30 % tra le reclute e 50 % nel complesso della popolazione). La situazione migliore era in Piemonte (solo il 5 % di analfabeti) mentre peggiorava drasticamente scendendo al sud. Nel 1913 le cose migliorarono ma rimase comunque un tasso di analfabetizzazione elevato tra la popolazione che raggiungeva il 40 %.L’ECONOMIA ITALIANA DURANTE L’ETA’ GIOLITTIANALo sviluppo economico a nord e a sudL’Italia iniziò a svilupparsi a livello industriale a partire dal 1896, in ritardo rispetto alle grandi potenze europee: questo periodo venne definito “decollo” e coincise con il periodo giolittiano. Dal 1902 al 1913 il PIL aumentò del 70 % e l’industria acquistò un peso sempre più crescente rispetto al settore agricolo che rimase comunque quello prevalente nell’economia italiana. Questo sviluppo però lo si ebbe prevalentemente nell’Italia settentrionale e Giolitti si rese conto della gravità della “questione meridionale”: per questo Giolitti adottò una legislazione speciale per l’industrializzazione del meridione che comunque ebbe poco successo.L’industria automobilisticaAnche l’industria automobilistica italiana si mosse in ritardo rispetto alla produzione estera: nel 1899 nacque a Torino la Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT) e nel 1906 a Milano nacque l’ Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (ALFA) ma la produzione fino alla vigilia del primo conflitto mondiale rimase notevolmente più ridotta rispetto ad altri stabilimenti come la Ford (USA)Le difficoltà dell’industrialismo in ItaliaAl nord, insieme alle prime grandi fabbriche, sorsero anche le prima associazioni degli industriali come la CIDI (Confederazione Italiana Dell’Industria) nata nel 1910 che tutelava gli imprenditori del triangolo industriale. In Italia però molti ancora non consideravano l’industria come il fattore propulsivo dell’economia e questo clima rese difficile l’espansione dell’industrialismo.La società nell’età giolittianaL’alta borghesia nel 1901 costituiva l’1,7 % e i professionisti lo 0,7 % (la classe dirigente rappresentava il 2,4 % della popolazione) mentre gli operai erano il 10,1 % e i braccianti e i contadini il 35,6 %. Il resto della popolazione rappresentava la piccola borghesia. La società italiana risultava quindi divisa in due grandi categorie, i “ricchi” e i “poveri”.MEZZOGIORNO ED EMIGRAZIONELa politica di Giolitti nel mezzogiornoMentre Giolitti approvò delle leggi per favorire lo sviluppo economico nel mezzogiorno, il governo adoperò la forza contro i contadini meridionali reprimendo duramente diverse dimostrazioni. In realtà il meridione rappresentava una delle basi del potere giolittiano grazie alla folta presenza di deputati meridionali eletti grazie a sistemi clientelari.L’emigrazioneNel 1900 emigrarono più di 350.000 italiani, prevalentemente verso Stati Uniti, Argentina e Brasile, e nel corso dell’età giolittiana il numero di coloro che emigravano continuò ad aumentare. Quasi la metà proveniva dal meridione e gran parte anche dal veneto e tutto ciò contributi a modificare l’economia dato che gli emigranti cominciarono a far affluire denaro alle proprie famiglie.SOCIALISTI E CATTOLICILa politica giolittiana verso i sindacatiGiolitti tenne un atteggiamento neutrale verso i sindacati, anche nel 1904 quando scoppiò uno sciopero generale a Milano che si estese poi in tutta Italia, anche se in misure diverse. Il PSI non intervenne attivamente e si divise in due correnti: i riformisti che volevano limitare lo sciopero e i rivoluzionari che invece volevano utilizzarlo per far cadere il governo Giolitti. La Camera fu sciolta e furono indette nuove elezioni che videro l’avanzamento del partito socialista che però ne uscì indebolito dalle divisioni interne.La politica giolittiana verso i socialisti

Giolitti si proponeva di collaborare con i socialisti riformisti poiché riteneva che essi rappresentassero la classe operaia dell’Italia settentrionale e necessitava del loro sostegno. Filippo Turati gli appariva l’interlocutore più affidabile e lui stesso era disponibile a collaborare ma il partito, contrario a tutto ciò, fece pressioni e così il tentativo di Giolitti di stabilire buoni rapporti con i socialisti riformisti fallì.I massimalisti e Benito MussoliniNegli ultimi anni dell’età giolittiana si indebolì la corrente riformista del PSI e si rafforzò quella massimalista. Tra gli esponenti di spicco di quest’ultima compare Benito Mussolini che attaccò duramente il governo Giolitti grazie anche all’utilizzo del giornale “Avanti”, di cui era direttore, che utilizzò come efficiente strumento di propaganda.Giolitti e i cattoliciGiolitti quando nel 1961 ci fu l’unità d’Italia aveva solo 22 anni e per questo non entro nella discussione della partecipazione dei cattolici nella vita politica. Si rese però conto che nel suo periodo storico i cattolici erano numerosi e svolgevano una funzione importante nella vita politica; inoltre anche i cattolici intendevano lasciarsi alle spalle le antiche divisioni.La nuova legge elettorale e il “patto Gentiloni”Nel 1912 il parlamento approvò una riforma elettorale che concedeva il diritto di voto a chi avesse compiuto 21 anni (30 per gli analfabeti): in tal modo il numero degli elettori triplicò. Questo allargamento favoriva il PSI al nord, ma avvantaggiava Giolitti al sud sempre grazie all’utilizzo delle clientele. Inoltre Giolitti si era assicurato il sostegno dei cattolici. Nel 1906 era nata l’ Unione elettorale cattolica italiana: nel 1913, prima delle elezioni, strinsero al loro interno il “patto Gentiloni” che si proponeva di garantire la salvaguardia di alcuni principi come la tutela dell’istruzione religiosa ed il rifiuto del divorzio.LA CRISI DEL SISTEMA GIOLITTIANOLe elezioni del 1913Alle elezioni dell’ottobre 1913 votarono il 60 % degli aventi diritto e i socialisti raddoppiarono i loro deputati. Giolitti disponeva ancora della maggioranza ma non era più così solida poiché l’inserimento dei cattolici condizionò pesantemente la sua politica. Così, pur avendo ottenuto la fiducia nel dicembre 1913, nel marzo 1914 diede le dimissioni: finì così l’età giolittiana.Giolitti e le guerre colonialiNel 1911 l’Italia intraprese una guerra coloniale contro l’Impero Ottomano: terminò un anno dopo nel 1912 con la conquista della sovranità in Libia. La guerra alla Turchia poteva sembrare in contraddizione rispetto alla linea politica giolittiana ma in realtà Gilitti non era un pacifista, era infatti contrario ad eventuali conflitti europei ma non a guerre coloniali che, anzi, considerava come strumento per portare civilizzazione a popoli barbari.GLI INTELLETTUALI NELLA LOTTA POLITICAIl nazionalismoA destra, l’opposizione a Giolitti era guidata dai nazionalisti, che avevano molte adesioni tra gli intellettuali e che chiedevano uno Stato forte, irrealizzabile con un regime parlamentare. Erano perciò contrari alla democrazia perché ritenevano che rinunciasse a rendere grande l’Italia attraverso l’espansione imperialistica, e al socialismo che accusavano di sabotaggio degli interessi nazionali, date le loro posizioni internazionalistiche. Il maggior esponente fu Enrico Corradini che distinse il “patriottismo” dal “nazionalismo”: il patriottismo rappresentava l’amore verso l’Italia mentre il nazionalismo serviva per affermarne la potenza. Inoltre il nazionalismo doveva essere un tentativo per spostare il problema della vita nazionale dalla politica interna a quella estera: l’antagonismo di classe doveva trasformarsi in antagonismo tra nazioni ricche e nazioni povere. L’Italia, per Corradini, faceva parte di quelle “nazioni proletarie” che dovevano rendersi grandi e conquistare ricchezza e prestigio attraverso la guerra.Le polemiche degli intellettualiMentre nel risorgimento gli intellettuali avevano un’impronta liberale, nel ‘900 divennero la voce del nazionalismo. Tra gli scrittori che contribuirono maggiormente a diffondere le idee nazionaliste vi furono Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Prezzolino, Giovanni Papini e Filippo Tommaso Martinetti (il più grande esponente nonché fondatore del “futurismo”).LA GUERRA IN LIBIALe cause della guerraLa politica coloniale italiana intrapresa da Crispi nell’800 fu un insuccesso. Ma l’instaurazione del protettorato francese in Marocco preoccupò l’Italia che decise di avere la propria sfera di influenza in nord Africa occupando la Libia. L’Italia dichiarò quindi guerra all’Impero ottomano nel 1911 grazie al sostegno dei nazionalisti ma anche di alcuni socialisti.Lo svolgimento della guerraNel 1911 si cominciarono a far sbarcare le prime truppe in Libia che, forti di 100.000 uomini riuscirono a superare l’esercito turco (anche se solo sulla costa). Il governo decise allora di estendere ulteriormente le operazioni militari occupando Rodi e altre dodici isole (che formarono il Dodecaneso). Così nel 1912 l’Impero ottomano fu costretto a firmare il trattato di Losanna con il quale riconobbe la sovranità italiana in Libia; le popolazioni arabe però, attraverso numerose operazioni di guerriglia, crearono non pochi problemi agli italiani che si videro costretti a limitare la loro sfera di influenza alle sole zone costiere.