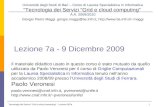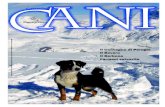L'Emanuele n. 9 - Dicembre 2009
-
Upload
centro-eucaristico -
Category
Documents
-
view
230 -
download
6
description
Transcript of L'Emanuele n. 9 - Dicembre 2009

Carissimi amici…Ai lettori…
ormai prossimi alla fine di un altro anno, nel mio cuore si animano diversi sentimenti che racchiudo tutti in una parola semplice ma vera: grazie. Ai collaboratori, a chi continua e a chi termina, diciamo grazie per averci accompagnato con la loro competenza e simpatia offrendoci preziosi percorsi di riflessione e di approfondimento. Grazie a voi, amici abbonati e lettori occasionali, che fedelmente ci manifestate apprezzamento e fiducia. Grazie a tutto lo staff del Centro Eucaristico che assicura cura e premura nel predisporre tutto perché L’Emanuele continui il suo ideale originario: mantenere vivo il legame tra Eucaristia e vita in tutte le sue dimensioni.Questo sentimento di gratitudine lo voglio raccogliere e racchiudere in questa preghiera di Jean-Pierre Dubois-Dumée:
Dio ci benedica oggi e sempre e renda la nostra vita un canto che si eleva per raggiungere ogni cuore; chi è in attesa e chi è già stato toccato dall’amore di Dio; chi fa difficoltà a sperare e chi ha trovato il senso della vita e riesce a dare colore e calore all’esistenza; chi vive l’angoscia dell’oggi per la paura del domani e chi ha raggiunto la pace del cuore e vive tutto come dono… L’Emmanuele, il Dio con noi, che accoglieremo a Natale sia per tutti l’antico e nuovo annuncio di un tempo che si prefigura come pieno di luce, di vita, di amore, di verità, di pace… Buon Natale e buon Anno a tutti.
Ogni bene p. Luca
Grazie per il pane, il vento, la terra e l’acqua.Grazie per la musica e per il silenzio.Grazie per il miracolo di ogni nuovo giorno.Grazie per i gesti e le parole di tenerezza.Grazie per le risate e per i sorrisi.Grazie per tutto ciò che mi aiuta a vivere,nonostante le sofferenze e lo sconforto.Grazie a tutti quelli che amo e che mi amano.E che questi mille ringraziamenti si trasformino in un’immensa azione di grazie quando mi rivolgo a te,
fonte di ogni grazia e roccia della mia vita.Grazie per il tuo amore senza confini.Grazie per il pane dell’Eucarestia.Grazie per la pace che viene da te.Grazie per la libertà che tu ci dai.Con i miei fratelli io proclamo la tua lodeper la nostra vita che è nelle tue manie per le nostre anime che ti sono affidate.Per i favori di cui tu ci inondie che non sempre sappiamo riconoscere.Dio buono e misericordioso,che il tuo nome sia benedetto,sempre.Amen.

Editore:Provincia Settentrionale dei Padri SacramentiniDirettore responsabile:Luca [email protected]
Direzione:via Padre Longari, 724010 Ponteranica (BG)Tel. 035.571061Fax 035.574294e-mail:[email protected] grafica:Grazia Turani
Conto Corrente Postale:n. 15025240 intestato a:Prov. Sett. PP. SacramentiniCentro Eucaristico via Longari, 7 24010 Ponteranica (BG)Autorizzazione:n. 35 del 9/12/93 (Trib. BG)
AbbonAmEnto 2010ItALIA: 22,00 Europa E MEditErranEo: 44,00africa-aMErica-asia: 59,00ocEania: 64,00La spEdizionE aLL’EstEro avviEnE soLo coME posta prioritaria Sped. in abb. post.-BGStampa: Divisione Novastampa
Gruppo SiZ, Verona
Si autorizza la riproduzione di testi citando la fonte
Associato all’USPIISSN 0394-6045
Garanzia di riservatezzaLa Provincia Settentrionale dei Padri Sacramentini, in qualità di Editore, ga-rantisce, ai sensi dell’art. 13 del d. legs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, che i dati relativi agli Abbonati vengono trattati nel rispetto della leg-ge. Il trattamento dei dati sarà correlato all’adempimento di finalità gestionali, am-ministrative, statistiche, di ricupero crediti, ricerche di mercato, commerciali e pro-mozionali su iniziative offerte dal Centro Eucaristico ed avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, anche mediante l’au-silio di mezzi elettronici e/o automatiz-zati. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta la mancata elargizione dei servizi previsti. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. legs. 196/2003, tra cui cancellare i dati ed opporsi al loro utilizzo per finalità commerciali, rivolgendosi al Responsabi-le Dati della Provincia Settentrionale Padri Sacramentini, Via Longari 7, 24010 Ponte-ranica (BG); oppure via e-mail a: [email protected]
DICEMBRE 2009
Spiritualità liturgica Una spiritualità comunitaria ed ecclesiale 4di Lino Emilio Diez Valladares sss
Contemplare l'Eucaristia Adorazione e vita evangelica 8di Giovanni Moretti sss
Bibbia La preghiera di Gesù 11 di Davide Carbonaro omd
Catechesi mistagogica Carissimo lettore… 14 di B Arturo Aiello, Vescovo di Teano-Calvi
ATTUALITÀ - VITA DELLA CHIESA
Testimoni Una vita spesa tra le case di Maria 18 di Davide Carbonaro omd
Attualità: lettera ai cercatori di Dio Lavoro e festa 60 di Francesca RedolfiCrediti fotografici:APS 7,18,31,32,33,34,43,50,51,52,53,54,63; www.jiunlimited.com COP,1,2,4,5,8,11,14,15,16,17,37,38,39,43,54,60; www.wga.hu 21,23,25,27,29,35,46,50,56,57,59; www.dariogallina.it 40,41; www.mantovastradaviniesapori.it 40; www.montevergine.librari.beniculturali.it 55.
CATECHESI
Img. copertina: un tipico fiore e colore del Natale che ci ricorda che il mistero dell’incarnazione è mistero di passione e di gioia.
2 - L’EMANUELE 9/2009
Anno 107°

SOMM
ARIO
9
FORMAZIONE - INFORMAZIONE
Famiglia oggi Se un figlio si consacra a Dio… 37 di Maria Angela Masino
Ordini monastici e abbazie San Benedetto Polirone: la proprietà fondiaria 40 di Giuliana Fantoni
Pellegrini in cammino Gesù, il pellegrino 43 di B Carlo Mazza, Vescovo di Fidenza
In cammino con san Paolo La prima Tessalonicesi nella nostra vita 46 di Giuseppe Crocetti sss
Proposta di Lectio Date loro voi stessi da mangiare 50 di Luca Zanchi sss
Abisso di luce: la spiritualità liturgica di Divo Barsotti La vera vita 54 di Aurelio Porfiri
Arte e fede In viaggio attraverso l'arte sacra: El Greco 56 di Giovanni Gusmini
LE DOMENICHE E LE FESTE
Anno C: da Maria Madre di Dio alla 3a Domenica per Annum«Gli fu messo nome Gesù…» G. Polini 21«In principio era il Verbo…» L. Zanchi 23«Dov’è il re dei Giudei che è nato?» G. Polini 25«Tu sei il mio figlio prediletto, in te…» L. Zanchi 27«Riempite d’acqua le giare» L. Zanchi 29«Oggi si è adempiuta questa Scrittura…» L. Zanchi 35
PREGHIERA
Cammino di preghiera Il pellegrino: un tremante d’amoreper il segreto di una vita feconda 31 di Giampietro Polini sss
L’EMANUELE 9/2009 - 3

UnA SPIRITUALITà COMUnITARIA… Il cristiano tramite la liturgia è guidato
nel contemplare ogni volta con più intensità la gloria del Signore, “come in uno specchio” (2 Cor 3,18), fino ad essere trasformato in questa stessa immagine. E lo fa attraverso il dialogo che si instaura tra Dio ed il suo po-polo mediante la proclamazione della Parola (Dio parla ed il popolo accoglie la sua parola trasformatrice e risponde con la acclamazio-ne, la lode, la propria offerta, la supplica), e la celebrazione dei sacramenti (Dio si offre ed il popolo lo riceve come una grazia che trasforma, che deve tradursi nell’esistenza concreta).
L’incontro con Dio, sia pur a livello comu-nitario (nell’unità del popolo di Dio), nella li-turgia non è mai come se si trattasse di una moltitudine anonima; è sempre con ogni per-sona individualmente, benché sia membro della chiesa.
Questa essenziale caratteristica di comu-nione ha una dimensione verticale, di unio-ne per mezzo della celebrazione comunita-ria tra ogni persona e Dio, ed una dimen-sione orizzontale, di unione tra colo-ro che parte-cipano al-
la celebrazione liturgica. Entrambi sono fon-damentali perché la liturgia non è un’azio-ne privata ma patrimonio e manifestazio-ne del Corpo ecclesiale di Cristo, che è il “sa-cramento di unità”, e lo implicano profonda-mente (Sacrosantum Concilium 26).
In tal senso, la celebrazione della liturgia deve avere come effetto lo stringere legami di comunione ecclesiale, in primo luogo tra la comunità locale (che è la realtà concreta del mistero della chiesa) e la concretezza del-la chiesa. Pertanto si può affermare che nella liturgia si manifesta maggiormente il miste-ro della chiesa.
Nell’assemblea liturgica la chiesa trova la sua forma concreta di localizzazione, per cui noi che siamo riuniti in assemblea pren-diamo coscienza e ci realizziamo come chie-sa che esiste in un luogo determinato ed è li che vive la sua testimonianza e missione. La liturgia sottolinea la dimensione comunita-ria dell’esperienza cristiana con il frequente riferimento ad una molteplicità di immagi-ni: popolo, gregge, famiglia, ecc. Inoltre, i te-sti liturgici ci introducono nel carattere “mi-sterioso” della chiesa, che è chiamata: corpo mistico di Cristo, sposa di Cristo, madre no-stra, nuova Eva, città santa, città di Dio, Ge-rusalemme celeste, regno di Dio, casa di Dio, ecc… La dimensione ecclesiologica della li-turgia si rende evidente in particolar modo
nella celebrazione dei sacramenti, il cui ministro e soggetto è sempre la Chiesa.
I sacramenti della chiesa, che forma-no la liturgia, sono mezzi di partecipa-zione diretta ed efficace degli atti reden-tori di Cristo, in particolar modo la sua
morte e risurrezione. Da questi na-sce l’assimilazione alla persona di
Cristo, o imitazione nella pro-pria vita dei misteri cele-
brati nella liturgia. È questo un tema
che appare in molte orazio-
ni: imitare o testimo-niare nelle opere ciò che si cele-bra nel sa-
Unaspiritualitàcomunitariaed ecclesiale4 - L’EMANUELE 9/2009
SPIRITUALITÀ LITURGICAdi Lino emiLio diez vaLLadares sss

cramento. Così, ad esempio, la colletta del ve-nerdì dell’ottava di Pasqua: “concedici di re-alizzare nella vita quanto celebriamo nella fede”. In tal senso la spiritualità liturgica è un continuo stimolo per il credente affinché conformi la propria vita a quanto celebra. Tale verità la si comprende adeguatamente solo se si considera il sacramento come un incontro obiettivo ed efficace della salvez-za di Cristo, incontro che trasforma e rinno-va il cristiano. Di fatti il cristiano può porta-re a compimento la passione di Cristo (opera morale) perché questa è già dall’inizio in lui come realtà sacramentale (l’essere cristiano). Pertanto, il sacramento non è principalmente visto come un mezzo per realizzare un con-tatto con la persona di Cristo, soprattutto al fine di stabilire un “colloquio” interiore con lui, dimensione sottolineata da un certo ti-po di spiritualità, ma come il punto di incon-tro che è, allo stesso tempo, comunicazione del mistero e causa di assimilazione a Cri-sto precisamente nella prospettica del miste-ro comunicato.
… ED ECCLESIALELa liturgia è azione di Cristo realizza-
ta nella Chiesa e mediante la chiesa. Cristo e chiesa sono inseparabili, come la testa lo è per il corpo. Con il battesimo il cristiano è introdotto nel sacerdozio regale (Sacrosan-tum Concilium 14) che si esercita all’interno del corpo ecclesiale di Cristo; e tale sacerdo-zio si esercita in primo luogo nella celebra-zione della liturgia e da questa nelle dimen-sioni testimoniali (kerigmatica ed apostolica) e caritativa. Il ministro ed il soggetto di tut-ta la liturgia è la chiesa; benché in date cele-brazioni, come quelle sacramentali, tale di-mensione di ministro debba essere esercitata (rappresentata) da un ministro ordinato che attua in persona ecclesiae.
È nella celebrazione liturgica che si in-troduce il carattere di “mistero” della chie-sa: corpo mistico, sposa, madre, nuova Eva, città di Dio, città santa, nuova Gerusalemme, casa di Dio, regno di Dio, ecc.
Nella liturgia, il cristiano, insieme a colo-ro che formano l’assemblea, esercita il pro-prio sacerdozio regale nella lode e nella sup-plica (dimensione di culto) e riceve da Dio, nell’umile atteggiamento di grata accoglien-za, la Parola ed il sacramento (dimensione di santificazione). Dio dà (Parola e sacramen-to) alla chiesa, e attraverso lei, ad ogni fede-
le, e la celebrazione di una comunità concre-ta, per mezzo della sua unione a Cristo, si in-serisce nell’azione della chiesa intera. Nella liturgia si “sente con la chiesa” nel senso che, lasciando ogni soggettivismo, la propria in-teriorità si armonizza con i sentimenti del-la chiesa veicolati dal calendario liturgico e dalle distinte azioni liturgiche (letture, euco-logia…). Celebrare la liturgica suppone sen-tirsi chiesa ed essere inserito profondamente nella comunione ecclesiale.
D’altra parte è nella chiesa che si da una costante epifania dello Spirito che agisce sulla comunità, sugli individui e sui segni sa-cramentali. Che la spiritualità liturgica sia ecclesiale significa, dunque, che ci inserisce nella dinamica dell’azione dello Spirito.
AzIOnI COMUnITARIEConsiderando che la liturgia è la celebra-
zione della comunità sacerdotale, si segue il suo carattere comunitario e la predilezione per le celebrazioni comunitarie, come espres-sione di tutto il Corpo sacerdotale: “La santa madre chiesa desidera ardentemente che si portino tutti i fedeli a quella piena partecipa-zione, cosciente ed attiva, nelle celebrazioni liturgiche, che esige la natura della stessa li-turgia” (SC 14); “le azioni liturgiche non so-no azioni private, ma celebrazioni della chie-sa, che è “sacramento di unità”, ossia, popo-lo santo congregato ed ordinato sotto la di-rezione dei vescovi. Pertanto appartengono a tutto il Corpo della chiesa, lo manifestano e lo implicano ma i singoli membri si sono in-teressati in diverso modo, secondo la diversi-tà degli stati, degli uffici e della partecipazio-ne effettiva” (SC 26).
La preferenza accordata, nella riforma li-turgica, a tale norma è evidente, come dimo-stra la stessa struttura della celebrazione, vi-sta sempre dal punto di partenza: una comu-nità che celebra, e ristabilendo il senso del-la celebrazione comunitaria, incluso in alcu-ni sacramenti in cui tale dimensione non era ben coltivata: battesimo, penitenza…
PARTECIPAzIOnE PIEnACome conseguenza si ha la possibilità di
una piena partecipazione di tutti i fedeli nel-la liturgia, nei limiti imposti dalla stessa in-dole delle celebrazioni e senza invadere il campo riservato ad altri ministri della chie-sa. Osserviamo, dunque, che la piena parteci-pazione non si misura solo a livello spiritua-
L’EMANUELE 9/2009 - 5

Una spiritualitàcomunitariaed ecclesiale
le, ma anche come compromesso vitale per la pienezza del sacramento.
La partecipazione nella liturgia, nella sua dimensione ecclesiale, porta alcune esigen-ze per una spiritualità comunitaria. Si tratta di una caratteristica della spiritualità cristia-na che oggi si sta recuperando nei movimen-ti moderni della spiritualità, dopo un tempo di predominanza dell’individualismo, pur es-sendo ancora agli inizi. La liturgia deve svol-gere un ruolo di fonte, culminante ed allo stesso tempo pedagogico, per dare, a tale spi-ritualità comunitaria, concretezza e valore.
Teologicamente è chiara la dimensione ecclesiale e comunitaria di tutta la celebra-zione. Liturgicamente esso si esprime in for-ma più piena mediante le preghiere e i segni liturgici: siamo una comunità, un corpo, una famiglia.
Spiritualmente, sul piano della vita, sia-mo ancora lontani da una coscienza ed una vita a livello comunitario modellata sulla li-turgia. Vi sono una molteplicità di motivi: a) schemi mentali, culturali e spirituali ancora troppo ancorati all’individualismo religioso; b) difficoltà oggettive della vita comunitaria, che possono vincersi solamente vivendo le tensioni e superandole nella stessa logica del-la celebrazione liturgica; c) mancanza di vere comunità celebranti, dove esista continuità tra la vita quotidiana ed il culto liturgico.
LITURGIA E CARITà fRATERnASe guardiamo all’ideale della vita liturgi-
ca vissuta, e costituita dalla comunità degli Atti degli apostoli, si può affermare: “per ce-lebrare bene l’Eucaristia non basta il fatto di riunirsi in un certo numero di cristiani nello stesso luogo… con l’obiettivo di offrire a Dio il culto pubblico; è necessario che durante la settimana si costituisca una comunità, una famiglia, in cui ogni membro sia disposto a servire gli altri. Pertanto, il culto specifica-tamente cristiano, che è l’Eucaristia, è, dun-que, inseparabile dalla vita cristiana; inoltre, non solo implica che durante la celebrazione i cristiani si sentano uniti tra loro e che ma-nifestino tale unione attraverso un qualche gesto esteriore, come ad esempio lo scambio di pace o l’elemosina per i poveri; esige dun-que una trasformazione completa della vita”.
LITURGIA PORTATA ALLA VITA Il segno pieno della celebrazione liturgi-
ca, specialmente l’Eucaristia, suppone una
continuità che deve realizzarsi nell’esisten-za quotidiana. Resi “concorporei e consagui-nei” nell’Eucaristia (S. Cirillo di Gerusalem-me), bisogna vivere in fraternità, “come Cor-po Mistico”. Ciò richiede che all’interno delle comunità celebranti ci sia un continuo sfor-zo per adeguare la vita concreta alle esigen-ze comunitarie della liturgia: continuità tra il celebrare ed agire: amore, servizio, frater-nità… Tutte esigenze dell’amore reciproco, rinnovate e riscoperte ogni giorno nella cele-brazione liturgica. È vivere come un continu-um della grazia comunitaria della liturgia in qualsiasi altra espressione della vita a livel-lo comunitario: preghiera, lavoro, ricreazio-ne e programmazione apostolica, correzio-ne fraterna, comunicazione di esperienze…; è superare le tensioni inevitabili nella stessa logica della celebrazione liturgica, che met-te in rilievo l’amore sempre nuovo e gratuito di Dio e la completa donazione fino al sacri-ficio… La liturgia si converte così nella scuo-la di amore nel “sacramento della quotidia-nità”.
DAL SEGnO qUOTIDIAnO ALLA REALTà ChE BISOGnA COSTRUIRE
La tensione quotidiana tra il segno e la realtà della comunità vi è sempre. Non si può concludere una celebrazione senza arriva-re alla vita quotidiana, il che non può far di-sprezzare la celebrazione perché non riesce a raggiungere la piena realtà del segno po-sto nella liturgia. Lavoro quotidiano è passa-re dal segno alla realtà, in un costruire ogni giorno qualcosa di nuovo. Nella celebrazione esiste interazione tra i segni e l’efficacia degli stessi. L’Eucaristia non è né semplice signifi-catività di una realtà esistenze, né semplice realizzazione di una realtà a divenire. È l’in-terazione tra ciò che siamo (…) e ciò che vo-gliamo essere secondo il progetto di Dio, che esprimiamo nell’utopia della celebrazione. È un confronto tra l’adesso della nostra vita con il Regno che si rende presente nella cele-brazione.
Pertanto, la liturgia, anche a livello eccle-siale e comunitario, fa sperimentare la real-tà della chiesa e la sua natura, proiettata nel-la sua realizzazione fino alla pienezza della vita, che adesso solo parzialmente si celebra. “La liturgia… contribuisce al grado sommo a che i fedeli esprimano nella propria vita, e manifestino agli altri, il mistero di Cristo e la natura autentica della vera chiesa” (SC 2).
6 - L’EMANUELE 9/2009

Una spiritualitàcomunitariaed ecclesiale Scrive Giovanni Crisostomo: “Ogni volta che Dio ci annuncia
e ci dà il Vangelo la comunità deve prenderlo, abbracciarlo, farlo suo per lodare Dio e vivere il Vangelo a gloria di Dio Padre”. La celebrazione del mistero deve essere sempre annuncio del mistero, al punto che le parole e i gesti celebrati devono assolutamente e solamente annunciare, nella potenza dello Spirito Santo, il mistero della salvezza ed essere capaci di comunicazione, altrimenti non generano comunione e non favoriscono la testimonianza. Ogni celebrazione allora, in modo particolare l’Eucaristia, non è semplicemente un rito, è memoriale… Che brutto quando si sentono preti e laici che al termine di una celebrazione dicono: «che bella cerimonia!». Qualsiasi celebrazione non è una semplice circostanza, non è solo una data da ricordare o un ricordo che non si vuole dimenticare, è molto di più è un evento che si traduce concretamente in gesti, parole, sensazioni, bisogni… è un evento la celebrazione: è grazia. La liturgia allora diventa punto di incontro, è il luogo della comunione: io raggiungo Dio e Dio si fa vicino a me; la liturgia celebra il desiderio reciproco dell’uomo e di Dio di incontrarsi. Questo incontro avviene in un luogo, in uno spazio e in un tempo che non sono casuali e improvvisati, ma curati e preparati, e non solo con un rispetto rubricistico, ma con premura e serietà. Questo incontro avviene nell’ordinarietà della vita che si riveste nella celebrazione della straordinarietà dell’amore di Dio che continua a creare e a salvare, un amore sempre nuovo e creativo nella fedeltà. Il luogo per eccellenza di questo incontro è un luogo vitale, è il popolo di Dio, siamo noi: dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro. Lo spazio fisico è la chiesa, la casa della comunità, dove si trova l’Altare che rappresenta Cristo, quell’Altare attorno al quale ci raduniamo per celebrare il mistero della comunione e della condivisione per eccellenza di un dono che è dato per l’unità: l’Eucaristia. Louis Marie Chauvet dice che lo spazio ha un’incidenza immediata sulla comunicazione che si effettua nella celebrazione. C’è poi un tempo che non è solo quello cronologico e biologico. Tutte le celebrazioni liturgiche sono inserite in un Anno Liturgico, quello costituito dalla successione delle domeniche e delle feste, raggruppate nei tempi di Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, Ordinario. Così nell’anno liturgico, la chiesa fa memoria nella vita del mistero di Gesù, nato, morto, risorto. Nella SC al numero 102 si dice: l’anno liturgico è la celebrazione memoriale, in giorni determinati, dell’opera della salvezza compiuta da Cristo Signore. L’anno liturgico è quindi un percorso di fede e di catechesi che in modo ciclico mi annuncia l’opera di Dio e mi introduce nel mistero di Dio così come Gesù me lo ha rivelato e donato.
La ceLebrazione cristiana è sempre ceLebrazione deL mistero di dio
Parliamone!A proposito di…Riflessioni del direttore

AdorAzionee vitA evAngelicA
La forza dell’annunzio non consiste soltanto nel dire ciò che Gesù ha detto, ma nel fare
ciò che Gesù ha fatto.
di Giovanni moretti sss
ConTemPLARe L'eUCARISTIA
8 - L’EMANUELE 9/2009

AdorAzionee vitA evAngelicA
1 IL VAnGELO DELL’EUCARISTIAL’Eucaristia ci è consegnata dalla tradi-
zione, per mezzo dei riti, della Chiesa. Ogni volta che la celebriamo, rinnoviamo le paro-le di una formula liturgica, anch’essa tradi-zionale cioè ricevuta, che dice ciò che Cristo fece «la notte in cui fu tradito». Quando fac-ciamo la memoria di Cristo noi prendiamo il pane e rendiamo grazie, lo spezziamo e lo di-stribuiamo; anche con il calice noi facciamo ciò che Cristo disse e fece. Questo era il suo comando e questa è la nostra tradizione da duemila anni. È sorprendente notare come il linguaggio usato da Paolo per indicare la tra-dizione eucaristica sia praticamente lo stesso per indicare la trasmissione del Vangelo. Ec-co due testi:
«Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quel-lo che a mia volta vi ho trasmesso: il Signo-re Gesù, nella notte in cui veniva tradito, pre-se del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fa-te questo in memoria di me”. Allo stesso mo-do, dopo aver cenato, prese anche il calice, di-cendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne be-vete, in memoria di me”. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo ca-lice, voi annunziate la morte del Signore fin-ché egli venga» (1Cor 11,23-26).
«Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato… Vi ho trasmesso dunque, anzi-tutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto e risuscitato il terzo gior-no secondo le Scritture» (1Cor. 15,1-4 passim).
Questo accostamento tra l’annuncio del vangelo e quello dell’Eucaristia (1Cor 11,23 e 15,3) ci permette di parlare di «vangelo del-l’Eucaristia» e di poter dire che tutto il van-gelo si concentra nell’Eucaristia e si trasmet-te proprio nella celebrazione del mistero pa-squale di morte e risurrezione di Cristo. L’Eucaristia illumina il vangelo nella sua to-talità; ma anche il vangelo illumina l’Eucari-stia che celebriamo e mangiamo. È importan-te per il nostro tema sull’adorazione, ricor-dare e non dimenticare ciò che Gesù ha vis-suto e il modo con cui la chiesa lo ha com-preso, e tramandato nella successione delle generazioni cristiane. Come il vangelo illu-
mina l’Eucaristia, così l’Eucaristia illumina ogni aspetto del vangelo: Questo vale per la Pasqua di Gesù, ma anche per la moltiplica-zione dei pani, la preghiera, la predicazione, i miracoli di Gesù. Quando celebriamo l’Eu-caristia anche la nostra vita, il nascere e il morire, la chiamata a un particolare tipo di vocazione, il sacerdozio e l’amore degli sposi, l’attenzione ai poveri, la giustizia, il deside-rio di vivere oltre la morte; tutto è illuminato dalla parola del vangelo e l’Eucaristia man-giata è la presa di possesso da parte di Cristo della nostra vita. Non possiamo comprende-re e vivere nulla dell’Eucaristia senza il van-gelo. Anche l’adorazione eucaristica necessi-tà di questa visione unitaria. Si è spesso in-vitati a fare spazi di silenzio durante l’adora-zione davanti all’Eucaristia, ma attenti a non cadere nel tranello di pensare che l’Eucari-stia sia muta: al contrario essa parla proprio con la parola del vangelo; il nostro silenzio è necessario per imparare ad ascoltare la fre-schezza e l’attualità del vangelo che illumina la vicenda storica che stiamo vivendo.
2 L’AnnUnCIO DEL VAnGELO E LA CELEBRAzIOnE EUCARISTICA SOnO InSEPARABILILa forza dell’annunzio non consiste soltan-
to nel dire ciò che Gesù ha detto, ma nel fare ciò che Gesù ha fatto. Questa è l’identità del-la comunità cristiana: e anche i riti annun-ciano chi noi siamo: «siamo e vogliamo con-tinuare a essere il corpo di Cristo e l’eco della sua Parola», una «nuova alleanza nel suo san-gue per la storia di oggi».
Ciò che diciamo del vangelo e dell’Eucari-stia vale anche per l’adorazione. Noi sappia-mo che nel secondo millennio l’adorazione eucaristica ha in qualche modo supplito uno stile di celebrazione incomprensibile al po-polo per la lingua latina, per l’eccessiva con-centrazione dei riti nelle mani del clero, per un eccesso di rigore ascetico (es. le esigenze del digiuno), per una morale a volte così os-sessiva come al tempo del giansenismo che a volte esasperava i sensi di colpa per il pec-cato piuttosto che aprire all’amore di Dio. Questo complesso di fatti si sono spesso in-trecciati in alcuni tempi fino a tenere di fat-to i fedeli lontano dalla mensa del Signore. L’adorazione eucaristica nelle sue varie for-me di esposizione diurna e notturna, proces-sioni eucaristiche, quarantore, visite al Sa-
L’EMANUELE 9/2009 - 9

cramento nel tabernacolo, hanno permesso al popolo di vivere una certa spiritualità eu-caristica con molta libertà, di alimentare la vita di fede, di sentire la vicinanza del Signo-re anche quando certi rigori ascetici e mora-li li facevano sentire lontani dal Signore.
Indubbiamente la buona fede popolare ha introdotto mentalità e forme devozionali di-scutibili sulle quali non vogliamo soffermar-ci. Vogliamo invece richiamare in positivo il grande insegnamento del Concilio sull’im-portanza della Parola di Dio inseparabile dalla celebrazione, dell’importanza di torna-re a comunicarsi durante la celebrazione e di venerare insieme Parola e sacramento. Dice a questo proposito un importante documen-to conciliare, la “Dei Verbum”, n. 21:
«La chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dal-la mensa sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Insieme con la sacra tradizione, la chiesa le ha sempre con-siderate e le considera come la regola supre-ma della propria fede; esse infatti, ispirate da Dio e redatte una volta per sempre, comunica-no immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare, nelle parole dei profeti e degli apostoli, la voce dello Spirito santo».
E ancora ai nn 25-26: «Perciò è necessario che tutti, i chierici, in
primo luogo i sacerdoti di Cristo…, i diaconi e i catechisti… tutti i fedeli, soprattutto i religio-si, ad apprendere “la sublime scienza di Gesù Cristo” (Fil. 3,8) con la frequente lettura del-le divine scritture. “L’ignoranza delle scrittu-re, infatti, è ignoranza di Cristo”. Si accostino dunque volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia ricca di parole divine… Si ricordino però che la lettura della sacra scrit-tura deve essere accompagnata dalla preghie-ra, affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l’uomo; poiché “gli parliamo quando pre-ghiamo e lo ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini”» (n. 25).
«In tal modo, dunque, con la lettura e lo studio dei libri sacri “la parola di Dio com-pia la sua corsa e sia glorificata” (2Tess. 3,1) e… riempia sempre più il cuore degli uomini. Come dall’assidua frequenza del mistero eu-caristico si accresce la vita della chiesa, così è lecito sperare nuovo impulso di vita spiri-tuale dall’accresciuta venerazione della paro-la di Dio, che “permane in eterno”» (n. 26).
3 PERMAnEnTI In PREGhIERA DAVAnTI A CRISTO E PER GLI UOMInICome durante la celebrazione eucaristi-
ca siamo insieme, come fratelli, in ascolto del vangelo e nel mangiare alla mensa del Si-gnore risorto, anche l’adorazione eucaristica deve ricuperare questi grandi valori per al-lenarci a permanere in preghiera davanti a Cristo e in comunione con i fratelli.
L’adorazione non può chiudersi nei limi-tati orizzonti delle nostre necessità, e non si può limitare ad un semplice gesto di fe-de privato; si deve ricuperare la dimensione della comunione con i fratelli e il senso del-la missione perché è davanti a Dio Padre che ritroviamo la bellezza di sentirci tutti figli e fratelli; è davanti a Cristo che facciamo tut-ti l’esperienza di essere redenti e perdonati; è nello Spirito che insieme diventiamo secon-do la volontà di Dio partecipi della sua santi-tà. I vangeli ci fanno notare come Gesù, nel-le giornate massacranti tra le folle che lo cer-cavano per ascoltare la sua parola e essere da lui guariti, sentiva la necessità di tempi di preghiera, liberi da ogni attività umana: così leggiamo che alla sera, o di notte, o al matti-no fuggiva per pregare in luoghi isolati.
«Vi è qui una legge del nostro essere creatu-re, è l’arresto di ogni attività umana… è l’ele-mento che meglio esprime la sovranità assolu-ta di Dio sulla sua creatura, Dio ha diritto di esigere da noi alla Sua presenza, questa forma di appartenenza esclusiva, di annientamen-to, di dimissione delle nostre attività umane e transitorie: l’adorazione è questo. Per un’ani-ma che ha il senso di Dio questa cosa non of-fre dubbi; ed è nella misura in cui l’uomo per-de il senso del divino, e in conseguenza, quel-lo del suo essere di creatura, che perde anche il senso della preghiera come pura “perdita di sé” davanti a Dio. La preghiera di adorazione che è l’essenziale della preghiera, non serve a nien-te nel senso proprio del termine, e finché non si sarà attuato a fondo questo, non si saprà pregare veramente. Che utilità può derivare dalle prime tre domande del Pater? La nostra orazione deve essere ricercata in primo luogo come opera d’adorazione e d’amore totalmente gratuita. (…) L’adorazione, la preghiera non è in primo luogo un sentimento, né un pensiero, ma è il riconoscere la presa di possesso di Dio su noi stessi (…). È un atto che suppone mol-to coraggio ed abbandono di sé ad una attivi-tà del Cristo in noi…» (René Voillaume, Come loro… Ed. Paoline).
10 - L’EMANUELE 9/2009
di Gesù

di davide CarBonaro omd
I sentimenti del figlio BIBBIAiL PErcorSo DEL 2009il comandamento nuovo Gv 13,31-38
La via al Padre Gv 14,1-14
La promessa del Paraclito Gv 14,15-31
La vera vite Gv 15,1-17
il mondo vi odia Gv 15,18-27; 16,1-4
L’opera dello Spirito Gv 16,5-15
Dalla tristezza alla gioia Gv 16,16-24
La vittoria sul mondo Gv 16,25-33
La preghiera di Gesù Gv 17,1-26
La preghieradi GesùGiovanni 17,1-26

12 - L’EMANUELE 9/2009
La preghiera
di Gesù
L’Evangelista Giovanni ci consegna nel-la notte della cena pasquale (Gv 17,1-26), una lunga invocazione firmata
dall’amore (Cf. Gv 17,26), perché amore è il nome di Dio (1Gv 4,16). La preghiera non si può confondere con i sentimenti o con le emozioni, mutevoli e a volte devianti. Tutta-via, il grido dell’uomo che incontra il gemi-to dello Spirito, rende trasparenti, autenti-che le emozioni ed i sentimenti di cui l’uo-mo è intriso. L’espressione “preghiera” porta iscritta in sé la domanda, la ricerca, il desi-derio. Essa è imparentata con il termine lati-no “procura”, attraverso il quale s’identifica colui che chiede ai genitori la figlia in matri-monio. L’obiettivo della supplica per ambe-due i casi (la preghiera e la procura), è otte-nere l’unione. Così pregare è chiedere l’uni-tà con se stesso con il prossimo con Dio. La preghiera sana la frattura della solitudi-ne umana poiché apre all’altro. D’altra par-te, l’espressione “supplica”, richiama l’esse-re piegato non su se stesso, ma sull’altro tan-to da definire nelle sue accezioni, il massimo dell’unione umana e spirituale: “l’amplesso”. In effetti, le parole che tessono la preghiera di Gesù durante la cena pasquale conducono all’unità, fra il Maestro e i discepoli e sono una sintesi di tutto il discorso con il quale Gesù ha voluto rivelare ai suoi e a noi le pro-fondità dell’ intimità divina (Cf. 1Cor 2,10).
LA PREGhIERA InDIRIzzA AL PADRE:“LEVATI GLI OCChI AL CIELO” (Gv 17,1)
I primi cinque versetti offrono il movi-mento della preghiera di Gesù che gli stu-diosi definiscono “concentrico” nel suo an-damento letterario. La preghiera è rivolta al Padre come fine ultimo. La stessa moda-lità espressiva e corporea con la quale Ge-sù indirizza il suo sguardo richiama l’orien-tamento, il fine della sua preghiera e di ogni preghiera dei discepoli. In effetti, la Chie-sa nel formulare le sue invocazioni ha sem-pre tenuto presente questa struttura, indi-rizzando al Padre ogni movimento sia cor-poreo, gli occhi e le mani rivolte al cielo, sia interiore, intelligenza mente e volontà, sia verbale. Questa direzione è supportata nei primi cinque versetti di Gv 17 da tre ver-bi: il verbo “dare” e ogni dono, come anche ogni potere, proviene dall’alto (Cf. Gv 3,3.31; 19,11; Gc 1,17). Il verbo “glorificare”, anch’es-so legato all’innalzamento del Figlio dell’uo-mo, proclamazione del suo esodo (Cf. Gv
3,14; Gv 12,32.34; Eb 7,26). Infine, il verbo “portare a compimento” che implica la pie-nezza dell’amore, il suo traboccare (Cf. Gv 1,14; 15,11; 16,24), ma anche il suo fine ulti-mo (Gv 13,1). È importante notare al verset-to 2 il motivo che intreccia il dono e il pote-re di Gesù: quello sulla carne. Nel caso del Quarto evangelista questa espressione indi-ca il dono supremo che il Padre ha realizza-to nei confronti della nostra umanità invian-do il suo Figlio nella carne fragile e morta-le (Cf. Gv 1,14). Anche questo motivo dell’in-carnazione indirizza la preghiera del Figlio e dei figli che in lui chiedono il dono della vita eterna. Il gesto iniziale richiama un’al-tra preghiera di Gesù rivolta al Padre presso la tomba dell’amico Lazzaro (Cf. Gv 11,41ss). Gesù prega davanti all’ultimo limite dell’uo-mo, prega per la morte dell’amico, occasione della glorificazione del Padre; prega davan-ti alla propria morte che inaugura la gloria (Cf. Gv 12,27ss); prega davanti ai suoi amici, che dovranno affrontare la morte (15,18ss) perché non cedano all’odio del mondo che divide, ma all’unità generata dall’amore che muore per l’altro.
LA PREGhIERA PER GLI AMICI: “IO PREGO PER LORO PER qUELLI ChE TU MI hAI DATO, PERChé SOnO TUOI” (Gv 17,9)
Tra due imperativi si estende il corpo del-la preghiera di Gesù (Gv 17,6-23) che ha co-me fine il Padre e come oggetto i discepoli, i suoi amici (Gv 15,13ss): “custodiscili” (Gv 17,11) e “santificali” (Gv 17,17). La preghie-ra si muove in un ritmo che tocca il passato, il presente e il futuro. Il passato corrispon-de al memoriale, al fatto che Gesù è il ver-tice della manifestazione di Dio. L’apertu-ra del corpo della preghiera con il verbo del-la rivelazione divina “ho manifestato” (Cf. Gv 17,6 vedi anche il ritorno del risorto in Gv 21), costituisce il cuore del memoriale. Già fin dall’inizio del Prologo Giovanni ci ha detto che proprio Gesù è colui che ha svelato il Padre e solo lui possiede i termini per rac-contarlo (Cf. Gv 1,18). In effetti, lo stile del-la preghiera di Gesù evoca la struttura bibli-ca dell’alleanza e della benedizione. D’altro canto, la stessa rivelazione del nome di Dio a Mosè, lascia intravedere nel chiarore del ro-veto, la signoria divina di “Colui che era, che è che sarà” (Es 3,14; Cf anche Gv 1,17), no-me con il quale è firmato l’ultimo libro della Bibbia (Cf, Ap 1,8). Se il passato è nella me-

L’EMANUELE 9/2009 - 13
La preghiera
di Gesù
moria, il presente è nel dono, il futuro è nel dono perpetuato “in coloro che crederanno” (Gv 17,20). Nella formulazione della preghie-ra eucaristica la Chiesa ha presente questo ritmo della domanda di Gesù. Questa, rivol-ta al Padre, fa memoria e invoca nell’attesa che il Figlio ritorni. Nel corpo della preghie-ra sono evocati alcuni elementi già pronun-ciati da Gesù nel suo discorso (Gv 14-16). Il tema della gioia compiuta (Gv 17,13) richia-ma la conclusione del brano della vite (Cf. Gv 15,1-11). Il riferimento all’odio per Gesù e i discepoli (Cf. Gv 15,18) lo ritroviamo in Gv 17,14: “il mondo li odia”, tuttavia il rime-dio è il dono della parola ed il comandamen-to dell’amore reciproco che genererà l’uomo nuovo ed il mondo nuovo. Infine, la questio-ne della verità nella preghiera (Gv 17,17-19) fa eco al dono dello Spirito di verità che apre alla testimonianza (Gv 15,23-27).
LA PREGhIERA SACERDOTALE E SPOnSALE: “AffInChé SIAnO UnO COME nOI” (Gv 17,11)
Gesù articola una “preghiera sacerdota-le” ed “eucaristica”. Nel senso che unifica in sé ogni preghiera, il grido che sale dal cuo-re di ogni Adamo della storia fino all’ulti-mo uomo generato sulla terra. È eucaristi-ca nel senso che Gesù pronuncia un memo-riale di gratitudine che abbraccia il tempo, la storia, il cosmo fino a raggiungere il seno del Padre sul quale il Figlio è rivolto da sem-pre e dal quale è glorificato (Cf. Gv 1,18 Cf. anche 17,5.24). Questa preghiera sacerdota-le è anticipo e profezia del suo innalzamento sulla croce. Egli si affida al Padre e affida i discepoli di ogni tempo a lui rendendoli par-tecipi della sua Pasqua di morte e risurrezio-ne. Dal Golgota l’uomo, e l’intera creazione riconosceranno colui che non solo ha prega-to per l’unità, ma è divenuto lui stesso stru-mento di unità, catalizzatore di tutte le divi-sioni che portano il mondo alla deriva. La ri-velazione dell’amore nella notte della Pasqua la illumina, nonostante la tenebrosa figura del “figlio della perdizione” (Gv 17,12) specu-lare a quel “il mondo non ti ha conosciuto” (Gv 17,25 Cf. anche 1,10), ferita che segnala la possibilità del rifiuto dell’amore. Quanto ci consegna l’evangelista Giovanni attraver-so le parole di Gesù, tocca il vivo del nostro essere cristiani. Il nostro rapporto con Cri-sto ed il Padre, ha un carattere sacerdotale e sponsale. Nel dono supremo di Gesù, nel-la sua glorificazione noi diveniamo partecipi
della natura divina come affermerà l’aposto-lo Pietro (Cf. 2Pt 1,4). Le prime rappresen-tazioni iconografiche del crocifisso (vedi la scena della crocifissione nella Chiesa di San-ta Maria Antiqua a Roma o il Volto Santo di Lucca attribuito dalla leggenda a Nicode-mo), trasmettono questa immagine sacerdo-tale regale e sponsale. Il Cristo è elevato sul legno, rivestito della tunica sacerdotale, con i segni della gloria, trasforma il segno della maledizione umana (Cf. Gal 3,13), in altare, trono e talamo nel quale Dio si unisce per sempre alla nostra umanità.
IL fIGLIO PREGA In nOI: “PREGO AnChE PER COLORO ChE CREDERAnnO In ME MEDIAnTE LA LORO PAROLA” (Gv 17,20)
Lo sguardo orante di Gesù si concentra attraverso i suoi discepoli (Gv 17,16-19) ver-so la comunità di domani (Gv 17,20-23). La comunità del presente e del futuro si dovrà misurare sulla “parola data” da Gesù (Cf. Gv 17,14), che consegna lo Spirito e la vita (Cf Gv 6,63) che illumina (Cf. Gv 8,32), che puri-fica (Cf. Gv 15,3). Nella preghiera Gesù espri-me al Padre il suo desiderio di unità per tut-ti coloro che si fideranno e si affideranno al-la sua Parola. Nel suo desiderio si dischiude anche una promessa: “siano uno in noi” (Cf. Gv 17,21). La rivelazione ha qui il suo verti-ce. Non solo Gesù prega per noi, ma prega in noi, egli è infatti la nostra unità (Cf. Ef 2,14). Tale unità, egli stesso afferma, è garantita perché: “hanno custodito la mia parola” (Gv 17,6) ed è il tramite della fedeltà dei discepo-li di ogni tempo. L’espressione “custodire” implica sia il conservare che l’osservare. È lo sposo che conserva il vino buono fino alla fine (Cf. Gv 2,10), è l’unguento che la donna versa sul corpo di Gesù perché sia conser-vato per la sepoltura (Cf. Gv 12,7). Come il corpo di Gesù, così la sua parola, i discepoli conserveranno e osserveranno, perché a sua volta uniti in lui e tra loro siano custoditi dal mondo e dal divisore (Cf. Gv 17,11.15). Cos’è custodire la parola nel contesto del quar-to evangelo se non custodire l’amore di Ge-sù e per Gesù? In effetti, l’unità dei discepo-li non è data da compromessi o accordi, ma è alleanza, benedizione e promessa che ge-nera l’unità (Cf. Dt 6,4). Gesù glorificato dal Padre già nella notte in cui la divisione è tra i suoi discepoli, nella sua preghiera sacerdo-tale, chiede e consegna i suoi amici al Padre origine di ogni unità.

14 - L’EMANUELE 9/2009
di B artUro aieLLo, Vescovo di Teano-Calvi
CATeCheSI mISTAGoGICA
“Perdonami. Non sono uno scrittore.Non ho dimestichezza con “la parrocchia di carta” dove direttori di riviste si muovono spediti e articolisti fanno tripli salti mortali e tessono testi che sanno dell’arte del ricamo. Non so pensare da solo: sono un pastore. Posso balbettare e incespicare sotto l’occhio di Polifemo, di una telecamera o avere vertigini davanti a un foglio bianco, ma, se davanti ho un’assemblea, mi si scioglie la lingua come accadde a Zaccaria quando impose il nome al suo bambino o agli apostoli il mattino di Pentecoste…”

L’EMANUELE 9/2009 - 15
Carissimo lettore…C arissimo lettore,
uso il singolare perché non credo nelle folle oceaniche di lettori e
spettatori e, se il Manzoni uscendo fuori dal sipario dei suoi “Promessi Sposi” sente di poter colloquiare coi suoi “venticinque let-tori”, per me, fatte le debite proporzioni, ho pensato che un solo lettore fosse più che ba-stante. Ho fatto fatica a immaginarti mentre sfogliavi le pagine di questa rivista per due anni (l’annata scorsa de L’Emanuele con in copertina volti di bambini e questa che ti ha portato in casa omaggi floreali), ho immagi-nato il tuo volto, l’età, la condizione sociale ed ecclesiale, i dubbi, le speranze. Qualche volta ti ho visto sorridere o arricciare il naso davanti a ossimori o accostamenti arditi,

16 - L’EMANUELE 9/2009
altre volte ti ho spiato preso dal racconto o bisognoso di chiudere gli occhi per fare una sintesi tua e per fissare e prolungare un’emozione che ti dava il testo.
Perdonami. Non sono uno scrittore. Non ho dimestichezza con “la parrocchia di car-ta” dove direttori di riviste si muovono spe-diti e articolisti fanno tripli salti mortali e tessono testi che sanno dell’arte del ricamo. Non so pensare da solo: sono un pastore. Posso balbettare e incespicare sotto l ’oc-chio di Polifemo, di una telecamera o avere vertigini davanti a un foglio bianco, ma, se davanti ho un’assemblea, mi si scioglie la lingua come accadde a Zaccaria quando impose il nome al suo bambino o agli apo-stoli il mattino di Pentecoste. Lo scrittore vede nascere e muovere il racconto sotto il pigiare dei tasti, il teologo impenna il suo pensiero nel silenzio del suo studio mentre confronta i testi di Agostino e Tommaso, ma il pastore è muto senza un gruppo o un’assemblea cui parlare al pari di certe molecole che da sole intristiscono, ma al cospetto di altre innescano mille e mille re-azioni chimiche. Il direttore de L’Emanuele non sa il mio disagio mensile dinnanzi allo schermo bianco-latte del computer senza poter scrivere una parola, la ricerca di un volto cui parlare, quel battere delle ciglia di un ascoltatore cui chi parla è legato come il naufrago alla fune che lo salva. Per questo ho dovuto, di volta in volta, darti un volto, immaginare una reazione, intuire un calo di attenzione cui porre riparo, intravedere che una parola creava connessioni nel tuo vissuto, richiamava ricordi sepolti, apriva nuovi orizzonti. Scusami, non so fare che il pastore e non basta che ci sia un uomo e un bastone, senza le pecore un pastore precipita nel buio. Rischia di perdersi. Come Sansone coi capelli rasati mi sono trovato spesso sen-za forze. Ho capito che sono i grandi alunni che fanno grande il maestro e non viceversa.
Ed ora, dopo due anni, siamo al congedo. Ho la sensazione di aver detto poco o nulla sul grande Mistero che campeggia al centro della vita della Chiesa. L’Eucaristia quando tenti di dirla ti sfugge dalle mani. Come l ’amore. Le catechesi mistagogiche sono una spiegazione dei segni di una celebra-zione come il contenuto antropologico dei gesti dell’amore può interessare il filosofo,
il fotografo, il coreografo, ma è il ballerino che lo fa rivivere ridestando il desiderio. Ho ridestato in te il desiderio dell’Eucaristia? Me lo dirai in paradiso. Non ha risposte una catechesi scritta. Lascia l’amaro in bocca. Vorrei averti trasmesso la passione per la dolce Memoria del Pane, per la gioia d’essere Chiesa intorno all’altare, per il suono delle Sue Parole che non passeranno, per il Dolo-re e l’Amore che si abbracciano sulla Croce, per i mille gesti misurati dell’Eucaristia, per le gocce d’acqua nel vino, l’Elevazione, le genuflessioni, i segni di croce, i fiori, le to-vaglie di lino, i paramenti sacri, gli inchini, i baci, le preghiere, i canti e i silenzi. Vorrei averti trasmesso la passione per il Mistero che si fa vicino, accanto, palpabile e ti pren-de e ti porta lontano.
Una catechesi mistagogica è l’essere presi per mano e condotti per strade sconosciute, paesi misteriosi, montagne incantate. Quello che Virgilio e Beatrice fanno per Dante nel viaggio della Divina Commedia io l’ho fatto per te, con te. Ma il mistagogo non è una semplice guida turistica che ti descrive le stratificazioni di un sito archeologico o la bellezza di un capitello composito, è qualco-sa di più, somiglia piuttosto agli esploratori che Giosuè mandò in avanscoperta nella Terra Promessa e che tornarono ricchi di suggestioni, di sapori e odori da raccontare per destare il desiderio di varcare la soglia del luogo dove scorreva latte e miele. Non è un tecnico del gesto liturgico che scompo-ne gli elementi facendo emergere lo strato carolingio o medioevale di un’anafora, ma un poeta che ridesta negli esuli la nostalgia della patria perduta.
Il senso di incompiutezza che io sento e che, forse, avverti anche tu, è un richiamo a ricominciare dal principio. Ogni catechesi che si conclu-de ne apre mille altre. “Per ogni viaggio che finisce c’è sempre un nuovo viaggio da ricominciare” cantava Fran-cesco De Gregori. Mi sem-bra che l’intera vita cristiana sia un itinerario da iniziare sempre daccapo, ogni giorno, ogni domenica, in ogni inizio di anno liturgico. Lo sai bene che non è ripetizione ma, ad
Carissimo lettore…

L’EMANUELE 9/2009 - 17
ogni giro corrisponde un avvicinamento al centro come in una spirale. Ora è tempo che Virgilio scompaia e intervenga Beatrice. Si è compagni solo per un tratto di strada.
Per essere sincero appieno debbo con-fessarti, caro lettore, che tra le mille ombre con cui ho dialogato per dare forza a quanto andavo scrivendo, ti ho pensato prete alle prese con una celebrazione da preparare, da vivere, da far vivere o da verificare come alla moviola, a sera, a chiesa chiusa per scoprire i gesti deboli, quelli trainanti, le “note false” come dicono i concertisti per descrivere non una stonatura ma una nota imperfetta. Ho avuto un occhio all’assemblea, agli osser-vatori distratti, ai giovani nascosti dietro le colonne, ma è a te che ho pensato quasi di continuo, a te che presiedi la Santa Cena e forse mai sei stato iniziato all’arte del pre-siedere. A te crocifisso tra l’altare, la sede e l’ambone in un triangolo di morte e di vita e condannato (“dolce condanna”!) a ripetere i gesti del Redentore perché il Maestro possa essere presente tra i tuoi figli che sono Suoi. Lo so che i lettori de L’Emanuele sono per lo più laici e persone impegnate ad affiancare i Padri Sacramentini nell’adorazione, ma il cuore è venuto a bussare a te, prete, che forse fai fatica a vivere la celebrazione come preghiera e rischi le secche dell’abitudine e del gesto ripetuto senz’anima. Umilmente ho sentito di proporti le mie povere riflessioni in margine ai tempi e ai momenti della Mes-sa per invitarti a riprendere il gusto delle Cose sante che vanno date ai Santi. Ora la parola passa a te che da anni hai smesso di spiegare ai tuoi fedeli e a te stesso il cammi-no dell’Eucaristia e per questo vedi la chiesa vuota la domenica. Sono certo che a partire dalle mie povere sollecitazioni riuscirai a fa-
re di più e meglio provando a raccontare ai ragazzi, ai giovani, agli adulti e agli anziani ciò che di più ti sta a cuore. Perché ho esclu-so i bambini? Per due motivi: innanzitutto perché sono quelli che comprendono di più il mistero essendo naturalmente contem-plativi, e poi perché sono gli unici a cui oggi ancora, fosse solo alla vigilia della Prima Comunione, qualcuno cerca di spiegare i segni della celebrazione eucaristica. Lo so, mio caro Don, che tu saresti stato più bravo a scrivere delle catechesi mistagogiche sulla Messa, più preciso nei termini teologici, più avvincente, più creativo nel far corrispon-dere il rito santo con i mille rituali della vita. È per questo che ho scritto: suscitare i mille carismi che hai e che muoiono sotto la coltre di abitudini inveterate facendoti ingranare la quinta alla Preghiera Eucari-stica o ritenere che “preparare un’omelia è inutile tanto…”. Sì, caro lettore, è tempo che tu riprenda a spiegare la Messa perché la ri-forma della Chiesa passa sempre attraverso un ritrovato senso dell’Eucaristia. Il resto è accademia. Perdona la mia pedanteria e af-frettati a fare meglio.
Per te, per me e per chi segretamente avesse intercettato questo nostro dialogo a distanza utilizzo a commiato le parole di Sant’Agostino a chiusura di una delle sue vo-luminose opere che corrispondevano anche a cicli di catechesi e di predicazione per i suoi fedeli: “Ecco che io sto per deporre que-sto libro e voi per tornarvene ciascuno a casa sua. Ci siamo trovati assai bene sotto questa luce comune, ne abbiamo davvero gioito, ne abbiamo davvero esultato: ma, mentre ci separiamo gli uni dagli altri, badiamo bene a non allontanarci da Lui”.
Carissimo lettore…
Gesù disse: “Fate questo in memoria di me”L ’Eucaristia è…

Una vita spesa tra le case di Maria
tratti della spiritualità di San Giovanni Leonardi(1541-1609)
nel iV centenario dalla morte
di davide CarBonaro omd
TeSTImonI

“Vi ho offerti alla Regina degli An-geli ovunque voi andrete ella sarà vostro rifugio e protezione”. Con
queste parole ci viene trasmessa dai primi biografi di San Giovanni Leonardi una sor-ta di istantanea della fondazione dei Chierici Regolari della Madre di Dio avvenuta a Luc-ca nel piccolo Oratorio di Santa Maria della Rosa il 1 settembre 1574. Più tardi P. Ippoli-to Marracci, scrittore mariano tra i figli più illustri del Santo lucchese, scriverà: “pose la Vergine Maria tra le fondamenta della sua istituzione”. E ancora additando in una sua lettera ai religiosi la spiritualità mariana del Leonardi, riferiva come la preghiera dell’An-gelus era tra le preferite del Santo e che la memoria dell’Incarnazione sovente accarez-zava la mente ed il cuore. Tra le giaculatorie che il Leonardi amava ripetere vi era quel-la che, alludendo alle parole del Cantico dei Cantici (1,3), affermava il desiderio profondo della sequela di Cristo partendo dal discepo-lato di Maria: “Attirami a te o Madre Santa”. Si può dire da questi brevi tratti, che la Ver-gine Maria fu la vera dimora del Leonardi, il luogo dove egli sperimentò l’indissolubile primato di Cristo nella sua esistenza e l’ap-passionato amore alla Chiesa immacolata e ferita. Se egli amava ripetere ai suoi religio-si, “abbiate Cristo avanti agli occhi della vo-stra mente e con lui misurate le cose” era al-la “scuola” di Maria che egli aveva appreso a meditare tutte queste cose nella profondità del cuore (Lc 2,51). Giovanni Leonardi fon-datore dell’Ordine della Madre di Dio, Fon-datore del Santuario dell’Arco, Confonda-tore di Propaganda Fide e Patrono dei Far-macisti, nasce nel 1541 in provincia di Luc-ca, a Diecimo, ridente borgo medievale nel-la mediavalle del Serchio. Nel 1558 si trasfe-risce a Lucca per apprendere l’arte dello spe-ziale e si stabilisce presso un noto farmaci-sta dal quale lavorerà per dieci anni. In cit-tà vanno diffondendosi le idee protestanti in conseguenza degli intensi scambi commer-ciali che i lucchesi hanno con i paesi d’oltral-pe. Giovanni frequenta i padri domenicani e da loro mutua l’esigenza di un forte rinnova-mento della Chiesa. Alla morte del padre egli lascia la professione di speziale e si accinge agli studi di teologia per divenire sacerdote. Viene ordinato il 22 dicembre del 1571. Ini-zia la sua attività pastorale tra i bambini e i
giovani prendendosi cura di insegnare loro il catechismo, convinto che essi rappresen-tano l’inizio del rinnovamento nella Chiesa e nella società. Nel 1574, il 1 settembre, Padre Giovanni con il primo nucleo di giovani che si sono raccolti intorno a lui, fonda l’Ordi-ne dei Chierici Regolari della Madre di Dio. Gli inizi non sono facili per la nuova comu-nità religiosa, così rigorosa e radicale nella pratica evangelica. Nel 1587 padre Leonar-di lascia Lucca, costretto all’esilio per cin-que anni. Si reca a Roma dove viene accolto da san Filippo Neri che gli sarà grande ami-co e protettore. Lo presenta al Papa Clemen-te VIII che ha modo di conoscere la grandez-za del sacerdote lucchese e gli affida impor-tanti incarichi quale Visitatore e Commissa-rio apostolico, a Madonna Dell’Arco, Aversa e Montevergine, per attuare la riforma del-la Chiesa, avviata dal Concilio di Trento. Do-po il periodo trascorso a Napoli e in Campa-nia come fecondo apostolo di rinnovamen-to ecclesiale, torna a Roma; nel 1601 gli vie-ne affidata la chiesa di Santa Maria in Por-tico. Negli ultimi anni di vita si adopra in-stancabilmente per attuare il rinnovamen-to ecclesiale; nel 1608 formula il progetto per una nuova congregazione missionaria, che diverrà poi il Collegio di Propaganda Fide. Giovanni Leonardi muore a Roma il 9 otto-bre 1609. È dichiarato Santo da Pio XI nella Pasqua del 1938. Una vita spesa “tra le Case di Maria”. Se da una parte il Leonardi pose la sua dimora in colei che aveva offerto nel grembo immacolato una tenda all’Altissimo, l’esistenza del nostro Santo non solo fu trac-ciato dalla presenza di Maria, ma egli come l’Apostolo Giovanni la prese tra le sue real-tà più care (Cf. Gv 19,27). Fin dalla sua gio-vinezza nel piccolo borgo di Diecimo e nel-la vicina frazione di Villa Basilica nel silen-zio delle antiche pievi dedicate all’Assunta, elesse Maria quale custode della sua castità e la volle come sua celeste Patrona e più tar-di dell’Ordine. Da giovane prete percepì che le istituzioni alle quali lo Spirito dava corpo, erano riflesso di quel si incondizionato che Maria pronunziò per la salvezza dell’uma-nità. In effetti, la prima regola che egli indi-cò ai primi compagni fu l’obbedienza, la ca-pacità di porre mente e cuore alla volontà di Dio servendolo in modo radicale. Quasi a vo-ler confermare questo suo desiderio di pren-
Una vita spesa tra le case di Maria
L’EMANUELE 9/2009 - 19

tra le case di Maria
Una vita spesa
I
dere dimora presso la Vergine e di costru-irgli una casa in mezzo agli uomini, si fece pellegrino insieme ai primi compagni presso il Santuario di Loreto custode delle povere mura nelle quali dimorò il Verbo fatto car-ne. La spiritualità lauretana ed il pellegri-naggio, segnarono la devozione dei primi pa-dri che, non solo produssero una abbondan-te letteratura mariana (vedi il pellegrinag-gio a Loreto del Venerabile Cesare Franciot-ti), ma nella Chiesa di Santa Maria Corteor-landini, Casa Madre dell’Ordine a Lucca, nel XVII secolo i religiosi leonardini vollero viva questa memoria spirituale del Fondatore con una riproduzione della dimora lauretana. Il tempo dell’esilio del Santo occupa una gran-de parentesi della sua esistenza. Questo è il tempo della fedeltà vissuta. Nella “spiritua-lità dello sguardo” che il Leonardi trasmet-te in alcune omelie giovanili, possiamo indi-viduare i tratti del suo travaglio intimo: “A te i miei occhi conquistati da te”. Se l’iconogra-fia (ma anche il ricordo dei primi compagni) ci consegna una immagine del Santo con gli occhi bassi e profondamente riservato; nei suoi scritti, la teologia dell’occhio spiritua-le, si può dire che trasmette un’altra icono-grafia, quella della osservazione interiore ca-pace di leggere gli accadimenti, anche quelli dolorosi, con una visione superiore delle co-se. È nel “patto degli occhi” con il Figlio del-la Vergine, il Crocifisso-Risorto che il San-to ora può guardare la Chiesa bella e feri-ta. Una Chiesa da riformare nel capo e nel-le membra. Una Chiesa da rifare guardando a Maria colei che “Stava più vicina alla Croce perché era anco più vicina a’ suoi dolori; anzi era in Croce col Figlio perché l’anima è più do-ve ama che dove anima”. Questo amore cro-cifisso, animò i passi del Santo riformato-re. Tra i suoi primi incarichi, portare la pa-ce intorno alla memoria mariana dell’Arco a Sant’Anastasia. Nel nome di Maria non ci si può dividere. Così la piccola edicola maria-na più volte ferita dall’insensatezza degli uo-mini, diventa icona della Chiesa ferita, per la quale il Leonardi fu chiamato a spendere le sue fatiche apostoliche. Il farmacista-prete non fondò solo un santuario, costruì una di-mora per quanti desiderano guarire nel pro-fondo i mali del corpo e dello spirito. Instan-cabile il Santo ricevette dal Papa Clemente VIII il mandato di visitare un’altra Casa di Maria, il secolare santuario della Madonna di Montevergine ad Avellino. Intorno a que-
sto luogo si era irradiato il dono della vita consacrata sotto la Regola di Benedetto.
Ma quando i beni della terra attirano alla terra e allontanano il cuore dall’ascendere verso i beni celesti, la consacrazione religio-sa perde il suo mordente. A Montevergine il Leonardi offrì una “nuova dimora” ai figli di Maria, i Virginiani, ad essi consegnò il primato del Vangelo di Gesù, invitandoli a spogliarsi di ciò che impedisce l’ascesa verso Cristo e a “risplendere come luci evangeliche poste su un alto monte”. Anche per i suoi figli il Leonardi volle una Casa di Maria a Roma. Il Papa gli affidò l’antico santuario mariano sulle rive del Tevere dedicato a “Maria porto della romana sicurezza”. Da quel Porto il Santo desiderò salpare per le nuove terre, ma questa fu l’ultima Casa di Maria che egli abitò. Le sue parole nella not-te del beato transito di quattrocento anni fa furono ancora dedicate allo sguardo: “se tu vedessi!”. Non ci è dato sapere il contenuto della visione, il nostro sguardo contempla oggi nella fragilità delle reliquie, testimoni silenziosi della resurrezione futura, la san-tità di Giovanni Leonardi “affascinate uomo di Dio”, costruttore di vita evangelica. La nostra “misura” è Cristo. Con questa indi-cazione magisteriale, il Papa Benedetto XVI nell’udienza Generale del 7 ottobre 2009, in occasione delle celebrazioni conclusive del IV centenario, ha voluto indicare nel Leo-nardi una figura-simbolo, non solo in rife-rimento alla sua santità di vita, ma anche alla luce del suo impegno sul piano sociale e culturale. Benedetto XVI ha infatti afferma-to: “In quegli anni, nel passaggio culturale e sociale tra il secolo XVI e il secolo XVII, co-minciarono a delinearsi le premesse della fu-tura cultura contemporanea, caratterizzata da una indebita scissione tra fede e ragione, che ha prodotto tra i suoi effetti negativi la marginalizzazione di Dio, con l’illusione di una possibile e totale autonomia dell’uomo il quale sceglie di vivere «come se Dio non ci fosse». È la crisi del pensiero moderno, che più volte ho avuto modo di evidenziare e che approda spesso in forme di relativismo. Giovanni Leonardi intuì quale fosse la vera medicina per questi mali spirituali e la sinte-tizzò nell’espressione: «Cristo innanzitutto», Cristo al centro del cuore, al centro della sto-ria e del cosmo. E di Cristo – affermava con forza – l’umanità ha estremo bisogno, perché Lui è la nostra «misura».
20 - L’EMANUELE 9/2009

tra le case di Maria
IL’EMANUELE 9/2009 - 21
1 GEnnaioMaria Madre di Dio
«Gli fu messo nome Gesù…»
In quel tempo, i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E, dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima di essere concepito nel grembo della madre.
DAL VAnGELO SECOnDO LUCA 2,16-21
Prima letturaNumeri 6,22-27
Il Signore indica al suo popolo le parole con le quali invocarlo per ottenere la sua benedizione. Affidandosi interamente a lui, essi potranno avere la vera pace.
Seconda letturaGalati 4,4-7
L’invio nel mondo di Cristo, nato da donna, porta il tempo al suo compimento e chiude la lunga attesa messianica. Egli è venuto per donarci la salvezza, ossia: riscattarci dalla legge antica e renderci veri figli di Dio.
VangeloLuca 2,16-21
I pastori che vanno a visitare Gesù raccontano ai presenti e a Maria quanto Dio ha rive-lato loro. Otto giorni dopo la nascita, Gesù viene circonciso e riceve un nome che esprime il suo compito: donare a tutti la salvezza di Dio.
Inizia un nuovo anno civile: il 2010! E la Chiesa, all’inizio di questo nuovo anno, ci in-vita a contemplare il dono di Maria, Madre di Dio, celebrando il mistero attraverso il quale una donna ha generato il Figlio di Dio. Sì, perché Maria non ha generato un uomo che suc-cessivamente è stato accettato da Dio come Figlio, ma ha generato Dio stesso. Oggi, a con-clusione dell’Ottava di Natale, dopo aver fissato lo sguardo sul Figlio che ci è stato “donato”, la Chiesa ci invita a rivolgere la mente e il cuore alla Madre di Gesù: a guardare con stupore il miracolo che si rinnova in ogni nascita e che qui, ora, sa mettere al centro i due protagoni-sti del Natale: il Figlio, Gesù, e la Madre, Maria. È il testo evangelico che ci introduce nella delicatezza di questo stupore, narrando la visita dei pastori alla grotta di Betlemme. Dopo l’annuncio dell’Angelo i pastori “andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro”. I pastori di Betlemme sono di esempio per come bene iniziare il nuovo an-no. Lo sguardo di Dio si posa su di loro: la notte li ha riempiti di luce e la loro vita ha trovato un senso. Tutta la vita del cristiano è racchiusa in questa semplice scena di pastori, posta, non a caso, all’inizio di questo nuovo anno perché illumini i nostri passi nei giorni che ver-ranno. “I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano
Jacopo bassano «Adorazione dei pastori»1590-91, San Giorgio maggiore, Venezia

I
udito e visto, com’era stato detto loro”. Come quei pastori i quali, una volta usciti dalla grot-ta, se ne tornarono glorificando e lodando Dio, così anche i credenti, con la stessa energia e lo stesso slancio, lasciandosi un anno di vita alle spalle entrano nel nuovo avendo Gesù tra le braccia per amarLo e per mostrarLo al mondo. Quale consolazione sarebbe se qualcuno po-tesse continuare a scrivere dei cristiani quel che l’evangelista nota per i pastori: “Tutti quelli che udirono, si stupivano delle cose che essi dicevano”! È sempre affascinante contemplare la tenerezza della Madre, che avvolge e cura il Figlio, insieme “suo” ed “altro” da sé. Che con-templa il frutto della propria paziente attesa e del proprio travaglio. E che, insieme, non può smettere di stupirsi della vita che nasce da sé e della novità che fiorisce dal proprio grembo. È il mistero della maternità. È la bellezza della vita che nasce: della vita che è donata, ma che, insieme, è ricevuta come un dono. La bellezza, soprattutto, di poter dare un nome alla vita che nasce da sé: di poter amare il figlio che nasce, di poter costruire con lui una relazio-ne, di potersi, anche, fidare di lui, di potersi affidare a lui. Tanto più se la Madre è Maria e il Figlio Gesù…
MARIA, REGInA DELLA PACELa festa di Maria, Madre di Dio, cade proprio all’inizio del nuovo anno civile e in occa-
sione della “giornata mondiale della pace”, che già dal 1968 il Papa Paolo VI ha fissato per questa data, quasi come un augurio di gioia e di fraternità per tutti i giorni che ci stanno, ancora intatti, davanti: la luce di Maria, che noi invochiamo come “Regina della Pace”, può e deve riempirli con tutta la ricchezza di amore che essa ha riversato nel mondo dandoci Cristo “nostra pace”. È ormai consolidata tradizione che il primo giorno dell’anno la Chiesa si riunisca in preghiera per invocare la pace. È per dire che i primi passi dell’anno vogliamo che siano passi di pace. Erano i passi dei primi pastori. Siano perciò anche i passi di ogni discepolo di Gesù e di ogni uomo di buona volontà. La pace, richiede l’impegno tenace degli uomini. È un dono che viene dall’alto ed è un frutto dello Spirito l’amore che opera nel cuore degli uomini. Per questo la preghiera d’inizio di questo nuovo tempo è l’antico augurio degli angeli: “…Gloria a Dio in cielo …e pace in terra agli uomini che Dio ama”. Tutti aspiriamo a vivere nella pace. Ma la pace vera, quella annunciata dagli Angeli nella notte di Natale, non è semplice conquista dell’uomo o frutto di accordi politici; è prima di tutto dono di Dio che viene dall’alto.
p. Giampietro Polini sss
Noi ti supplichiamo, o Madre santa,di volgere lo sguardo misericordiosoa questo mondo inquieto a te consacrato,perché ogni uomo si consideri figlioe concorra ad operare,mediante il tuo amore e il tuo esempio,la propria Redenzioneaprendo il cuore a Cristo. Insegnaci, o Maria, a vivere e a testimoniare il Vangelo. Amen.
La grande tradizione liturgica della Chiesa ci insegna che, per una fruttuosa partecipazio-ne, è necessario impegnarsi a corrispondere personalmente al mistero che viene celebra-to, mediante l’offerta a Dio della propria vita, in unità con il sacrificio di Cristo per la salvez-za del mondo intero. Se questa mancasse, le nostre celebrazioni, per quanto animate, rischierebbero la deriva del ritualismo. Pertan-to occorre promuovere un’educazione alla fede eucaristica che disponga i fedeli a vive-re personalmente quanto viene celebrato.
Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis 64
PREG
HIA
MO
22 - L’EMANUELE 9/2009

IL’EMANUELE 9/2009 - 23
«in principio era il verbo…»
3 GEnnaio
DAL VAnGELO SECOnDO GIOVAnnI 1,1-18
2a Domenica dopo Natale
Prima letturaSiracide 24,1-4.8-12
La Sapienza viene descritta come una persona unita a Dio e, al tempo stesso, distinta da Lui. Essa, originata prima dei secoli, è il segno della presenza di Dio nel mondo.
Seconda letturaEfesini 1,3-6.15-18
La sapienza di Dio può essere donata all’uomo attraverso lo Spirito. Per questo, san Paolo chiede a Dio di effondere sui cristiani lo spirito di sapienza, affinché essi possano vivere in conformità con il suo progetto di salvezza.
VangeloGiovanni 1,1-18
Il bambino nato a Betlemme è il Verbo di Dio che si è fatto uomo. Egli, da sempre esistente in Dio, è venuto sulla terra per rivelarci la nostra condizione di figli di Dio, donandoci in pienez-za la sua grazia e la sua verità.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta.Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. (forma breve)
Il vangelo di questa Domenica è lo stesso che viene proclamato a Natale, nella Messa del giorno. La Liturgia non fa altro che riprendere i grandi temi già proclamati nelle festività trascorse e approfondirli, riproponendoli alla nostra attenzione. Questo brano del vangelo di Giovanni è di una profondità grandissima. Giovanni non ci offre il racconto semplice della nascita di Gesù, come fanno ad es. Matteo e Luca che tuttavia sottolineano lo stupore susci-tato dall’evento e la sua grandezza. Giovanni in fondo invita ognuno di noi a chiedersi: chi è questo bambino che è nato per noi? Chi abbiamo visto a Betlemme nella povertà di una grotta? Chi è apparso in mezzo a noi nella debolezza di un neonato che ha bisogno di tutto?
Enguerrand Charonton, «Incoronazione della Vergine»
(dettaglio: Gesù) 1453-54musée de l’Hospice, Villeneuve-les-Avignon

I
Egli vorrebbe dirci: “Non fermatevi alle apparenze”. Quel bambino è il “Verbo” di Dio, è cioè la stessa Parola di Dio, quella attraverso la quale Dio all’inizio ha creato tutto l’universo, che si è fatta uomo. Questa Parola è una “persona”, la persona del Figlio di Dio, che esiste da sempre, è eterna come lo è appunto Dio, ma che in un momento ben preciso è entrata nella storia umana nella maniera più concreta e forte possibile: ha preso la nostra stessa natura, ha “posto la sua tenda”, la sua abitazione in mezzo a noi. In questo Prologo è possibile vede-re la grande condiscendenza di Dio: non è stato l’uomo a innalzarsi, a doversi sforzare per arrivare a Dio (cosa che sarebbe stata ed è comunque impossibile), ma è stato Dio a “discen-dere”, a venire incontro a noi poveri e bisognosi di salvezza. Tutto ciò Dio lo ha fatto perché credessimo al suo amore, perché potessimo incontrarlo, “vederlo”.
Infatti, dice Giovanni, Dio nessuno lo ha mai visto, ma in Gesù Cristo ne abbiamo un’im-magine viva. Egli ce lo rivela, ce lo fa conoscere perfettamente, per quanto è possibile a noi creature umane e in una maniera adatta a noi. Dio non ci ha schiacciato col peso della sua divinità, ma in Gesù si è fatto vicino attraverso segni umili e poveri, con un amore divino e umano insieme: e ciò affinché noi potessimo accoglierlo, aprire il nostro cuore alla sua ma-nifestazione, lasciarlo entrare veramente nella nostra vita. Ma tutto ciò non è scontato. Gio-vanni lo sottolinea fortemente: “…le tenebre non l’hanno accolta (la luce)”, “…il mondo non lo riconobbe”, “…i suoi non l’hanno accolto”. Tutto questo perché è grande il mistero della nostra libertà: possiamo rifiutare Dio, possiamo rifiutare il suo amore, sebbene Dio in per-sona sia venuto a dircelo. Giovanni usa un’immagine forte, quella della luce: Gesù è la luce del mondo; accogliendo lui, noi uomini possiamo essere guariti dalla nostra cecità e vedere il cammino da percorrere, il cammino che porta alla vera vita e alla gioia.
Anche oggi, spesso, l’uomo preferisce restare nelle tenebre, perché non vuole che le sue opere cattive siano smascherate, siano messe in luce, perché non vuole cambiare vita. Infatti accogliere Gesù, la “Parola” di Dio, significa essere disposti ad entrare nel Regno di Dio, che è costruito su una logica totalmente diversa da quella del mondo. Certo Gesù, come Parola di Dio, è parola che ha un senso pieno, è tutto parola ed è parola di tutto.
p. Luca Zanchi sss
Signore Gesù, che cammini sulla nostra terra e soffri le nostre povertà per annunciare il comandamento della carità, infondi in noi il tuo Spirito d’amore che apra i nostri occhi,per riconoscere in ogni uomoun fratello:e finalmente diventi quotidianoil gesto semplice e generosoche offre aiuto e sorriso,cura e attenzione al fratello che soffre,perché in questo Natale non facciamo festa da soli.Amen.
Carlo Maria MartiniPREG
HIA
MO
24 - L’EMANUELE 9/2009
In particolare, per la relazione tra ars ce-lebrandi e actuosa participatio si deve innanzitutto affermare che «la migliore ca-techesi sull’Eucaristia è la stessa Eucaristia ben celebrata». Per natura sua, infatti, la liturgia ha una sua efficacia pedagogi-ca nell’introdurre i fedeli alla conoscenza del mistero celebrato. Proprio per questo, nella tradizione più antica della Chiesa il cammino formativo del cristiano, pur sen-za trascurare l’intelligenza sistematica dei contenuti della fede, assumeva sempre un carattere esperienziale in cui determinante era l’incontro vivo e persuasivo con Cristo annunciato da autentici testimoni.
Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis 64

II Magi: cercatori di Dio. I magi sono dunque questi cercatori di Dio; sono immagine di quella grande famiglia umana che nonostante tutto ha il volto e lo sguardo rivolto ver-so l’alto; sono uomini fragili e coraggiosi il cui cammino è fatto di incertezze e di errori. Si mettono in cammino, giungono nella città sbagliata, perdono di vista la stella, parlano del Bambino con l’uccisore dei bambini, cercano un Re e trovano un Dio – Pastore! I magi: uomini pazienti e premurosi, pronti sempre “…a fissare gli abissi del cielo fino a bruciarsi gli occhi del cuore…” (David M. Turoldo).
La ricerca di Dio inizia accettando di fare un cammino, lasciandosi guidare dalla luce della stella e poi dalle parole della Scrittura, lette docilmente e intelligentemente e custodite
L’EMANUELE 9/2009 - 25
6 GEnnaioEpifania del Signore
«dov’è il re dei Giudei che è nato?»
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la
sua stella, e siamo venuti per adorarlo».(...) Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella – che avevano visto nel suo sorgere – li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi, aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. (forma breve)
DAL VAnGELO SECOnDO MATTEO 2,1-12
Prima letturaIsaia 60,1-6
Dopo l’esilio, Gerusalemme diviene luce per il popolo di Israele e per tutte le genti, poiché in essa abita di nuovo il Signore potente e glorioso. È Lui che unifica tutti i popoli e li attira a sé, per donare loro la sua salvezza.
Seconda letturaEfesini 3,2-6
Il mistero, cioè il progetto di Dio che Cristo ci ha rivelato, è que-sto: alla salvezza sono chiamati non solo gli ebrei ma anche i pagani. Essi, ora, formano con i Giudei un solo popolo nuovo, che è la Chiesa.
Vangelo Matteo 2,1-12
La profezia di Isaia trova com-pimento nell’episodio dei Magi, simbolo dei pagani che, attratti dalla luce di Gesù-Re, vanno a Lui per adorarlo. Essi, però, lo troveranno non a Gerusalemme ma a Betlemme, piccola città di Davide.
Federico Fiori barocci«Adorazione dei magi»i, 1561-63
Rijksmuseum, Amsterdam

N
amorosamente. I Magi questo hanno capito. La Parola di Dio, che pareva loro essersi spen-ta, ha orientato il loro cammino e gli ha conferito nuovo vigore. E li ha portati a Colui che, come bimbo di Maria, non si è loro imposto, ma ha atteso di essere riconosciuto e adorato: “naufraghi sempre in questo infinito, eppure sempre a tentare, a chiedere, dietro la stella che appare e dispare, lungo un cammino che è sempre imprevisto. Magi, voi siete i santi più nostri, i pellegrini del cielo, gli eletti, l’anima eterna dell’uomo che cerca, cui solo Iddio è lu-ce e mistero”.
I Magi: adoratori di Dio. I magi sono anche adoratori stupiti e meravigliati del Dio na-scosto e invisibile, rapiti essi stessi all’Amore delle realtà invisibili. Adoratori gioiosi, mossi e guidati dalla stella luminosa della Parola di Dio. È forse questo il messaggio e la lezione misteriosa dell’Epifania: adorare un Bambino! I sapienti d’Oriente si fanno piccoli e poveri davanti alla Sapienza venuta da Altrove. Nei Magi venuti da lontano, la Chiesa ammira e contempla la disponibilità di tutti coloro che si sentono chiamati a scoprire un segreto affa-scinante.
Adorare. Si, perché l’adorazione è l’espressione spontanea di chi si sente colpito dalla vicinanza di Dio; l’adorazione è lo stupore di chi è sconvolto da una luce troppo intensa; l’adorazione è silenzio, gioia intima, pace profonda, tipica di chi sa vivere di fronte agli altri in modo riservato e distaccato, perché sfiorato e avvicinato da ciò che più conta nel cammi-no della fede: la Presenza di Dio, il suo Mistero che trafigge. L’adoratore è uno che ha il co-raggio di fare ogni giorno il vuoto di se stesso, offrendo sempre il meglio che possiede: oro, incenso e mirra.
I Magi: sorpresi dal Dono offrono i loro doni. Quando i Magi giungono alla meta, sorpresi e meravigliati dal Dono che Dio fa loro, con gioia grande offrono i loro doni: oro, incenso e mirra. Sono il dono di sé, l’oro del loro amore; l’incenso della loro stima e della loro adorazione; la mirra della tristezza e della loro sofferenza, perché venga superata e tra-sformata. E che cosa ricevono in cambio? Cristo è la risposta al desiderio profondo di ogni uomo, il dono perfetto oltre il quale nulla si può desiderare.
p. Giampietro Polini sss
26 - L’EMANUELE 9/2009
Lo splendore della tua gloria, o Dio, illumini i cuori perché, camminando nella notte del mondo, alla fine possiamo arrivare alla tua dimora di luce. Donaci l’esperienza viva del Signore Gesù che si è rivelato alla silenziosa meditazione dei Magi e all’adorazione di tutte le genti; e fa’ che tutti gli uomini trovino verità e salvezza nell’incontro illuminante con lui, nostro Signore e nostro Dio. Amen.
Un segnale convincente dell’efficacia che
la catechesi eucaristica ha sui fedeli è si-
curamente la crescita in loro del senso del
mistero di Dio presente tra noi. Ciò può
essere verificato attraverso specifiche ma-
nifestazioni di riverenza verso l’Eucaristia, a
cui il percorso mistagogico deve introdurre
i fedeli. Penso, in senso generale, all’impor-
tanza dei gesti e della postura, come l’ingi-
nocchiarsi durante i momenti salienti della
preghiera eucaristica. Nell’adeguarsi alla
legittima diversità di segni che si compiono
nel contesto delle differenti culture, ciascu-
no viva ed esprima la consapevolezza di
trovarsi in ogni celebrazione davanti alla
maestà infinita di Dio, che ci raggiunge in
modo umile nei segni sacramentali.
Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis 65PREG
HIA
MO

NNel tempo della gioia e dello stupore per la bontà e la verità di Dio che si è fatta storia ancora una volta in Gesù, lo Spirito Santo giunge ad attestare in modo solenne la divinità di Gesù: Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Ciò accade in un momento in cui Gesù, come un uomo qualsiasi, compie il gesto penitenziale di sottoporsi al battesimo di Giovanni, manifestando così la sua solidarietà con i peccatori. Con la celebrazione odierna, la Chiesa ci invita a rituffarci nel nostro battesimo per riscoprire il significato e il senso del grande dono che porta con sé questo sacramento: diventare figli di Dio, cancellare l’impron-ta del peccato ed entrare nella vita nuova. Riscoprire come il Signore ci ha lavato mediante un lavacro di rigenerazione nello Spirito Santo; risentire chiara e limpida la voce di Dio,
L’EMANUELE 9/2009 - 27
10 GEnnaioDomenica del Battesimo
« tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto»
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno
che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto»
DAL VAnGELO SECOnDO LUCA 3,15-16.21-22
Prima letturaIsaia 40,1-5.9-11
Isaia profetizza che il Signore si rivelerà in tutta la sua gloria, e ogni uomo la vedrà. Dio, infatti, verrà in mezzo agli uo-mini come un ‘pastore potente’: benevolo nei rapporti con le persone, ma forte nella lotta contro il male e il peccato.
Seconda letturaTito 2,11-14; 3,4-7
Dio ha mandato Gesù nel mondo per renderci tutti suoi figli, rigenerandoci mediante il battesimo nello Spirito. Di conseguenza, siamo chiamati ad una vita nuova: rinunciare al male e vivere nella giustizia e nella carità.
VangeloLuca 3,15-16.21-22
Su Gesù, battezzato e in pre-ghiera, discende lo Spirito Santo, che lo consacra alla sua missio-ne e lo rivela a tutti i presenti come Figlio di Dio. Attraverso di lui, ogni uomo potrà ricevere la salvezza e diventare figlio di Dio, purificato e rinnovato con il fuoco dello Spirito.
Annibale Carracci «battesimo di Gesù»1584, San Gregorio, bologna

L
che anche a noi dice: Tu sei mio figlio. Come battezzati siamo quindi chiamati a rigenerarci continuamente, lasciando che sia lo Spirito di Cristo a generare in noi la forza, il coraggio e la costanza non solo nel dirci ma nell’essere cristiani. Essere – cioè – uomini di luce, di spe-ranza, di gioia; per sconfiggere con lo Spirito di forza che ci è stato donato le bufere dell’in-credulità, della paura, della tristezza, e avere invece un volto e un cuore radiosi e splendenti. Rituffarci nel nostro battesimo vuol dire non limitare il nostro battesimo ad un rito, ad una data, o a una festa che ci ricorda il dono della vera vita. Significa, invece, sentire che lo Spi-rito che ci è stato donato in quel giorno non è scivolato via come l’acqua, ma è presente oggi più che mai per riaccendere il fuoco dell’amore e del grazie, che con la vita vogliamo innal-zare a Dio perché Egli continua a rivolgersi a noi, dicendo: Tu sei mio figlio.
Facciamo risuonare come una litania di riconoscenza nel nostro cuore le parole del sal-mo: Benedetto il Signore che dona la vita! Benedetto il Signore che dona la vita a me ogni volta che, donandomi il suo Spirito, mi aiuta a non lasciarmi vincere dal peccato, ma mi sostiene con il dono della sua grazia, costante e generosa. Seguire Cristo, infatti, significa intraprendere un cammino di umiltà, di verità, di luce, dietro a Lui che ci insegna la verità del nostro essere.
Noi, feriti dal peccato, purificati nel battesimo, sempre oscillanti fra la scelta del bene e del male, della santità e del peccato, possiamo scegliere Dio e il suo amore o, viceversa, rifiu-tarlo. Seguire le orme di Gesù è impegnarsi a camminare su una strada che, nonostante sia stretta e sassosa, conduce alla vita eterna, conduce a sentire la voce di Dio: Tu sei mio figlio.
Il Gesù del vangelo che – in preghiera – viene battezzato da Giovanni, ci aiuta a capire quello che le antiche Scritture ci insegnano: il battesimo è fuoco che brucia il male radicale dell’uomo; è, come diceva il profeta Malachia (3,2-3), fuoco del fonditore e lisciva dei lavan-dai; è acqua che purifica. Ma il battesimo cristiano è soprattutto presenza di Dio nell’uomo, è Spirito vivificatore che produce la nuova vita. Bellissime le parole del profeta Ezechiele, il quale dice che l’acqua non è solo principio di purificazione, ma di fecondità e vita, di ri-cre-azione e trasformazione: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati… vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno Spirito nuovo (36,25-26).
p. Luca Zanchi sss
28 - L’EMANUELE 9/2009
Ti ringrazio perché, con l’acqua battesimale, mi hai fatto risorgere con Cristo e hai riempito la mia anima dello splendore della tua grazia. Voglio rinnovare in questo momentole mie promesse battesimali, con cui mi sono impegnato a vivere nella santità dei figli di Dio. Conserva in me la fede, la speranza e la carità, e concedimi di essere fedele alla tua legge per tutta la vita.
Già Agostino aveva detto: «nemo au-tem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adorando – Nessuno mangia questa carne senza prima adorarla; peccheremmo se non la adorassimo». Nell’Eucaristia, infatti, il Figlio di Dio ci viene incontro e deside-ra unirsi a noi; l’adorazione eucaristica non è che l’ovvio sviluppo della Cele-brazione eucaristica, la quale è in se stessa il più grande atto d’adorazione della Chiesa.
Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis 66
PREG
HIA
MO

LLe nozze di Cana, per il Vangelo di Giovanni, costituiscono la prima uscita pubblica di Gesù dopo la manifestazione al Giordano con il battesimo ricevuto da Giovanni, e la succes-siva chiamata dei primi discepoli.
L’EMANUELE 9/2009 - 29
17 GEnnaio2a Domenica per Annum
«riempite d’acqua le giare»
DAL VAnGELO SECOnDO GIOVAnnI 2,1-12
Prima letturaIsaia 62,1-5
L’incontro del Signore con il suo popolo, ritornato dall’esilio, è descritto come un matrimonio. Esso è segno dell’amore di Dio, che l’ha portato a riscattare e a sposare Israele, dopo la deva-stazione ad opera dei popoli nemici.
Seconda lettura1 Corinzi 12,4-11
S. Paolo afferma che tutti i cristiani hanno un carisma, ma non tutti lo stesso. Questo, però, non deve diventare motivo di separazione, poiché la sorgente dei carismi è lo Spirito, che li dona a ciascuno per l’edificazio-ne di tutti.
VangeloGiovanni 2,1-12
’episodio di Cana annuncia le nozze fra Dio e l’umanità, cioè l’alleanza definitiva per mezzo di Gesù Cristo. Il segno da lui compiuto rivela il suo volto di Signore e Salvatore, che si manifesterà pienamente nell’ora della sua passione e morte sulla croce.
Hieronymus bosch«banchetto di nozze a Cana»
museum boijmans Van beuningen,Rotterdam
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le giare»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono colà solo pochi giorni.

Cana di Galilea racchiude la vicenda perenne dell’umanità, racconta la relazione tra Dio e ogni uomo come una dedizione sponsale, amorosa e reciproca, esclusiva e gelosa, per sem-pre. Una relazione d’amore sempre minacciata: «Non hanno più vino» dice Maria a Gesù: e noi oggi potremmo dire: non c’è più pace come desiderio di unità; non c’è più amore come capacità di donarsi all’altro senza pretendere nulla in cambio; non c’è più rispetto della vita al punto che si uccide per dei capricci umani; non c’è più fede come decisione di dedicare tempo a Dio, perché tutto il resto è più importante di Lui, ecc. Dio però in questo contesto di delusione e vuoto, non si rassegna, Maria a Cana non si rassegna; Maria incarna ognuno di noi, è spinta da una forte speranza che la anima; sa che qualunque cosa chiederà al Figlio gliela concederà, sa che le cose possono andare dal piccolo al grande, dal debole al forte, dall’acqua al vino. Con lei, ogni credente, ognuno di noi, sa che è possibile ripartire. La stra-da è segnata dalle sue parole: «Fate quello che vi dirà». «Fate le sue parole. Fate il Vangelo». Non solo ascoltatelo o annunciatelo, ma fatelo, rendetelo vita e gesto. E si riempiranno le anfore vuote della vostra vita.
Quando le sei giare di pietra della mia umanità saranno offerte a lui, colme fino all’orlo di tutto ciò che è umano, sarà lui a mutare questa semplice acqua nel migliore dei vini. Lui che inacrna nei suoi gesti e nelle sue paerole la benevolenza e la fedeltà di Dio.
A Cana di Galilea, Maria è icona del volto gratuito di un Dio che ha a cuore la felicità degli uomini: nulla hanno fatto gli sposi per meritare il miracolo, ma Dio interviene, indiffe-rente ai meriti (unico merito è la povertà, il finire del vino). Il Dio in cui io credo, allora, è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, un Dio felice che ci vuole felici e realizzato e non schiavi del vuoto che ha volte si crea attorno a noi.
Mettiamoci di fronte al Signore con la nostra vita, la giara di pietra piena di acqua, piena di noi e delle nostre sicurezze solo umane, perché il Signore trasformi questa acqua in vino buono che serva per la felicità e la buona riuscita del cammino della mia famiglia, della mia comunità cristiana.
Gesù non è capace solo di cambiare l’acqua in vino: se lo accogliamo, ci cambia il cuore e la vita. Ci fa passare da una vita grigia ad una vita piena di colori. E allora non ci resta altro da fare davvero quello che ci dirà.
p. Luca Zanchi sss
30 - L’EMANUELE 9/2009
Santa Maria, donna del vino nuovo, noi ti ringraziamo perché con le parole “fate tutto quello che egli vi dirà”, tu ci sveli il misterioso segreto della giovinezza, ci assicuri quel vino che assicurerà la gioia della vita. E ci affidi il potere di svegliare l’aurora anche nel cuore della notte.
Ricevere l’Eucaristia significa porsi in at-teggiamento di adorazione verso Colui che riceviamo. Proprio così e soltanto così diventiamo una cosa sola con Lui e pre-gustiamo in anticipo, in qualche modo, la bellezza della liturgia celeste. L’atto di adorazione al di fuori della santa Messa prolunga ed intensifica quanto s’è fatto nella Celebrazione liturgica stessa. Infat-ti, «soltanto nell’adorazione può maturare un’accoglienza profonda e vera. E proprio in questo atto personale di incontro col Si-gnore matura poi anche la missione sociale che nell’Eucaristia è racchiusa e che vuole rompere le barriere non solo tra il Signore e noi, ma anche e soprattutto le barriere che ci separano gli uni dagli altri».
Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis 66
PREG
HIA
MO

VIENI, DOLCE LUCE, VIENI…!Il presente schema può aiutare a vivere comunitariamente o singolarmente un’ora di adorazione eucaristica. La preghiera si articola in quattro momenti, ognuno dei quali sottolinea un particolare atteggiamento della celebrazione eucaristica: «Vieni, Dolce Luce, vieni…!»; «La Parola svela il Vol-to»; «Canta… e cammina…!»; «Conducimi, Luce Gentile, conducimi…!». Mentre viene esposto il Santissimo Sacramento, si esegue un canto adatto.
PRESIDENTE Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.TUTTI Amen.PRESIDENTE Tu, o Signore, hai illuminato il cielo di luci multicolori. Alla notte e al giorno hai comandato di alternarsi in pace, dando come regola a loro, una amicizia fraterna.TUTTI La notte pone termine alle fatiche del nostro corpo, il giorno ci risveglia alle faccende che ci occupano. Ma noi fuggiamo le tenebre, ci affrettiamo al giorno senza tramonto, verso il giorno che mai conoscerà la tristezza del crepuscolo.
Viene ora invocato il dono della luce. Durante il «Rito del Lucernario» colui che presiede l’adora-zione eucaristica propone alcune invocazioni. Dopo ogni invocazione verranno accesi, progressiva-mente, tre ceri o lumini, precedentemente preparati e predisposti sull’altare, accanto al Santissimo Sacramento. Il «Lucernario», e il rito dell’accensione dei ceri o lumini, può essere accompagnato dal canto di un canone o di un breve ritornello…
PRESIDENTE Vieni Spirito Santo, vieni, vento leggero sopra le messi all’alba. Esultino, davanti a Te, i campi e quanto contengono. Soffia nel nostro giardino e spargine gli aromi. (mentre si accende il primo lumino, si acclama cantando…)
Vieni Spirito Santo, vieni, vento leggero guida sicura e ardente dentro la nostra vita. Trasforma ansia e fatica in delicata bellezza. Soffia nel nostro giardino e facci sentire il tuo profumo. (mentre si accende il secondo lumino, si acclama cantando…)
Il PEllEGRInO: un tremante d’amore
per il segreto di una vita fecondaSalmo 128
«Amo la tua casa, Signore» I salmI dI pellegrInaggIo
di GiamPietro PoLini sss
L’EMANUELE 9/2009 - 31
CAmmIno DI PReGhIeRA

Vieni Spirito Santo, vieni, vento leggero dolce come la timida freschezza. Soffia su ogni cenacolo chiuso e su ogni cuore di pietra. Che ascoltino in silenzio tutti coloro che attendono, nella speranza, un tuo segno d’amore. Vieni e veglia su di noi, fragili creature del vento. Amen. (mentre si accende il terzo lumino, si acclama cantando…)
PRESIDENTE Non ferirmi, Luce, lasciati guardare, lascia che, per un attimo, io ti guardi. Luce: seme di silenzio, mano che sboccia mentre dipinge Dio, pietra che cambia colore, trascorrere non sempre uguale delle ore, sole che si china nell’ombra, musica composita che nasce dalla Parola.TUTTI Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo... PRESIDENTE Signore, i miei occhi di mendicante si stupiscono sempre del ritorno della fioritura TUTTI e della forza dell’autunno che si rinnova.
PRESIDENTE Signore, le mie mani di mendicante sono radici che spaccano la terra, cercano l’aria e la luceTUTTI e sentono come chi guarda, e si aprono come chi ascolta.
PRESIDENTE Signore, i miei occhi e le mie mani di mendicanteTUTTI sono utili non per vendicare il passato ma per salvare il futuro. Amen.
LA PAROLA SVELA IL VOLTOViene ora intronizzata la Parola di Dio. Chi presiede la veglia di preghiera porta solennemente all’Ambone il Lezionario o l’Evangeliario. Questo momento può essere accompagnato con un canto gioioso di acclamazione alla Parola.
PRESIDENTE «Che cosa vi è di più bello del Salmo? Bene ha detto lo stesso Davide: “Lodate il Signore, poiché bello è il Salmo. Al nostro Dio sia lode gioiosa e conveniente”. Ed è vero! Il Salmo infatti è benedizione del popolo, lode a Dio, inno di lode del po-polo, applauso generale, inno dell’universo, voce della Chiesa, canora professione di fede…» (Sant’Ambrogio, Enarrationes in Psalmos, 1, 9).
LETTORE Dal SalMo 128 1Canto delle ascensioni.
Beato l’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. 2Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d’ogni bene. 3La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. 4Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore. 5Ti benedica il Signore da Sion!
32 - L’EMANUELE 9/2009

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. 6Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele!
PRESIDENTE «Il Salmo è devozione piena di autorevolezza, gioia della liberazione, grido di al-legrezza, esultanza della gioia. Mitiga l’ira, respinge l’angoscia, solleva dal pianto. Arma nella notte, magistero nel giorno, scudo nel timore, festa nella santità, im-magine della quiete, pegno della pace e della concordia: come una cetra, da suoni diversi e diseguali esprime un unico canto. Lo spuntare del giorno fa risonare il canto del Salmo, col canto del Salmo risponde il tramonto» (Sant’Ambrogio, Enarrationes in Psalmos, 1, 9).
(pausa di silenzio e meditazione – canto di adorazione) Preghiamo Donaci, Signore, di camminare nel tuo Santo Timore con operosa docilità, per-
ché possiamo essere ammessi a cogliere i frutti eterni delle tue benedizioni cele-sti. Per Cristo nostro Signore...
CANTA… E CAMMINA…!PRESIDENTE Sant’Agostino nei suoi “Discorsi” e nel suo “Commento ai Salmi” dice: «Cantate a Lui un canto nuovo, cantate a Lui con arte nel giubilo. Il giubilo è un
certo suono che significa che il cuore vuol dare ciò che non può essere detto… Vuoi dunque salmeggiare? Non sia soltanto la tua voce a cantare le lodi Divine, ma alla tua voce s’accordino anche le opere. Se canterai solo con la voce, verrà un momento in cui dovrai tacere: canta invece con la tua vita, in modo da non tacere mai. Canta come cantano i viandanti: canta e cammina! Senza smarrirti, senza indietreggiare, senza fermarti. Canta e cammina!».
Quando cantiamo la lode, la supplica, il giubilo, la fiducia…, diventiamo ciò che cantiamo. La lode e il canto è la forma di preghiera che più immediata-mente riconosce che Dio è Dio! La lode e il canto è una partecipazione alla beatitudine dei cuori puri, che amano Dio nella fede prima di vederlo nella Gloria.
Alcuni oranti leggeranno ora alcune invocazioni. Dopo ogni invocazione si può cantare un canone o un breve ritornello…
1° Orante Stimo profondamente le persone di fede. Anche tu puoi diventarlo se cerchi di vivere con coerenza. (Si acclama cantando un canone o un breve ritornello…)
2° Orante Il tuo primo impegno è il lavoro che ti serve per vivere e mantenere con decoro la tua famiglia. (Si acclama cantando un canone o un breve ritornello…)
3° Orante La tua sposa sarà la compagna con la quale costruire comunione; i figli, frutto del vostro amore, daranno gioia e pienezza ai tuoi giorni.(Si acclama cantando un canone o un breve ritornello…)
4° Orante Partendo da questo impegno parteciperai alla costruzione della società con responsabilità e iniziativa. Questo è lo stile di vita di chi crede nel Signore!(Si acclama cantando un canone o un breve ritornello…)
5° Orante Quando sarai vecchio ti auguro di poter tenere in braccio dei bei nipotini
L’EMANUELE 9/2009 - 33

allegri e pieni di vita. È con persone come queste che il Signore costruisce la pace sulla terra, la vera convivenza fra gli uomini. (Si acclama cantando un canone o un breve ritornello…)
PRESIDENTE Preghiamo. Dio, misteriosa presenza nascosta in ogni creatura, ragione ultima del nostro cercare e sperare, Padre di Gesù Cristo, il nostro fratello più caro, il Giusto, nel quale hai rivelato la via della vita, donaci di saper accogliere la tua parola e di fare di tutta la nostra esistenza un canto; e di camminare senza soste lungo la strada che conduce al tuo volto e al tuo abbraccio.TUTTI Amen.
CONDUCIMI LUCE GENTILE, CONDUCIMI…!PRESIDENTE Sia Benedetto il Signore ora e sempre. A Lui, fonte della vita e della luce, innalziamo ed eleviamo la nostra preghiera.
LETTORE Dio nostro, tu ci liberi dal paese della schiavitù e ci conduci al regno della libertà: TUTTI resta per noi il Padre pieno di amore.
LETTORE Dio nostro, tu ci insegni a camminare e ci stringi tra le braccia:TUTTI resta per noi la Madre piena di sollecitudine.
LETTORE Dio nostro, tu ci attrai con legami di bontà e ci unisci a te con vincoli d’amore:TUTTI resta per noi lo Sposo sempre fedele.
LETTORE Dio nostro, tu sei presente in mezzo a noi e conosci le nostre gioie e le nostre ansie: TUTTI resta per noi il Fratello sempre vicino.
LETTORE Dio nostro, tu ci ami fino alla fine e ci perdoni quando ti rinneghiamo: TUTTI resta per noi l’Amico che non viene mai meno.
L’adorazione si conclude con le preghiere spontanee, il «Padre nostro», il canto di benedizione, l’«Oremus», la benedizione eucaristica e il canto finale.
PRESIDENTE Preghiamo. Padre Santo noi celebriamo la tua fedeltà alla Chiesa Sposa amata di tuo Figlio il Messia: concedile di essere pronta per le nozze e di apparire nel giorno del Signore senza macchia né ruga ma santa e irreprensibile davanti a Lui vivente con te e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli.
TUTTI Amen.
34 - L’EMANUELE 9/2009 L

L’EMANUELE 9/2009 - 35LLa liturgia di oggi mette in luce l’identità profonda della Chiesa: noi siamo un popolo ra-dunato attorno dalla Parola di Dio e costituito in unità dalla Parola di Dio; siamo un popolo salvato dalla presenza vera di Cristo che “oggi” (come in ogni Eucarestia) è in mezzo a noi come Messia e Salvatore.
Nella prima lettura di oggi si racconta di Esdra che legge e spiega la Parola di Dio al po-
3a Domenica per Annum24 GEnnaio
« oggi si è adempiuta questa scrittura… »
Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero
ministri della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore”. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi».
DAL VAnGELO SECOnDO LUCA 1,1-4; 4,14-21
Prima letturaNeemia 8,2-4a.5-6.8-10Ascoltando la lettura e la spie-gazione della Bibbia, il popolo di Dio piange, colpito da queste parole che lo invitano alla conversione. Neemia interviene e lo esorta a non dimenticare la gioia e la carità nel giorno del Signore.
Seconda lettura1 Corinzi 12,12-31S. Paolo insegna che i cristiani sono uguali, perché formano un solo corpo in Cristo; ma sono anche diversi fra loro, a motivo dei carismi. Si deve però giungere all’unità, poiché tutte le membra sono necessarie al corpo della Chiesa.
VangeloLuca 1,1-4; 4,14-21Dopo il prologo con cui spiega lo scopo del suo vangelo, Luca ci presenta Gesù che, nel giorno di sabato, entra nella sinagoga di Nazaret e partecipa alla litur-gia. Alzatosi a leggere un passo del profeta Isaia, egli annuncia che quella profezia è diventata realtà: è Lui il Messia.
michelangelo buonarroti«Profeta Isaia» (dettaglio)
1509, Cappella Sistina, Vaticano

a Dio36 - L’EMANUELE 9/2009
polo tornato dalla schiavitù. È un momento importante della ricostruzione seguita all’esilio in Babilonia (siamo verso la metà del V sec. a. C.). Il tempio e le mura di Gerusalemme sono già stati, con fatica, ricostruiti, e ora siamo ad una nuova importante tappa: il popolo d’Isra-ele – in modo pubblico e solenne – assume nuovamente la “legge” di Dio, la Torah, come fondamento della propria vita. Il popolo si commuove ascoltando il racconto della fedeltà di Dio e piange i suoi errori e si apre alla fiducia del perdono e alla gioia di Dio che diventa la sua forza.
Nel Vangelo Gesù annuncia il senso della sua presenza e della sua missione, che è in sin-tonia con quanto da sempre Dio è e fa per il suo popolo: «mi ha mandato per annunciare ai poveri il liueto messaggio, per proclamare ai prigionieri la libertà, e ai ciechi la vista, per rimet-tere il libertà gli oppressi e annunciare un anno di grazia».
Dio sceglie di partire dagli ultimi, dai poveri, dagli esclusi; Dio vuole ricominciare dalla periferia della terra, dai sotterranei della storia, da coloro che non ce la fanno: Dio nella sua Parola, che ancora oggi risuona come Parola di salvezza, è novità in un mondo che troppo facilmente si abitua a stili e scelte che non sempre portano verso la luce ma ci abituano al buio; Dio è novità in un mondo che si accontenta troppo facilmente delle parole degli uomi-ni.
Le nostre parole dicono, ma possono anche contraddirsi, affermano ma non necessaria-mente realizzano, come capita nelle piccole o grandi bugie che costellano la nostra vita, nel-le promesse che rimangono nella sfera del pensiero e non si concretizzano , non si rendono visibili nella vita. Invece la Parola di Dio realizza sempre quello che dice, è una Parola sicu-ra è quella roccia su cui costruire la nostra vita perchè possa resistere alle diverse tempeste e burrasche che potrebbero metterci in pericolo.
Sia nel vangelo sia nel racconto dell’Antico Testamento, si vuole sottolineare l’importan-za della Parola di Dio che letta e meditata può diventare luce e forza, verità e vita per i cuori che l’accolgono.
Giovanni Paolo II nella “Novo Millennio Ineunte” (39) ha scritto: «Non c’è dubbio che il primato della santità e della preghiera non è concepibile che a partire da un rinnovato ascolto della Parola di Dio, Parola viva che interpella, orienta e plasma l’esistenza». Recuperiamo que-sto aspetto della nostra identità, leggiamo e meditiamo, magari anche in famiglia, questa Parola che detta e data per noi.
p. Luca Zanchi sss
Gesù,il tuo pensiero mi illumini,la tua parola mi guidi,i tuoi occhi mi seguano, le tue orecchie mi ascoltino.Le tue braccia allargate sulla croce mi aprano all’amore universale,i tuoi piedi crocifissi mi spingano a donarmisenza misura di stanchezza ai fratelli.Il tuo cuore aperto sia per mefonte di grazia nel camminoe luogo di riposo nella stanchezza. Amen.
Guglielmo Giaquinta
Di grande giovamento sarà un’adeguata ca-techesi in cui si spieghi ai fedeli l’importanza di questo atto di culto che permette di vivere più profondamente e con maggiore frutto la stes-sa Celebrazione liturgica. Nel limite del pos-sibile, poi, soprattutto nei centri più popolosi, converrà individuare chiese od oratori da ri-servare appositamente all’adorazione perpe-tua. Inoltre, raccomando che nella formazio-ne catechistica, ed in particolare negli itine-rari di preparazione alla Prima Comunione, si introducano i fanciulli al senso e alla bellezza di sostare in compagnia di Gesù, coltivando lo stupore per la sua presenza nell’Eucaristia.
Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis 67
PREG
HIA
MO

Se un figlioSi conSacraa Dio
“Giovani che prendono
decisioni diverse da quelle desiderate dai
padri, cambiano la vita tracciata dai genitori
e scelgono Dio…”
FAmIGLIA oGGIdi maria anGeLa masino

Giovani che prendono decisioni diverse da quelle desiderate dai padri, cam-biano la vita tracciata dai genitori e
scelgono Dio. È il caso di Paola nata da una famiglia laica di sinistra che scopre la fe-de. Lascia geologia, il fidanzato, prende i vo-ti di castità e povertà e obbedienza e si con-sacra. C’è Pier Giorgio che mette la laurea in ingegneria nel cassetto e cambia vita. Niente carriera in una multinazionale, ma iscrizio-ne al seminario per diventare sacerdote. C’è poi Anna che dopo un brillante esordio co-me stagista in una agenzia di stampa a Wa-shington prende l’aereo torna a Roma dove inizia il lungo iter che la porterà a diventare suora di clausura. Paola, Pier Giorgio, Anna hanno cercato in autonomia la propria stra-da. Una scelta inattesa e sconvolgente che rompe il patto non scritto fra padri e figli. E che lascia ferite più o meno profonde nei ge-nitori. Perché questo tipo di scelte disegna-no un destino non previsto e riservano stra-ordinari e difficili percorsi per la famiglia convinta di aver costruito con il dialogo e la contrattazione un futuro fatto su misura per i figli. Ricordiamolo: se le scelte convergen-ti gratificano un genitore in quanto rassicu-ranti e consolatorie, le divergenti, quelle op-poste, lo spiazzano, lo spingono a porsi do-mande portandolo a delusioni e talvolta do-lori. Fino a una trentina d’anni fa un figlio non partecipava neppure alle decisioni fa-miliari. Oggi è diverso: il sogno di ogni ge-nitore è quello di avere un ragazzo felice e per questo papà e mamma lottano allo stre-mo per garantirgli benessere, studi adegua-ti e per assicurargli una carriera già traccia-ta. Il problema è che a un certo punto, ognu-no di noi si guarda dentro. In quel momento si scopre che il percorso intrapreso non è più quello sognato dai genitori.
Vediamo le storie di chi è passato attra-verso questa esperienza sia dalla parte dei figli che dei genitori.
IL VOLOnTARIATO nOn MI BASTAVAIeri gli amici, il
fidanzato, un corso di laurea in geologia. Una vita feli-ce in una famiglia unita e laica. Oggi un iter altrettanto felice, ma fi-nalmente completo. Alessia che ora è una consacrata dopo aver preso i voti di
castità, povertà, obbedienza ha creato una casa-famiglia per donne abbandonate e bam-bini. Una scelta che ha sorpreso i suoi, so-prattutto sua madre un po’ impaurita da que-sto futuro inatteso. «Ho riconosciuto la voca-zione. Ho sentito qualcosa dentro di me che mi attirava verso Dio», spiega Alessia. Ed è in quel momento che si comincia a meditare una scelta che può cambiare la vita, la voca-zione, appunto. «Ho cercato per lungo tempo una risposta dentro di me, un segno per ca-pire se ero sulla strada giusta. Ma ciò che av-vertivo fortissimo e totalizzante era il desi-derio di fare qualcosa per gli altri. Il volon-tariato non mi bastava, così, ho incontrato il sacerdote della mia scuola superiore e gli ho raccontato quel che provavo. Lui mi ha det-to: stai sentendo Dio, ora, sta a te cammina-re verso di lui. Così in breve tempo è arriva-ta la conversione e la decisione di consacrar-mi», aggiunge Alessia. Senza abbandono non c’è disciplina, né impeccabilità. Anche il ma-estro zen insegnava ai novizi a “tener duro” e ad abbandonarsi. Questi due atteggiamenti, classici del temperamento guerriero, anche nelle spiritualità non cristiane realizzano la perfetta simbiosi attivo-passivo, inspirazio-ne ed espirazione. Un guerriero è un caccia-tore che calcola tutto, che sa controllarsi. Ma una volta che ha calcolato tutto, lui agisce, si lascia andare e questo è l’abbandono. «La fe-de per me è disciplina di ferro, attenzione a ogni atto e ogni cosa; ogni istante è un pre-testo per avanzare sul cammino della cono-scenza: il sonno, i sogni, gli incontri, l’Adora-zione, le veglie», dice Alessia.
LA PAURA DEI GEnITORIMio marito e io siamo sempre stati cre-
denti, o meglio, praticanti nel senso che an-diamo a Messa, facciamo la Comunione, preghiamo regolarmente la sera, ma quando nostra figlia ci ha detto che era sua intenzione diventare suora siamo impazziti di dolore, incapa-ci di capire il senso di quel che ci stava succedendo. Eppure – come sostiene Olivier Clement, uno dei nostri autori preferiti – il sen-so della vita è il Cristo. E,
38 - L’EMANUELE 9/2009

allora, perché ora che Francesca aveva de-ciso di puntare su Gesù siamo caduti in de-pressione? Appartenevamo allora anche noi all’esercito di coloro che riducono il cristia-nesimo a filantropia, a valori che facilitano il buon funzionamento sociale e non in Vita? Ce lo siamo chiesto più volte chiacchierando la sera. Eppure il Dio Vivente, come ha det-to uno psicanalista cristiano non è l’equiva-lente simbolico di un relazione altruistica, ma Amore. Ricordando sempre Olivier Cle-ment: «Il nostro compito è quello di un amo-re umile, crocifisso, creatore, capace di met-tere i giovani in cammino». Ma dov’era que-sto Dio per noi?
Analoga esperienza capita ad Angiola, madre di Silvio che decide dopo un periodo di intensa meditazione di entrare in semina-rio. «Tutti abbiamo provato almeno una vol-ta il mal d’amore, quella sofferenza lacerante che ci lascia come animali feriti, come succe-de alle eroine dei romanzi, da Emma Bovary ad Adele H. Ecco, quando ho saputo che mio figlio stava per diventare sacerdote ho prova-to una sofferenza simile, una specie di cadu-ta a strapiombo nella realtà. Ho pensato che ciò fosse dovuto al fatto che sono sempre sta-ta laica, ma non era precisamente quella la ragione del mio malessere. Avevo percepito la nuova vita di mio figlio come un profondo distacco da me, come un lutto. Dopo il pri-mo periodo particolarmente cupo e duro ho cominciato a spostare il mio centro di gravi-tà dall’emisfero destro al sinistro. Ed è stato in quel momento che ho capito il mio erro-re: in realtà avevo instaurato con mio figlio un legame di dipendenza. «Gli ho dato tutto, pensavo, e, ora, che era giunto il momento di raccogliere, lui se ne va. Ecco, ho comin-ciato a capire la base egoistica del mio amo-re», spiega Angiola. Dall’età della Prima Co-
munione non mettevo piede in una chiesa, ma in quel periodo ho sentito il bisogno di tornare a Messa e di acquistare un li-bro di preghiere.
LA SECOnDA nASCITA DEI fIGLIIn Africa presso i Kikuyu, durante le
cerimonie di iniziazione, la ma-dre del neofita si
siede e prende il ragazzo tra le gambe. Viene legata a lui con un budello di montone. Geme come se stesse partorendo e il ragazzo emet-te vagiti come un neonato. Viene quindi ta-gliato il budello che chiaramente rappresen-ta il cordone ombelicale. La cerimonia mima una nuova nascita. Queste pratiche, così co-me tutti i riti connessi di inghiottimento da parte della madre terra, erano molto diffu-si, in particolare in Oceania e nel continen-te nero. Il protagonista dell’iniziazione sfug-ge quindi alla madre carnale per inoltrarsi a pieno titolo nei misteri della seconda nasci-ta. Non è un ritorno all’utero, ma una spin-ta assolutamente nuova verso una vita diver-sa. Oltre alla scoperta della dimensione sa-cra della natura, l’iniziazione porta i mem-bri di una popolazione a ritrovare in modo più intimo, ma anche meno dipendente il va-lore dei legami di sangue, della società, del-la saggezza. All’opposto delle società indige-ne, l’Occidente ha perduto ogni riferimento a qualsiasi processo iniziatico e così il figlio rimane perennemente dipendente dai genito-ri. O viceversa i genitori rimangono «incolla-ti» ai loro figli. Ma ciò vuol dire che qualco-sa non ha funzionato nel modello di attacca-mento.
IL LEGAME COn I fIGLIÈ psicologia spicciola, facilmente consta-
tabile quella che ci ricorda come rispetto ai figli, tutti noi sviluppiamo un legame le cui radici sono le stesse che stavano alla base dei primi rapporti con i nostri genitori. Mentre molto è stato scritto sull’attaccamento dei fi-gli, quello dei genitori non è stato altrettan-to studiato.
La tradizione popolare parla di istinto materno, ma cosa sottintende precisamen-te questa inclinazione? La cultura analiz-za gli atteggiamenti dei genitori in termi-ni di aspettative e ruoli, di relazioni all’in-terno della famiglia. Esiste tuttavia un terri-torio, che si colloca al confine tra il biologi-co e il mentale, che costituisce il fondamen-to, in gran parte inconscio, di tutti i lega-
mi più stretti, compre-so quello con i figli. Anche questo, infat-
ti, fa parte di quei rap-porti che usiamo defini-
re viscerali per sottolineare la predominanza della loro na-
tura corporea. Che persiste anche quando siamo consapevoli che un figlio
non ci appartiene.
L’EMANUELE 9/2009 - 39

di GiULiana Fantoni
oRDInI monASTICI e ABBAZIe
San Benedetto Polirone La ProPriEtÀ
FonDiaria

L’EMANUELE 9/2009 - 41
La nascita dell’abbazia di San Benedet-to Polirone risale a un’epoca posterio-re a quella delle prime fondazioni mo-
nastiche di epoca longobarda e franca e ciò influì anche sull’organizzazione economica delle sue terre. Mentre nei patrimoni degli enti ecclesiastici più antichi, i beni, frutto occasionale di lasciti, erano sparsi e distri-buiti in varie regioni, Polirone fin dalle sue origini godette di una base terriera compat-ta, oltre che cospicua, dono della famiglia che aveva voluto il monastero. Il legame con i Canossa, però, impose anche molti vinco-li e solo alla morte di Matilde prese avvio un nuovo corso alla ricerca di un equilibrio nei rapporti di forza tra istituzioni e interessi locali, nuovo corso in cui la nostra abbazia sviluppò un proprio ruolo nella gestione dei poteri signorili e di quelli patrimoniali. Con l’espansione, ad esempio, verso zone limi-trofe al nucleo originario, per esempio verso Lucca e il Veneto, si intendeva creare un or-dinamento religioso e politico che assorbisse nuove entità senza sottrarre loro una sostan-ziale autonomia. In tal modo si ripercorreva l’esperienza politica dei Canossa, che ave-va interessato le contee di Brescia, Mantova, Ferrara, Modena, Reggio, a cui si aggiunse-ro pertinenze a Chioggia e Pellestrina, per il rifornimento di sale, e nell’area del lago di Garda per quello di olio.
Il nucleo della proprietà continuava a es-sere, però, nell’Oltrepò Mantovano, dove il paesaggio era dominato dalla ricchezza di acqua e proprio questo elemento svolse un ruolo significativo nello sviluppo delle atti-vità legate al monastero di San Benedetto. Ai fiumi e ai torrenti, perciò, caratterizzati dall’andamento abbondante tipico dei corsi d’acqua di derivazione alpina, si alternavano boschi, selve e paludi, per cui fossati, acqui-trini e argini erano una presenza costante. Il primo problema affrontato fu quello della regolamentazione dell’acqua, prima fra tut-te quella del Po, in particolare nei suoi due più ampi rami del Po Vecchio a sud e del Li-rone, poi Po Lirone, o Po Nuovo, a nord, che circondavano l’isola di San Benedetto. Già nei documenti più antichi ricorrente è il ri-ferimento sia alla minaccia di piene e di rot-
te, sia alle terre che, sottratte all’acqua, fu-rono impiegate nella cerealicoltura. Pro-prio questo secondo aspetto è legato all’im-ponente lavoro di riorganizzazione opera-to dai monaci stessi o sotto la loro direzione, per cui a fianco delle coltivazioni di cerea-li e alla pesca, importante era l’allevamento brado del suino, per provvedere al quale si conservava la selva glandifera, mentre il bo-sco ceduo consentiva l’approvvigionamento di legname. La necessità di pianificare le ri-sorse forestali e idriche era dunque l’urgen-za maggiore; fin dalla fondazione dell’abba-zia, si imposero ingenti opere di arginatu-ra e di canalizzazione e l’ampia dimensione delle opere di bonifiche, perseguita non so-lo dal monastero di Polirone, ma anche dal-le città e definita dallo storico Bruno Andre-olli “vera e propria aggressione al regime li-bero delle acque”, fu condotta in modo siste-matico e talvolta richiese anche tempi lun-ghi. In tutte le terre periodicamente danneg-giate dalle acque dei fiumi, maggiori o mi-nori, si innalzarono argini, si scavarono ca-nali, si aprirono chiaviche, cioè canali scol-matori per liberare i terreni dalle acque pio-vane altrimenti destinate a ristagnare, si co-struirono ponti e strade per incentivare le comunicazioni e il commercio e le terre pro-sciugate e rese fertili venivano in parte sot-tratte anche alla malaria. In tal modo il pae-saggio assumeva fisionomia che si potrebbe definire ‘mobile’, in quanto in continuo cam-biamento; d’altra parte, a differenza del mo-nachesimo tradizionale e con concezione an-che in questo caso più moderna, l’esperienza polironiana puntava a una progressiva e più completa sostituzione dell’incolto con le ter-re messe a coltura.
Nonostante il grande impegno profuso nella regolamentazione delle acque, i peri-coli non vennero mai del tutto rimossi, pie-ne e ‘aque magne’ si susseguivano invadendo campi e boschi e i numerosi canali di dre-naggio, compresi principalmente, per quan-to riguarda il territorio dell’abbazia, tra Po Vecchio e Po Lirone, tracciavano anche le li-nee di confine delle comunità, di cui alcune erano controllate dal vescovo, altre sotto la giurisdizione dell’abate. Questa normativa e quella per la quale le paludi peschiere di proprietà del vescovo della diocesi di Man-tova, e utilizzate anche dalle comunità a lui soggette, dovevano sottostare all’esercizio
San Benedetto Polirone

42 - L’EMANUELE 9/2009
BIBLIOGRAFIAStoria di San Benedetto Polirone, AAVV., Bologna, Pàtron, 2002, 3 volumi
dello ‘ius navigandi’ di pertinenza dell’abate, generarono frequenti contenziosi tra le due istituzioni ecclesiastiche che vedevano i pro-pri diritti reciprocamente compromessi.
I contrasti con il vescovo non si limitaro-no a questo aspetto, ma, di pari passo con l’accrescersi della potenza economica del monastero, coinvolgevano le nascenti real-tà cittadine su cui il potere episcopale eser-citava la propria giurisdizione in modo più o meno diretto e pressante, e analoghi proble-mi potevano sorgere anche con altre fonda-zioni ecclesiastiche urbane e con le famiglie aristocratiche emergenti.
Gli interventi di sistemazione idraulica influivano anche sul sistema di colonizza-zione dei terreni appartenenti al monaste-ro. Infatti, sui coloni di terre coltivabili in cambio del pagamento di un canone di af-fitto pesava l’urgenza di provvedere alla bo-nifica e i contratti collettivi spesso erano di durata perpetua: in tal modo si consentiva la realizzazione di importanti opere idrau-liche, ma al contempo si stabiliva uno stret-to legame tra popolazioni e terre bonifica-te. In queste zone, pertanto, si sviluppò ta-le tipo di contratto invece di quello a mez-zadria, più stringente rispetto alle scaden-ze, ma più in grado di tutelare la proprietà e di offrire garanzia di un intervento in tempi ragionevoli.
I lavoratori della terra erano tuttavia te-nuti al rispetto di pesanti vincoli nei con-fronti di San Benedetto Polirone. Innan-zi tutto il legame era di tipo feudale, stipu-lato cioè da un’investitura a cui provvedeva l’abate in rappresentanza del monastero, il che obbligava i coloni a una condizione ser-vile, da cui, cioè, non potevano sciogliersi se non con autorizzazione dell’abate mede-simo, che esercitava piena giurisdizione su tutti i propri uomini. Questi, inoltre, erano tenuti a dare al monastero un terzo dei frut-ti ricavati dal lavoro sulle terre loro conces-se. In cambio della casa, dell’orto e dell’aia dovevano consegnare nel giorno di S. Ste-fano una spalla di maiale, e per vendere la terra ricevuta in investitura dovevano pri-ma ottenere il consenso del monastero, che comunque manteneva diritto di prelazione e a un prezzo più favorevole. In caso di ne-cessità i contadini dovevano accorrere in ar-mi, ricevendo in cambio il vitto, e accorrere altresì a riparare le rotte causate dall’acqua sull’isola di San Benedetto, inoltre doveva-
no garantire decorosa ospitalità al rappre-sentante del monastero che si fosse trovato a passare per le terre medesime e contribuire all’onere di ricevere onorevolmente da parte del monastero il Papa, l’imperatore, un pre-lato, un marchese o altra personalità di ran-go. Era preoccupazione del potere abbaziale impedire che sui territori di Polirone si ra-dicassero altri poteri, per cui si giunse a de-cretare che, come negli altri feudi una don-na che volesse maritarsi doveva ottenere li-cenza dal suo signore dietro pagamento di una tassa. Nei beni del monastero una don-na destinata alla successione di un territorio poteva essere autorizzata a contrarre matri-monio solo dal permesso dell’abate e degli altri proprietari delle terre concesse in inve-stitura dal monastero. Seguendo il medesi-mo obiettivo si impediva anche alle vedove di contrarre nuovo matrimonio senza il con-senso dell’abate e le sostanze di coloro che morivano privi di eredi legittimi o di coloro che erano stati condannati a morte passava-no al monastero.
Tale costrittiva regola, a cui i contadini cercarono di sottrarsi anche con aperte ri-bellioni, garantiva, tuttavia, la ricchezza di San Benedetto, che nel sec. XIII il cronista Salimbene de Adam registrava tra i quattro monasteri benedettini più potenti insieme con quelli di Cluny, San Gallo e Montecassi-no e anche nel secolo successivo, nonostan-te la crisi, il monastero polironiano potè so-pravvivere grazie al forte radicamento loca-le. Ad aumentare la fama di questo monaste-ro contribuì anche la grande biblioteca, frut-to del lavoro di un importante ‘scriptorium’ già in funzione nel sec. XI, quando con l’af-filiazione a Cluny si era creato un rinnovato clima culturale, destinato a indirizzarsi, do-po l’allontanamento dall’abbazia borgogno-na, verso i nuovi modelli toscani.
GESÙ

PeLLeGRInI In CAmmInodi B CarLo mazza
Vescovo di Fidenza
L’EMANUELE 9/2009 - 43
GESÙ
Al pellegrino vero, ispirato dal desiderio di conversione, è necessario
lo sguardo ammirato sul “modello” originario che è Gesù pellegrino. Camminare verso di lui presuppone che sia conosciuto il contesto storico-religioso-culturale in cui Gesù si è formato. Gesù è figlio di una famiglia ebrea che vive alla “periferia” rispetto al “centro” di Gerusalemme, ben radicata nella tradizione dei padri, assidua nella preghiera e nell’osservanza della Legge. Di questa tradizione val bene scoprire le radici religiose, i contenuti della fede, le consuetudini di vita, in quanto aiutano a comprendere il “Gesù pellegrino” per orientare i nostri passi sulle sue orme e vivere una profonda esperienza di pellegrinaggio in comunione con lui.
“ Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre” (Giovanni 16,28)

GESÙil pellegrino
SPAzIO E TEMPOCome è noto le dimensioni che stanno a
fondamento del pellegrinaggio sono lo spa-zio e il tempo. Esse determinano la condizio-ne dell’esistenza dell’uomo nella storia e dun-que i confini del suo pensare e del suo agire. Tempo e spazio comprendono anche le ca-tegorie dell’anima e del corpo, il linguaggio interiore ed esteriore dell’esperienza uma-na, innestandovi il desiderio del cuore, l’im-maginazione della mente, la stessa presen-za di Dio. Secondo la complessa tradizione biblica, le dimensioni del tempo e dello spa-zio, per quanto concerne la nostra riflessio-ne, si concretizzano attraverso il tempio, la festa e il pellegrinaggio, cioè in quel partico-lare triangolo sacro che richiama alla santi-tà e che costituisce l’identità religiosa di ogni israelita.
IL TEMPIOIl tempio, nelle diverse formulazioni e re-
alizzazioni, designa e testimonia il modo di concepire e vivere il rapporto con Dio che si è manifestato in diversi modi ed eventi ai Pa-triarchi, ai Re, ai Profeti e al popolo stesso. In tale linea di rivelazione e di pietà, la sto-ria del tempio si identifica con la storia della fede di Israele, divenendo luogo della presen-za, dimora di Dio, tenda dell’Altissimo, luogo dell’incontro.
Se teniamo lo sguardo su Gesù osservia-mo che lui venera il tempio, ma diventa il nuovo tempio (Lc 2,41-50; Gv 2,14); pratica le
tradizioni come un pio israelita, ma condan-na il formalismo religioso (Mt 5,23 ss); rico-nosce nel tempio “la casa di Dio”, ma caccia con gesto a forti tinte profetiche i mercanti (Mt 21,12-14); ne prevede la rovina (Mt 23,38 ss). In Gesù il vecchio tempio perde la sua funzione sacrale e viene sostituito dal suo stesso corpo (Gv 2,19-21; 10,17).
Attraverso la riflessione di Paolo, i cristia-ni comprenderanno che loro stessi sono par-te integrante del nuovo tempio, prolungan-do il corpo di Cristo: la Chiesa è il tempio di Dio, edificato su Cristo, fondamento e pietra angolare (1 Cor 3,10-17; 2 Cor 6,16 ss). Ogni membro del corpo di Cristo è “tempio vivo dello Spirito Santo” (1 Cor 6,19; Rm 8,11).
LA fESTAIl tempo della festa è dimensione essen-
ziale del culto ed è collegato con le cele-brazioni di fondamentali aspetti della vita dell’uomo, come la nascita, la morte, il ciclo della natura, la memoria di fondazione. Nel-la festa l’uomo rende grazie, implora, chie-de perdono a Dio, stabilendo uno stretto con-tatto con la potenza della divinità che pre-siede la storia cosmica e umana. Le celebra-zioni della festa sono strettamente connes-se alle vicende del tempo storico e al territo-rio. In esse il credente ebreo celebra il rico-noscimento della potenza creatrice di Dio, la liberazione dell’esodo, la fiducia nella fedel-tà di Dio.
Per i cristiani, popolo della nuova alle-anza, la festa unica è la Resurrezione, la Pa-squa del Signore. Ripetuta settimanalmente nella domenica, essa ingloba e riassume tut-to il senso della festa perché è celebrazione del Giorno del Signore, il Signore dei giorni, la vittoria di Gesù sulla morte; diventa tem-po della libertà, memoria della creazione, at-tualizzazione del riscatto da ogni vincolo di peccato, anticipo del futuro.
IL PELLEGRInAGGIOIl tempio e la festa sono collegati al pel-
legrinaggio. Esso funge da linea calda nel-la quale scorre la densità dell’esperienza re-ligiosa, culturale, sociale e politica del popo-lo di Israele. Il pellegrinaggio si svolge con un ordinamento rituale ben delineato; rea-lizza la pienezza dell’appartenenza al popolo della promessa; consolida i legami parentali e relazionali e le convinzioni religiose. Tem-pi, riti, modalità gestuali e devozionali sono
44 - L’EMANUELE 9/2009

GESÙil pellegrino
eseguiti con particolare rigore e sono tutelati dall’autorità religiosa e civile. Lungo la tradi-zione storica è andato formandosi una specie di “manuale del pellegrino”. Esso raccoglie i canti dei pellegrini (salmi ascensionali: dal 120 al 134) mentre essi “salivano” a Gerusa-lemme. Sono composizioni di varia estensio-ne ed esprimono sentimenti di vibrante pie-tà. Il loro contenuto racchiude una catechesi che consente di riflettere sulle realtà fonda-mentali della religione.
Gesù si inserisce in questa tradizione del popolo di Israele con spontaneità e fedel-tà, peregrina ogni anno a Gerusalemme (Lc 2,41) anche nella sua vita pubblica (cfr. Gv 11,55-56). Luca stesso rappresenta l’azione salvifica di Gesù come la meta intenziona-le di un misterioso pellegrinaggio a Gerusa-lemme (Lc 9,51).
GESù PELLEGRInO DEL PADREVerso la fine della sua vita Gesù lascia
agli apostoli una testimonianza autobiogra-fica: “Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre” (Gv 16,28). Secondo il vange-lo di Giovanni, la peregrinazione di Gesù si colloca nel compimento della sua missione redentrice ed esplicita plasticamente la stes-sa figura di Gesù pellegrino. In tal modo du-plice si manifesta l’immagine di Gesù pelle-grino: l’una rivela la sua identità divina, l’al-tra la sua identità umana.
Perciò il processo dinamico dell’“uscire dal Padre” significa la dipendenza di Gesù dalla decisione del Padre e rivela la sua tra-scendenza. Così l’altro dinamismo del “ve-nire nel mondo” sta ad indicare che l’evento dell’incarnazione è assunto da Gesù in mo-do del tutto consapevole. Allo stesso modo il processo dinamico del “ritorno” è tutto in-centrato sulla libertà di decisione da parte di Gesù e sulla consapevolezza del compimento della volontà del Padre, in perfetta comunio-ne di intenzione: “Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era ve-nuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavo-la…” (Gv 13,3-4).
L’Autore della Lettera agli Ebrei ribadisce la stessa visione circa la venuta del Signore: “Per questo, entrando nel mondo, Cristo di-ce: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il pecca-to. Allora ho detto: Ecco, io vengo per fare, o
Dio, la tua volontà (Sal 39,7-9). Ed è per que-sta volontà che noi siamo stati santificati (Eb 10,5-10). Appena prima lo stesso Autore sa-cro ribadisce che “Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore” (Eb 9,24).
Dunque Gesù Cristo è l’esemplare, il mo-dello del pellegrino fedele che attua la volon-tà del Padre, che accetta ogni prova, anche la più ignominiosa, “sottoponendosi alla cro-ce, disprezzando l’ignominia, e si è assiso al-la destra del trono di Dio” (Eb 12,26). Questa obbedienza gloriosa di Gesù la ritroviamo descritta dall’apostolo Paolo là dove si invita i cristiani ad “avere gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo” (Fil 2,5-9).
Gesù pellegrino realizza il disegno di sal-vezza, si conforma alla volontà del Padre, ed è accolto nella gloria: il suo tragitto umano si identifica con la sua vocazione e missione, il suo ritorno al Padre proclama il compimen-to dello scopo della sua esistenza terrena.
IL DISCEPOLO nOn è DA MEnO DEL MAESTROA questo punto non possiamo non do-
mandarci: che cosa implica l’esperienza di Gesù, la rivelazione circa quello che Dio ha compiuto in Gesù pellegrino, per la fede dei discepoli? Come la peregrinazione di Gesù illumina la vita cristiana? Il cristiano, facen-dosi pellegrino, cammina sulle orme di Ge-sù, ne riproduce la sua esistenza, si confor-ma a lui?
Appare evidente che per chi “segue” Gesù, per aver parte al suo destino, non può non assumere come modello di vita la sua figu-ra per intero, pure nella consapevolezza della propria inadeguatezza ad essere “come lui”. Tuttavia, animati e illuminati dalla sua gra-zia, i cristiani ripercorrono la sua esistenza e cercano di viverne il mistero: il discepolo non è da meno del maestro perché gli è da-to di aver parte alla “conoscenza” del Padre mediante la parola rivelativa del Figlio (cfr. Gv 15,15).
Seguendo “Gesù via” (Gv 14,6) si incontra decisamente Gesù Cristo che “è lo stesso, ie-ri, oggi e nell’eternità” (Eb 13,8), secondo la confessione di chi lo aveva visto, conosciuto e creduto come “il Figlio di Dio, il re d’Isra-ele” (Gv 1,49). Così il pellegrinaggio si fa atto di fede, di speranza e di carità, nella sequela di Gesù, pellegrino del Padre.
L’EMANUELE 9/2009 - 45

GIoVAnnI GIRoLAmo SAVoLDo«Sant’Antonio Abbondio e San Paolo»c. 1515, olio su tela,Gallerie dell'Accademia, Venezia
LA PRIMATESSALONICESI
NELLA NOSTRA VITA
di GiUsePPe CroCetti sss
In CAmmIno Con SAn PAoLo

1 LA PRIMA LETTERA DI PAOLO E IL PRIMO SCRITTO DEL nUOVO TESTAMEnTOÈ necessario, innanzitutto, prendere co-
scienza dell’importanza di 1 Ts già per la sua collocazione storica. Con questo suo scritto Paolo ci riporta a poco più di un ventennio dopo la risurrezione di Gesù, av-venuta nell’anno 30, cioè all’anno 52 quando la scrive da Corinto durante il suo secondo viaggio missionario. In essa egli richiama, sia pure parzialmente, la sua predicazione ai tessalonicesi, avvenuta cinque anni prima, verso gli anni 46-48, e riecheggia quanto era già diventato patrimonio di quella nuova co-munità. Con 1 Ts Paolo dà inizio agli scritti del Nuovo Testamento, in quanto i Vangeli, pur cogliendo il messaggio dalla persona e dalla bocca di Gesù, verranno messi in scritto tra gli anni 70 e 100. Inoltre con tale scritto Paolo riprende quanto la tradizione apostolica, già prima di lui, trasmetteva oralmente; in più egli ci dà un abbozzo di quanto svilupperà nelle sue lettere successi-ve. In breve, 1 Ts deve consolidare in noi la fiducia sulla storicità della persona di Gesù e del suo messaggio.
2 DIO PADRE E “IL VAnGELO DI DIO” Paolo presenta Dio come “Padre nostro”
(3,11), come “Dio Padre nostro” (3,13), rie-cheggiando così la preghiera del Pater. Le ragioni per le quali a Padre aggiunge l’agget-tivo “nostro”, cioè di Paolo stesso e dei letto-ri fra i quali ci siamo noi, sono molteplici. È Padre perché il Vangelo è suo: “Vi abbiamo annunziato il vangelo di Dio” (2,2,3.4.8.9). A Dio, quindi, risale il progetto della salvezza, che ha una meta precisa: Dio “vi chiama al suo regno e alla sua gloria” (2,12). Inoltre, nella sua infinita bontà, Dio ha affidato a Paolo il Vangelo che egli annuncia: “vi ab-biamo annunziato il vangelo di Dio” (2,9). Vangelo che è anche “Vangelo di Cristo” (3,2), mediante la predicazione che Gesù ha fatto, la sua opera e la sua stessa persona.
Infine, da un punto di vista ben diverso, è anche “il nostro vangelo” (1,5), di Paolo in quanto lo predica. Da quell ’annuncio del Vangelo, opera divina che si accompagna alla collaborazione umana, è nata in Tes-salonica la comunità dei credenti in Cristo, che Paolo qualifica come “fratelli amati da Dio” ed “eletti da lui” (1,4). La nascita della comunità cristiana di Tessalonica è il punto d’arrivo dell’azione del Padre. In essa Dio compie la sua opera di Maestro interiore: “Voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri” (4,9).
3 GESù CRISTO, SIGnORE E REDEnTORE, COL qUALE SAREMO PER SEMPREColui che Paolo colloca in primo piano
nel suo testo è Gesù Cristo. Con tenerezza e fede profonda Paolo nomina Gesù qualifi-candolo come “Signore nostro Gesù Cristo”: “Signore”, cioè il titolo divino; “nostro”, cioè il rapporto che Gesù ha stabilito con noi, diventando quasi nostro possesso; “Gesù”, cioè il Figlio di Maria; “Cristo”, cioè il Mes-sia promesso. Altrove riserva abitualmente a Gesù il solo titolo di “Signore”. In tutti que-sti casi egli riecheggia il grido liturgico che si innalzava nella celebrazione eucaristica: “Maranathà”, cioè: “Signore nostro, vieni!” (1 Cor 16,22).
Inoltre, Paolo associa intimamente Dio Padre e Gesù Cristo, mettendo Gesù sullo stesso piano di Dio. Fa questo già nel pri-mo versetto affermando che la chiesa dei tessalonicesi è “in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo” (1,1). Ripete la cosa in chiave di desiderio e di preghiera: “Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il Signore nostro Gesù diri-gere il nostro cammino verso di voi!” (3,11). Questi modi di esprimersi di Paolo ci dicono in modo evidente che la divinità di Cristo – non solo in Paolo ma anche già prima – face-va parte della tradizione apostolica, la quale riproduceva il messaggio di Gesù stesso. Di conseguenza, è del tutto stonato pensare –
LA PRIMATESSALONICESI
NELLA NOSTRA VITA
Abbiamo avuto la grazia, nel corso di questi due ultimi anni, di leggere integralmente la prima lettera ai Tessalonicesi. In quest’ultima puntata vogliamo richiamare alcuni dei ricchi contenuti dogmatici, morali, ecclesiali,
storici e spirituali che questo scritto eccezionale contiene. La ragione ultima di questo nostro compendio – che è molto parziale, dato anche lo spazio disponibile – è quello di trasferire il messaggio di 1 Ts nella nostra vita, cioè nel nostro modo di pensare e agire.
L’EMANUELE 9/2009 - 47

come fanno alcuni – alla divinizzazione di Gesù come una cosa tardiva e inventata sul-la linea della divinizzazione dell’imperatore. Nel nostro caso, poi, sarebbe stato diviniz-zato un crocifisso, non un imperatore, pochi anni dopo la sua morte, e ciò sarebbe avve-nuto tra un popolo strettamente monoteista!
Nello stesso tempo Paolo afferma ancora in piena sintonia col kerygma primitivo la divinità di Cristo e il suo mistero pasquale, cioè la sua opera redentrice: “Noi credia-mo infatti che Gesù è morto e risuscitato” (4,14). Per cui raggiungiamo la salvezza “per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi” (5,9-10). Che dire del ritorno glorioso e imminente di Cristo, della sua parusìa? Non si può negare che Paolo ritorna spesso su questo tema. Dice che i tessalonicesi si sono convertiti per “atten-dere dai cieli il suo Figlio” (1,10); che sono essi, per lui, un vanto “davanti al Signore nostro Gesù, nel momento della sua venuta” (2,19; cf 13). Quando poi scoppia la crisi per i cristiani tessalonicesi morti prima della parusìa, Paolo dà delle direttive (3,13-18), ma non del tutto sufficienti, tanto che vi ritorna nel brano successivo (5.1-11) e ancora in mo-do pesante in 2 Ts. Rileviamo, d’altra parte, che l’attesa della parusìa imminente, pur fra molti eccessi, mette in rilievo un dato positivo: il desiderio di essere al più presto uniti al Signore con la redenzione defini-va. La conclusione dei due principali brani escatologici va proprio in questa direzione: “Saremo sempre con il Signore” (4,17) e “Sia che vegliamo [siamo ancora in vita] sia che dormiamo [siamo già morti], viviamo insie-me con lui” (5,10).
4 LO SPIRITO SAnTO nEI PREDICATORI, nEGLI UDITORI, nELLA COMUnITàPaolo ricorda come il vangelo da lui an-
nunciato si è diffuso fra i tessalonicesi “non soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con pro-fonda convinzione” (1,5). A questa molte-plice ed efficace azione dello Spirito, in chi parlava, si è aggiunta, nello stesso tempo, una uguale azione in chi ascoltava, per cui i tessalonicesi hanno accolto la Parola “con la gioia dello Spirito Santo” (1,6) nonostante le tante difficoltà. Inoltre, Dio, chiamandoli al-la santificazione, “vi dona il suo santo Spiri-to” (4,8); quindi esercita un’attività continua sui tessalonicesi. Ad essi Paolo chiede; “Non spegnete lo Spirito” (5,19).
5 LA “ChIESA” DEI TESSALOnICESI E LA GIOIA DI ESSERE CRISTIAnI Paolo, associando a sé Silvano e Timòteo,
scrive “alla Chiesa dei Tessalonicesi” (1,1). Commentando questo versetto presentam-mo il contenuto straordinario che esprime la parola ebraica qāhāl, assemblea culturale, tradotta spesso dai LXX con ekklesía. Paolo vede in quel piccolo e perseguitato gruppo di individui, che sono diventati cristiani, la replica e la realizzazione della qāhāl dell’An-tico Testamento.
Forse anche per questo egli è tanto en-tusiasta di tale “chiesa” che profonde lodi frequenti ed esagerate su quanti la compon-gono. Occorre, di certo, ridimensionarle, sia badando alla formula retorica che Paolo usa per conquistarsi sempre più la simpatia di quei cristiani, sia badando anche alle corre-zioni che apporta a quanto ha detto, aggiun-gendo, per esempio, che “possiate progredire ancora di più” (4,1).
Tuttavia, è fuori dubbio che siamo davan-ti a una comunità fervorosa, entusiasta, gio-iosa e eroica per le sofferenze che sopporta per la sua adesione a Cristo.
6 GLI IMPEGnI MORALI Paolo non presenta elenchi di virtù da
praticare o di vizi dai quali tenersi lontano. Raccoglie l ’ insieme dell ’impegno morale sotto l’immagine – che era stata usata da Gesù – della vigilanza nell’attesa del Signo-re: “Noi invece, che siamo del giorno, dob-biamo essere sobri, rivestiti con la corazza della fede e della carità e avendo come elmo la speranza della salvezza” (5,8). Esorta, anche qui, come opzione di fondo, a “comportarvi in modo da piacere a Dio” (4,1). In concreto sottolinea con forza l’impegno dell’amore fraterno e della pratica della castità.
7 UnA DUPLICE PROPOSTA COnCLUSIVARiviviamo la testimonianza di 1 Ts nella
proclamazione della Preghiera Eucaristica, che si muove in questa struttura chiastica: Dio Padre, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, le parole dell’istituzione, lo Spirito Santo, Ge-sù Cristo, Dio Padre. Meditiamo l’intera 1 Ts ai piedi di Gesù Sacramentato.
Contenuto dogmatico, morale, ecclesia-le, storico ed altro, ci radichino sempre più profondamente nel contenuto della nostra fede e nell’impegno di conformare ad essa la nostra vita.
48 - L’EMANUELE 9/2009

Carissimi amiCi,da tempo stavo pensando ad una proposta che ora voglio sottoporre alla vostra attenzione. Ho pensato di offrirvi la possibilità di avere raccolti in un CD tutti i numeri de L’Emanuele 2009 che potrete consultare sfogliandoli sul vostro computer e scaricare gli articoli che vi interessano, sempre citando la fonte.
Sul CD che riceverete, troverete tutte le indicazioni necessarie per accedere alla consultazione on-line dei diversi numeri de L’Emanuele.
È un opportunità per stare al passo con i tempi nell’era mediatica che stiamo vivendo e, perché no, potrebbe anche essere un regalo che fate a persone che sapete particolarmente interessate ai diversi argomenti trattati su L’Emanuele.
Chi fosse interessato dovra’ ComuniCare la sua riChiesta del Cd entro il 10 gennaio 2010 per riCeverlo poi entro febbraio 2010 telefonando allo 035.571061 o inviando una mail all’indirizzo [email protected]
Offerta LanciOcOmprese Le spesedi spediziOne
e 8,00

RAFFAELLo SAnZIo«Il miracolo dei pani e dei pesci», 1515
tempera su carta, montata su tela,Victoria and Albert museum, Londra
DATE LORO VOI STESSI
DA MANgIARE(Matteo 14,13-21)
PRoPoSTA DI LeCTIodi LUCa zanCHi sss
ASCOLTIAMO LA PAROLA
Dal Vangelo di Matteo
13Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e
si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma
la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. 14Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla
e sentì compassione per loro e guarì i loro
malati. 15Sul far della sera, gli si accostarono
i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è
ormai tardi; congeda la folla perché vada nei
villaggi a comprarsi da mangiare». 16Ma Gesù
rispose: «Non occorre che vadano; date loro
voi stessi da mangiare». 17Gli risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci!». 18Ed
egli disse: «Portatemeli qua». 19E dopo aver
ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese
i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi
al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. 20Tutti mangiarono
e furono saziati; e portarono via dodici ceste
piene di pezzi avanzati. 21Quelli che avevano
mangiato erano circa cinquemila uomini,
senza contare le donne e i bambini.

nello stesso versetto si dice che “Gesù par-tì di là”, “si ritirò in disparte”, “in un luogo deserto”. Una distanza che la folla colma cer-candolo, là dove si è ritirato, una folla che non si arrende e non accetta questa “certa” lontananza.
13b “La folla lo seguì a piedi”.
La gente disorganizzata, senza meta, va a piedi verso quella che ritiene l’unica meta possibile, verso Gesù, lasciando alle spalle le altre possibili mete offerte dai centri abitati.
14 Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
15 Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare».
Gesù si accorge dello stato d’animo di questa povera gente e “ne prova compassio-ne”; cioè prova una tenerezza ed un affetto tali che non riesce a non sentirsi coinvolto
Tutto il racconto di Matteo della moltiplicazione dei pani, è condiviso da tutti e quattro gli evangelisti. Questo indica che per le prime comu-nità cristiane quel miracolo fu un fatto molto rilevante tanto che Mat-
teo e Marco lo riferiscono per ben due volte. Nel vangelo, quindi, è presente sei volte in tutto.
Il gesto di Gesù diventa il gesto dei discepoli: ecco l’ideale continuità tra il Messia e ognuno di noi, chiamati ad avere in noi gli stessi sentimenti che furono di Gesù Cristo, sentimenti che ci devono rendere capaci di vede-
re, agire ed essere non solo presenti effettivamente, ma presenza significativa, capaci di dare quello che noi abbiamo già ricevuto, è la reciprocità del dare che genera un vortice d’amore in cui tutti sono avvolti e coinvolti.
DATE LORO VOI STESSI
DA MANgIARE
PRESTIAMO qUALChE ATTEnzIOnE AL TESTO
Premessa sinotticaGuardando la Sinossi si nota come l’am-
bientazione, il contesto in cui Gesù opera la moltiplicazione/condivisione dei pani e dei pesci, siano diverse. Matteo pone il fatto subito dopo che Gesù ha ricevuto la brutta notizia della uccisione di Giovanni Battista. Marco e Luca lo collocano quando gli apo-stoli tornano dalla loro prima esperienza di apostolato. Matteo lo vede come il gesto di Gesù che placa l’amarezza degli animi dovu-ta alla triste notizia su Giovanni; per Marco e Luca il miracolo è narrato al culmine della gioia di Gesù e dei dodici apostoli.
13 Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città.
Matteo qui riferisce un verbo cui tiene tanto: ritirarsi e scrive: “Gesù si ritirò in di-sparte”. Anachoréo è detto in greco, da cui deriva la parola anacoreta: persona che si ritira dal mondo, dai centri abitati. Matteo usa questo verbo 10 volte nel suo vangelo: chissà quale significato vi voleva veramente dare. È certo che qui, in questo versetto, il ritirarsi di Gesù, il suo nascondersi, velarsi quasi, è marcato con forza. Infatti sempre
L’EMANUELE 9/2009 - 51

da quella gente, dai loro volti, dalle loro sto-rie, dai loro problemi, dalle loro malattie… Perché la gente era “stanca, sfiduciata come pecore senza pastore” (Mt 9,36). Si dice allo-ra nel testo che Gesù prende l’iniziativa: “si prende cura di loro” e li guarisce, compiendo ciò che disse, riguardo a Dio, il profeta Eze-chiele: “Andrò in cerca della pecora smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata” (34,16). L’evangelista Marco dice, invece, che Gesù “si mise ad insegnar loro molte cose” (6,34).
Dall’insieme si capisce che il deserto fio-risce di cose belle, cariche di grande uma-nità: Gesù è colui che fa tutto ciò. Però i discepoli si accorgono che questi gesti non sono sufficienti: la gente ha fame, ormai è sera ed il luogo in cui si trovano è deserto. Sembra che lascino intendere che ormai, umanamente parlando, la situazione è così critica che è quasi impossibile tenere in vita tanta gente affamata. Si può solo tentare di “congedarli, mandandoli nei villaggi che sor-gono ai margini del deserto”.
16 Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare».
17 Gli risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci!».
18 Ed egli disse: «Portatemeli qua». “Non occorre che vadano”, cioè non è ne-
cessario spezzare il legame che lo lega alla folla, anche di fronte ad una realtà che sem-bra insormontabile. E aggiunge: “Date loro voi stessi da mangiare”. È come se dicesse: voi avete il cibo di cui la gente necessita e non ve ne accorgete. Con un po’ di buona vo-lontà si può risolvere il problema senza fare drammi.
In quel “Portatemeli qua” le cose cam-biano. La situazione drammatica non si può solo affrontare in maniera drastica: ognuno pensi per sé andando nei villaggi vicini; ma anche in altre forme che non richiedono ne-cessariamente l’allontanamento e la separa-zione da quella folla che con Gesù ormai ha stabilito un forte legame
A questo punto si apre un altro scena-rio. Non solo l’impossibile diventa possibile attraverso Gesù, ma si va al di là di ogni
aspettativa. Il legame di Gesù con il popolo si rinsalda anziché spezzarsi e diventa festa.
19 E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla.
20 Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati.
21 Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
Gesù dice: Fateli sedere sull’erba” e dimo-stra ai discepoli come ci sia un’altra strada da percorrere senza arrivare alla disperazio-ne o alla dispersione: la strada è la seguente: la condivisione. Condividere il poco che si possiede, cinque pani e due pesci, con chi non ne ha. Tutto dipende dalla mano: se es-sa è chiusa e non dona, è la fame; se essa è aperta e fa parte di ciò che possiede, è la sa-zietà, è la festa. I discepoli stando con Gesù hanno imparato che facendo dono di quello che si ha “si può mangiare e saziarsi” ed es-sere fratelli. Il dare non è una perdita, ma un guadagno. Il condividere sazia così tanto che da quanto si ha condiviso si può anche raccogliere degli avanzi: dodici ceste, dodi-ci, cioè tante quante sono le tribù d’Israele, quindi bastanti per tutto il popolo; e quanti sono i mesi dell’anno; cioè, condividendo, ci sarà sempre del cibo e per tutti.
Al versetto 21, Matteo dice che i presenti erano cinquemila, cioè tanti quanti forma-rono la prima comunità cristiana di Geru-salemme (Atti 4,4); aggiunge inoltre: “senza contare le donne e i bambini”. Con questo, Matteo vuol mettere in relazione il miracolo presente con quanto accadde nel deserto al popolo ebreo guidato da Mosé (Esodo 12,37). Il popolo con Mosé gustò la manna, mangiò le quaglie come cibo divino; con Gesù, la gente imparò a non dividersi, a non sparpagliarsi per i villaggi per poter soprav-vivere, ma a farsi dono a vicenda di quanto aveva: con questo sistema si mangia a sazie-tà e ne avanza anche per altri momenti di condivisione.
52 - L’EMANUELE 9/2009

RILEGGIAMO IL TESTO E CALIAMOLO nELLA VITA
1. Comprare… Dare
Due atteggiamenti opposti, riassunti da due verbi: comprare o dare. Comprare, dico-no gli apostoli. Ed è la nostra mentalità: se vuoi qualcosa, lo devi pagare. Non c’è nulla di scandaloso, ma neppure nulla di grande in questa nostra logica dove trionfa l’eterna illusione dell’equilibrio del dare e dell’avere. In questo sistema chiuso, prigioniero della necessità, Gesù introduce il suo verbo: date voi stessi da mangiare. Non già: vendete, scambiate, prestate; ma semplicemente, ra-dicalmente: date. E sul principio della ne-cessità comincia a spuntare, a sovrapporsi un altro principio: la gratuità, l’amore senza calcoli, il disequilibrio, dare senza aspettar-si niente. Solo la gioia di dare.
2. “Non abbiamo che cinque pani e due pesci!”
Il Signore sa bene che nelle mani dei di-scepoli c’è poco: appena cinque pani e due pesci; eppure debbono rispondere al bisogno di quella folla senza rimandarla indietro. Il miracolo inizia proprio qui: dalla debolezza messa con fiducia nelle mani del Signore. E viene moltiplicata. La povertà diventa abbondanza. Il miracolo è operato dal Si-gnore, ma non senza l’aiuto dei discepoli. Il Signore ha bisogno delle nostre mani, anche se deboli, delle nostre risorse, anche se mo-deste. Egli rende forte la nostra debolezza e ricca la nostra povertà.
“Non abbiamo che cinque pani e due pe-sci!”, si lamentano gli apostoli. Si spaventano di fronte all’ordine di Gesù di saziare tanta folla. Forse anche oggi i cristiani si spaven-tano di fronte alla sfida del nostro mondo pagano, e si sentono impotenti. L’invito di Gesù è di credere non solo alle proprie ca-pacità, ma alle risorse di Dio. È necessaria questa coscienza “orgogliosa” della “potenza del vangelo” - lievito che silenziosamente ma efficacemente trasforma la pasta. La missio-narietà non ha altra sorgente che in questa sicurezza di poggiarsi su Dio. Era tutta la forza di Paolo: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo,
la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati”. “Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati”. Quanto è abbondante il dono di Dio, e la Chiesa ne ha sempre riserva per tutti! Dono di Dio è il cibo spirituale dell’Eu-caristia. Dono di Dio è pure la carità che dall’Eucaristia deriva. Non è mai mancata la carità della Chiesa lungo i secoli, sempre pronta a “guarire i malati”. Anche oggi la Chiesa è la prima a moltiplicare il pane della sua carità, sia in terra di missione per alle-viare fame e ingiustizie, sia qui da noi per vincere emarginazione e nuove povertà.
3. “Date voi stessi da mangiare”
Gesù apre la strada della fraternità! Con quello spezzare i cinque pani per i cinque-mila egli ci fa vedere che quanto sembra impossibile a prima vista, è possibile, perché c’è anche la potenza dell’amore del Padre che si serve dei nostri gesti fraterni! Il ve-ro miracolo è qui, nella condivisione, nella compassione, nell’amore. I miracoli li potete compiere anche voi. Solo chi ama e condi-vide moltiplica il pane. Perché solo l’amore può compiere i miracoli. Come diceva Ma-dre Teresa di Calcutta: amate e fidatevi della provvidenza. Non pensate a tutti quelli per cui non potete fare nulla, ma occupatevi di una persona per volta. Gesù ama compiere i suoi miracoli a partire dal poco. Dal poco, dai nostri gesti quotidiani, dai nostri cuori con-vertiti si può ricavare, il molto dell’abbondan-za, il miracolo della moltiplicazione.
PREGhIERA fInALE
Alla mensa di Dio c’è posto per tuttic’è posto anche per me.Alla mensa di Dionon ci sono differenze né discriminazionie l’invito è libero e senza costrizioni.Alla mensa di Dio troveremo il Paneper sfamarci, non porteremo regali, niente doni, niente inviti da ricambiare solo noi con il nostro niente.
L’EMANUELE 9/2009 - 53

Pochi giorni fa, mentre ero affaccenda-to nelle miserie della vita, mi è capita-to con un conoscente di scambiare al-
cune parole che, devo ammetterlo, mi han-no un poco spiazzato. Si parlava della vita e di come viverla intensamente e lui mi faceva l’elogio dei piaceri della vita che vanno vis-suti all’insegna del “Carpe diem”: sesso, ci-bo, potere, fama, denaro… in effetti, pure se esternamente tentavo di opporre qualche (vana) resistenza, internamente solidarizza-vo d’istinto con il piano di vita che questa persona mi andava proponendo. E chi non lo farebbe? Infatti, il mio conoscente mi ten-tava con tutto il desiderabile possibile a vi-ste umane. E come uomo ho reagito (inter-namente) aderendo a questo piano. Ma non sono un animale che reagisce solo d’istinto: le mie convinzioni personali mi hanno por-tato a reagire e a formulare un’altra doman-da. Ma quale senso dai così alla vita, non hai paura di un giudizio finale per una vita vis-suta puramente nel godimento di uno ste-rile egoismo? A questo punto lui, anche se con rispetto, si è messo a ridere e mi ha det-to che lui crede solo a quello che la scienza ci dice di credere, solo a quello che è osser-vabile. Mi riferiva come oramai la scienza ci dia risposte su tutto e come possiamo avere un’idea di quello che ci circonda. In effetti la risposta sembrava convincente e io avrei do-
vuto alzare le braccia e dire: mi arrendo, ab-bandonandomi poi ad una vita di eccessi e tutta centrata sul qui ed ora. Però ci ho pen-sato bene e ho realizzato che il mio amico presentava nel suo ragionamento grandi fal-le: la scienza ci dice tutto su chi siamo e do-ve andiamo? Al contrario! Il mistero della vi-ta rimane un mistero, ci sono teorie, alcune anche affascinanti, ma sono teorie. Su molte cose intorno a noi, sappiamo veramente po-chissimo, quindi l’ottimismo scientifico do-vrebbe perlomeno essere venato di sana pru-denza. E molti scienziati infatti esercitano questa virtù. Quindi, ho cominciato a riflet-tere su cosa è la vera vita. Quella prospetta-ta dal mio amico sembra solo un surrogato, piacevole per l’istante, di quello che dovreb-be essere la vita. Ma cosa è la vera vita? E che rapporto ha con quello che viviamo nella liturgia? La vera vita è vivere sfrenatamente i piaceri sensuali?
Come mi capita spesso ultimamente, ri-corro a Divo Barsotti per avere risposte che illuminino queste tenebre della coscienza (ma poi cosa è la coscienza? Anche su que-sto gli scienziati dibattono invano). Nel libro che già più volte ho citato, “La fuga immobi-le”, trovo questa meditazione: “Il cristiane-simo non è per questo mondo – non può tra-sfigurarlo che nella morte (…) La sua vittoria non è che la morte. Tutti gli sforzi in altro sen-
LAVERAVITA
La spiritualità liturgica di Divo Barsotti di aUreLio PorFiri
54 - L’EMANUELE 9/2009
ABISSo DI LUCe

vuto alzare le braccia e dire: mi arrendo, ab-bandonandomi poi ad una vita di eccessi e tutta centrata sul qui ed ora. Però ci ho pen-sato bene e ho realizzato che il mio amico presentava nel suo ragionamento grandi fal-le: la scienza ci dice tutto su chi siamo e do-ve andiamo? Al contrario! Il mistero della vi-ta rimane un mistero, ci sono teorie, alcune anche affascinanti, ma sono teorie. Su molte cose intorno a noi, sappiamo veramente po-chissimo, quindi l’ottimismo scientifico do-vrebbe perlomeno essere venato di sana pru-denza. E molti scienziati infatti esercitano questa virtù. Quindi, ho cominciato a riflet-tere su cosa è la vera vita. Quella prospetta-ta dal mio amico sembra solo un surrogato, piacevole per l’istante, di quello che dovreb-be essere la vita. Ma cosa è la vera vita? E che rapporto ha con quello che viviamo nella liturgia? La vera vita è vivere sfrenatamente i piaceri sensuali?
Come mi capita spesso ultimamente, ri-corro a Divo Barsotti per avere risposte che illuminino queste tenebre della coscienza (ma poi cosa è la coscienza? Anche su que-sto gli scienziati dibattono invano). Nel libro che già più volte ho citato, “La fuga immobi-le”, trovo questa meditazione: “Il cristiane-simo non è per questo mondo – non può tra-sfigurarlo che nella morte (…) La sua vittoria non è che la morte. Tutti gli sforzi in altro sen-
so falliscono. Non rimane che morire” (pag. 212) Wow! Qui il mio conoscente probabil-mente sbiancherebbe e io, sinceramente, ten-do a capirlo. La prospettiva di Barsotti è, co-me al solito, sanamente radicale: si vive ve-ramente solamente quando si muore. Ora non dobbiamo pensare solamente alla fine fisica, ma, nella prospettiva che ci interessa, anche alla morte ai piaceri di questo mondo. Troviamo nella spiritualità cristiana molti momenti in cui questo è annunciato con sor-prendente chiarezza. Sant’Ignazio di Loyola chiede ai suoi discepoli di obbedire al Papa “perinde ac cadaver”, alla maniera di un ca-davere, rinunciando cioè agli impulsi egotici.
Nella nostra liturgia, spesso ci sembra che al centro ci sia solamente l’ego assem-bleare, l’autocompiacimento di svolgere un compito che non mostra i segni di un richia-mo altro. Per correggere il rischio dello sca-dere in un fumoso misticismo, siamo caduti in un antropocentrismo liturgico che celebra una festa senza il festeggiato. L’enfasi nella risurrezione ha messo da parte il dato del-la passione e morte, che è centrale nel miste-ro cristiano. La risurrezione non potrebbe esistere senza questo, non si risorge se pri-ma non si muore. Ecco che le parola di Divo Barsotti ci riportano ad una dimensione più autentica del vivere liturgico e quindi del vi-vere cristiano.
Già, ma perché stabilire questo collega-mento tra vivere liturgico e vivere cristia-no? Nel fare questo non si fa che seguire l’in-segnamento della Chiesa a partire dal Motu Proprio sulla Musica Sacra del 22 novembre 1903 che ci dice che il “vero spirito cristiano” viene attinto innanzitutto “dalla sua prima ed indispensabile fonte, che è la partecipazio-ne attiva ai sacrosanti misteri e alla preghie-ra pubblica e solenne della Chiesa”. Quindi questo collegamento tra vita liturgica e vita cristiana è al cuore dell’insegnamento del-la Chiesa. Ma spesso le nostre liturgie si fan-no sociologiche, si fanno spiegazione, dida-scalia. Si è cercato di non cadere nel peri-colo del sacro come numinoso ma ci si è ri-trovati nella liturgia come preghiera didat-tica. Si rimane nella vita quotidiana e certa-mente essa non può non essere una partenza imprescindibile; ma ci sembra non ci sia lo scarto tra la vita e la vera vita, cioè la mor-te. Ci sembra che questo vivere liturgico sia informato del principio temporale, come se la liturgia si realizzasse nel tempo presente e
non fosse un cuneo infilato nel presente per aprirlo all’infinito.
Hegel sarebbe felice di questa concezione della liturgia che tanto deve alla sua rifles-sione. Se non si capisce il valore di questo morire per vivere io credo non ci si avvicina alla pregnanza dell’atto liturgico.
Padre Stefano Albertazzi è un sacerdo-te della Comunità dei Figli di Dio, la congre-gazione religiosa fondata da padre Barsot-ti; bontà sua, legge quanto vado scrivendo sul loro fondatore su queste pagine. Recente-mente ha pubblicato un libro basato sui dia-ri del Padre dal titolo “Sull’orlo di un dupli-ce abisso” (Edizione San Paolo). Durante la presentazione del libro a Firenze (20 maggio 2009) si è congedato dai presenti con que-ste significative parole: “Per tanti anni io non ho accet-tato questo padre che mi da-va la morte per darmi la vi-ta, e mi sono ribellato a lui con tutte le mie forze. Vole-vo la vita subito, senza pas-sare per la morte. Per molto tempo ho fatto a pugni con lui – e in parte credo di far-li ancora –: ma con la sua morte qualcosa si è mosso dentro di me e io ho final-mente iniziato di accettare la mia morte, di accogliere cioè finalmente don Divo come mio padre”. Queste belle parole ci fan-no vedere quanto espresso da Divo Barsotti in una loro incarnazione concreta.
Poco tempo fa ho perduto mia madre. Per me è stata una fine, per me è stato come vedere il sole farsi improvvisamente buio. Poi, ho pensato a come anche lei si sia da-ta la morte per darmi la vita, come avesse ri-nunciato a tanti piaceri per darsi alla fami-glia e sacrificare se stessa per un bene che lei vedeva ancora maggiore. Quello che so-no, quel poco che faccio tra mille inciampi, lo devo a questa umile donna del popolo che ha rinunciato a se stessa per me. Mi ha ge-nerato come una spiga libera al vento perché io mi facessi seme per altri raccolti. Mia ma-dre, chicco di grano, come mille altri chicchi di grano, ha scelto la vera vita e insieme a tanti altri come lei, si è posta a fondamento del fiorire di mille primavere non macchiate dal contingente ma sempre fresche e profu-mate di eternità.
LAVERAVITA
L’EMANUELE 9/2009 - 55

56 - L’EMANUELE 9/2009
di Giovanni GUsmini
ARTe e FeDe
IN VIAGGIOattraverso
l’ARTESACRAQuesto numero
« ADORAZIONE DEI PASTORI»
EL GRECO
Prima di affrontare un autore come El Greco bisogna pensarci bene. Occor-re aver passato un po’ di tempo a me-
ditare sulle sue opere, dal momento che sol-tanto osservarle non basta. A prima vista se ne ricava un’impressione talmente for-te da rimanerne quasi storditi: la contorsio-ne dei corpi, la lividezza della luce, la fanta-smagoria dei colori, l’impressionante con-trasto chiaroscurale pongono davanti agli occhi dell’osservatore una sorta di visione onirica, metafisica, assoluta. Chi, pensan-do che siamo a cavallo tra Cinque e Seicen-to, vada alla ricerca dei canoni tradizionali cui è abituato si trova completamente spiaz-zato: non v’è traccia della linea, del disegno, del culto della classicità, cui era legata l’Ac-cademia, ma non c’è nemmeno la realtà, ri-tratta nella sua cruda verità, come stava fa-cendo Caravaggio e avrebbero fatto molti altri dopo di lui. Sì, è vero: qua e là sembra-no emergere richiami al luminismo di Ti-ziano o a certe visioni cupe e squillanti del Tintoretto. Tuttavia tali ascendenti paiono subito non bastare a rendere ragione di un episodio così strano da rimanere isolato per secoli nel campo della pittura.
Ed è proprio per questo che, superato il primo acchito, di un autore così non si può non subire il fascino. Non solo per il gusto di ammirare qualcosa di originale e di ine-dito, bensì perché si è consapevoli che un pittore così non solo ha scritto da solo un capitolo originale della lunga vicenda del-la pittura in Europa, ma ha anche gettato dei semi che per molto tempo a venire con-tinueranno a portare frutto, risorgendo ina-spettati.
Del resto per lo stesso El Greco l’appro-do al suo personalissimo stile non fu l’epi-sodio di un momento, ma il culmine con-

L’EMANUELE 9/2009 - 57
IN VIAGGIOattraverso
l’ARTESACRA
sapevole di un’ampia esperienza umana, nel-la quale egli attraversa sostanzialmente tut-te le forme dell’arte sua contemporanea: vale la pena renderne brevemente conto, per ap-prezzare in modo ancora più marcato il suo contributo.
Domenikos Theotokopoulos nacque a Candia, sull’isola di Creta, nel 1541. Allo-ra l’isola era territorio veneziano, situazione che – dal nostro punto di vista – fu assai pro-pizia, dal momento che permise l’incontro e la reciproca fecondazione tra la pittura vene-ta e quella bizantina, che ancora sopravvive felicemente in Grecia e dintorni. Ne nacque quel particolare stile che va sotto il nome di veneto-cretese, i cui prodotti sono una vera e propria sintesi delle due tradizioni pittori-che appena citate: vi appare il classico stile bizantino delle icone, ieratico e trascendente, ma esso è reso con un’attenzione al colore, al chiaroscuro, alla costruzione delle figure, che i bizantini non conobbero mai e che fu invece appannaggio dei veneti.
Il giovane pittore, mentre ancora si tro-vava sull’isola dove era nato, si cimentò pro-prio con il dipingere tavole di questo tipo, ri-chieste dalla committenza e amate per la de-vozione privata della gente: oggi – grazie ad accurate ricerche – siamo a conoscenza di almeno tre opere dipinte in questi anni e con questo stile: la Dormizione della Vergine, un San Luca che dipinge la Madre e il Bambino e la Deposizione di Cristo nel sepolcro, tutte dipinte tra il 1560 e il 1567): si tratta di tavo-le, realizzate a tempera, o a olio, e oro, il cui stile è esattamente quello delle icone orien-tali, il quale è sostanzialmente rimasto inva-riato dall’epoca bizantina ad oggi.
Poco dopo il 1566, anno in cui viene ci-tato in un documento cretese con la qualifi-ca di maestro pittore, egli si trasferì a Vene-zia, dove rimase poco tempo, ma dove riu-scì comunque a lasciarsi impressionare pro-fondamente dalla pittura di Tintoretto, che all’epoca stava dipingendo le immense tele della Scuola Grande di San Marco, il cui ac-ceso colorismo metafisico si impose a Dome-nikos come un esempio di cui non si sarebbe mai più potuto dimenticare.
Già nel 1570 egli si trasferì a Roma, do-ve il miniaturista di origine dalmata Giulio
Clovio lo prese a ben volere, si fece ritrarre da lui (il dipinto, del 1570-72, si trova oggi al Museo Nazionale di Capodimonte, a Napo-li), e lo introdusse nel fecondo ambiente del-la Roma papale, dove egli ebbe occasione di ammirare le opere di Michelangelo, ricavan-done un’impressione altrettanto profonda.
Proprio mentre si trovava a Roma, Dome-nikos incontrò Diego de Castilla, Decano del Collegio dei Canonici della Cattedrale di To-ledo: fu questo l’incontro che in maniera più decisiva segnò la biografia, ma anche lo sti-le del giovane pittore. Gli venne, infatti, com-missionata la pala per l’altar maggiore del-la chiesa di San Domenico el antiguo (ora all’Art Insitut di Chicago), che egli dipinse nel 1577, interpretando il tema dell’Assunzio-ne della Beata Vergine Maria al Cielo. Al suc-cesso che coronò la presentazione della tela, seguirono innumerevoli altre commissioni, che fecero di Domenikos uno dei pittori più noti della Spagna del suo tempo, al punto ta-le che gli venne attribuito quell’appellativo, El Greco, che lo immortalò già presso i con-temporanei e in seguito presso i posteri, fino a noi. Alla Spagna egli rimase da allora sem-pre fedele, fino alla morte, occorsa a Toledo nel 1614, all’età di 73 anni.
Del resto fu proprio la Spagna, con la sua religiosità carica e solenne, che si espri-meva tanto in ridondanti architetture come in spettacolari retabli per gli altari maggio-ri, a contribuire forse più di tutto alla defini-zione dello stile di El Greco. I temi sacri, in-fatti, anche se non vanno trascurati i ritrat-
Particolare del dipinto, efficace per comprendere il particolarissimo tipo di pennellata di El Greco

58 - L’EMANUELE 9/2009
ti, costituirono sempre il suo soggetto prefe-rito: egli dipinse con forza ed efficacia tanto immense pale d’altare come piccoli formati per la devozione privata, in entrambi infon-dendo un profondo senso religioso dell’even-to sacro narrato.
E probabilmente proprio per esprime-re la forza trascendente della grazia divina, cui il dipinto rimanda, anzi, che attraverso il dipinto stesso sembra sprigionarsi attorno, egli sentì sempre più pressante l’esigenza di trasfigurare forme e figure, colori e paesag-gi, lasciandosi ormai nettamente alle spalle i canoni della pittura tradizionale, per spa-ziare in modo del tutto innovativo verso uno stile assolutamente inedito. Dalla sua tavo-lozza egli sceglieva ormai solo colori prima-ri, resi con tono lucente e smaltato; le figu-re umane si assottigliavano nella forma di fiamme, le quali parevano fremere, in un’at-mosfera prevalentemente cupa e burrascosa, senza tuttavia rinunciare ad allungarsi ver-so l’alto; le ambientazioni, a poco a poco, ve-nivano inghiottite da impenetrabili campitu-re nere, solo attraversate dal lampeggiare di guizzi improvvisi di una luce violenta, qua-si artificiale.
Nello scomporsi totale della forma, nello scomparire dei particolari, cui presto si ac-compagnò un uso sempre più rapido e som-mario della pennellata, non potè che trion-fare la dimensione essenziale dell’opera, il suo senso profondo e recondito, la verità di cui essa aspirava ad essere un pur minusco-lo frammento.
Al vertice, e al tempo stesso al termine, di questo percorso spirituale e artistico si collo-ca una delle ultime tele che El Greco dipinse: si tratta di una Adorazione dei Pastori, origi-nariamente realizzata per l’altare maggiore di quello stesso Monastero di San Domeni-co el antigiuo per cui egli, tanti anni prima, aveva prodotto la sua prima opera spagno-la. Alla morte del pittore, che dovette succe-dere di lì a poco, essa venne scelta per la sua tomba, collocata in una delle cappelle latera-li di quella medesima chiesa, prima di essere finalmente traslata al posto per il quale era stata pensata.
Anche davanti a questo dipinto, come di-cevo all’inizio, c’è bisogno di fermarsi a con-templare e a riflettere un po’ più a lungo: certamente esso ci sconcerta, forse ci ur-ta anche un po’, noi che siamo abituati a un ben diverso linguaggio per narrare della na-scita del Cristo, preferendo, soprattutto in
questo periodo dell’anno, l’atmosfera calda e rassicurante delle luminarie natalizie.
La pittura di El Greco ci porta, invece, di-rettamente dentro al mistero di cui la nasci-ta del Salvatore è l’inizio nel tempo: egli è la luce del mondo, e come tale fa la sua irruzio-ne nell’atmosfera surreale del dipinto. Tut-to sembra essere messo in movimento da es-sa: le figure vengono restituite alla vita e li-berate dalla prigionia del fondo scuro, per-ché illuminate dai raggi di quella luce; i lo-ro panneggi smaltati ne riflettono i baglio-ri improvvisi; i loro occhi ne sono quasi ac-cecati, come quelli del pastore che sta all’im-mediata sinistra della Vergine, il cui vol-to prende a sfavillare come un fuoco che di-vampa. E questa luce di straordinaria poten-za, quando raggiunge questi corpi, o anche le nubi del cielo o le rocce della terra, o per-sino quell’ignota architettura che si intrave-de sullo sfondo, ne smaterializza i contorni, così che il colore possa entrare direttamen-te a contatto con la luce e con essa mesco-larsi, fino a diventare un tutt’uno. Oltre al-la luminosità, sembra quasi di sentire il calo-re che va sprigionandosi attorno: il buio e il freddo di quella notte nera che tutto sembra-va aver raggelato, avvolto, vinto, fino a soffo-carlo, sono a poco a poco punti, attraversati, sconfitti dai raggi della luce che il Salvato-re è venuto ad accendere sulla terra. Da que-sto incontro, ogni cosa riceve nuova energia e nuova vita, tutto acquista una nuova forma e viene trasfigurato, ricreato: nulla è più co-me prima.
E davanti a questa vorticosa danza del-la luce e del colore, quel senso di smarrimen-to e quasi di angoscia che il dipinto ci aveva trasmesso (o che forse aveva semplicemente già trovato dentro di noi e portato a coscien-za) cedono il posto ad un irrefrenabile senso di partecipazione e di gioia. Ci verrebbe qua-si la voglia di entrarci, in questo dipinto, per gustare un po’ dell’abbaglio di quella luce, per esserne anche noi rischiarati, per assapo-rarne il calore, così vivo e intenso. E magari per prendere di volta in volta il posto di quei personaggi: e ora riempirci di stupore insie-me ai pastori (e persino al bue), ora danzare a braccetto con gli angeli in cielo. E alla fine fermarci con Maria, per lasciarci con lei ra-pire dalla meraviglia, per contemplare con lei il volto del Bambino, incandescente di lu-ce, e godere della grandissima gioia di averlo finalmente trovato, alla fine e al cuore della inesausta ricerca di cui è fatta la nostra vita.

“Adorazionedei Pastori”
1612, olio su tela,Madrid,
Museo del Prado
El GrEco

“ noi siamo eredi del lavoro delle generazioni che ci hanno preceduto e insieme costruttori del futuro di coloro che vivranno dopo di noi…”
di FranCesCa redoLFi
ATTUALITÀ Lettera ai cercatori di Dio
60 - L’EMANUELE 9/2009
Lavoroe festa

In questo nuovo appuntamento dedicato alla Lettera ai cercatori di Dio, affrontia-mo un altro interessante spunto offertoci
dal documento della Cei: il tema del lavoro.Se la Lettera gli ha dedicato un intero ca-
pitolo, è perché il lavoro è una dimensione importante della nostra vita. Senza sminuire l’importanza e la centralità di amore, fami-glia, affetti, sappiamo bene che l’occupazione che svolgiamo quotidianamente ci qualifica, ci dà un senso di appartenenza, ci aiuta a co-struire un tassello della nostra identità.
Una bella riflessione sul senso del lavoro ci arriva dalla Lettera ai cercatori di Dio:
«Non viviamo per lavorare, ma lavoriamo per vivere. Non lavoriamo per fare soldi – o almeno non dovremmo farlo solo per questo –, lavoriamo per vivere dignitosamente. Non lavoriamo solo per noi, ma per far vivere co-loro che non sono ancora in grado di lavora-re, i bambini, e coloro che non possono più lavorare, gli anziani. Il lavoro deve servire a realizzare la nostra dignità di persone. Non è una merce che si compra e si vende, ma un’attività umana libera e responsabile.
La crescita in consapevolezza e in respon-sabilità ci ha aiutato a scoprire un’altra ra-gione del nostro lavoro: lavoriamo per il be-nessere della collettività e dell’umanità in generale. In tal senso, il lavoro è un obbligo morale verso il prossimo: in primo luogo ver-so la famiglia, poi verso la società a cui si ap-partiene, la nazione di cui si è cittadini, l’in-tera famiglia umana. Noi siamo eredi del la-voro delle generazioni che ci hanno precedu-to e insieme costruttori del futuro di coloro che vivranno dopo di noi».
Il lavoro però non ha soltanto una dimen-sione sociale, ma possiede anche una forte connotazione religiosa. Il lavoro umano ha cioè un’ulteriore ragione d’esistere, oltre alla mera sussistenza, e i cristiani la trovano nel riferimento a Dio. E questa prospettiva «of-fre un respiro di speranza alla nostra fatica», una visione più ampia in cui collocare il no-stro impegno quotidiano.
«Mediante il lavoro l’uomo collabora con Dio nel portare a termine la creazione. Lo riferisce una delle prime pagine della Bib-bia. Dopo aver creato il mondo, Dio coman-da all’uomo e alla donna: “Riempite la ter-ra e soggiogatela, dominate sui pesci del ma-re e sugli uccelli del cielo” (Genesi 1,28). Sog-giogare la terra vuol dire prendere possesso dell’ambiente e governarlo, rispettando l’or-
dine posto in esso dal Creatore e sviluppan-dolo a proprio vantaggio, per soddisfare i bi-sogni propri, della famiglia e della società. In questo consiste l’impresa della scienza e del lavoro per umanizzare il mondo, al fine di farne la dimora dell’uomo, una casa di giu-stizia, di libertà e di pace per tutti».
Dio ha creato il mondo ma non lo ha “fi-nito” del tutto. Allora diventa compito dell’uo-mo farsi carico della “creazione” del mondo. L’uomo, come comandato da Dio, ha preso possesso della terra, abitandola, adattandola alle sue esigenze, trasformandola. Negli ulti-mi decenni, in particolare, si è assistito a dei cambiamenti di portata vastissima, grazie al-le nuove tecnologie.
«Non siamo però padroni del creato – ci ricorda la Lettera –. Dobbiamo collabora-re con Dio nel portarlo a compimento, ri-spettando la natura e le leggi insite in essa. Dio ci ha affidato il creato, perché potessi-mo custodirlo e perfezionarlo, non per sfrut-tarlo e manipolarlo a nostro piacimento. Ce lo ricorda ancora il libro della Genesi: “Il Si-gnore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardi-no di Eden, perché lo coltivasse e lo custodis-se” (2,15). Il lavoro – vissuto in condizioni ri-spettose della giustizia e della dignità uma-na, oltre che dell’ambiente affidatoci dal Cre-atore – è la via in cui l’uomo realizza questo compito».
Lavoro come obbligo morale verso il pros-simo, come compimento della volontà di Dio, dunque. Ottimi propositi, ma che spesso si scontrano con una realtà non sempre ro-sea. Non mancano infatti le contraddizioni e i problemi: c’è chi si rende conto di lavorare troppo e di non avere più tempo per sé o per la famiglia, ci sono i giovani sedotti dalle bel-le speranze di un’occupazione ben remunera-ta e rispondente alle loro aspirazioni, che in-vece trovano lavori privi della benché mini-ma garanzia.
Il lavoro, è bene ricordarlo, è insieme un diritto e una responsabilità. Ma oggi pur-troppo – e oltre a vederlo con i nostri occhi lo sostengono diversi esperti – tende ad esse-re sempre meno un diritto e molte persone rischiano di perdere il posto, o lo hanno già perso e potrebbero non trovare un altro im-piego. Un dramma che si consuma sempre più spesso a causa della crisi economica e di aziende che la “usano” come scusa per taglia-re il tagliabile. Un dramma non solo econo-mico, ma anche psicologico, perché, e qui ci-
L’EMANUELE 9/2009 - 61
Lavoroe festa

tiamo ancora la Lettera, «nel lavoro entrano in gioco la nostra dignità di persone, il senso e la qualità della nostra vita, l’esercizio quo-tidiano della nostra relazione con gli altri...». Perciò «percepiamo la difficoltà e perfino il dramma di chi non riesce a trovare lavoro. La negazione del diritto al lavoro, di cui sof-frono ancora tante donne e uomini di questo tempo, specialmente fra i giovani, non può lasciarci indifferenti. Per il lavoro impegnia-mo la maggior parte della nostra esistenza. Veniamo da esperienze e da modelli di tessu-to sociale in cui il lavoro era gravato da con-dizioni disumane: dannoso alla salute, cari-co di pericoli, segnato da orari insopporta-bili, pagato in nero. Oggi, certamente, mol-te cose sono cambiate, anche se non sempre e non per tutti».
Affiorano oggi problemi nuovi, connes-si alla globalizzazione, alla delocalizzazio-ne, alla concorrenza, alle difficoltà delle im-prese, alle ricorrenti crisi economiche. È cre-sciuto il livello medio della ricchezza, ma nel contempo si sono allargate le aree della po-vertà e dell’emarginazione. E si diffonde an-che nel mondo industrializzato maggiore in-certezza, più “liquidità” e flessibilità, meno fiducia, meno senso di “fedeltà” reciproco tra azienda e lavoratore.
C’è meno impegno a voler mantenere un rapporto lavorativo, molta facilità nel tron-carlo e lasciare quindi la persona da sola alle prese con la difficoltà di cercare altro.
Nel contesto attuale dominano logiche che tante volte calpestano la dignità della persona umana e il suo diritto al lavoro.
«Non è difficile constatare come, pur-troppo, la cultura occidentale abbia messo alla base dell’idea del lavoro una prospettiva economicistica e materialistica, che finisce con il riservare il primato al denaro. Questo è uno dei più gravi errori del nostro tempo, da cui deriva un principio perverso nella vita sociale: avere sempre di più, secondo la logi-ca per cui la ricchezza deve produrre nuova ricchezza e bisogna perciò tendere sempre al massimo profitto.
Una delle conseguenze più tragiche è sot-to gli occhi di tutti: uno sviluppo squilibrato, che crea diverse velocità di crescita, per cui i popoli ricchi diventano sempre più ricchi e i popoli poveri sempre più poveri. Questa di-sparità va accentuandosi anche tra le compo-nenti di una stessa comunità».
Tuttavia, fortunatamente, esistono anche realizzazioni positive, persone e aziende im-
pegnate che hanno saputo trasformare le ter-re più aride e rendere i contesti di produzio-ne più difficili luoghi di umanità benestante, promuovendo la qualità della vita di tutti.
Tanto però resta ancora da realizzare. «Siamo consapevoli che molto di quello che c’è da fare riguarda la direzione e il senso del nostro impegno, la qualità del nostro la-voro e dell’ambiente in cui esso si svolge, la sicurezza che prevenga ogni possibile dan-no ai lavoratori. Abbiamo tutti domande in-quietanti e possediamo frammenti di rispo-ste concrete.
Condividendo le une e le altre, possiamo progettare un futuro forse più felice del pre-sente, da condividere come protagonisti».
Un ultimo tema affrontato nella Lettera riguardo al lavoro è la necessità della festa e del riposo.
«Sì, c’è un modo concreto per esprimere la dignità di chi lavora: sospendere l’attività lavorativa con il riposo settimanale, a somi-glianza di Dio che, dopo avere creato il mon-do, si riposò. L’uomo partecipa al lavoro e al riposo di Dio: entrambi sono per lui una be-nedizione e un dono, fecondi di vita e neces-sari per affermare la dignità della persona umana».
La pausa settimanale non ha solo lo sco-po di recuperare le forze e riposarsi, per poi ricominciare la settimana ritemprati.
In realtà, riposare e celebrare la festa «sono espressione della “libertà” dell’essere umano, esperienza di comunione in famiglia e di incontro fraterno nella comunità, pos-sibilità di ravvivare la relazione con la natu-ra… Partecipando all’Eucaristia domenicale i cristiani sono chiamati a liberarsi dall’ido-latria del denaro, del possesso, del lavoro os-sessivo e a crescere nella sobrietà e nella soli-darietà con i più deboli». Anche se spesso og-gi manca il tempo vuoto, viene meno la pau-sa domenicale e, anche quando c’è, troppo spesso è riempita da altro lavoro, quello do-mestico.
«La festa e il riposo restano per molti un’aspirazione, troppo lontana per essere sperimentata. Ma non è giusto rassegnarsi e non ci aiuta a crescere in umanità con-statare le esigenze, senza venirvi incontro e immaginare alternative. Dobbiamo cercarle insieme, mettendo a frutto fantasia, amore, competenza e responsabilità. In questa ricer-ca tutti siamo chiamati a collaborare, perché la posta in gioco riguarda tutti. E lo sguardo della fede ci è di grande aiuto».
62 - L’EMANUELE 9/2009

L’EMANUELE 9/2009 - 63
SPIRITUALITà LITURGICA (L. E. Diez Valladares sss)Alla scoperta della spiritualità liturgica ....................................1/4Fonte e culmine ...................................................................................................................2/4La Liturgia, incontro con Cristo ................................................................3/4La Liturgia, unificatrice della vita cristiana ........................ 4/4Vivere ciò che celebriamo .................................................................................5/4Centrati in Cristo ..................................................................................................................6/4Animati dallo Spirito ....................................................................................................7/4Guidati dalla Parola di Dio ................................................................................ 8/4Una spiritualità comunitaria ed ecclesiale ..........................9/4
COnTEMPLARE L'EUCARISTIA (G. Moretti sss)Venite, prostrati adoriamo ................................................................................1/8«Il Signore Dio tu adorerai…» ...................................................................2/8Ti adoriamo Trinità .........................................................................................................3/8L'adorazione nella storia della chiesa cattolica .........4/8Lasciarsi formare dal mistero celebrato e adorato ...................................................................................................... 5/8Come adorare? ......................................................................................................................6/8Attirare l'attenzione sui segnidel Pane e del vino ..........................................................................................................7/8Adorazione e combattimento spirituale ...............................8/8Adorazione e vita evangelica ..................................................................... 9/8
BIBBIA (D. Carbonaro omd)Li amò sino alla fine ...................................................................................................1/12La via del cuore ..................................................................................................................2/11L’amore promesso ........................................................................................................3/11La vera vite .................................................................................................................................4/11Il mondo vi odia ................................................................................................................5/11L'opera dello Spirito ..................................................................................................6/11Dalla tristezza alla gioia .....................................................................................7/11La vittoria sul mondo .............................................................................................8/11La preghiera di Gesù ...............................................................................................9/11Testimoni:Una vita spesa tra le case di Maria ................................................ 9/18
CATEChESI MISTAGOGICA (B Arturo Aiello)Mistero della fede .........................................................................................................1/16Ricordati… ................................................................................................................................2/14Osiamo dire… ..................................................................................................................... 3/14Una Parola soltanto ..................................................................................................4/14“Le cose sante ai santi” ........................................................................................5/14Ad occhi chiusi per essere visto ......................................................... 6/14Un paese innocente ..................................................................................................7/14L’Amore dopo l’Amore… ................................................................................8/14Carissimo lettore… ....................................................................................................9/14
LE DOMAnDE DEI GIOVAnI (A. Genziani sss)Dio e i giovani: un amore che si risveglia ......................... 1/37Non capisco il no che mi viene detto! ....................................2/18Ricerca della felicità… oppure dono? .................................... 3/18Il mistero oltre le sbarre ....................................................................................4/18Amare per essere amati:Chiara alla ricerca di sé e… .............................................................................7/18Un navigatore per… amico ........................................................................8/18
CAMMInO DI PREGhIERA (G. Polini sss)«Amo la tua casa, Signore!» ........................................................................1/31Il pellegrino: vegliato e custodito da una Sentinella sempre vigile ........................................................2/31Il pellegrino: incamminato e orientato verso una Presenza ...................................................................................................3/31Il pellegrino: un orante con le mani e gli occhi aperti ad uno Sguardo ..................................................4/31Il pellegrino: un prigioniero liberato dall’inganno di un laccio .................................................................................5/31Il pellegrino: circondato e avvolto dalla premura di Dio ...............................................................................................6/31Il pellegrino: uno che semina nel piantoe raccoglie con il canto ........................................................................................7/31Il pellegrino: dal mattino alla sera custodito dal Dio Provvidente .............................................................8/31
INDICE ANNATA 2009[il primo numero indica il numero della rivista, il secondo la pagina]

64 - L’EMANUELE 9/2009
Il pellegrino: un tremante d’amoreper il segreto di una vita feconda ...................................................9/31
fAMIGLIA OGGI… (M. A. Masino)Malinconia .................................................................................................................................1/54Difficoltà a vivere in coppia .......................................................................2/37Il feto sogna: un invito ad approfondire la nostra meditazione ..........................................................................................3/37La via della piccolezza .........................................................................................4/37L’arte di camminare ..................................................................................................5/39Cibo, ieri e oggi .................................................................................................................6/39Con la testa e con il cuore… ......................................................................7/37Famiglia: il vocabolario della gioia ...............................................8/39Se un figlio si consacra a Dio…. .........................................................9/37
ORDInI MOnASTICI E ABBAzIE (G. Fantoni)Alle origini del monachesimo occidentale: l’abbazia di Montecassino ............................................................................1/40Montecassino: la regola e le vicende politiche .....2/40Montecassino: la proprietà fondiaria .......................................3/40Bobbio: San Colombano,un monaco venuto dall’Irlanda ..........................................................4/40Bobbio: la fondazione .......................................................................................... 5/42Bobbio: la proprietà fondiaria ...............................................................6/42San Benedetto Polirone: la fondazione ............................... 7/40San Benedetto Polirone:un monastero e la sua storia ....................................................................8/42San Benedetto Polirone: la proprietà fondiaria ......9/40
PELLEGRInI In CAMMInO (+ Carlo Mazza)La vita umana è un cammino… ........................................................1/44La persona al centrodella comunità pellegrinante .................................................................2/44Le dimensioni interiori del pellegrino ....................................3/44Il “pellegrinaggio ecclesiale” come esperienzain atto del mistero della Chiesa in itinere ........................4/43Teologia e spiritualità del pellegrinaggio .......................5/45Eucaristia: cibo dei pellegrini ..................................................................6/45Il pellegrinaggio come metafora della vita ...................7/43Urgenza dello spirito e senso della vita ..............................8/45Gesù, il pellegrino ........................................................................................................ 9/43
In CAMMInO COn SAn PAOLO (G. Crocetti sss)Piacere a Dio e diventare santi ..............................................................1/47Amore fraterno, serenità, laboriosità .......................................2/47Saremo sempre con il Signore ..............................................................3/47Vigilate, siate pronti .................................................................................................4/48Vivete in pace tra voi ..............................................................................................5/48Questa lettera sia letta ai fratelli .......................................................6/48Il Dio della pace vi santifichi ..................................................................... 7/46Siate lieti, non spegnete lo Spirito ................................................8/48La prima Tessalonicesi nella nostra vita ..............................9/46
ABISSO DI LUCELa spiritualità liturgica di Divo Barsotti (A. Porfiri)
La presenza assente .................................................................................................1/50Alle pendici del silenzio ....................................................................................2/50La liturgia cosmica ......................................................................................................3/50Il primato della bellezza ...................................................................................4/51Possedere Dio ..................................................................................................................... 5/51Lo spasimo della materia ...............................................................................6/51Parola di Dio, Parola in Dio ...........................................................................7/49La vera vita ................................................................................................................................9/54
PROPOSTA DI LECTIO (L. Zanchi sss)«Gesù accarezza e benedice i bambini…» ....................2/54Guarigione di due ciechi e di un muto .................................. 4/58Gesù siede a mensa con i peccatori ............................................ 5/54La vedova di Nain .......................................................................................................... 6/54La peccatrice perdonata ...................................................................................7/52La guarigione della suocera di Pietro ......................................8/52Date loro voi stessi da mangiare ......................................................9/50
ARTE E fEDE (G. Gusmini)Carlo Ceresa: «San Felice da Cantaliceche adora la Natività» ......................................................................................................1/57Caravaggio: «Cena in Emmaus» ..................................................................2/57Georges de La Tour: «La Maddalena penitente» .........3/57Raffaello Sanzio: «Lo sposalizio della Vergine» ................4/53Giovanni Bellini:«Il Cristo deposto sorretto da due angeli» ....................................5/58Cima da Conegliano: «Madonna dell’arancio» ..............6/58Antonello da Messina:«San Girolamo nello studio» ................................................................................7/56Annibale Carracci: «Domine, quo vadis?» .................................8/57El Greco: «Adorazione dei pastori» .....................................................9/56
ATTUALITàLettera ai cercatori di Dio (F. Redolfi)
Ripartire dai poveri .....................................................................................................1/61Come un uomo sulla terra ............................................................................2/62David Grossman ..............................................................................................................3/62La donna è una persona ..................................................................................4/62Educarci alla sobrietà ............................................................................................5/62Curarsi con l’aiuto della natura ............................................................6/62La conquista della felicità ...............................................................................7/62«L’uomo non può vivere senza amore» ...............................8/62Lavoro e festa .......................................................................................................................9/60
ChIESA (C. Casalegno)L’amicizia di due santi (1a parte) ................................................................ 5/18L’amicizia di due santi (2a parte) ................................................................ 6/18