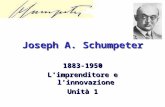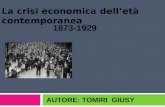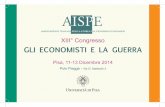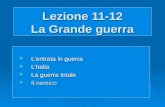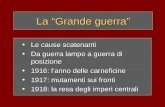LE NUOVE GUERRE DELL'ETÀ GLOBALE. · 6 Su Schumpeter e la guerra si veda AA.VV, Le teorie della...
Transcript of LE NUOVE GUERRE DELL'ETÀ GLOBALE. · 6 Su Schumpeter e la guerra si veda AA.VV, Le teorie della...

"La nostra narrazione può confermare ciò che molti hanno sempre sospettato, cioè che la storia è il documento dei crimini e delle follie del genere umano [...] Ci sono meno ragioni di sperare nel futuro di quante ce ne fossero a metà degli anni '80 [...] Il mondo rischia sia l'esplosione che l'implosione. Il mondo deve cambiare". Eric Hobsbawm, Il Secolo breve.
"The first casualty when war comes is truth". Senatore Hiram Warren Johnson, 1918.
"La motivazione economica non basta da sola a spiegare l'entità, la brutalità e l'assoluta crudeltà delle nuove guerre". Mary Kaldor, Le nuove guerre.
LE NUOVE GUERRE DELL'ETÀ GLOBALE. DOPO IL 'SECOLO BREVE'. Dal 1989 ad oggi.

PREMESSA.
Ed eccoci arrivati all'ultima lezione: una rapida nota sulle 'nuove guerre' che a partire dal crollo del muro di Berlino (1989) e dalla dissoluzione dell'U.R.S.S. (1991) hanno insanguinato e insanguinano il nostro mondo. Con questo tema si chiude il presente libro, un lavoro informativo che ha presunto di svolgersi alla maniera di Melchisedec e di evidenziare la connessione strutturale dei macro-fenomeni del presente storico. Le 'nuove guerre' di cui parleremo brevemente rispondono anche (certo, non solo e non sempre!) al bisogno politico di deviare in senso nazionalistico e xenofobo le tensioni sociali che la disoccupazione tecnologica (di cui abbiamo parlato nella prima lezione) produce; le 'nuove guerre' sono anche (sia pur non esclusivamente) la conseguenza delle devastazioni ambientali che spingono i popoli a spostarsi e lottare per il controllo delle risorse naturali sempre più scarse (si vedano le pagine dedicate alla seconda lezione, e si pensi -per far riferimento anche solo a un caso- alla peggior siccità avvenuta in Africa orientale negli ultimi 60 anni: la siccità del 2011 in Etiopia e Somalia, con le relative turbolenze politiche); le 'nuove guerre' sono caratterizzate -dice Mary Kaldor- da una “assoluta crudeltà”1, quella stessa brutalità assoluta che abbiamo visto essere messa in atto dal nazionalismo razzista hitleriano (terza lezione) e dal progetto totalitario titino (quarta lezione); le 'nuove guerre' sono intinte (molto spesso) di quel furor religioso fondamentalista che abbiamo incontrato nella quinta lezione; infine, lo studio delle dinamiche psicologiche delle 'nuove guerre' ci offre una probabile e terribile verità: molti dei contractors (le decine di migliaia di soggetti che intervengono in questi nuovi conflitti come mercenari) sono giovani (anche occidentali) che soffrono di quel nichilistico senso di vuoto esistenziale di cui ci ha parlato Galimberti nella sesta lezione; molti di essi (non tutti) sono giovani che vanno in guerra per denaro, per 'sport' e bisogno di avventura; per coprire quel niente di senso che avvertono nella loro interiorità. Tutto si tiene, e purtroppo 'si tiene' molto male.
Le pagine che seguono non vogliono essere una riflessione sulle filosofie della guerra da Eraclito a Nietzsche; né vogliono essere un trattato di polemologia, e men che meno possono essere una cronaca dettagliata delle guerre degli ultimi 25 anni (anche se verrà fornita una veloce elencazione dei principali conflitti di questo periodo). Cercherò semplicemente di ricordare i caratteri definitori e generali di questo attuale “tempo della guerra”2, come dice il generale Fabio Mini. E lo farò cominciando con una riflessione sui modelli interpretativi delle relazioni internazionali dell'ultimo quarto di secolo. Cominciando con il sottolineare i limiti evidenti della celebre formula di Francis Fukuyama, l'idea della fine della storia.
A – 'FINE DELLA STORIA' O 'FINE DELLA GEOGRAFIA'? Come è già stato ricordato, nel 1989, addirittura alcuni mesi prima che il muro di Berlino venisse smantellato, Francis Fukuyama sviluppava il concetto della End of History: la storia, intesa come sequenza devastante di guerre e conflitti, sembrava allo storico ed economista nippo-statunitense essere giunta alla fine. Il bipolarismo U.S.A.- U.R.S.S. che aveva caratterizzato la seconda metà del Novecento e che aveva prodotto la Guerra Fredda, il timore di un conflitto termo-nucleare e le tante proxy-wars (le 'guerre per procura', come quelle di Corea, del Vietnam o dell'Afghanistan), ebbene, il bipolarismo suddetto pareva avere i giorni contati (l'U.R.S.S., economicamente e politicamente stremata, si sarebbe disciolta alla fine del 1991, e gli Stati Uniti sarebbero rimasti l'unica super-potenza planetaria). Stante l'imminente trionfo planetario del sistema economico capitalistico e del sistema politico liberal-democratico (e quindi con la globalizzazione del libero mercato e delle idee di stampo occidentale), Fukuyama prevedeva
1 Mary Kaldor, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'era globale. Carocci, Roma, 2003 (ed. or. 1999), p. 122.2 Fabio Mini, Soldati, Einaudi, Torino, 2008, p. 6.

dunque che in futuro non vi sarebbero più state guerre catastrofiche. La pace portata dal libero mercato e dalla democrazia liberale si sarebbe imposta ovunque, essendo venuto meno (e a tutto vantaggio del primo) lo scontro tra capitalismo e socialismo, cioè il conflitto fondamentale che aveva caratterizzato tutto il Novecento. L'incauto ottimismo celebrativo spingeva Fukuyama fino al punto di affermare che il libero mercato e la democrazia liberale rappresentavano “il punto di arrivo dell'evoluzione ideologica dell'umanità” e la “definitiva forma di governo tra gli uomini”3.
[NOTA A MARGINE. LA GUERRA NELLA CULTURA LIBERAL-DEMOCRATICA E NEL MARXISMO. Bisogna poi dire che del resto, come riconosce Francesco Tuccari, “gli argomenti di Fukuyama […] aggiornavano all'epoca post-bipolare una assai lunga e autorevole tradizione di riflessioni che avevano variamente insistito sulle inclinazioni e le virtù strutturalmente pacifiche dei regimi politici non autoritari e soprattutto dello 'spirito del commercio'”4, uno spirito incompatibile con la guerra. Gli argomenti di Fukuyama, in altri termini, non erano particolarmente originali. Già agli inizi dell'Ottocento il liberale francese Benjamin Constant aveva sostenuto con forza che la guerra nuoce all'economia, devasta le terre e interrompe i commerci, cioè che la guerra -anche quando risulta vittoriosa- “costa infallibilmente più di quanto non renda”. La stessa idea, cioè l'idea secondo la quale la diffusione del sistema industriale e della mentalità capitalista renderà superate tutte le guerre, la si può facilmente ritrovare nei grandi esponenti della cultura positivista, in Saint-Simon (per il quale “l'industria è la nemica della guerra”5) e in soprattutto in Comte che, come è ben noto, contrappone nel suo Corso di filosofia positiva (1830-1842) lo stadio positivo delle società umane (cioè lo stadio industriale e pacifico, quello della piena maturità umana) allo stadio teologico-metafisico, violento e infantile, proprio di una umanità ancora 'primitiva' e immatura. Poi, poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, il concetto viene ribadito dal britannico Norman Angell in un libro che in pochissimo tempo diventa un best-seller del mondo occidentale: La grande illusione (1909). La 'grande illusione' di cui parlava Angell era esattamente quella di cui avevano già discusso Constant, Saint-Simon, Comte, Spencer e tanti altri: l'illusione che la guerra e l'aumento del potere militare potessero aumentare il benessere economico delle nazioni. E infine non si può non ricordare almeno a grandi linee la Sociologia dell'imperialismo (1919) dell'economista austriaco Joseph Schumpeter, non foss'altro perché in questo lavoro Schumpeter si opponeva in modo netto alla linea interpretativa marxista del fenomeno bellico, una linea che Lenin e Jaures avevano sviluppato pochi anni prima. Se per Lenin le guerre e le imprese coloniali sono il frutto dell'azione dei gruppi capitalisti, cioè di quei trusts e cartelli che cercano di conquistare mercati e materie prime a livello planetario; se per Jean Jaures “il capitalismo porta con sé la guerra così come il nembo porta il temporale”, per Schumpeter -tutt'al contrario- è proprio la mancanza di spirito imprenditoriale e di calcolo capitalistico a causare i conflitti. Le guerre sono per l'austriaco la conseguenza del permanere di una mentalità atavica, 'medieval-feudale', belluina, improntata a codici di valore che pongono l'onore guerriero al di sopra dell'onesto lavoro6. Schumpeter ricalca Constant: le guerre sono sempre 'anti-industriali': costano più di quanto possano rendere! Inutile dire che la teoria del carattere pacifico del mercato (una teoria dai lunghi natali, e che dunque da Constant risale la scala della storia fino a Fukuyama) è sempre stata assolutamente osteggiata e addirittura derisa dal pensiero della sinistra socialista, per la quale le guerre hanno soprattutto motivazioni economiche legate alla ricerca di petrolio o colonie etc.]
Va detto poi che l'ottimismo di Fukuyama riguardo alla fine della storia (intesa come fine delle guerre) si diffuse rapidamente e diventò l'opinione condivisa da moltissime persone in Occidente. Sembrò per un breve momento (tra il 1989 e il 1991) che l'umanità si fosse davvero incamminata verso la realizzazione dell'ideale kantiano della pace perpetua7. Oggi sappiamo bene che purtroppo la 'pace perpetua' è ben lontana dal tradursi in realtà. Indubbiamente la globalizzazione economica e la mondializzazione dei costumi e dei consumi ha fatto giganteschi passi in avanti, come prevedeva Fukuyama, ma l'integrazione economica si è accompagnata alla frammentazione politica: molti Stati sovrani sono esplosi o implosi attraverso guerre sanguinose (come nel caso della Jugoslavia, dell'Iraq, dell'Ucraina orientale, del Sudan etc.); le guerre tra gli Stati e soprattutto dentro gli Stati sono tornate numerose e violentissime; gli Stati
3 Citato in Francesco Tuccari, La politica mondiale dopo il 1989, Loescher, Torino, 2003, p. 44.4 Francesco Tuccari, op. cit., p. 48.5 Citato in Gaston Bouthoul, Sociologia delle guerre. Trattato di polemologia, Pgreco Edizioni, Milano, 2011
(ed. or. 1951), p. 102.6 Su Schumpeter e la guerra si veda AA.VV, Le teorie della guerra e della pace, Piemonteuropa (supplemento al n.1
del 1985), Torino, pp. 33-36.7 Francesco Tuccari, op. cit., pp. 42-44.

nazionali stessi sono entrati in crisi, erosi da fattori e forze interne (localismi, regionalismi, tribalismi, politiche dell'identità e 'noismi' vari) e da fattori e forze esterne (gli interessi delle grandi corporations multinazionali e transnazionali, capaci di piegare ai loro desiderata i governi nazionali, di controllarli e pilotarli; gli interessi di quelle imprese multinazionali che Tuccari considera come “le più potenti forze politiche del nostro tempo”8). Come ha ricordato Antonio Negri,
il denaro, la tecnologia, il lavoro e le merci attraversano con crescente facilità i confini nazionali; lo Stato-nazione ha cioè sempre meno potere per regolare questi flussi e per imporre la sua autorità sull'economia […] Tuttavia, il declino della sovranità dello Stato-nazione non significa che la sovranità, in quanto tale, sia in declino. […] La sovranità ha assunto una forma nuova, composta da una serie di organismi nazionali e sovranazionali uniti da un'unica logica di potere. Questa nuova forma di sovranità globale è ciò che io chiamo Impero9.
In altri termini, la globalizzazione economica e l'omologazione dei costumi ha probabilmente condotto alla formazione dell'Impero di cui parla Negri (l'impero non-localizzato delle corporations), ma sicuramente non ha impedito (o forse addirittura ha favorito) la frantumazione politica di molti Stati attraverso le nuove guerre e in generale ha condotto all'indebolimento della sovranità statuale. Le guerre, anziché scomparire come residui atavici di un passato ormai morto, sono tornate a dominare la scena mondiale, assumendo -come vedremo- aspetti del tutto nuovi. Tantissime nuove guerre, dunque. La storia non è finita. Semplicemente, la storia ha messo fine alla formula della 'fine della storia'. O, come ricorda con molta efficacia Maddalena Oliva, “History is on the move again”10. E forse bisognerebbe aggiungere a tal riguardo anche le annotazioni caustiche di Zygmunt Bauman e Paul Virilio, i quali preferiscono parlare di “fine della geografia”11: non è finita la storia, bensì la geografia, nel senso che le distanze geografiche e i confini sono stati perforati e superati dai capitali senza frontiere, da internet, dalla rivoluzione telematica e dalla omologazione degli stili di vita, e ciò che era lontano è diventato vicino. Nel senso che, ancora, la guerra si fa quasi dappertutto, e spesso in maniere assai simili. Nel senso, dunque, che si è affermata non la pace ma un nuovo disordine mondiale, un vero e proprio Pandaemonium bellico senza limiti geografici: attacchi terroristici in Francia e in Belgio; guerre asimmetriche e preventive in Iraq e Siria; guerre ai cartelli della droga in Messico etc. etc. Con l'economia e gli stili di vita, pare essere stata globalizzata anche la violenza bellica: c'è “il contadino che nel pieno della giungla del Sud-est asiatico beve coca-cola”, e c'è “il notabile africano alla guida di una Toyota in un villaggio della savana”; ci siamo noi che con un semplice clic annulliamo la geografia inviando una e-mail a un amico oltre-oceano; ma c'è anche -troppo spesso!- “il cecchino serbo che indossa scarpe Adidas e ascolta Madonna nel suo walkman mentre spara sui civili di Sarajevo”12.
È giunto il momento, a questo punto, di dare un rapido sguardo ad alcune delle principali (nel senso di 'più sanguinose') guerre che hanno costellato la storia globale degli ultimi 25 anni. Naturalmente, si tratterà di una presentazione inevitabilmente e ampiamente incompleta, e del tutto sommaria.
B) I PRINCIPALI CONFLITTI DEL PERIODO 1989-2017.
8 ivi, p. 28.9 Michael Hardt, Antonio Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Milano, Rizzoli, 2002, pp. 13-14.10 Maddalena Oliva, Fuori fuoco. L'arte della guerra e il suo racconto, Odoya, Bologna, 2008, p. 20.11 Si veda Francesco Tuccari, op. cit., p. 8.12 Francesco Tuccari, op. cit., p. 22.

1. 1991: Prima Guerra del Golfo. Bombardamenti aerei statunitensi e inglesi su Baghdad. Gli iracheni di Saddam Hussein abbandonano il Kuwait, che avevano invaso. Gli occidentali intervengono in esecuzione della Risoluzione 660 dell'O.N.U, e l'intervento -pertanto- è avallato dal Consiglio di Sicurezza. Si tratta dell'operazione Desert Storm.
2. Iniziano nel 1991 le “guerre jugoslave”, che si protrarranno fino al 1999. Scontri devastanti tra serbi, sloveni, croati e bosniaci di varia nazionalità e religione: le guerre assumono un marcato carattere etnico. Nel 1995, come è noto, si verifica il massacro di Srebrenica: più di 8.000 civili, musulmani bosniaci, vengono massacrati dalle truppe serbo-bosniache di Mladic, sotto gli occhi dei caschi blu olandesi.
3. 1993: gravi scontri in Somalia tra le truppe O.N.U (inviate per porre fine alla guerra civile) e le bande del generale Aidid.
4. 1994: in Ruanda infuria la guerra civile tra hutu e tutsi, nella pressoché totale indifferenza dell'O.N.U. Le persone massacrate a seguito dello scontro etnico-tribale sarebbero almeno 500.000, secondo Human Rights Watch, ma altre fonti portano il numero complessivo ad almeno 800.000 vittime.
5. 1994-1996: 100.000 sarebbero i civili ceceni uccisi durante la guerra per l'indipendenza della Cecenia (regione
caucasica). La Russia post-comunista guidata da Boris El'cin si oppone ai ceceni in una serie di terribili battaglie per il controllo della capitale Groznyj, ma alla fine è costretta a riconoscere l'indipendenza della nuova repubblica.
6. 1995: l'assassinio di Yitzhak Rabin, leader israeliano che aveva firmato un accordo di pace con il leader palestinese Arafat (a Washington, nel 1993, alla presenza del presidente Bill Clinton), è un durissimo colpo al processo di pacificazione di tutta l'area medio-orientale. In Israele salirà al potere la destra di Netanyahu.
7. 1996-1997: Prima Guerra del Congo. Scontri inter-etnici tra hutu e tutsi congolesi, questi ultimi guidati da Laurent Kabila e appoggiati dal Burundi e dall'Uganda. Kabila inizia la ribellione contro il governo di Mobutu, sanguinario dittatore del Congo (l'ex Congo Belga o Zaire, come allora si chiamava l'attuale Repubblica democratica del Congo, ricchissimo di diamanti, oro, coltan, rame e tanti altri minerali preziosi sfruttati da compagnie straniere). I civili uccisi ammonterebbero a 250.000.
8. 1998-2003. scoppia e dilaga la Seconda Guerra del Congo, chiamata anche “grande guerra africana”, Secondo tutti gli studiosi questa è stata la guerra più sanguinosa tra tutte quelle combattute dai tempi della Seconda Guerra Mondiale! Tale conflitto ha coinvolto 8 stati africani (tra gli altri Ruanda, Burundi, Uganda, Namibia, Zimbabwe, Angola) ed è stato combattuto soprattutto da milizie mercenarie e milizie popolari Mai-Mai (guidate da anziani della tribù, capi di villaggio e vari signori della guerra locali). I combattimenti (e le carestie e le malattie conseguenti alla guerra) hanno causato la morte di circa 5 milioni e mezzo di persone. Naturalmente, il conflitto -complicato dalle lotte etniche tra hutu e tutsi- aveva tra le sue ragioni di fondo il controllo delle risorse minerarie della regione centro-africana.
9. 1999: è l'anno della guerra dell'Occidente in Kosovo, regione della ex-jugoslavia a maggioranza albanese che sta subendo una dura repressione per mano dei serbi. La Serbia (la Repubblica federale iugoslava guidata da Slobodan Milošević) non intende concedere l'indipendenza al Kosovo. Massacri e violenze imperversano tra milizie serbe e membri dell'UCK (le forze di liberazione del Kosovo, formazione terrorista albanese) . La strage di Račak (45 corpi di civili kosovari trovati uccisi in un fosso, strage di cui vengono accusati i serbi) acuisce la crisi e fornisce il pretesto finale per l'intervento umanitario armato dell'Occidente contro la Serbia, ma Fabio Mini e altri non esitano a dichiarare “falso” l'evento13. La N.A.T.O. interviene (senza alcun mandato O.N.U) per fermare la 'pulizia etnica' effettuata dai serbi con bombardamenti aerei su Belgrado, e alla fine i serbi sono costretti a ritirarsi dal Kosovo. Come ricorda Alessandro Dal Lago, “la N.A.T.O. si è assunta il compito di intervenire in Kosovo in 'nome del mondo', estromettendo di fatto l'O.N.U. e segnandone il declino come organismo politico-diplomatico incaricato di dirimere conflitti o controversie internazionali”14
Anche l'aeronautica militare italiana ha partecipato all'intervento.
10. 1999-2009: sono gli anni della Seconda Guerra Cecena. La Federazione Russa (guidata dal 2000 dal presidente Putin) attacca la Cecenia e riconquista gran parte del territorio della repubblica caucasica ampiamente infiltrata da terroristi islamisti (che combattono a fianco dei separatisti ceceni).
11. 2001- in corso: guerra in Afghanistan. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 gli U.S.A di George Bush iniziano la “guerra al terrore” con l'invasione dell'Afghanistan dominato dai talebani del mullah Omar. Lo scopo dichiarato è quello di distruggere al Qaida e catturare o uccidere Osama bin Laden, responsabile degli attacchi dell'11 settembre e
13 Fabio Mini, Perché siamo così ipocriti sulla guerra?, Chiarelettere, Milano, 2012, p. 24.14 Alessandro Dal Lago, Polizia globale. Guerra e conflitti dopo l'11 settembre, Ombre Corte, Verona, 2003, p. 48.

ospitato dai talebani (bin Laden sarà poi ucciso nel 2011 da forze speciali statunitensi in Pakistan). L'invasione dell'Afghanistan (operazione Enduring Freedom) non ha l'esplicita autorizzazione dell'ONU ma riceve comunque un vasto sostegno internazionale. Anche l'esercito italiano viene coinvolto in Afghanistan (dal 2002-2003) come membro della missione Isaf (International security assistance force) voluta dalla NATO per sostenere la lotta contro i talebani con interventi militari ma anche con compiti di assistenza e azioni umanitarie a favore delle popolazioni locali. Dall'inizio della missione Isaf ad ottobre 2015 sono morti 52 militari italiani (non tutti a seguito di scontri armati), ricorda il sito internet di Internazionale. Altra importante osservazione: alla fine del 2009 -ricorda la CNN- in Afghanistan erano presenti più di 100.000 contractors, milizie private a contratto (cioè mercenari) che operano per conto del Pentagono (U.S.A.). E' segno evidente della 'privatizzazione' della guerra in corso. Sempre più mercenari e sempre meno soldati regolari.
12. 2003-2011: sono gli anni della Seconda Guerra del Golfo: una coalizione internazionale (la coalizione dei volenterosi,
the coalition of the willing ) guidata dagli U.S.A. di George Bush junior attacca l'Iraq di Saddam Hussein (che verrà catturato e impiccato a fine 2006). Lo scopo dichiarato della guerra è di deporre Saddam per timore (del tutto infondato, come si saprà poi15) che egli possa dotarsi di armi di distruzione di massa, (in tal senso, la guerra dell'Occidente diventa una guerra preventiva) e per stroncare l'appoggio iracheno al terrorismo islamista (altro motivo che si rivelerà inconsistente). L'attacco, non approvato dall'O.N.U., genera una profonda instabilità politica che perdura tutt'ora, nonostante il conflitto sia stato dichiarato concluso con il passaggio nel 2011 di tutti i poteri al nuovo governo iracheno insediato dagli statunitensi. Anche l'Italia ha partecipato al conflitto (33 i caduti militari italiani, e molti durante l'attacco a Nasiriya nel 2003). Non meno di 160.000 i civili iracheni morti durante il conflitto. E anche in questo conflitto non sono mancati numerosissimi casi di crudeltà, imputabili ad entrambe le parti (sono note le torture inflitte da truppe americane a prigionieri iracheni nella prigione di Abu Ghraib, a pochi chilometri da Barghdad). Circa 160.000 sono anche i contractors attivi in Iraq a fine 2007, secondo i dati del New York Times.
13. 2003- in corso. Nel 2003 inizia la Guerra del Darfur (Sudan). Si tratta di uno spaventoso conflitto con caratteristiche tribali che contrappone i Janjawid (i “demoni a cavallo”, cioè combattenti arabi appartenenti a tribù di nomadi sostenuti dal governo sudanese) e le tribù di etnia Fur (principalmente agricoltori, sono maggioranza nella regione del Darfur ma minoranza nel complesso della popolazione sudanese). Nel conteggio dei morti, la cifra ritenuta credibile dalla maggior parte degli studiosi arriva alle 400.000 vittime (la maggior parte a seguito di carestie e malattie provocate dalla guerra). Si tratta di un conflitto tribale tra gruppi che professano la stessa religione (musulmana).
14. 2009: conflitti e massacri in Nigeria a seguito dell'azione terroristica di Boko Haram, gruppo jihadista sunnita che combatte il governo, accusato di essere strumento delle grandi compagnie occidentali (ENI, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil etc.) che sfruttano il petrolio nigeriano e devastano l'ambiente del delta del Niger.
15. 2011: una forza internazionale (formata tra gli altri da Francia, Regno Unito, U.S.A., Italia) interviene militarmente in Libia, autorizzata dalla risoluzione 1973 dell'O.N.U. Anche questa volta l'intervento armato avviene ufficialmente allo scopo di proteggere l'incolumità della popolazione civile minacciata dalla repressione che le truppe regolari libiche al comando del dittatore Gheddafi stanno attuando ai danni della rivolta popolare. Anche in questo caso, dunque, l'intervento occidentale avviene all'insegna della guerra umanitaria. Gheddafi verrà ucciso in ottobre dai ribelli, e il suo sistema di potere spazzato via. Ma per la Libia non sarà la pace: caduto il regime di Gheddafi, scoppia una guerra civile complicata nel 2014 dalla infiltrazione di elementi dell'Isis (jihadisti sunniti) nel paese.
16. 2012-2013: scoppia la guerra civile in Mali: un conflitto complicato da questioni etniche e religiose. Nel nord del paese le forze dei tuareg si alleano a fazioni fondamentaliste jihadiste in lotta con il governo centrale.
17. 2014 -in corso: nell'ambito della guerra al terrore si forma una coalizione internazionale guidata dagli U.S.A. contro l'Isis (lo Stato Islamico di Iraq e Siria) guidato da al-Baghdadi. L'Isis è la formazione jihadista sunnita che ha preso il potere in varie città dell'Iraq (Mossul, Falluja) e della Siria (Raqqa). Gli U.S.A, la Francia, il Regno Unito e anche alcuni paesi arabi bombardano con attacchi aerei e sostengono il governo dell'Iraq (un governo insediato dagli stessi statunitensi alla fine della seconda guerra del Golfo) e le popolazioni curde contro i jihadisti dell'Isis. Anche la Russia del presidente Putin ha iniziato dal 2015 ad attaccare l'Isis. La situazione è a dir poco caotica.
18. 2014 – oggi: guerra nell'Ucraina orientale. Dopo che, nel 2014, la Crimea è stata di fatto annessa alla Russia con un referendum non riconosciuto dall'O.N.U., una parte consistente della popolazione del Donbass (Ucraina orientale abitata da elementi di etnia russa) si è ribellata al legittimo governo di Kiev, venendo appoggiata con invio di
15 Fabio Mini, Perché siamo così ipocriti sulla guerra?, op. cit., p. 26. Così si esprime Mini: “Era falso il pretesto delle armi di distruzione di massa di Saddam[…] Il segretario di Stato Colin Powell, già comandante della guerra del Golfo del 1991, fu costretto a presentarsi agli alleati e alle Nazioni Unite mostrando foto false e campioni di antrace prodotta negli U.S.A. per documentare il possesso iracheno di armi nucleari e chimiche”.

'volontari' e armi dalla Russia. La guerra, che gli analisti esitano a definire semplicemente come una guerra civile vedendovi implicato anche un paese straniero (la Federazione Russa, appunto), ha fino ad oggi causato la morte di alcune migliaia di persone.
19. 2015 – in corso: nel 2015 scoppia una guerra civile in Yemen. Da una parte gli huthi (gruppi armati a maggioranza sciita); dall'altra le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita (sunnita). Nel conflitto si sono inseriti anche gruppi di jihadisti affiliati all'Isis.
In definitiva, la situazione mondiale è oggi talmente confusa che gli osservatori hanno persino difficoltà a precisare e quantificare il numero dei conflitti in corso: secondo Stefano Consiglio, dell'International Business Times, a fine 2014 gli Stati coinvolti in guerre internazionali o civili sarebbero stati almeno 62; secondo il “Conflict Barometer” prodotto annualmente dall'Heidelberg Institute for International Conflicts Research nel 2014 gli “higly violent conflicts” sono stati 46. Secondo il sito www.guerrenelmondo.it aggiornato al 2017 vi sarebbero attualmente 67 Stati coinvolti in guerre. Ciò che sembra sicuro è che le guerre vanno guadagnando sempre più terreno nel mondo. Si consideri la cartina dei conflitti datata 2011:
Fonte Peace Reporter – Conflitti nel mondo it.peacereporter.net/conflitti/9/1
La mappa del 2011 non segnala ancora, comprensibilmente, la comparsa di nuovi conflitti, come ad esempio la guerra in Libia e gli scontri nel Donbass (Ucraina). Purtroppo, la cartina dei conflitti all'anno 2015 (vedi sotto) evidenzia l'estendersi dei fenomeni bellici.

fonte www.cimedipace.it
Queste dunque alcune delle tante e terribili nuove guerre della nostra storia. Si dovrà allora sostituire la formula di Fukuyama, smentita dalla storia recente, con il giudizio ben più cauto e preoccupato che Eric Hobsbawm inserì proprio nelle pagine finali del suo celeberrimo Il Secolo breve (1994):
La nostra narrazione può confermare ciò che molti hanno sempre sospettato, cioè che la storia è il documento dei crimini e delle follie del genere umano [...] Ci sono meno ragioni di sperare nel futuro di quante ce ne fossero a metà degli anni '80 [...] Il mondo rischia sia l'esplosione che l'implosione.Il mondo deve cambiare"16.
C) IL NOVECENTO: 'secolo breve', 'secolo nullo', 'secolo lungo' o 'secolo delle tribù'? E qui si apre un'altra questione storiografica. Si tratta di una questione che, peraltro, non si riduce a una polverosa discussione accademica ma intende gettare una luce di comprensione sui nuovi conflitti che stanno imperversando negli anni che stiamo vivendo.Hobsbawm, come è noto, definì il Novecento come il “Secolo breve”, racchiuso tra il 1914 e il 1991, distinguendolo dal “lungo Ottocento”. In sostanza, per lo storico britannico (di formazione marxista, morto nel 2012) i primi 14 anni del Novecento appartengono ancora di diritto alla civiltà occidentale dell'Ottocento:
Questa civiltà era capitalista nell'economia, liberale nella struttura istituzionale e giuridica, borghese nell'immagine caratteristica della classe che deteneva l'egemonia sociale. Era una civiltà che si gloriava dei progressi della scienza, del sapere e dell'istruzione e che credeva nel progresso morale e materiale; era anche profondamente persuasa della centralità dell'Europa17.
La Prima Guerra Mondiale (1914) segna la fine della civiltà dell'Ottocento e della supremazia politica ed economica di quell'Europa che aveva conquistato il mondo. Il crollo dei regimi comunisti dell'est e, in particolare, la dissoluzione nel 1991 dell'Unione
16 Eric Hobsbawm, Il Secolo breve. 1914. L'era dei grandi cataclismi, Rizzoli, Milano, 1995 (ed. or. 1994), pp. 673-674.
17 ivi, p. 18.

Sovietica (quel regime politico le cui basi erano state poste dalla Rivoluzione d'Ottobre, nel 1917, nel pieno della Grande Guerra) segnano la fine del Secolo breve, che lascia il passo ad un'epoca di instabilità politica ed economica, quella che stiamo vivendo oggi. E dopo il 1991
ancor più palese dell'instabilità economica e politica mondiale è stata la crisi sociale e morale […] È stata una crisi delle credenze e dei presupposti sui quali la società moderna si è fondata […] ossia una crisi dei presupposti umanistici e razionalistici condivisi sia dal capitalismo liberale sia dal comunismo18.
Il presente, concludeva Hobsbawm, è caratterizzato dal “rifiuto del sapere scientifico-tecnologico da parte di consistenti fette dell'opinione pubblica”19 e dalla sfiducia nella possibilità del progresso morale dell'umanità.
Tuttavia la tesi di Hobsbawm non ha incontrato il favore e il consenso di tutti gli studiosi. Il Novecento è stato davvero un 'Secolo breve'?
Secondo Karl Dietrich Bracher, il grande storico tedesco morto lo scorso anno, “il bilancio del periodo 1914-1918 non può essere ridotto alla semplice formula 'rottura o continuità'” e bisogna riconoscere che la prima guerra mondiale fu sicuramente il frutto di tensioni e di “problemi irrisolti che sono tutti riscontrabili già nel periodo prebellico e anzi addirittura nel secolo precedente”20. Di più: come già aveva sostenuto James Joll, la Grande Guerra del 1914 non fu una cesura completa con il secolo precedente anche perché le idee e i movimenti politici del Novecento “avevano già fatto quasi tutti la loro apparizione prima del 1914”21. L'ideologia nazista riprendeva concetti e idee già stratificate nel pangermanesimo e nel darwinismo sociale dell'Ottocento, e il comunismo leninista affondava le sue radici nelle teorie di Marx. Ma non basta: il Novecento sembrava a Bracher essere ben più 'lungo' di quanto la cronologia e le idee di Hobsbawm lasciavano supporre anche se si guarda in avanti, verso il XXI secolo! Infatti, se assumiamo -come sosteneva Bracher- che il Novecento sia stato il secolo delle ideologie, cioè del trionfo di sistemi di pensiero che si oppongono alla convivenza civile e celebrano la violenza (comunismo e nazismo in primo luogo) presentandosi come religioni politiche depositarie di verità assolute e indiscutibili (religioni politiche che -come tali- mirano a distruggere chi non vi si adegua, e che stanno a fondamento dei regimi totalitari) allora il Novecento non è ancora finito! Nell'Epilogo 1999 aggiunto all'opera da cui stiamo citando, Bracher infatti precisava che
Sciaguratamente l'ideologia della verità assoluta come principio di legittimazione di una dittatura totalitaria del partito unico compare ancora o di nuovo anche dopo la fine dei sistemi totalitari di destra e di sinistra, riproponendosi ora […] nei movimenti del cosiddetto fondamentalismo, cioè in una forma particolare e prevalentemente regressiva del totalitarismo e del radicalismo, che non solo nell'ambito degli Stati islamici, ma anche nelle ondate di esasperato settarismo apocalittico-cristiano sviluppa un potere seduttivo e distruttivo, e si oppone alla democrazia liberale22.
Se sono crollate le ideologie totalitarie del nazismo e del comunismo, ne stanno comunque comparendo altre, quelle legate ai movimenti fondamentalisti islamisti (e non solo islamisti) che indubbiamente fanno da sfondo giustificatorio a tanta parte delle nuove guerre del nostro presente. I movimenti terroristi fondamentalisti sono a tutti gli effetti movimenti totalitari, cioè organizzazioni che mirano a controllare tutta la società civile in ogni suo aspetto, esattamente come le organizzazioni totalitarie del secolo scorso. Ed è esattamente come dire che il Novecento 'secolo delle ideologie' -sotto questo aspetto- è ben lontano dall'essersi concluso! E cioè, ancora, è come dire che il Novecento non è stato 'breve'; è stato, al contrario, un secolo talmente 'lungo' e sanguinoso da protrarsi e insinuarsi sino all'oggi. Il Novecento è davvero il secolo lungo e
18 ivi, p. 23.19 ivi, p. 24.20 Karl Dietrich Bracher, Il Novecento. Secolo delle ideologie, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 123.21 ibidem.22 ivi, pp. 401-402.

inconcluso, in quest'ottica.
Un'altra linea interpretativa non così dissimile da quella di Bracher (anche se formulata con un tono di amara partecipazione ben più marcata) è quella che ci è stata offerta dal cardinal Martini nella nota lettera pastorale Quale bellezza salverà il mondo?, del 1999. Qui Martini citava direttamente l'opera di Hobsbawm e, con quella gentilezza mai polemica che lo contraddistingueva, il cardinale osservava che
Gli eventi del 1999 nei Balcani hanno come cancellato il giudizio diffuso che il Novecento fosse il "secolo breve" (Eric Hobsbawm), concluso col fatidico 1989. Ciò che sembrava irripetibile delle atrocità del Novecento ricompare: guerra, genocidi, distruzioni e morte. Il secolo che sembrava chiudersi con la crisi delle ideologie si ritrova attraversato da steccati e contrapposizioni ideologiche analoghe a quelle delle due guerre mondiali o dei lunghi decenni della guerra fredda: in questo senso si potrebbe dire che il nostro è "il secolo non più breve"; è il secolo in cui le ideologie che si credevano finite continuano in realtà a influenzare, con la loro logica di contrapposizioni, le scelte dei singoli e dei popoli, producendo nuove e terribili violenze. Noi sappiamo infatti che quanto è avvenuto nei Balcani non è che una delle tragedie che segnano tanti altri paesi, soprattutto nell’Africa23.
Martini si riferisce alla Guerra del Kosovo e alle tante guerre africane in corso nel 1999. E introduce nel suo discorso la formula del Novecento come “secolo non più breve”: le violenze e le atroci guerre con cui si era aperto il Novecento e che sembravano irripetibili erano ricomparse proprio alla fine del secolo. Le “ideologie che si credevano finite” e che invece conducono a nuove violenze sono, con riferimento esplicito ai Balcani, le ideologie nazionaliste ed etniciste, quelle stesse che avevano dato inizio e slancio alla prima guerra mondiale (non a caso scoppiata con l'attentato di Sarajevo). Ciò che il cardinal Martini stava sottolineando era, semplicemente, che la storia del secolo Novecento non aveva insegnato nulla all'umanità: tutto era cominciato con i feroci nazionalismi e tutto si stava nuovamente concludendo con il ritorno di fiamma di altrettanto feroci nazionalismi. Insomma, si potrebbe ben dire che il Novecento sembrava configurarsi nelle parole di Martini come il secolo nullo, né breve né lungo. Un secolo che non aveva lasciato nell'umanità alcuna traccia di progresso morale, alcun insegnamento morale. Penso di non sbagliare se rintraccio in alcune pagine di Bauman (scritte poco dopo quelle di Martini) una profonda consonanza con le osservazioni del cardinale. In Il disagio della postmodernità Bauman, parlando dei nazionalismi, dei provincialismi e degli etnocentrismi dilaganti un po' ovunque nel presente, riconosce che
Tutto quello che la modernità aveva giurato di distruggere vede oggi la sua dolce rivincita. La comunità, la tradizione […] le radici, il sangue, la terra, la nazione: oggi nessuno condanna più tutto ciò […] siamo certamente entrati nei tempi della tribù e degli atteggiamenti tribali […] almeno in questo senso la lunga strada laterale percorsa dalla modernità ci ha riportati al punto di partenza”24.
Il “punto di partenza” che unisce il presente (cioè gli inizi del XXI secolo) al passato (gli inizi del XX secolo) è costituito dalla violenza bellicosa del tribalismo nazionalista. E questi sono i tempi della tribù, proprio come cent'anni fa. Cent'anni di niente: un 'secolo nullo'! Con buona pace delle teorie ormai 'archeologiche' di Fukuyama.
Bauman, Bracher e Martini (ma in fondo anche Hobsbawm), al di là delle diverse amarezze che venano le loro considerazioni, ci hanno comunque offerto indicazioni preziose e utili a comprendere molti aspetti delle nuove guerre. Una gran parte degli attuali conflitti, infatti, sono motivati o da furori nazionalistici e 'tribali' (definiti e declinati anche con modalità religiose fondamentaliste) o dal presunto 'bisogno morale' di intervenire per ragioni umanitarie, cioè per difendere quei gruppi
23 Si veda Carlo Maria Martini, Quale bellezza salverà il mondo?, www.dehoniane.it
24 Zygmunt Bauman, Il disagio della postmodernità, Paravia Bruno Mondadori, Torino, 2002, p. 87.

etnici e quelle popolazioni civili che sono minacciate di sterminio dai movimenti nazionalisti suddetti.
D) LE DUE FORME DELLE NUOVE GUERRE. Quali sono dunque, alla luce della precedente presentazione sinottica dei conflitti, i tratti rilevanti e tipici delle nuove guerre dell'era post-bipolare? Cosa può dirci un abbozzo di trattazione fenomenologica delle nuove guerre? Seguendo il criterio delle motivazioni ideologiche dei soggetti implicati nelle guerre, mi pare sia innanzitutto possibile tracciare una non troppo grossolana distinzione tra D1) guerre tribali e D2) guerre dell'Occidente. Ma subito devo premettere che le due espressioni, 'guerre tribali' e 'guerre dell'Occidente', verranno qui utilizzate come del tutto spoglie di significato valutativo. Le 'guerre tribali' non sono in assoluto più violente e distruttive (e dunque peggiori) delle 'guerre dell'Occidente'; sono semplicemente diverse per motivazioni e metodi adoperati.
D1) GUERRE TRIBALI. Le guerre che qui in senso lato chiamo 'tribali' sono, seguendo la lezione di Mary Kaldor, i conflitti dettati o motivati dalla “politica dell'identità”. La Kaldor, nel suo classico del 1999, Le nuove guerre, così definisce la 'politica della identità:
Con l'espressione “politica dell'identità” intendo riferirmi a quei movimenti che muovono dall'identità etnica, razziale o religiosa per rivendicare a sé il potere dello stato. […] Sia che parliamo dei conflitti tribali in Africa, dei conflitti religiosi nel Medio Oriente e nell'Asia meridionale, o dei conflitti nazionalisti in Europa, la caratteristica comune è il modo in cui le etichette [etniche, razziali o religiose] vengono usate come una base per le rivendicazioni politiche […] la politica dell'identità tende ad essere esclusiva, a frammentare e a guardare all'indietro. Raggruppamenti politici basati su identità esclusive tendono a essere movimenti nostalgici, fondati sulla ricostruzione di un passato eroico [...]Ogni politica basata su identità esclusive genera necessariamente una minoranza, il che conduce nei casi migliori alla discriminazione psicologica contro coloro che sono etichettati diversamente, nei casi peggiori all'espulsione di popolazioni e al genocidio”25.
Le politiche dell'identità dunque chiedono ai loro aderenti di rifiutare chi viene definito come diverso: la diversità deve essere cancellata. La diversità dell'altro deve e può essere cancellata, aggiungo a commento e integrazione del testo di Kaldor, in due modi:1 - attraverso un processo di assimilazione forzata (o più raramente volontaria): è il caso del croato che diventa serbo assumendo la cultura (religiosa, linguistica, gastronomica etc.) della comunità che lo 'ospita'; del meridionale che da 'terrone' può diventare 'uno di noi'; del miscredente che si converte alla versione salafita dell'Islam etc. In questo caso -direi- siamo di fronte alla logica dell'etnocentrismo e alla convinzione identitaria secondo cui l'etnia (la comunità definita in termini culturali, non biologici) a cui si appartiene viene giudicata la migliore; la logica dell'etnocentrismo è chiaramente assimilazionista, e offre all'altro, al 'diverso', la possibilità di 'redimersi' lasciandosi assorbire, antropofagizzare;2 – oppure attraverso una logica eliminazionista e genocidaria che intende il proprio gruppo come razza biologicamente definita e separata, e i 'diversi' come non-assimilabili ma solo allontanabili o uccidibili (per usare una espressione cara a Agamben): ci troviamo qui di fronte alla logica eliminazionista del razzismo, quello praticato storicamente dal nazista verso l'ebreo, dal klansman verso il 'negro', dall'hutu fanatizzato verso il tutsi etc. Sia come sia, la politica dell'identità (in entrambe le sue versioni, sia quella etnocentrica sia quella razzista-biologista) tende a generare esclusione, discriminazione e spesso guerre e genocidi, ci ha ricordato Kaldor. Le politiche dell'identità sono sempre politiche della esclusione. Sono sempre politiche del 'noismo', come avrebbe detto Todorov: politiche che contrappongono un 'noi' (i
25 Mary Kaldor, op. cit., pp. 90-92.

'migliori', la nostra tribù) agli 'altri' (i 'peggiori'). Ed è ancora Kaldor a sottolineare con chiarezza che le nuove politiche dell'identità sono strettamente legate alla globalizzazione economica e culturale in corso: esse sono “almeno in parte una risposta alle ansie prodotte dalla globalizzazione”26, una reazione (venata di nostalgia verso il passato) alla avanzata della aggressiva modernità economica, che genera disparità di reddito, disoccupazione e miseria sociale27. In tal senso, “la nuova politica basata sulle identità particolaristiche può essere interpretata come una risposta a questi processi globali: come una forma di mobilitazione politica di fronte alla crescente impotenza dello stato moderno” 28. Le politiche dell'identità spesso generano guerre e massacri, generano cioè effetti di frantumazione politica in nome della difesa di micro-comunità regionali, etniche, tribali etc.; e sono una risposta sbagliata e perversa delle comunità 'sotto assedio' alle paure e alle incertezze economiche (disoccupazione e sfruttamento) alimentate, per di più, dalle ondate migratorie di altre genti affamate che caratterizzano questo inizio di secolo. Jihad e McMondo, cioè frammentazione politica e globalizzazione, guerra e circolazione dei capitali, si alimentano a vicenda: ce lo ha insegnato Benjamin Barber, e con lui anche Bauman (si veda la quinta lezione). Infine, afferma ancora Kaldor, le politiche dell'identità, le politiche localistiche, sono molto spesso fomentate ad arte da uomini politici locali che alimentano e sfruttano pregiudizi popolari “per ottenere il consenso di quanti sono esclusi e abbandonati, alienati e insicuri, allo scopo di conquistare e conservare il potere”29; e questo accade un po' ovunque, in Ruanda come nella ex-Jugoslavia e nell'Europa occidentale, ovunque cioè la globalizzazione abbia lasciato masse escluse dai suoi benefici, abbia prodotto -come si usa dire- masse di left behind. 'Guerre tribali', caratterizzate da politiche che rifiutano l'inclusione dell'altro nel rispetto della sua diversità (religiosa, culturale, linguistica, fisica etc.), sono dunque quelle guerre che vengono solitamente etichettate come 'guerre etniche', guerre nazionaliste o guerre di religione, a seconda che la 'tribù' (cioè la comunità esclusiva) che si vuol difendere o affermare sia intesa come comunità religiosa o nazione razziale o nazione culturale; e sono molto spesso guerre civili, che spappolano l'unità statale. 'Guerre tribali' sono, in questo senso lato, le guerre jugoslave (1991-1999) tra serbi, croati, sloveni, musulmani bosniaci e kosovari; la guerra civile in Ruanda tra hutu e tutsi (1994); la grande guerra del Congo (1998-2003); le guerre cecene (1999-2 009); la guerra in Sudan tra Janjawid e Fur (dal 2003); gli scontri sanguinosissimi tra sciiti e sunniti salafiti in Iraq (a partire dal 2003) e Siria; la guerra nell'Ucraina orientale, tra ucraini ed elementi filorussi, e così via. Guerre che in alcuni casi hanno prodotto milioni di morti…
D2 ) GUERRE DELL'OCCIDENTE. Poi ci sono quelle che chiamerei le 'guerre dell'Occidente' (come del resto fa anche Maddalena Oliva30). Sono le guerre che hanno a loro fondamento ideologico motivazioni cosmopolitiche e universalistiche. L'Occidente moderno (Europa occidentale e U.S.A.), si è sempre vantato e qualificato (a torto o a ragione) come terra delle libertà civili e politiche, della tolleranza e delle opportunità estese a tutti, senza distinzioni di razza o religione o etnia o sesso. Come 'luogo' della inclusione. Le guerre condotte dall'Occidente sono conflitti che basano le loro fondamenta morali (o forse solo le loro giustificazioni) su quella che Mary Kaldor chiamerebbe “la politica delle idee” (contrapposta alla politica della identità, volta nostalgicamente al passato e alla protezione di comunità ristrette minacciate dal presente):
La politica delle idee è caratterizzata soprattutto da progetti rivolti al futuro […] Questo tipo di politica tende ad integrare e ad includere tutti quelli che sostengono un'idea [indipendentemente dalle origini etniche o religiose o sessuali], anche se -come ha dimostrato la recente esperienza- il carattere universalistico di tali idee
26 ivi, p. 91.27 ivi, p. 88.28 ivi, p. 90.29 ivi, p. 97.30 Si veda Maddalena Oliva, op. cit., p. 22.

può servire da giustificazione per pratiche totalitarie e autoritarie31.
Dunque, le guerre dell'Occidente sono guerre che vantano atteggiamenti universalistici, che cioè vengono condotte (ipocritamente?) in nome dell'umanità intera, delle libertà democratiche, della dignità di ogni persona, dell'inclusione di ogni essere umano in una comunità internazionale fondata sulla giustizia e l'uguaglianza politica e giuridica. Proprio perché questa è sempre la motivazione ideale che spinge (o che legittima e giustifica) l'Occidente post-bipolare a far guerra, proprio per questo le tante guerre che Stati Uniti e N.A.T.O. e Paesi europei hanno condotto nel mondo in questi ultimi 25 anni sono state e sono chiamate dai media occidentali con espressioni che Mini giudica 'fantasie linguistiche': “guerre umanitarie”(ad esempio quella in Kosovo, 1999; o l'intervento militare in Libia, 2011), per fermare la strage di civili perpetrata da dittatori e tiranni; ma anche “guerre preventive” o “operazioni di polizia internazionale” (come nel 2003 in Iraq), per impedire che sanguinari dittatori possano entrare in possesso di armi di distruzione di massa; o anche “guerre contro il terrore” (come l'operazione Enduring Freedom in Afghanistan 2001), per affermare la libertà dei popoli. Tutte guerre 'giuste', cioè tutte 'guerre di difesa' (secondo la lezione di Tommaso d'Aquino, una lezione ampliata e aggiornata a uso e consumo delle potenze occidentali): difendersi dal terrore, difendere le libertà civili e politiche; difendere l'umanità oppressa. Tuttavia le cose sembrano davvero molto più complicate di quanto appaiano a prima vista. Fabio Mini (generale di corpo d'armata, già capo di stato maggiore del comando N.A.T.O per il Sud Europa e comandante della forza internazionale di pace in Kosovo nel 2002-2003) ha avuto il coraggio (e l'autorevolezza di chi le guerre le ha viste) di accusare l'umanitarismo ipocrita dei Paesi occidentali in una serie di libri di notevole interesse.
L'umanitarismo ipocrita diventa alibi per la guerra o la sopraffazione, ma si dimentica spesso dell'umanità. […] La “guerra umanitaria”, oltre a essere un ossimoro, è diventata la più grande ipocrisia anche ai vertici delle organizzazioni internazionali. […] Il motivo della guerra meno confessabile è anche il più ovvio: gli affari. […] l'ipocrisia favorisce gli affari, e la guerra è un grosso affare. Non è più un affare di Stato, come diceva Sun-tzu, o un affare tra Stati, come diceva Rousseau, o la prosecuzione della politica degli Stati, come diceva Clausewitz: la guerra è una questione di profitto, spesso sporco, e gli Stati sono al servizio dei grandi affari32.
A trarre profitto dalla guerra sono le multinazionali, e qui Mini non si astiene dall'indicare alcune delle principali responsabili delle sciagure umane connesse alla guerra: la farmaceutica Pfitzer; la multinazionale dei prodotti chimici Monsanto; la multinazionale Lockheed Martin, “simbolo del mondo industriale legato alla produzione di armamenti, che della guerra e dei profitti di guerra vive, e anche bene”33: colossi sovranazionali capaci di corrompere e piegare ai loro interessi uomini politici, funzionari statali, medici e giornalisti. Nella pagina conclusiva di un'altra sua opera Mini arriva a spendere parole durissime nei confronti di chi svilisce l'etica militare asservendola a interessi economici, parole che ricordano il famoso discorso d'addio alla presidenza tenuto nel 1961 da Eisenhower:
In altri settori, anche di vertice, l'etica è stata sostituita dalla logica delle cordate politico-industrial-militari e dalle fedeltà extraistituzionali34.
Il 'complesso militare-industriale' di cui parlava con toni assolutamente preoccupati Eisenhower quasi sessanta anni fa è evidentemente in ottima salute ancora oggi, secondo Mini. Ed è una vera, grande minaccia per la pace e per la democrazia. È questo intreccio di interessi a promuovere le fantasie lessicali che mirano ad addolcire presso l'opinione pubblica occidentale la parola 'guerra'. Ridurre il dramma della guerra a 'guerra
31 Mary Kaldor, op. cit., p. 91.32 Fabio Mini, Perché siamo così ipocriti sulla guerra?, Chiarelettere, Milano, 2012, pp. 29-35.33 ivi, p. 39.34 Fabio Mini, Soldati, Einaudi, Torino, 2008, p. 124

umanitaria', 'guerra al terrore', 'azione di polizia internazionale', 'guerra preventiva' et similia significa compiere una duplice, funambolica e intrecciata operazione linguistica e politica: da una parte tranquillizzare l'opinione pubblica ottenendone il consenso e l'appoggio in nome dell'umanità offesa e del mondo intero; dall'altra presentare alla medesima opinione pubblica la guerra come lotta contro il Male assoluto, al quale non si deve concedere tregua e con il quale non si deve negoziare e scendere a patti, suggerendo dunque che la guerra deve continuare. Come dice Oliva,
Una guerra che si configura quindi come “azione di polizia”, anche e soprattutto per la pretesa di essere una guerra giusta, fa ricadere il nemico nella fattispecie del criminale, delegittimandolo irrimediabilmente. […] L'avversario, di fronte al diritto assoluto di chi combatte in nome dell'umanità e della civiltà, è condannato a incarnare il torto (il Male) assoluto35.
In questo modo, se la guerra viene proposta come 'umanitaria', il nemico che minaccia l'umanità viene espulso dal mondo degli uomini: diventa 'disumano'. La disumanizzazione dell'avversario risulta però funzionale alla prosecuzione senza limiti della guerra e all'aumento dei profitti di chi la guerra fortemente la vuole. Corollario assolutamente spiacevole: se poi il nemico non è un uomo, allora anche la tortura nei suoi confronti può essere accettata e praticata, come la lezione di Abu Ghraib insegna. In fondo, non si tortura un uomo!
Le 'guerre dell'Occidente' si presentano come risposte 'democratiche e liberali' alle guerra delle tribù; le 'guerre delle tribù' si presentano a loro volta come rifiuto di quell'Occidente a cui spesso imputano le tribolazioni delle tribù. Guerra chiama guerra, e sembra non finire. La logica dell'esclusione uccide; la logica dell'inclusione (nominale) fa lo stesso. Le guerre tribali e d'Occidente finiscono poi spesso per fondersi le une nelle altre, in un disordine che sembra davvero diventare mondiale: è il Pandaemonium!
[NOTA A MARGINE. LE MOLTE RAGIONI DELLE GUERRE. Breve considerazione polemologica. Ma bastano le ragioni economiche, la ricerca del profitto economico, a spiegare la virulenza delle guerre? "La motivazione economica non basta da sola a spiegare l'entità, la brutalità e l'assoluta crudeltà delle nuove guerre "36, si chiede la Kaldor. E lo stesso Mini lo riconosce: gli affari, ci ha detto, sono il motivo “meno confessabile” delle guerre, ma questo non significa che essi siano l'unico motivo. Di più: quasi certamente le motivazioni economiche non sono mai le sole cause delle guerre, nuove o vecchie. Per quanto le considerazioni antropologiche e polemologiche generali esulino dagli obiettivi del presente lavoro, un breve cenno alle considerazioni di Gaston Bouthoul (il padre della polemologia sociologica) potrebbe risultare utile a questo riguardo. Bouthoul afferma con forza che
Appena si ha a che fare con forme di civiltà di tipo complesso, le guerre che esse si fanno tra di loro sono in generale “politeliche”, sia nei loro scopi e sia nel loro significato37.
Le guerre sono inevitabilmente “politeliche”, cioè hanno molteplici scopi e motivazioni e cause, suggerisce Bouthoul. Le guerre possono avere scopi economici (la conquista di mercati e materie prime) rafforzati da motivazioni religiose; possono essere causate da ragioni di politica interna ( cioè possono essere indotte e volute dai leader di una comunità o di uno Stato per dirottare all'esterno le tensioni sociali, che rischierebbero di far crollare il loro sistema di potere, scagliando la aggressività delle masse contro nemici costruiti ad arte); possono essere un intreccio complesso di con-cause costituito dal desiderio di imporre il proprio credo religioso o politico e nel contempo rafforzare le proprie posizioni economiche; possono essere tutto questo e altro ancora, ma -diceva il sociologo francese- l'impulso bellico sembra avere radici più profonde, e gli scopi economici e/o politici e/o religiosi sembrano essere soltanto le vie e i mezzi e le forme con cui si esprime tale impulso. In effetti, dice Bouthoul, “sembra che i fattori economici siano al servizio degli impulsi alla guerra […] e il viceversa non sembra vero”38, poiché “non si può seriamente sostenere che le crisi economiche provochino sempre la guerra”, e “il più gran numero delle guerre sono scoppiate senza essere state precedute da crisi economiche”39. Del resto, la guerra non pare nemmeno essere il prodotto di sistemi politici
35 Maddalena Oliva, op. cit., p. 23.36 Mary Kaldor, op. cit. p. 122.37 Gaston Bouthoul, op. cit., p. 239.38 ivi, p. 267.39 ivi, p. 255.

particolari: “Ci sono monarchie pacifiche e repubbliche, anche se socialiste, bellicose […] i regimi politici e la tendenza alle guerre non hanno fra loro alcun rapporto”40. Anche le democrazie fanno le guerre! Quanto ai leader religiosi, ci sono “papi pacifici e […] papi sempre pronti a far la guerra”41, e così dicasi per le altre religioni. E dunque quali sarebbero le cause profonde delle guerre, vecchie e nuove, del vecchio e sempre nuovo impulso bellico? Senza mai citare la 'pulsione di morte' di freudiana memoria, Bouthoul sembra giungere a una salomonica ma non peregrina conclusione quando afferma che
è la nostra psicologica o biologica predisposizione alla intransigenza la vera determinante [della guerra]42.
Cosa poi Bouthoul intenda per 'predisposizione alla intransigenza' diventa chiaro allorché elenca, tra i motivi psicologici che spingono alla violenza intransigente, la volontà di potenza e il desiderio di distinzione sociale 43, il bisogno di affermazione del proprio io e il desiderio di riscatto sociale44. Senza dimenticare (e Bouthoul non lo dimentica) “l'amore inconfessato per la guerra”, “festa suprema”: sport, attività ludica, svago che diverte, che spezza la noia di un'esistenza monotona, e in più rinsalda la solidarietà di gruppo; attività che “presenta, almeno quando è al suo inizio, un indiscutibile carattere distraente”45. Bouthoul non menziona esplicitamente Pascal (che già nei suoi Pensieri aveva visto nella guerra una espressione del bisogno universale di divertimento), ma l'idea sembra essere la medesima: la guerra risponde al bisogno di affermazione di sé e di distinzione sociale, ma anche al desiderio di 'festa'. 'Festa' significa non pensare alla propria pochezza esistenziale, alla propria miserevole condizione; significa distrazione, 'divertissement' nel senso propriamente pascaliano: fuga dalla noia e dal pensiero della propria miseria. E la guerra così può diventare davvero 'festa crudele' (anche se -va pur detto- un autore della prima metà del Seicento, Emeric Crucé, consigliava come rimedio alla noia di far “fare, agli uomini , dei grandi lavori utili, strade, canali, arsenali, che servano al commercio”46). Così volontà di potenza e volontà di festa si uniscono a formare una esplosiva mescolanza psicologica che genera l'impulso bellico e si radica tanto nei leader politici quanto in molti dei giovani che cercano l'avventura e il bel gesto; parimenti, la medesima mescolanza psicologica finisce poi per trovare in questioni economiche o religiose o politiche la via per esprimersi, trasformando le suddette questioni in motivi giustificatori. Detto ancora in altri termini, la guerra sembra essere -nell'ottica di Bouthoul- la conseguenza della volontà di affermarsi con intransigenza in campo economico o religioso o politico, di ottenere distinzione e riconoscimento e allo stesso tempo di fuggire la noia e il pensiero della propria mortalità. In una parola, la guerra è volontà di potenza, ma -aggiungo- volontà di potenza che appartiene solo a chi è talmente terrorizzato dal pensiero di sé da preferire vivere nella costante ignoranza di se stesso. È 'volontà ignorante', vorrei dire. Significativamente, anche il generale Mini riconosce che la guerra, oltre a servire interessi economici e politici, soddisfa il “gusto” umano per la razzia e la conquista, “perché c'è gente [...] che ha bisogno di usare violenza sugli altri esseri umani e sulle cose terrene per dimostrare a se stessa di essere viva e potente”47. Sono persone che hanno il “gusto della guerra”: sono dominate da una sordida volontà di potenza, e traggono piacere dalla guerra, vi si divertono. E 'volontà di potenza' è anche la parola-chiave della lettura che Galimberti offre dell'esperienza bellica: “volontà di potenza in cui sono da reperire le radici vere di ciò che chiamiamo guerra”48;una volontà di potenza che Galimberti
connette strettamente all'Occidente, 'terra del tramonto' e del nichilismo.]
E) 1989 – OGGI: I CARATTERI DELLE NUOVE GUERRE.Ma abbandoniamo le riflessioni antropologiche e filosofiche, e torniamo alle 'nuove guerre',
quelle del mondo post-bipolare, dal 1989 a oggi, quelle guerre pandemoniche che risultano dall'intreccio di 'tribù' e 'Occidente'. Quali caratteristiche ne definiscono la 'novità'? In cosa sono davvero nuove? La letteratura scientifica risulta essere, in merito, sufficientemente concorde. Kaldor, Hobsbawm, Keegan, Mini, Oliva, Dal Lago e tanti altri insistono nel sottolineare gli stessi temi (accordando a questo o a quello maggior o minor spazio nelle loro considerazioni). Vediamoli.
1 – Le guerre in questione sono 'nuove' innanzitutto perché sono legate alla globalizzazione economica e culturale che dopo il 1989 è giunta a piena maturazione. L'occidentalizzazione del
40 ivi, p. 503.41 ibidem. 42 ivi, p. 266.43 ivi, p. 23644 ivi, p. 369.45 ivi, pp. 352-355.46 ivi, p. 510.47 Fabio Mini, Perché siamo così ipocriti sulla guerra?, op. cit., p. 61.48 Umberto Galimberti, Parole nomadi, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 83.

mondo (come dice Serge Latouche) o, se si preferisce, la macdonaldizzazione del mondo (secondo la formula di Barber) ha scatenato la reazione violenta di molte regioni del mondo. L'integrazione economica ha mortificato culture secolari e ha prodotto vaste sacche di povertà materiale, e in queste zone di miseria hanno pescato quei leader che hanno cavalcato il disagio per ottenere potere (spesso scatenando conflitti). Ricordiamo ancora e per l'ultima volta che nell'epoca della globalizzazione e dell'integrazione economica si è verificata una straordinaria ondata di frammentazione politica: gli Stati sovrani sono entrati in crisi (e alcuni sono letteralmente esplosi -si pensi alla fine della ex-Jugoslavia o alla diminuzione territoriale dell'Ucraina o allo spappolamento politico del Sudan etc.). Gli Stati-nazione hanno visto diminuire il loro potere, eroso dall'alto (dalle influenze delle multinazionali, dell'Impero di cui parlava Negri, capace di pilotare le decisioni dei politici nazionali volgendole a loro favore) ed eroso dal basso (dalle proteste e dalle spinte separatiste delle varie regioni etniche che compongono molti Stati).
2 – Ne viene come conseguenza che le guerre di cui parliamo sono 'nuove' anche nel senso che sono sempre più guerre civili condotte da milizie e movimenti irregolari, interne allo Stato (indebolito e sempre meno 'sovrano'), e sempre meno guerre tra gli Stati, come invece è accaduto in precedenza.Hobsbawm ci ha ricordato che
All'inizio del XXI secolo, ci ritroviamo in un mondo in cui le operazioni armate non sono sostanzialmente più nelle mani dei governi. […] il numero dei conflitti internazionali ha seguitato a ridursi in modo pressoché ininterrotto, mentre al contempo le guerre interne sono diventate più comuni di quelle combattute fra Stati diversi.49
Dunque, le guerre sono diventate sempre più guerre civili: guerre dentro la Bosnia o dentro il Ruanda o dentro l'Ucraina etc. Oppure sono guerre tra gruppi e bande armate irregolari che sconfinano e scavalcano, che passano i confini per portare morte al di là e al di qua delle frontiere, coinvolgendo una pluralità di Stati (come nel caso della grande guerra del Congo) . O infine sono 'operazioni di polizia internazionale' condotte da Stati sovrani e bene organizzati (gli U.S.A., il Regno Unito, la Francia etc.) contro movimenti terroristi sparpagliati in vaste aree geografiche (come nel caso dei talebani e di al-Qaeda in Afghanistan, nel 1991).
3) – Ne viene anche che le vittime delle nuove guerre sono sempre e sempre più vittime civili. Popolazioni civili coinvolte spesso loro malgrado nei conflitti, popolazioni che subiscono la pulizia etnica, i saccheggi e le razzie compiute dalle bande armate, o subiscono i bombardamenti terrorizzanti delle forze internazionali in lotta contro il terrorismo. Ecco i dati che Hobsbawm ci presenta a questo riguardo:
Nel corso del XX secolo, però, il peso della guerra si è spostato progressivamente dalle forze armate ai civili, i quali, oltre a esserne le vittime, sono diventati sempre più spesso gli obiettivi designati delle operazioni militari […] mentre nella Prima guerra mondiale la percentuale di civili tra le vittime era stata solo del 5 per cento, nella Seconda è salita al 66 per cento. Oggi, secondo le stime più diffuse, tra l'80 e il 90 per cento delle vittime dei conflitti sono civili. La percentuale è cresciuta dopo la fine della Guerra fredda50.
4) - Altri aspetti di novità riguardano il modo in cui le guerre vengono condotte, e non solo i motivi esplicitamente dichiarati (guerre umanitarie o guerre a difesa della tribù). Le nuove guerre, quando vengono condotte dall'Occidente, diventano guerre asimmetriche, o -se si vuole- guerre post-eroiche. Ecco una assoluta novità della guerra post-bipolare. “La guerra asimmetrica”, ricorda Maddalena Oliva, “è un conflitto in cui una parte dotata di una forza schiacciante cerca di distruggere un avversario infinitamente più debole che combatte in modo non convenzionale e 'scorretto'”51. È più che evidente, per intenderci, la superiorità militare e
49 Eric Hobsbawm, Imperialismi, Rizzoli, Milano, 2007, pp. 11-12.50 ivi, p. 13.51 Maddalena Oliva, op cit., p. 52.

tecnologica dell'esercito statunitense rispetto alle truppe irregolari e alle bande armate dei serbi in Kosovo o dei terroristi dell'Isis in Iraq e Siria o delle bande somale a Mogadiscio. La superiorità militare occidentale è dovuta senza dubbio alla RMA (Revolution in Military Affair) di cui già parlava la Kaldor nel suo libro del 199952 e che ha infine trionfato con la Seconda Guerra del Golfo (2003)53.
La RMA non è altro che il risultato della applicazione della rivoluzione elettronica al campo degli armamenti e della comunicazione militare.
L'esercito statunitense, il più tecnologizzato al mondo, è in gradi di attuare “operazioni di guerra non militari”54: l'infowar e la cyber-war cioè operazioni che non spargono sangue ma permettono di dominare gli avversari accecando i loro sistemi radar di difesa computerizzati con l'invio di virus informatici, e anche di diffondere false notizie via internet riguardo agli spostamenti di truppe avversarie etc. Ma soprattutto l'esercito statunitense è in grado come nessun altro di praticare l'air power, cioè di dominare lo spazio aereo grazie a sistemi satellitari GPS (sistemi di posizionamento globale) e di colpire dall'alto con precisione chirurgica il nemico, distruggendolo al suolo con gli APR (aerei a pilotaggio remoto), più comunemente noti come 'droni'. I droni militari, privi di equipaggio umano e pilotati anche da migliaia di chilometri di distanza, consentono di condurre una guerra del tutto asimmetrica, senza perdite umane da parte dell'esercito che ne dispone. I droni, in altri termini, sono sofisticate armi high -tech dai costi altissimi e dalla precisione impressionante che permettono di attuare una guerra 'post-eroica', come è stata definita da Edward Luttwak: 'post-eroica' perché non richiede il contatto diretto con il nemico, e quindi evita la necessità di arrivare a quello scontro sul terreno che richiede coraggio personale55. I soldati che manovrano i droni sono infatti dei tecnici che svolgono lavoro d'ufficio e ammazzano con un clic su una tastiera di computer. Sono soldati 'nuovi' per guerre nuove.
Una guerra di questo tipo permette ai governi delle potenze occidentali iper-tecnologiche (in primis gli U.S.A) di garantirsi il consenso (o comunque di evitare lo scontento) dell'opinione pubblica interna, visto che tende ad azzerare le perdite dei militari; inoltre, una guerra asimmetrica di questo genere costringe inevitabilmente gli avversari “infinitamente più deboli” a disperdersi sul territorio evitando di concentrare le forze, che diverrebbero un troppo facile bersaglio. Il nemico tende a sparpagliarsi e a combattere per bande, spesso infiltrandosi nelle città e mescolandosi ai civili (trasformati il più delle volte in scudi umani: si pensi ad esempio a quanto successo recentemente alla popolazione inerme dell'irachena Mossul in mano all'Isis). I nemici delle potenze occidentali finiscono poi per reagire praticando la guerriglia e il terrorismo, cioè adoperando quei metodi 'non convenzionali' e 'scorretti' che scatenano odio e paura, e non mirano a 'conquistare i cuori' delle popolazioni massacrate. I metodi 'scorretti' di cui parla Oliva sono anche (almeno in parte) la risposta armata (e criminale) di chi non può ovviamente scontrarsi in campo aperto con le potenze dell'RMA. Così oggi il campo di battaglia non coincide più con le trincee della Grande Guerra né con gli apocalittici scontri frontali tra carri armati (si pensi ad esempio alla battaglia di Kursk, 1943) della Seconda Guerra Mondiale, cioè non coincide più con luoghi in cui si scontravano giganteschi eserciti regolari dotati di armamenti sostanzialmente 'alla pari', sotto il profilo tecnologico.Ora il campo di battaglia si trasforma nelle strade di città semidistrutte bersagliate da cecchini e bombardate dall'alto e razziate da bande di carnefici. E i civili inermi finiscono per diventare le prime vittime della guerra.
5) – Un'altra novità che rende 'nuove' le guerre è la privatizzazione delle forze militari. La crisi degli Stati sovrani, particolarmente evidente in Africa e in varie zone dell'Asia ma consistente anche in aree del mondo occidentale (una crisi -s'è detto varie volte- legata alla globalizzazione economica) ha condotto alla formazione di unità combattenti irregolari e frammentate che sfuggono
52 Mary Kaldor, op. cit., p. 180.53 Maddalena Oliva, op. cit., p. 42.54 ibidem.55 Mary Kaldor, op. cit., p. 38.

al controllo delle forze pubbliche. Mary Kaldor su questo punto è chiarissima: “Il 'fallimento' dello Stato si accompagna infatti ad una crescente privatizzazione della violenza”56. Mentre le forze armate regolari sono in decadenza a causa di tagli alle spese militari, alla carenza di armamenti e al declino di prestigio (e su tutto ciò Mini concorda perfettamente), vengono formandosi gruppi paramilitari e unità di mercenari. I gruppi paramilitari sono formazioni di “uomini armati stretti in genere intorno ad un unico leader e […] spesso i gruppi paramilitari sono associati a particolari fazioni politiche o a partiti estremisti”57, come le tristemente famose Tigri di Arkan in Bosnia o le milizie armate in Georgia. Spesso in Africa questi gruppi reclutano a forza soldati-bambini. Vi sono poi compagnie militari private, mercenari sotto contratto: i famosi e sempre più numerosi contractors appartenenti a famosissime organizzazioni come la Black Water (oggi Academi), ritenuta la principale fornitrice di 'operatori di sicurezza' al Dipartimento di Stato U.S.A. I contractors sono spesso inglesi, statunitensi, russi e francesi arruolati in gruppi “ingaggiati da governi o da società multinazionali”58 e impiegati in combattimento ovunque gli interessi economici di tali corporations e tali governi (anche occidentali) lo richiedano: Africa, Asia, Europa orientale… I nuovi mercenari del XXI secolo sono poi spesso ex-militari in pensione o senza lavoro, ma anche giovani occidentali annoiati in cerca di emozioni forti, giovani svuotati da quel nichilismo imperante di cui i vari Galimberti hanno parlato, e per di più allettati da stipendi molto alti. A tal riguardo, la solita 'impudente' e onesta imprudenza spinge il generale Mini ad affermare che
la Difesa americana è stata praticamente privatizzata in toto: oltre alle forniture di armamenti e servizi di manutenzione, le industrie della difesa e le società collegate forniscono il personale (contractors) per una serie di servizi operativi e logistici nei teatri di guerra. Nel marzo 2011 il dipartimento della Difesa americano aveva in Afghanistan e Iraq più contractors che soldati. Considerando che fra i due teatri erano dislocati oltre duecentomila militari, si ottiene un rapporto fra civili a contratto e soldati mai raggiunto dagli U.S.A. in nessuna guerra precedente. […] Questo sbilanciamento verso la privatizzazione della guerra […] mette le istituzioni pubbliche al servizio del profitto privato”59.
E tutto ciò nonostante nel 1989 l'O.N.U. abbia varato una Convenzione internazionale contro il reclutamento di mercenari. Peccato che finora pochissimi Stati (tra questi l'Italia) abbiano ratificato tale Convenzione! Così gli Stati finiscono per assumere le compagnie militari private “anche in sostituzione dei propri eserciti”60.
Quanta parte dei 54 miliardi di dollari di aumento per le spese militari che l'attuale governo degli Stati Uniti ha or ora promesso finiranno nelle tasche di multinazionali delle armi e di compagnie private militari? La domanda è lecita.
6- Infine, un'ultima novità delle 'nuove guerre' consiste nella loro evidente spettacolarizzazione televisiva, mediatica. La guerra è cambiata anche nel modo in cui viene raccontata, nel senso che la narrazione della guerra in un'epoca di “telecrazia”61 tende a diventare sempre più falsante. Se è indubbiamente vero che da sempre “The first casualty when war comes is truth”, cioè che la verità è da sempre la prima vittima di guerra, uccisa dalle menzogne e dalle mistificazioni di chi ha interesse a promuoverla, mai quanto oggi i mezzi di comunicazione di massa e la loro capillare e iper-invasiva presenza nelle case dei cittadini globali consentono al complesso politico-industriale-militare (di cui parlano Mini, Oliva, e tanti altri) di trasformare la guerra in una colossale costruzione narrativa spettacolare e bugiarda. Chi dirige la spettacolarizzazione della guerra è
56 ivi, p. 109. 57 ivi, p. 110.58 ivi, p. 111.59 Fabio Mini, Perché siamo così ipocriti sulla guerra?, op. cit., pp. 41-42.60 Fabio Mini, Soldati, op. cit., pp. 76-78.61 Come è noto, l'espressione “telecrazia” è stata introdotta dal francese Paul Virilio. Per Virilio, la attuale tecnocrazia
“sta trasformando la realtà in telerealtà e la democrazia in una telecrazia per cittadini infantilizzati”, come ricorda Oliva a pagina 36 del suo lavoro.

sempre preoccupato del fall-out mediatico, della ricaduta sull'opinione pubblica dei paesi democratici62; e lo scopo che guida chi controlla i media televisivi è quello di “creare il consenso e il sostegno dell'opinione pubblica a favore degli obiettivi che si perseguono”, come dice Carlo Jean63. Il massiccio e controllato uso della televisione (e in generale dei mezzi di comunicazione) trasforma la realtà della guerra in una telerealtà distorta e falsata. Già la Kaldor nel 1999 aveva concluso il suo straordinario lavoro prospettando che
si può prevedere in questo caso un mondo in cui le “nuove guerre” giustificano le “guerre spettacolo” e viceversa, e in cui la stessa distinzione tra “nuove guerre” e “guerre spettacolo” comincia a venir meno64.
In altri termini, la guerra è diventata spettacolo, e la sua narrazione si è ridotta a infotainment, a informazione-che-diverte, cioè ancora a informazione che informa poco o non informa, e che si basa su almeno un preciso principio: “ciò che non viene comunicato non esiste”65. Si tratterà dunque di una narrazione della guerra che mira a emozionare ma non a spiegare; che seleziona e trasmette le immagini luccicanti e spettacolari (si pensi alle sequenze televisive dei bombardamenti notturni e dei lampi verdastri dei missili su Baghdad, sequenze trasmesse in diretta dalla CNN nel 1991 con un coverage giornalistico totale, 24 ore su 24); che enfatizza il ruolo dell'inviato chiedendogli di drammatizzare le sue emozioni e di esporle in pubblico; che non mostra la realtà della guerra, con i suoi cadaveri spappolati e smembrati, per non turbare la sensibilità dello spettatore e dell'opinione pubblica e non incrinare il consenso alla guerra66. La prima vera guerra televisiva (molto più televisiva che non la Guerra del Vietnam) è stata, secondo Oliva, la Prima Guerra del Golfo condotta dall'Occidente contro l'Iraq di Saddam nel 1991, in risposta alla invasione del Kuwait: le immagini in diretta trasmesse dalla CNN hanno mostrato molte luci e scoppi e nel contempo nascosto tutto: “si vede poco, e solo quello che la censura autorizza”67. A partire da quella guerra, la spettacolarizzazione è andata via via aumentando sempre più.La prossemica giornalistica (così la chiamerei) ha imposto uno stile ben preciso. Il giornalista televisivo deve mostrarsi alla telecamera in tuta mimetica o con casco protettivo, indicare lontane immagini di fumo e di scoppi, e accelerare la velocità con cui si esprime rendendo stridula e appassionata la voce… Sono quei giornalisti “da piscina”68 (non tutti, ovviamente) che ben si adeguano alla teatralizzazione della guerra e che non cercano le notizie ma le ricevono direttamente dal Pentagono attraverso i briefing che giornalmente i generali in comando organizzano. Notizie chiaramente filtrate e rilasciate da fonti governative sempre per costruire il consenso pubblico.
Di più. Ancora ai tempi della Guerra del Vietnam (1964-1975) i giornalisti occidentali erano liberi di spostarsi nelle zone di guerra (a loro rischio e pericolo) e dunque di documentarsi e anche di mostrare gli aspetti più scabrosi della guerra, inviando in patria ciò che filmavano o fotografavano e scoprivano (le immagini televisive venivano trasmesse con un ritardo di 24-72 ore rispetto all'evento documentato69; non erano ancora trasmesse in diretta satellitare). Ma proprio le crude immagini di violenza trasmesse dai giornalisti avevano favorito -come si sa- la crescita del dissenso interno agli U.S.A. a partire dal 1968, e sicuramente avevano contribuito alla sconfitta americana. Le perplessità sul “sanguinoso stallo” della guerra espresse in tv dal famoso Walter Cronkite, anchorman della CBS, misero in ginocchio il governo americano (il presidente Johnson commentò le parole di Cronkite con due lapidarie prole: “È finita”). I governi occidentali (e in particolare i governi statunitensi) hanno imparato la lezione del Vietnam. Dopo di allora, i
62 Maddalena Oliva, op. cit., p. 31. Qui la Oliva riporta le parole del generale Carlo Jean, autore di un'altra opera di rilievo: La comunicazione come potenza, 2006
63 ivi, p. 41.64 Mary Kaldor, op. cit., p. 184.65 Maddalena Oliva, op. cit., p. 71.66 ivi, pp. 131-132.67 ivi, p. 87.68 ivi, p. 92.69 ivi, p. 79.

giornalisti non sono più stati lasciati liberi di muoversi nei teatri di guerra, proprio per evitare il formarsi del dissenso interno. A partire dalla Prima Guerra del Golfo, i giornalisti sono stati embedded, 'incastonati', ancorati alle unità militari operative. Se essi intendono recarsi al fronte (e non rimanersene in hotel, accanto alle piscine), devono obbligatoriamente seguire determinate unità (e vedere e raccontare solo ciò che viene loro concesso di vedere): non sono più liberi di spostarsi; non possono intervistare truppe senza permesso degli ufficiali, non possono filmare caduti dell'esercito occidentale etc.70. In questo modo, però, in virtù dell'embedding e dei briefing, le uniche notizie pubblicate tendono a essere quelle offerte dagli organi governativi, con gravi conseguenze per la verità e la realtà della guerra. Si verifica, in altre parole, quel “paradosso della visibilità totale” di cui molti studiosi hanno parlato: con la spettacolarizzazione televisiva della guerra viene mostrato molto e per moltissime ore al giorno, ma si comprende pochissimo, e la guerra diventa “invisibile” (se con il termine 'visione' si intende un esercizio di intelligenza che passa attraverso la vista71). E l'invisibilità delle nuove guerre occidentali consente ai governi interessati di diffondere vere e proprie falsità, onde -ripetiamo per l'ultima volta- fabbricare il consenso alla guerra. Ecco un un famoso esempio di falsificazione delle notizie, falsificazione in questo caso preparata per vie traverse dal governo statunitense e (consapevolmente o meno) diffusa dalle reti televisive: per costruire il consenso attraverso la demonizzazione di Saddam Hussein (che certo un santerello non era!) e preparare la Guerra del Golfo del 1991 contro l'Iraq (che ha invaso il Kuwait), una ragazza kuwaitiana quindicenne, Nayirah, viene portata al Congresso americano a testimoniare della crudeltà dei soldati iracheni: secondo la ragazza, i soldati di Saddam staccavano la corrente elettrica alle incubatrici degli ospedali kuwaitiani, uccidendo i neonati. Peccato che la ragazza non abbia fatto altro che “recitare un copione per la regia della Hill & Knowlton”, una agenzia di pubbliche relazioni statunitense assoldata indirettamente dal governo kuwaitiano in esilio e diretta, tra gli altri, da Craig Fuller, consigliere politico del presidente Bush (senior). Il falso verrà scoperto solo più tardi, ma “quando nel gennaio 1991 il Senato americano vota l'inizio delle ostilità [contro l'Iraq di Saddam Hussein], sei senatori citano l'episodio dei bambini uccisi come una delle ragioni decisive per intervenire contro l'Iraq”72. Per non parlare poi delle notizie false diffuse con un certo imbarazzo da Colin Powell quando nel 2003 si trattò di attaccare per la seconda volta l'Iraq di Saddam: le 'armi di distruzione di massa' di cui Saddam sarebbe stato in possesso non furono mai trovate; in compenso la tv diventò -si può dire con facile gioco di parole- 'arma di distrazione di massa'!
Riassumendo in modo schematico, possiamo individuare le caratteristiche delle 'nuove' guerre (tutte già individuate da Kaldor e variamente sviluppate dagli altri autori) opponendole ai tratti distintivi delle 'vecchie guerre' in questo modo:
NUOVE GUERRE (dal 1989 a oggi) VECCHIE GUERRE (limitatamente al periodo 1900-1989)
- Connesse strutturalmente alla globalizzazione economica e culturale
- antecedenti la piena maturazione della globalizzazione.
- con motivazioni esplicite principalmente di due tipi: difesa della comunità minacciata dalla globalizzazione ('guerre tribali'); difesa dell'umanità minacciata (guerre umanitarie dell'Occidente)
- con motivazioni esplicite principalmente legate a ideologie universalistiche (comunismo, liberalismo) o a ideologie che si diffondono per reazione alle precedenti (nazismo, fascismo e varie forme di nazionalismo ).
- soprattutto guerre civili/tribali, e guerre - essenzialmente guerre tra Stati. Vittime in
70 ivi, pp. 91-92 e pp. 139-142.71 ivi, p. 132.72 Ivi, pp. 89-90.

condotte come 'operazioni di polizia internazionale'. Vittime in gran parte civili.
buona o in gran parte militari.
- guerre asimmetriche e post-eroiche (infowar, cyber-war, air-power); guerriglia terrorista.
- soprattutto guerre tra eserciti regolari dotati di pari tecnologia bellica.
- guerre caratterizzate dalla privatizzazione della violenza: gruppi paramilitari e compagnie private militari (contractors).
- guerre caratterizzate dal controllo pubblico della forza militare: eserciti regolari.
- guerre spettacolarizzate ('telecratiche' e 'telereali', caratterizzate da infotainment, embedding e briefing giornalistici); censura 'alla fonte': notizie offerte dalle fonti ufficiali.
- guerre caratterizzate da tentativi di censura di un prodotto giornalistico comunque frutto di libere indagini.
F) CONCLUSIONI. NUOVE GUERRE, 'DEMOCRAZIE IMBECILLI' E PROSPETTIVE DI PACE.
Le guerre compiute dall'Occidente negli ultimi 25 anni sono state esplicitamente combattute “in nome del mondo”, per esportare pace e democrazia ovunque, anche a genti restie ad accogliere messaggi umanitari. I risultati sconsolanti sono dinnanzi agli occhi di tutti coloro che vogliono vedere: le stragi, la paura e la miseria dei popoli sono dappertutto. Può la democrazia, come sistema standardizzato, essere 'esportata' con la guerra? Non sembrerebbe, almeno secondo Hobsbawm, che giudicava “illusoria e pericolosa” tale convinzione73. Eppure tutta una robusta linea di pensiero ha sostenuto la necessità di sostenere i “guerrieri democratici” (cioè occidentali) nella loro opera di pacificazione armata del mondo. E' la linea di pensiero che in Italia, ad esempio, è stata proposta da Angelo Panebianco (secondo il quale l'Occidente deve praticare un realismo politico che ammetta anche l'uso di metodi ai limiti della legalità per combattere il terrorismo e difendere i valori di libertà e democrazia). L'obbligo morale di sostenere la democrazia armata è stata poi avanzata da colui che è stato ritenuto il più autorevole tra gli storici militari del Novecento: l'inglese John Keegan, sostenitore degli interventi bellici in Iraq. Per Keegan, che val la pena citare come esempio letterario di tutta una recente mentalità democratico-interventista,
il militare [occidentale] deve essere pronto, uomo o donna, a rischiare la propria vita non semplicemente per i tradizionali valori per cui in passato combatteva il guerriero, ma per la causa della pace stessa. L'onore del guerriero valoroso ha acquisito un nuovo significato74.
E ancora:
tutte le persone ragionevoli desiderano vivere libere dalla minaccia incombente della guerra. Ciò è possibile solo grazie alla dedizione al dovere di soldati professionisti della democrazia. Costoro meritano il nostro rispetto, la nostra fiducia e il nostro sostegno75.
Che si debba rispetto a quei militari che si battono per la democrazia e la libertà è giudizio decisamente condivisibile, a mio avviso, ma che i soldati d'Occidente combattano davvero per una democrazia matura e meritevole di venire diffusa nel mondo (con metodi che si accompagnino a rispetto per le culture tutte, nei limiti del possibile) è altra cosa, ed è davvero cosa discutibile. Così Hobsbawm ricordava nel 2012 che
Oltre alle sue scarse possibilità di successo, lo sforzo di diffondere la democrazia nella sua versione standardizzata occidentale soffre anche di un radicale paradosso. […] Attualmente, una parte sempre più
73 Eric Hobsbawm, Imperialismi, op. cit., p. 67.74 John Keegan, La guerra e il nostro tempo, Mondadori, Milano, 2002 (ed. or. 1998), p. 61.75 ivi, p. 8.

grande della vita umana viene decisa al di là dell'influenza degli elettori, da entità sovranazionali pubbliche e private. […] A parte sollevare a posteriori complessi problemi di inganni e occultamenti di verità, la democrazia elettorale e le assemblee rappresentative hanno avuto poco a che vedere con quel processo [di decisione della guerra]. Le decisioni sono state prese in privato da piccoli gruppi di persone, in modo non molto diverso da quanto sarebbe accaduto in paesi non democratici76.
La democrazia elettorale, ci diceva Hobsbawm, può essere facilmente aggirata e raggirata da inganni, manipolazioni delle informazioni e costruzione del consenso, e portata contro il suo stesso interesse a sostenere le guerre da cui pochi trarranno enormi benefici materiali. La democrazia elettorale non è di per sé un bene assoluto, se non è sostenuta da educazione, senso critico e libertà di pensiero. Lo diceva già Barber: il McMondo minaccia la democrazia non meno del Jihad, perché combatte anch'esso quel senso critico senza il quale la democrazia liberale muore. La democrazia, diceva sempre Barber, non è semplicemente la possibilità di esprimere le proprie opinioni; è soprattutto la possibilità di esprimere argomentazioni razionali! Le democrazie -dice Mini, l'enfant terrible del nostro esercito (mi permetto di etichettarlo in questo modo e me ne scuso), possono essere rese imbecilli, anzi, lo sono già diventate: sono diventate “democrazie imbecilli (in senso etimologico) come la nostra”77. 'Imbecilli', dice Mini, nel senso di 'in baculum', deboli, traballanti, 'che si devono appoggiare a un bastone'. Se le nostre democrazie sono traballanti (perché non più realmente partecipate; non più o assai poco sostenute da educazione e senso critico; sempre più preda di telecrazia, di videocrazia e di spinte demagogiche), allora non sarà certamente questo il modello che dovremo esportare per garantire la pace e la libertà.
Cosa resta da fare, allora?Mary Kaldor nell'ormai lontano 1999 chiedeva che, accanto a interventi militari mirati e il
meno possibile distruttivi contro i vari tribalismi, si recuperasse un approccio cosmopolitico rafforzando le istituzioni internazionali in vista di una vigilanza globale contro ogni forma di esclusivismo politico, di intolleranza e di particolarismo, globalizzando la civiltà (e non solo l'economia) ed elaborando nuovi 'piani Marshall' (cioè piani di aiuto economico per le aree più povere del pianeta). Soltanto in questo modo si potrebbe evitare che il mondo crolli in una sorta di anarchia hobbesiana, di 'coming anarchy', disordine violento planetario, come paventava Robert Kaplan nel 1994. Per l'illuminismo liberale della Kaldor,
La “pace perpetua” immaginata da Kant, la globalizzazione della civiltà e lo sviluppo di forme di governo cosmopolitico sono ormai possibilità reali78
Passati ormai 18 anni dal libro della Kaldor, la pace resta lontana. La 'globalizzazione della solidarietà', di cui parlava il cardinal Martini come dell'unica speranza per la pace, resta ancora e solo una parola o poco più.
Nel 1940 l'antropologa statunitense Margaret Mead, che aveva conosciuto e studiato molti anni prima la società assolutamente non-violenta degli abitanti di Samoa (nell'Oceano Pacifico meridionale), arrivò ad affermare che “la guerra è solo un'invenzione, non una necessità biologica”79, convinta com'era che tutte le società avrebbero potuto in futuro adottare lo stile di vita samoano. Era la convinzione della Mead una pallida utopia? Forse no, ma che tutto il mondo diventi 'Samoa' è una possibilità fragile, legata alla diffusione di educazione, consapevolezza della fallibilità e della imperfezione personale, spirito critico kantiano, senso di responsabilità individuale. Una possibilità fragile di questo tipo è poco più di un nome diverso per 'utopia': l'utopia che un giorno tutti (anche i giovani annoiati che vanno alla guerra come
76 Eric Hobsbawm, Imperialismi, op. cit., pp. 73-76.77 Fabio Mini, Soldati, op. cit., p. 55.78 Mary Kaldor, op. cit., p. 170.79 Citato in John Keegan, op. cit., p. 30.

contractors) possano afferrare e comprendere la verità erasmiana del bellum dulce inexpertis: la guerra è piacevole solo per chi non l'ha mai sperimentata. Una utopia per cui chi scrive ritiene che valga la pena di spendersi; una utopia come modello a cui avvicinare il più possibile la realtà, lottando contro le 'volontà ignoranti' (come si è voluto chiamarle), e lottando per una democrazia non-imbecille. Il libro di Melchisedec si chiude qui, nella speranza di aver offerto un piccolissimo contributo alla conoscenza e alla educazione (posto che quest'ultima parola non risulti già troppo pretenziosa!); un minuscolo contributo a far sì che tutto il mondo diventi 'Samoa'.
BIBILIOGRAFIA e SITOGRAFIA.
- AA.VV, Le teorie della guerra e della pace, Piemonteuropa (supplemento al n.1 del 1985), Torino.
- Mariangela Ariotti, Tempi di guerra, Paravia Bruno Mondadori, Torino-Milano, 2000.
- Zygmunt Bauman, Il disagio della postmodernità, Paravia Bruno Mondadori, Torino, 2002.
- Joanna Bourke, Le seduzioni della guerra, Carocci, Roma, 2003.
- Gaston Bouthoul, Sociologia delle guerre. Trattato di polemologia, Pgreco Edizioni, Milano, 2011 (ed. or. 1951).
- Karl Dietrich Bracher, Il Novecento. Secolo delle ideologie, Laterza, Roma-Bari, 2001.
- Alessandro Dal Lago, Polizia globale. Guerra e conflitti dopo l'11 settembre, Ombre Corte, Verona, 2003.
- Umberto Galimberti, Parole nomadi, Feltrinelli, Milano, 2006.
- Umberto Gori, Guerra, in Bobbio, Matteucci, Pasquino (a cura di), Dizionario di politica, UTET, Torino, 1990.
- Michael Hardt, Antonio Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Milano, Rizzoli, 2002.
- Eric Hobsbawm, Il Secolo breve. 1914. L'era dei grandi cataclismi, Rizzoli, Milano, 1995 (ed. or. 1994).
- Eric Hobsbawm, Imperialismi, Rizzoli, Milano, 2007.
- Mary Kaldor, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'era globale.Carocci, Roma, 2003 (ed. or. 1999).
- John Keegan, La guerra e il nostro tempo, Mondadori, Milano, 2002 (ed. or. 1998).
- Carlo Maria Martini, Quale bellezza salverà il mondo?, www.dehoniane.it
- Fabio Mini, Soldati, Einaudi, Torino, 2008.

- Fabio Mini, Perché siamo così ipocriti sulla guerra?, Chiarelettere, Milano, 2012.
- Maddalena Oliva, Fuori fuoco. L'arte della guerra e il suo racconto, Odoya, Bologna, 2008.
- Francesco Tuccari, La politica mondiale dopo il 1989, Loescher, Torino, 2003