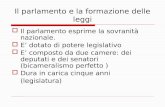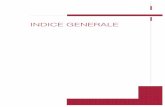L'accordo tra due leggi dell'accento paleogermanico
-
Upload
matteo-bartoli -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
Transcript of L'accordo tra due leggi dell'accento paleogermanico

Bartoli. 180 Accento paleogermanico.
L ' A C C O R D O T R A D U E LEO(I I D E L L ' A C C E N T O P A L E O G E R M A N I C O .
La posiz ione de l l ' accen to pa l eoge rman ico si pub s tab i l i re , o l t re che pe r mezzo del la n o r a Legge V e r n e r 0 , a n c h e per mezzo d ' u n ' a l t r a legge, che l ' a u t o r e di ques t e pag ine ha tes t6 f o r m u l a t a e si ~ p r o v a t o a d i m o s t r a r e 3).
P e r mag g i o r ch ia rezza ~ bene r i po r t a r e qui b r e v e m e n t e quel la fo rmula , con la omiss tone del tocar io e de l l ' e t i t i co 3). In posiz ione p ro ton i ca ~) le sonore 5) a r io -europee si sono a sp i r a t e nel l 'or lo mer id iona le del la sede p re i s to r i ca degli Ar io-europei , , ancora i nd iv i s i " (CODe d i rebbe l 'Ascoli) , e sono r i mas t e i n a l t e r a t e nel res to di que l l ' a rea . E invece fuor i della posizione p r o t o n i c a quel le sonore si sono assord i te nel ge rman ico e ne l l ' a rmeno , e sono r i m a s t e i m m u t a t e nelle a l t r e l ingue del la famigl ia .
In a lcuni casi, p e r es. in quel lo del got . brobar , le due leggi si a c c o r d a n o : quel got . b v iene da un ar io-eur , b-' e p da un ar io-eur . - ' t- , s icch6 a m b e d u e
quel le c o n s o n a n t i go t iche p r e s u p p o n g o n o un pa ro s s i t ono : ar io-eur , br~ter. In a l t r i casi, invece , C0De in quel lo del got . talhun, 8~x~ ecc., le due leggi d i s co rd an o : quel t p r e s u p p o n e un oss i tono e h u n paross i tono .
Ebbene, lo scopo che mi p ropongo in ques te pag ine 6 a n z i t u t t o di m o s t r a r e che le voci in cui le due leggi si acco rdano son pit1 n u m e r o s e di quel le in cui d i scordano. Ino l t re mi p roverb a t r a cc i a r e la s to r ia delle voci di ques to secondo t i po : p id p r ec i s amen te , ce rcherb di m o s t r a r e la Ioro et~ r e l a t i v a m e n t e t a r d a ( ~ 3 e 4), poi l ' a r ea dove sono sor te (w 5) e inf ine la causa o a lmeno la condiz ione di quel le i nnovaz ion i .
Si a v v e r t a i no l t r e che qui s a r a n n o raccol te solo voci che a b b i a n o un e t imo a r io -europeo indiscusso 6).
l) Sulle varie formule delia Legge Verner si vedano le citazioni nell'Arch, glott, it. XXII 119 (nota 16). A proposito della formula proposta ibid. XXI ~ 106 sg. si notino il got. hwahar, il sscr. katar,~-, r~6"rr da *~o'r_~p6r Riv. di filol. LVII! 25, nora 4 (invece di parossitont leggi ossitonO, e got. anbar , ~'~r da *-&;. Cfr. pag. 186, nora 9, Hirt V w 177 e. Meillet Bull. Soe. Ling. XXX 2 48 e 189.
2) Vedi rarficolo ,,Le sonore aspirate e le sonore assordite dell'ario-europeo e l'accord0 loro col ritmo", neIla Silloge linguistica, dedicata a Graziadio Isaia Ascoli, Torino, Chian- tore, 1929, pp. 63--130. La quale Silloge ~ stata pubblicata anche nell'Archivio glottologico italiano, volume XXll e XXIII (Sezioni riunite). Oltre alia nora abbreviatura Arch. glott, it., e a d altre egualmente note, sar/t qui usata l 'abbreviatura lntroduz., per in- dicate una mia lntroduzione alia neolinguistica (Prineipi, scopi, metodi), t3inevra, Olschki, 1925.
a) Vedi le citazioni nell'Arch, glott, it. XXII 119 (nota 14) e 125 (n. 85). ~) Pit~ precisamente: all'inizio d'una sillaba accentata. 1~ probabile che l'ario-europeo
avesse, in una fase antichissima, un accento espiratorio (o meglto prevalentemente espi- ratorio), e che questo sia stato sostituito pit1 tardi - - , in una parte dell'area preistorica degli Ario-europei (v. Arch. glott, it. XXII 117) ,,ancora indivisi" - - da un accento musicale o tono; v. Arch. glott, it. XXII 113 e specialmente le citazioni a pag. 126 (nota 98). Per la tesi contraria v. sopra tutto Meillet Bull. Soc. Ling. XXX ~ 41--6 [e XXXi 1--7].
s) Diversa, ma simile, ~ la storia delle sorde ario.europee: v. I'articolo ,,Le sorde aspirate dell'ario-europeo", negli Studl ilal. dl filol, glass., Nuova Serie, vol. VII (1930), pp. 5--23, - - Sul sscr, stikht7 (pag. 16) e s~cattil Meillet esprime, nel Bull. 8oc. Ling. XXX 2 69 sg., un'opinione the mi sembra meno/ondata , ma certamente pit~ brillante.
s) 8ulle fasi ario-europee deUe voci goL da~htar, tllus, gU~a si discute ancora e molto, tanto che esse non potrebbero provare nulla nel caso nostro. Perci6 quelle voei ed altre

Bartoli. 181 Accento paleogermanico.
8 1. I casi de l l ' accordo fra le due leggi si possono d iv idere in due gruppi . Si conf ron t ino :
ar io-eur , pa leogerm, russo. I. b-'p da cui b-p(h): got. bropar brdt-a;
Ii. b-p-' ,, ,, p-b- : anglosass, cnedan ~ gnet~. Nel p r imo t ipo l ' accen to cade fra la sonora e la sorda . Piti p r e c i s a m e n t e :
la sonora si t r o v a al l ' inizio d ' u n a s i l laba a c c e n t a t a e la so rda al l ' inizio d ' u n a s i l laba d i saccen ta ta . Percib la sonora si conserva nel pa leogermanico e la so rda r imane bensi sorda , m a viene a sp i r a t a 0 .
Nel secondo t ipo invece la sonora si assordisce e la so rda si sonor izza . Cominc iamo col t ipo bropar, m a a v v e r t e n d o e sp l i c i t amen te che esso
r icorre meno spesso ~) che il t ipo cnedan.
I. got. bro/mr: arm. eXbayr, russo brat, brtita, 9p{xopa), sscr. bhr~tar-; e l a t [rater ecc. got . ga-aars: lesb. $~p,o~, sscr. ahdr,:ati; paleonord , geisl(e) etc. (8 4): sscr. h~,as; anglosass , gielp: sscr. pra-galbhti-;
II. Ags. cnedan, isl. an t . knol)a: russo gnet(,, gnesti; alto ted. medio kobe ecc.: *'~'ux-~, da qui T ~ q (Esichio); a l to ted . an t . cor6n, chor.~n: sscr. ]u~:tite; got. paida: [ ~ ' ~ da * ~ ' r - ~ ; 0 got. tagr (cfr. w 2): lit. aszard; p a l e o n o r d . - t i g n , a l to ted . an t . uigOn (cfr. 8 6): sscr. dicdti O, lat . indicare; got. -tigu, alto ted . an t . -zug, oggi -zig (zwanzig ecc.)6): la t . decu-ria T)
(cfr. 8 4); (pa leonord . tog) al to ted . an t . zug, giziugOn (8 6): la t . gduc~re; paleonord , tong, al to ted . an t . zanga; 8~tx:~v; got. tuz-, al to ted . an t . zur: ~ - , sscr. du.~-.
simili saranno omesse, e baster~ rimandare alle citazioni nell'Arch, glott, it. XXII 121 sg. (nota 51); v. anche Walde-Pokorny 629. - - lnoltre saranno omesse le formazioni relati- vamente seriori (limitate al germanico o al gotico), quail got. barizeins, blgsan, diupipa, gauri]m e anche gabaur]3s, gakun/Js (e gakunds) e kalds.
1) Sull'etb. di_quell'aspirata v. Idg. Jahrb. VII 63 (41), X 281, XII 214 (19). Anche Arch. glott, it. XXll 113.
2) Nell'ario-europeo ,,ancora indiviso" le voci e forme con l'accento sull'ultima (cio~ con ~ ~ e ~ ~" all'uscita) erano pitt frequenti che quelle con I'accento sulla penultima (_, v): v. intanto l'articolo ,,Ancora una deviazione del greco dall'ossitonia ario-europea", nella Rivista ai filol, e d'istruz, class. LVIII (1930), pp. 24---39.
8) Sul tono di ~po~'rv)p e su quello di q~t~atT'/~p cfr. Vendryes M~m. Soc. Ling. XIX 75 ed E. Hermann Idg. Forsch. XXXVIII 149.
4) Come ~.6XX'q da *~tXX~ o sire.: v. Riv. di filol LVIII 24 sgg. Su [30t~x~ si veda il noto studio del compianto Thumb nella Zeitschr. f. vgl. Sprachf. XL1V 43; su alban. petk~, Jokl Idg. Forsch. XLIV 43.
5) Cfr. Meillet Bull. $oc. Ling. XXX 2 103---5. - - Sul ted. Zelchen e sim. v. idg. Jahrb. Xll 230 (T. E. Karsten).
a) Su altre forme germaniche (paleonord. tigr, tiog ecc.) v. ldg. Jahrb. XI 418 (Lid~n), XIV 212 (Collinder) e 215 (A. M. $turtevant).
v) Cfr. Glotta XVlll 270 (Maresch).

Bartoli. 182 Accento paleogermanico.
Anche diverse forme ario-europee con -t-' (46'- ecc.). got. *kn#ps, knOdai, kunds: sscr. jflatd-, "t'vorr6r paleonord. -kund: [3~'r6g, sscr. gatd-; got. satidg: sscr. sddittt-; got. tamida: sscr. damitd-; sass. ant. tand: lit. dantis ecc. (w 4);
lnfine le seguenti forme paleogerm, in -izd -ezd-uzl, d a - i s d ece. (v. pag. 186, n. 9):
got. hatizaX): • got. riqiza: ~pr sscr. rd/as; paleonord, setr, da seteza-: ~8~(6)-, sscr. sddas; e got. ]ukuzi: ~(~)u-fr , paleosl, i~esa.
8 2. In questo paragrafo saranno raccolte - - semplicemente raccolte - - le voci del tipo got. talhun ,,dieci", cio/~ queile dove le due leggi discordano: quel t accenna a una forma ario-europea ossitona e invece h a una base parossitona. Aceanto a quella forma troviamo la forma got. -tug, alto ted. ant. -zug etc. (w I), la quale assomiglia dunque a talhun nel significato. bla il t e il g di -tug accennano concordemente a una base ossitona.
Simili sono i casi seguenti: got.: ga-teihan, alto ted. ant. zihan; ma paleonord. -tign e simili da
ario-eur, d-k-' (cfr. 8 1); got. tiuhan, alto ted. ant. ziohan; ma paleonord, tog e sim. (w 1); alto ted. ant. trahan, zahar; ma got. tagr (w 3); got. tunpus; ma sass. ant. tand (8 4). E anche anglosass, gar, alto ted. ant. ger, paleonord, geirr; ma paleonord.
eisl(e) e sire., da ario-eur, g-'s. In tre casi poi le variant i antiche sono sparite: alto ted , a n t bar, forse sass. ant. gold (w 4); got. ga-tarhjan, sass. ant. torht; Cio~, sono sparite (cfr. w 3) le rispettive coppie *t~6s- e *par-', g-'t(h) e k-d-',
a-'k(a) e t-g-' (w 3).
8 3. Per le voci raccolte nel paragrafo precedente si pub fissare l ' e t ~ . Pitt precisamente: si pub fissare i'et& relativa delle forme seguenti:
got. tathun, alto ted. ant. trahan (e zahar), got. tunpus; alto ted. ant. e mod. bar, ger (e anglosass, gar, paleonord, geirr) e got. gulp.
E possiamo dire che esse sono posteriori alle rispettive variant i : got. -tigu (alto ted. ant. -zug), tagr, sass. ant. rand; *bos-' e *paz-', geis-e
*kaiz-', *gelt(h) e *kuld-'. Pitt precisamente, le fasi paleogerman. *talk(h)-, *t(r)ttk(h)r-, *t6nt(h)-,
*bbs- e *paz-', gels e *kaiz-', come gr. 8~• 8&• eec. (w 5), vengono bensl dalle fasi ario-eur, d#k-, ddkru ecc., ma queste sono meno antiche delle antichissime fasi ario-eur, d(u)e kont-, dakra 2) ecc. (8 6).
z) Cfr. R. Loewe Ztschr. f. vgl. Sprachf. XLVIII 9g sg.
~) 0 dakr6m, -~: cfr. l'autorevole opinione del Thumeysen ibid. XLVlll 66 sg.

Bartoli. 183 Accento paleogermanico.
Si veda questa semplice figura: GERMANICO LITUANO germanico
- - greco indiano. Essa rappresenta i due tipi seguenti: OSSITONO: got. tagr da ario-eur, dakrt'l; lit. aszar~; parossitono: alto ted. ant. trahan e zahar, da paleogerm. *t(r)cik(h)r-,
gr. 8~v.t~u , sscr. dr e aera-. Quel tipo ossitono ~ pifi antico che il parossitono, come si pub dedurre
da due indizi geografici: il rapporto cronologico opposto non sarebbe fondato n6 su prove n6 su indizi di sor tat) , e lo stesso ~ a dire dell 'ipotesi che i due tipi siano nati , ,contemporaneamente" ~).
Nel caso nostro, come in tanti altri, si pub ricorrere anzitut to alia norma dell 'area ,,meno esposta" 8). Tale ~ stata l 'area settentrionale, o meglio di Nord-Ovest (german. e baltica), della sede preistorica degli Ario-europei in confronto con l 'area di Sud-Est (greca e indiana)4), Percib ~ probabile che il tipo ossitono, conservato nella prima area, sia pifi antico che il tipo parossitono.
Questo rapporto cronologico risulta anche da una seconda norma: da quella dell 'area sparita s). A questo proposito si osservi anzitut to che dei due tipi germanici, tagr e trahan, il primo ~ sparito interamente o quasi 6). Ora ~ noto che nella storia dei linguaggi - - e non solo in questa 7) _ le creazioni pid antiche si spengono s) di solito 9) prima che le pid recenti.
4. Per le altre due parole, cio~ per il got. tunpus e talhun, ci dobbiamo contentare di una sola norma geografica, e cio~ di quella dell 'area meno esposta.
Si confronti in primo luogo il lit. dant~s (gen. plur. dante), e anche il sscr. datas e l'eol. [8o~xr da * ~ lO). Le forme parossitone si t rovano hell 'area pitt esposta: sscr. ddntas e gr. ~8~wrr 11 sass. ant. tand r imonta a una base ario-europea con d-t-' e invece il got. tunpus a un german, t-th.
Simile ~ la storia delle forme germaniche per ,,dieci". Oggi si conferma sempre meglio l ' idea geniale che quelle voci partano da una fase ehe signi-
1) Cfr. lntroduz., pp. 20 sg. 44, 81 sg.; Arch. glott, it. XXII 65 e 95. z) Cfr. Arch. glott, it. XXII 101 sg. 8) Cfr. Introduz., pp. 3 e 67. Meglio ,,meno esposta": v. Arch. glott, it. XXI166e 118
(nora 10). 4) Cfr. Studi ital. di filol, class. Vlll 17 (nota 1) e Idg. Jahrb. XI 76 (27). s) V. Introduz., pp. 15 sgg. e Riv. di filol. LVll 339 (nota 2). e) Cio~, per quello che mi consta. Ci6 che si dice deile parole ,,morte" vale, nel caso
nostro, anche per le ,,moribonde": v. Arch. glott, it. XXI 32. ~) Cfr. gli Atti del I Congresso nazion, di studi romani, Roma 1928,pag. 393, nota 1. s) S'intende che nessuna creazione ,,muore": nessuna si spegne proprio interamente,
senza lasciar traccia nei 'parlanti, e nessuna ~ creata proprio interamente, dal nuUa: v. w 2 e lntroduz, pp. 38 e 78.
9) Eccettuato il tipo JUVENIS e adolescens: Introduz., pp. 15, 22, 31 e 105. lo) Riv. di filol. LVIII 25, nora 4.

Bartoli. 184 Aecento paleogermanieo,
f i cava , ,due m a n i " l ) : con l ' a r io-eur , d(u)e kont- e sim. cfr. s p e c i a l m e n t e il gr. -• 3) e i l got . handus , , m a n o " . I1 t ipo pa ros s i t ono si t r o v a anche pe r ques te voci , come pe r , , l a g r i m a " e , , d e n t e " , ne l l ' a r ea piti e spos t a : cfr. 8~• e sscr. cldca. I1 got . -tigu e il lat . decu-ria sono sor t i , in u l t i m a anal is i , da u n a fase a r io -europea oss i tona , e invece il got . taihun da u n a fase g e r m a n i c a p a r o s s i t o n a : *talk(h)-.
Inf ine si con f ron t ino le fo rme seguen t i : r i zo ton iche : a r i z o t o n i c h e : l i t . b~sas basel ( femin . ) russo bos (*bds) bosd ( ,, ) germ. *has (*bbs) *paz6 *par-'
le t t . zdlts russo zolot6] germ. *gelt(h)- germ. *kulct-'
sscr. hg~as *y=to6? germ. geis *kaiz-' *kair-' L'a l to t e d . - a n t , bar ~ n a t o da l la conf luenza di *b6s- e *par-'. S i m i l m e n t e
il got . gulb da germ. *gdlt(h)- e *kuld-'; X~or forse da un *XcZor e da un *y,r e va r i e fo rme g e r m a n i c h e da geis- e *kair-': al to ted. an t . geis(i)la e ger, anglosass , gisil e gar, pa leonord , geisl(e) e geirr. Delle quai l v a r i a n t i si p o t r e b - bero n o t a r e var ie cose 8), m a nel caso nos t ro ci ba s r a c o n s t a t a r e che a n c h e le voci a l to ted. ant . bar, geis(i)la e ger ecc. sono seriori , di f ron te a*bos , *par- ecc.
Sono gli u l t imi echi di l unghe lot te , forse secolari , t r a le fo rme r i zo ton iche e le a r i zo ton iche , che c o n v i v e a n o nel la f less ione a r io -europea , n o m i n a l e e ve rba le , con l ' accen to m o b i I e 4).
w 5. Ora si con f ron t ino le fasi pa leogerm. *t6k(h)-, *t6nt(h)-, *t(r)6k(h)r- con ~-•162 e sscr. dcica, 686vx~ e ddntas, ~&• e dcru. Quelle fasi pa leoger- m a n i c h e non si possono s t a c c a r e dal le simili fasi greche e ind iane , sicch6 le une e le a l t r e v engono p r o b a b i l m e n t e da fase a r io -eu ropea pa ross i tona . Queste , cio6 le i nnovaz ion i ar io-eur , dek-, dfntes, ddkru, dal le fasi, anco ra pfft an t i che , ar io-eur , clue kont-, eclontds, dakr(~, sono sor te v e r o s i m i l m e n t e in u n a delle sedi p re i s to r iche degli Ar io-europei , , ancora ind iv i s i " .
x) V. ora ldg. Jahrb. XIII 76 ~E. H. Sturtevant). E Arch. glott, it. XXll 97 e Ztschr. f. vgl. Sprachf. XXXI 361--3.
2) Diverse sono le forme sscr. da~6t- e paleol, eccl. des~t/, slov. cles~l e sim.: cfr. Meillet Btfll. Soc. Ling. XXX 2 188 sg. e 223.
s) 1~ notevole, fra l'altro, che le forme con s significano quasi ttttte ,,frustino" o simili, e quelle con r invece ,,freccia" : gli 6 che le prime, essendo usate predominantemente nel singolare, partono dalla fase rizotonica (-'s-) e le altre invece, usate per 1o pifi nel plurale, dalla arizotonica (-r-').
4) Questa ~ decisamente, secondo tma mia salda e ormai vecchia opinione, la via migliore per la soluzione di questi e altri simili problemi, come ~ per es., l 'unione di &yoc86~ col got. god-, e di~b-6~ col lat. deus, e di altre numerose coppie, che sono in parte raccolte nella Riv. di filol. LVI 453; v. anche Arch. glott, it. XXII 85 e 90 sg. - - Di tm'altra opinione (di quale?) sono o erano lo Chantraine ed E. Fraenkel, ehe, nell'ldg. Jahrb. XIV 142 (18 sg.) e 259 (3), decisamente deviarono da quella via ,,ardua e buona". Cfr. poi Riv. di filol. LVI 424 (nota), LVII 336 (n. 1), LVili 37 (n. 9).

Bartoli. 185 Accento paleogermanir
Questo ~ tu t to cib che possiamo affermare oggi del l u o g o d 'origine di quelle innovazioni antichissime. Tu t t ' a l piti possiamo aggiungere un ' ipotesi che ci 6 suggeri ta dalla figura del w 3:
GERMANICO LITUANO germanico
- - greco indiano. Come si vede, il t ipo OSSITONO (got. tagr e lit. aszara) si t rova nel Set ten-
tr ione e manca al Mezzogiorno. Viceversa il t ipo parossi tono (Sdt• ecc.) piti diffuso nel Mezzogiorno che nel Set tentr ione. Percib ~ probabile che
quell ' innovazione, ario-eur, dd~ru da ario-eur, dakra o sim., sia sor ta in un 'a rea meridionale della sede preistorica degli Ario-europei, e di 1/l diffondendosi 0 sia gi tmta in alcuni dialet t i paleogermanici , sempre in un 'epoca anteriore alle immigrazioni.
w 6. Ora f inalmente 0, e solo ora, possiamo aff rontare il problema che, anche nel caso nostro, ~ il piti grave s): Quale ~ la causa delle innovazioni , che si possono chiamare t ipo 8o~• o meglio tz~Ou?
Ma ~ necessaria ancora una premessa, che r iguarda la c o.i1 d i zi o n e di quelle innovazioni. Essa ci ~ descr i t ta da una legge che ~ s t a t a formula ta test~. ') e ch iamata appunto legge di VAOu. Si confrontino queste fasi:
~ diviene ~ ~ e invece ~ _, resta
*~YX~ ,, ~TZ~ ,, &YX o~ ,,
La legge r iguarda le voci ario-europee che hanno un accento sul l 'u l t ima. Se ques ta era breve, I 'accento passa sulla penu t t ima ; se era lunga, r imane su quella.
L ' innovazione ~ a v v e n u t a in diverse al t re voci. Di queste spe t tano al caso nos t ro : got. ta ihun, alto ted. ant . trahan, got. tunpus , con 8~• ~ O u , ~ 6 ~ , sscr. d~ica ece. (w 4).
Poi le seguent i : come ~YX~ ~ posteriore a &yx~. e &YXO6 cosl german, alto ted. ant . lat. germ. alto ted. a.
- -kh z ihan . . . . ( in )d ica(re ) t~k '_ zeigfin . . . . z iohan . . . . (e)duca(re) . . . . gi-ziugOn
Certamente il rappor to fra ~YX~ e &yXo~ non 6 identico a quello fra z fhan e zeig~n e fra z iohan e -ziug~n. Ma ~ pur sempre simile, come si vede: quei due -h-an rif let tono una sil laba a tona e -g-6n una tonica.
x) Sulla diffusione di innovazioni fonetiche v. i cit. Acres du I. Congr. intern, deling., Leida, s. a. [1929], pp. 30 sg. e 107 sg.; anche Arch. glott, it. XXll 115, 125 (nota 88), 129,679 (sub imitazione), Riv. di filol. LVI 436 (nora 1) e LVII 337 sgg, - - Ma cfr. anche Meillet Bull. Soc. Ling. XXX 3 32.
2) Sull'ordine di tali ricerche (etA, centri d'irradiazione, cause) v. Arch. glott, it. XX 172--180, XXI 1, Riv. di filol. LVI! 343 sg. (nora 2).
3) Cfr. Arch. glott, it. XXII i17 (n. 2). 4) V. ora ibid. 96. - - Sul termine metatonia v. Riv. di filol. LVIII 35 (n. 3).

Bartoli. 186 Accen(o paleogermanico.
w 7. La legge di $ ~ ci d/l la condiz ione ~), r ipe t i amolo , non la causa d e l l ' i n n o v a z i o n e desc r i t t a nel p a r a g r a f o p receden te . Q u e s t a causa 9) e cosi quel le del la Legge Verne r e del la legge aff ine ad essa 9) r i m a n g o n o , in g ran pa r t e , a v v o l t e helle n e b b i e del la pre i s tor ia .
Pos s i amo dire, t u t t ' a l pitt, ehe i ' a ccen to a r io -europeo si ~ spos t a to in d iverse eta4), e mo l to pitt spesso ve r so l ' inizio del la p a r o l a che verso l a f i n e s), e p id di r ado nel ba l t i co e nel lo s lavo 9) che negli a l t r i l inguaggi ar io-europei . Sicch6 q u e l l ' i n n o v a z i o n e ~ s o r t a s p e c i a l m e n t e nei l inguaggi ar io-europei del ,Mezzogiorno e pitt t a r d i a n c h e in quell i de l l 'Occ iden te . E poss iamo osse rvare che in a lcun i dei l inguaggi non ar io-europei che sono v e n u t i in c o n t a t t o con gli a r io -europe i , p r i m a e dopo le im m ig raz ion i dei padr i nos t r i , l ' a c c e n t o o il t ono cade a p p u n t o sul la p r i m a s i l laba. T r a ques t i l inguaggi si t r o v a n o , pe r esempio, l ' e t ru sco T) e pitt d ' u n l inguaggio ugro-f innico .
Ma lasc iamo co tes t i p rob lemi e v e n i a m o a u n a conclus ione pitt sempl ice e ins ieme pitt sa lda .
Dalle p a g i n e che p recedono r i su l t a in p r imo luogo che le voci in cui le due leggi de l l ' accen to pa l eoge rman ico si a c c o r d a n o sono pitt n u m e r o s e che quel le in cui n o n si acco rdano . Ino l t r e si ~ v e d u t o che d iverse voci di q u e s t a seconda specie, o a l m e n o a lcune di esse, sono r e l a t i v a m e n t e recent i e h a n n o la lor~ causa (o la ioro condiz ione) in u n ' a l t r a legge: in que l la di g ~ 8).
Sicch6 la Legge Verne r e la sua af f ine si c o n f e r m a n o a v icenda . O megl io : la legge del celebre l i ngu i s t a danese , no ra da t e m p o e quas i i n t e r a m e n t e 9)
~) Cfr. Introduz., pp. 38 sgg. e 78 sg., Riv. di filol. LVIII 35 (n. 2) e i citati Acres du i Congr., pag. 108.
2) V. Arch. glott, it. XXI 2 113 sg. 8) Sulle diverse iunovazioni delle cousonanti germaniche (dette ,,Lautverschie-
bungen") v. ora Subak Arch. glott, it. XXll 627--635; anche 125 sg. (note 86 e 96), ldg. Jahrb. XII 214, Xlll 257 sg. e 268; inoltre Pokorny Wt~rter u. Sachen XII 306 sgg. (sul clima v. Arch. glott, it. XXII 127, nora 101). Da ultimo Otintert nei Betr~ige zur neueren Literaturgesch. XVI (1930) ed E. Lewy nella Ztsehr. f. vgl. Sprachf. LVlll 15.
4) Cfr. Riv. di filol. LVIll 34. 5) 1 casi come - ~ e sscr. sv~idft-, O ~ p ~ e gharm~-, . ~ e dhamti- (Arch. glott.
it. XXII 101 sg.) sono molto pit~ rari ehe quelli del tipo ~..~Ou (93 sgg.). s) V. Arch. glott, it. XXII 117, nora 4. v) Cfr. specialmente Sehrijnen M~m. Soc. Ling. XXIII 69 sg. e Devoto Arch.
glott, it. XXI! 209 sg. Sulle varie innovazioni linguistiche dipendenti dal prestigio v. Meillet Bull. Soc. Ling.
XX X 2 210 e Arch. glott, it. XXI 9 95 sgg. (Ooid~nich), XXll 129 e 679 (sub imitazione e inIlussi).
8) La legge di ~ . ~ u ~ insieme un' anomalia, contro le due leggi dell'accento paleoger- manico: v. Riv. di filol. LV! 434 e cfr. l'espressione del Verner Ztschr. f. vgl. Sprachf. XXIII 101 (alia fine del secondo capoverso) ,,eine regel f~r die unregelm~issigkeit". - - Sul dualismo fra legge e anomalia v. anche Arch. glott, it. XXII 123 (nora 62) e Terracini ibid. 649.
9) V. ora Meillet Bull. Soc. Ling. XXX a 48: ,,la Ioi de Verner n'est ~tablie que pour la consonne qui suit la syUabe initiale du mot; on n'en a aucune preuve pour le reste du mot". Ma la nuova formula della LEx VERNER (V. la prima nota del presente articolo) vale per tut te le sillabe e si accorda anche con la L~x TnORNEVSEN: got. agis agisis da agis(is) e invece aqizi da agisi ~[-v 'q ; v. w 1 (pag. 182), e cfr. intanto Hirt V 98 (w 63) e Loewe nella Ztschr.f. vgl. Sprachf. XLVIll 99 sg.

Bartoli. 187 Ar paleogermanica.
accolta, conferma ~) l 'al tra legge, che era contestata finora (v. pag. 184 nota 4) da alcuni eminenti maestri e colleghi.
[Correggendo le prove di stampa, trovo da fare qualche aggiunta alia dfiplice serie degli accordi: w 1. Nel I gruppo ~ da mettere anche il got. agis, agisis (v. pag. I86, note 9), nel II invece aqizi (ibid.).
In questo gruppo, inoltre, anglosass, cwidu, paleonord, kvdda e sim.: armonizzano con sscr. *jatfz, da cui jcttu, secondo la legge di ~ 8 ~ : w 6.
Anche aUa serie degli etimi autorevolmente contestati, pag, 180, nota 6, si pub aggiungere qualehe esempio: alto ted. ant. (anche medio e moderno) glas, got. trudan e altri.
Nessuno, per cib che mi consta, aUa serie delle dissonanze].
Torino. MATTEO BARTOL1.
INTERPRETATIONSFRAGE BEI GOTTFRIED VON STRASZBURG.
(Vgl. Neophilologus IX, 172).
Die Verse 16941--16966 in Gotffrieds Tristan (Ausgabe Marold) - - i n der Allegorie der Minnegrotte - - bieten lnterpretationsschwierigkeiten, die noch nicht befriedigend gel6st worden sind. Sie finden sich namentlich an zwei Stellen:
1. 16959--63: worauf bezieht sich das ir in 16959, das ir in 16960, das die in 16961, das die in 16963?
2. 16965: was ist das in fiir eine Art Wort und worauf bezieht es sich7 Ranke (Die AUegorie der Minnegrotte in GottJrieds Tristan) tibersetzt
16957 ft. : , ,Wit starren unverwandt empor zu dem kiinstlichen Werk der Tugenden
der Minne und zu dem Glanz, der von ihrem Ruhme zu uns herniederstrahlt, und wenn wir so emporstarren, so wachsen auch unserem Sinn die Schwingen, dai~ erfltiggewird und hochfliegend durchTugenden R~ihmliches hervorbringt."
Also: das ir in 59 bezieht Ranke offenbar auf minne, welches Wort in 41 zuletzt vorgekommen ist; das ir in 60 bezieht er auch wohl auf minne oder auf tugenden; die Verse 61 und 62 scheint er zu tiberschlagen, auch das die in 63. Ebenso wird n ich t deutlich wie er das in in 65 auffaBt.
1) Un'altra conferma si vede nel fatto che nei monosillabi indiani e greci i tipi bh~- e (-)[b, cio~ con I'asplrata ail' inizio e la non aspirata all'uscita, sono pid numerosi e - - c i 6
che pid conta - - pid antichi che i tipi contrari:
ba ~- e (-)~bh. Cfr. sscr. bhr~- eud ecc.: Arch. glott, it. XXIi 67 sg. e 70 sg. - - S imi lmente ira i
bisillabi indiani e greci i tipi
bh~b~ e bdbh~ sono pifi antichi e pid numerosi che il tipo boba, che abbJa cio~ due mealie e qualunque
tono e quantitY:
bdbd e b~ML