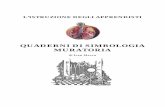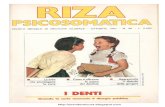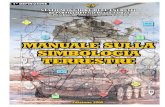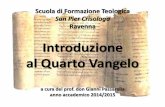La Simbologia Rosa-Croce
Transcript of La Simbologia Rosa-Croce

LA SIMBOLOGIA ROSA-CROCE
08-02-2007 - ripetuto il 21-06-2012)
M. Ven.,
credo che ogni Lavoro che viene presentato in Loggia debba avere un collegamento con i principi massonici che distinguono e reggono il nostro ordine. Quindi anche questo modesto Lavoro avrà un taglio che dovrà servire per farci meglio comprendere perché ci riuniamo nel Tempio.
Non darei per scontato che tutti quelli che hanno avuto un’iniziazione virtuale siano poi riusciti a comprendere il senso propriamente iniziatico, metafisico, della vita che abbiamo scelto di percorrere, e cioè dare un carattere esoterico del vivere insieme una meravigliosa esperienza di vita.
La Massoneria è la figlia naturale di una tradizione antichissima, che si perde nella notte dei tempi, e la tradizione ci dice che la verità è una e che la conoscenza iniziatica differisce da ogni sapere profano.
In tali condizioni si può comprendere che il nostro sapere non deve essere erudizione, ma punto di partenza per la riflessione per tutti coloro i quali, interessandosi veramente a tali studi, saranno coscienti di comprendere chi siamo, da dove veniamo e dove andremo.
Ringrazio il M. Ven. che mi ha concesso di presentare un Lavoro che possa illustrare i principi che hanno distinto il movimento Rosa-Crociano. L’itinerario che propongo non vuole tracciare le linee storiche, ma le premesse culturali che possono spiegare la nascita, nei primi del 1600, di una proposta di rinnovamento globale del sapere, della vita spirituale e di quella sociale, che una invisibile cerchia di Fratelli avrebbe deciso di rivolgere agli “uomini di buona volontà”.
Non dobbiamo dimenticare che nel Rinascimento riprese potentemente vigore la tradizione ermetica, e nella prospettiva di un rinnovamento globale, dopo secoli di tenebre, occorreva recuperare la chiave di lettura dell’Universo e sottoporre a verifica le possibilità dello spirito umano. Andò così rinnovandosi anche la comunicazione simbolica, con il recupero di immagini archetipali antichissime.
Vi sono ragioni per pensare che già Dante, con la sua associazione della “Fede Santa” e la sua filiazione templare, avesse proseguito la catena della tradizione, ed assistiamo quindi alla trasformazione del templarismo, dopo la sua apparente distruzione, per generare il nuovo movimento Rosa-Croce.
Nel Canto XXXI del Paradiso Dante così recita:
“In forma dunque di candida rosami mostrava la milizia santache nel suo sangue Cristo fece sposa”
E Dante, per la fine del suo viaggio celeste, prende per guida San Bernardo, che stabilì la Regola dell’Ordine del Tempio.
* * *
Parlare di Sapienza antica, nello spirito di Bernardo di Chiaravalle, scoprire le radici medievali cristiane dell’esoterismo quattrocentesco e cinquecentesco, sfruttando intuizioni spirituali, significa ricercare Dio, Dio e le sue leggi anche arcane, da lui stabilite per reggere l’ordine dell’Universo. Amerei che fosse la ricerca non di pochi eletti, talvolta appartati dal mondo, ma a vari livelli, da tutta una società in evoluzione sempre meno materialista, ma più vicina allo spirito.
Nella Gnosi, la Sapienza è la strada per recuperare ciò che fu perduto, ed ha la capacità di produrre unità dove vi era dispersione. La Gnosi può definirsi la ricerca della Conoscenza che salva. Conoscenza cioè della vera natura dell’uomo occultata nella materia, perché essa si ricongiunge nella pienezza dell’essere al principio vitale del quale è parte.

Questa ricerca equivale a percorrere faticosamente i gradini della scala che ascende al Cielo, i vari stati della Coscienza alla fine dei quali sta la perfezione dell’unione con Dio. Salire la scala iniziatica significa far morire un po’ alla volta l’uomo di terra perché alla sommità esso si dissolva completamente e l’uomo possa risplendere di luce nella pienezza della sua totalità, libero da scorie e legami con ciò che ha lasciato.
Esiste un ramo vitale della Gnosi che prendendo linfa vitale dall’albero della vita può portarci alla conoscenza intesa come concetto di Amore che salva. Il ruolo trainante di Amore appare quindi l’elemento distinguente che ha dato luogo e origine allo Gnosticismo, che è la strada per ricongiungere l’uomo a se stesso e a Dio.
Sembra che l’origine remota della Gnosi sia da ricercarsi nelle culture e nelle religioni iraniche, e nel loro incontro con il fertile misticismo giudaico. Da queste terre i Pitagorici appresero la magia del numero come chiave dell’armonia universale e la simbologia del Pentagramma stellato, il cui lato sta in rapporto aureo con il pentagono isoscele in cui è iscritto. Questo rapporto divenne simbolo della trascendenza divina e perciò matrice architettonica dei templi greci più celebri, dal Partenone di Atene a quello della Concordia di Agrigento. Platone lo ritenne lo strumento con cui Dio aveva creato l’Universo.
Da quelle stesse regioni giunse il culto misterico di Mitra, sapienza iniziatica nella quale il ricorrente simbolo del serpente conduce ancora una volta alla radice dell’albero cosmico.
Nei misteri di Mitra, la scala cerimoniale aveva sette gradini, ciascuno di un metallo diverso. Il primo gradino era di piombo e corrispondeva al cielo di Saturno, il secondo di stagno (Venere), il terzo di bronzo (Giove), il quarto di ferro (Mercurio), il quinto di lega monetaria (Marte), il sesto d’argento (la Luna), il settimo d’oro (il Sole). L’ottavo gradino rappresenta la sfera delle stelle fisse. In tal senso si riproponeva la relazione tra Gnosi ed Astrologia, da sempre accomunate nella visione di un Universo permeato da un unico spirito vitale e regolato da armonie matematiche e musicali. Il numero otto, estremo gradino di Mitra, rappresenta la pienezza dell’essere, di chi ha superato la scala iniziatica; riconduce a Sophia, che congiunge l’uomo, rinnovato e morto a se stesso, al suo “principio”.
Si deve al culto di Mitra se i Romani associarono il simbolismo solare con quello imperiale, secondo una tradizione che affondava le sue radici in Egitto e in Persia. Nell’architettura dei palazzi e dei mausolei imperiali tale simbolismo si traduce nell’adozione di piante circolari, come nel mausoleo di Adriano o in quello di Teodorico, nel quale la cupola ricavata da un gigantesco monolite di pietra istriana rappresenta la calotta del cielo.
Il cristianesimo si è nutrito della Gnosi: il vangelo di Giovanni respira di cultura gnostica. Cristo vi è presentato esplicitamente come albero della vita, mediatore tra la realtà visibile e quella invisibile. Così la croce venne a identificarsi con l’albero della vita, cioè con la conoscenza guidata da Amore: il braccio verticale fu simbolo della scala di Giacobbe, dell’uomo in ascesa verso Dio, mentre quello orizzontale lo fu della terra trasfigurata. Per questo nella chiesa cristiana la croce è collocata sull’altare, nell’ombelico del tempio, congiungendo misticamente la terra al cielo.
In epoca bizantina importanti cattedrali vennero dedicate alla divina Sapienza: nella loro architettura il simbolismo ascensionale dell’albero della vita e del centro del mondo è ancora una volta evidente nell’adozione della pianta centrale. Così è Santa Sofia a Costantinopoli, nella quale il cubo del mondo è sormontato dall’immensa cupola celeste. Il simbolismo dell’immagine di Luce, che la Sapienza può far risorgere nell’uomo, ci riconduce ai misteri gnostici. Troveremo ancora il trionfo del bianco, come catalizzatore di luce, nelle austere chiese cistercensi, che ripropongono la pianta di Cristo crocefisso, la cui armonia eleva un inno a Maria Sophia, regina del Cielo.
SIMBOLISMO DELLA ROSA - RICHIAMO ALL’ALBERO DELLA VITA - LA DIVINA SAPIENZA - L’ASPETTO FEMMINILE ESOTERICO DEL CULTO DI MARIA
Il simbolismo dell’Immagine di Luce, che la sapienza può far riemergere nell’uomo, ci riconduce con evidenza ai misteri gnostici. Troveremo ancora il trionfo del bianco, come puro

catalizzatore di luce, nelle austere chiese cistercensi, che ripropongono nella pianta Cristo crocifisso, ma la cui armonia eleva un inno a Maria Sophia, Regina del Cielo.
A ben ricordare, nella Rotonda di Montesiepi (San Galgano), proprio accanto, abbiamo visto una piccola cappelletta aggiunta un secolo più tardi sul lato nord-orientale, con affreschi di Ambrogio Lorenzetti, che raffigura Galgano con l’arcangelo Michele e San Bernardo, in adorazione di Maria, regina del cielo e patrona dell’ordine cistercense. Più in basso, sotto la Madonna, Lorenzetti dipinse una figura di Eva, sdraiata.
Nel rapporto tra Eva e Maria l’esoterismo medievale vede raffigurato il mistero della trasmutazione spirituale, di quell’alchimia interiore intesa non come chimica rudimentale ma come tecnica mistica per elevare l’anima a Dio. Consideriamo quindi l’elemento femminile interno al divino e dotato di propria autonomia; una teologia del genere, e cioè dell’eterno femmineo presente in Dio, appare anche nella gnosi islamica, con il ruolo attribuito a Fatima, la figlia del Profeta. A ben riflettere si tratta di una convergenza sorprendente che dimostra un legame stretto dell’esoterismo delle religioni monoteiste.
La presenza femminile nella sfera divina appare strettamente legata al tema della Sapienza, e in tal senso possiamo chiarire il posto che viene dato alla Vergine Madre che Sophia indica come la Sapienza divina, la Vergine eterna, l’Eva celeste, la dimora di Dio. E’ necessario comprendere che la Sophia significa l’elemento femminile rigorosamente presente nel divino. Simbolicamente si può parlare della compagna celeste di Dio.
Sophia rappresenta sia il corpo mistico di tutta l’umanità, sia il corpo di luce individuale, entrambi tesi a ricongiungersi con la propria origine. Quindi Fatima rappresenta sia il corpo mistico dell’umanità che l’anima trasfigurata, e in tal caso Fatima-Sophia è l’anima della Creazione, l’anima di ogni creatura, cioè quella parte costitutiva dell’essere umano che si presenta alla coscienza immaginativa essenzialmente sotto forma di un essere femminile, l’anima. Essa è l’eterno femminino nell’uomo per questo l’archetipo della Terra Celeste; essa è il paradiso e ne è l’iniziazione.
Voglio fare un riferimento interessante, cioè allo studio della Magia Naturale di Marsilio Ficino, che si basa sulle corrispondenze tra macrocosmo e microcosmo, che rendono possibile la realizzazione di talismani di energia, per mezzo di sostanze e prodotti naturali nei quali si concentrano le energie celesti. L’assioma di Ficino è illuminante: “...dato che non è possibile che si formino sulla Terra cose bellissime senza particolare beneficio e mirabile efficacia, è probabile che in sostanza di tal fatto siano incorporate virtù celesti.” Fra questi prodotti Ficino pone al primo posto i fiori (“De Vita”). Bach ha ripreso tale intuizione.
Vorrei accennare al concetto di Prima Mente, cioè alla prima creatura di Dio, eterna perché presente accanto a Lui prima del tempo. La prima mente era in origine senza forma e senza luce, ma trasformata da Amore si volse a Dio e ne ricevette luce e forma, cioè i principi ordinatori con i quali il cosmo sarebbe stato creato. Possiamo quindi affermare che Sophia, la Sapienza, appare analoga alla Prima Mente, alla materia prima universale, nella quale il Logos di Dio discese portando la Luce e la Bellezza, rendendola evidente e tramite fra la creazione e l’Uno. Questo nel cristianesimo è il ruolo di Maria, la donna che accolse il Verbo, divenendone il Tempio, immagine e prototipo di un’umanità trasfigurata.
Come prefigurato in Sophia, Maria è la strada per giungere a Dio e nello stesso tempo, nella veste dell’Assunta, il compimento di questa strada. Il Rinascimento dedicò a Maria la maggior parte delle chiese a pianta centrale, proprio perché esse riproponevano il simbolismo dell’ascensione. In oriente la pianta centrale è stata impiegata per le chiese dedicate a Sophia Santa, perché ciò dimostra ancora una volta l’affinità tra la figura di Maria e quella di Sophia, entrambe intese come strada che conduce al cielo. Basta guardare l’immenso ottagono del Duomo di Firenze dedicato ad un’inconsueta Santa Maria del Fiore. Il fiore fu immagine analoga a quella di Sophia, e quindi in Dante troviamo che la Rosa alla quale conduce Amore è simbolo delle nozze mistiche della Sposa e dell’anima con Dio.
E’ significativo che Dante abbia riproposto il simbolismo mistico della Rosa nel Paradiso. Il fiore fu anche il simbolo dei Fedeli d’Amore. Si tratta di una tradizione ermetica e gnostica che

fiorì in occidente a partire dall’XI secolo, sulle orme di una mistica Sufi, la quale utilizzò anch’essa la terminologia amorosa per simboleggiare la tensione amorosa dell’uomo verso Dio.
La mistica dell’Amore si diffuse con grande rapidità nel mondo occidentale: furono gli anni dell’improvviso nascere e fiorire in Provenza della Cabala, la pratica esoterica ebraica; dell’eresia catara, di origine manicheo-gnostica e legata al poetare d’amore dei trovatori provenzali; della fondazione dell’Ordine dei Templari, che ebbero la Regola scritta da San Bernardo verso il 1130. La poesia dei poeti siciliani della corte di Federico II ed in seguito quella del Dolce Stil Novo e di Dante si collocarono nell’alveo di questa tradizione esoterica. Nell’esperienza mistica ed esoterica dei Fedeli d’Amore pare riassumersi la vicenda simbolica della cattedrale di Santa Maria del Fiore e della sua cupola.
Sicuramente è la tradizione ermetica il comune denominatore di questa teologia dell’Amore, ed è dagli scritti espliciti di Ficino e Pico, e soprattutto dalla tradizione e concetti del “Corpus Hermeticum”, che possiamo risalire alla comprensione di tante composizioni poetiche che sono apparse fino ad oggi oscure. Nel Pimandro (il primo e più importante dei libri che compongono l’Hermeticum) si afferma che la salvezza è conoscenza di sé, attraverso il rinvenimento di quella forma luminosa che è l’Intelletto divino, presente in modo omologo sia accanto a Dio che nel cuore dell’uomo.
La donna cantata da Dante e dagli altri Fedeli d’Amore sembrava identificarsi con questo Intelletto divino. Il Valli dette ampia dimostrazione del significato mistico di queste donne, che egli identificò con la Sapienza. Valli ci ha indicato anche i precedenti della raffigurazione femminile della Sapienza e del rapporto amoroso con il quale l’anima si unisce a Dio, ritrovandoli nella Sophia gnostica; ma li ritroviamo nella Sapienza biblica, con particolare riferimento alla sua identificazione con la Sposa del Libano del Cantico dei Cantici; ma anche con la Sapienza identificata da Sant’Agostino, e non mancano certo i richiami ai significati della poesia d’Amore dei Sufi persiani.
Le donne dei Fedeli d’Amore sono accolte in Paradiso in modo trionfale. Così pure Beatrice nella Divina Commedia appare a Dante condotta su un carro trionfale, accompagnata dalle Virtù, e con ciò viene identificata con la Sapienza. Da Salomone: “Questa ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza, ho cercato di prendermela come sposa, mi sono innamorato della sua bellezza”.
Due secoli dopo, Giordano Bruno in un suo scritto ripete le parole di Salomone, descrive Sophia, la Sapienza divina, come l’amata e la sposa dell’anima: “Lei ho amato e ricercato fin dalla prima giovinezza, ho desiderato farla mia sposa e sono diventato amante della sua bellezza...”
Il Cantico, il più misterioso dei libri sapienziali della Bibbia, fu per il Medioevo cristiano il testo mistico per eccellenza, che simboleggiava l’unione estatica dell’anima con Dio e pertanto il “manuale” della dottrina dell’Amore cosmico; manuale iniziatico, perché il linguaggio erotico non poteva essere compreso da tutti nel suo significato esoterico. Beatrice come sposa del Cantico è dunque immagine dell’anima trasfigurata che accoglie l’iniziato alla fine del suo cammino, ma è anche immagine di una Sapienza individuale, presente nel profondo dell’anima, che conduce l’uomo a Dio attraverso l’iniziazione di Amore.
Dante, Fedele d’Amore, conclude l’itinerario iniziatico della Commedia con la visione del Fiore e di Maria nella gloria del Trono. “Vergine Maria, figlia del tuo figlio - umile e alta più che creatura - termine fisso d’eterno consiglio” (Paradiso, XXXIII). Nella preghiera di S. Bernardo sembrano quasi riecheggiare anche le parole della Sapienza biblica: “Dall’eternità stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della Terra” (Proverbi 8,22), come se Dante avesse voluto alludere proprio ad esse e suggerire una relazione stratta tra la figura di Maria e la Sapienza, cioè il Fiore (la Rosa).
L’Immacolata Concezione, Immacolata Visione del mondo creato, posta fra l’eternità e il tempo, come l’essere perfetto subito dopo Dio, Regina degli angeli, madre degli uomini, essa è la Sapienza, la celeste Sophia che nutre di sé le anime create. La festa dell’Immacolata Concezione è tradizione antica della Chiesa; misteriosamente essa è legata all’eternità, alla consumazione dei secoli, alla fine di un’era ed all’inizio di un mondo nuovo: si pensi alla terza profezia di Fatima, che la Chiesa non ha voluto ancora rivelare, ma si sa legata alla fine del millennio.

A questo proposito c’è una coincidenza sorprendente: il 12 Novembre 1486 Pico della Mirandola terminò le sue 900 “Conclusioni”; la IX di quelle cabalistiche afferma: “Se v’è qualche congettura umana plausibile sul futuro, mediante le occulte vie della Cabala possiamo trovare che la consumazione dei secoli avverrà con l’anno 2000 l’8 Dicembre, festa dell’Immacolata”.
L’analogia tra Maria e Sophia è adombrata anche in S. Bernardo, che vede Maria come la via che conduce al Figlio, così come Sophia è la via che conduce a Dio. Nella Vita Nova, Beatrice-Sophia appare a Dante vestita di rosso e poi di bianco, ma questi sono i colori dei Templari. Anche l’abito degli Ismaeliti (Hashishin), ordine esoterico e guerriero musulmano, era bianco e rosso e com’è noto quest’Ordine iniziatico sciita ebbe rapporti stretti con quello dei Templari.
Ma il bianco ed il rosso erano anche i colori dell’uovo filosofico dell’alchimia, che racchiude in sé la pietra filosofale. Nell’architettura del ciborio dipinto attorno alla figura di Maria nella chiesa di S. Francesco da Paola in Firenze, non sorprenderà allora notare ancora una volta la presenza della rosa a cinque petali, simbolo della Quintessenza e della Pietra della Sapienza, di quella quinta parte dell’uomo corrispondente all’Intelletto.
Nella Divina Commedia, Beatrice appare a Dante su un carro, insieme con tre fanciulle vestite di rosso, di bianco e di verde (tradizionalmente identificate con le tre virtù teologali) ed ella stessa è vestita con i tre colori, ma è interessante osservare che tutto l’esterno della cattedrale di Santa Maria del Fiore è impostato su questa tricromia sacra, con il marmo bianco di Carrara, con il serpentino verde di Prato, con il rosso del cotto. Anche la Madonna di San Francesco da Paola, a ben guardare, ha il manto candido orlato di una striscia verde; nella sua figura si ritrovano dunque tutti e tre i colori di Beatrice, Sapienza che guida Dante nei misteri più profondi del cammino iniziatico della Commedia.
Ciò che voglio dire è che queste coincidenze cromatiche per Beatrice e la Madonna templare ci confermano ancora una volta che nel Medioevo, e nei Fedeli d’Amore in particolare, esisteva una tendenza ad identificare Maria con la divina Sophia, con quel principio femminile presente nella sfera soprannaturale, che era comune anche all’esoterismo delle altre religioni del Libro sacro, quella ebraica e quella islamica.
Tornando al nostro discorrere iniziale si può affermare che la rosa a cinque petali, che nel simbolismo alchemico rappresenta proprio la quintessenza, cioè lo spirito fecondante e trasmutante, è la Sapienza cantata sotto forma di donna, cioè l’archetipo femminile, forma pura di luce, che accoglie l’iniziato oltrepassata la soglia del tempo e dello spazio.
LA ROSA - SIMBOLISMO
Nelle scuole iniziatiche c’è sempre qualcuno che vuole interpretare, forzando la mano alla tradizione, ciò che era la sapienza antica. Anche per i Rosa-Croce è avvenuta la stessa cosa: abbiamo così assistito ad un fiorire senza limiti, alla nascita di decine e decine di organizzazioni o movimenti che volevano richiamarsi all’ortodossia del pensiero Rosacrociano.
Ancora oggi decine e decine di associazioni iniziatiche nel nome dei Rosa-Croce pullulano tra le scuole di ricerca esoterica, e così pure la Massoneria vi dedica l’iniziazione del 18° Grado del Rito Scozzese ed esalta le caratteristiche speculative ed esoteriche del movimento. Persino Steiner attraverso gli scritti dello Schuré si è occupato dell’iniziazione dei Rosa-Croce. E’ chiaro che il vero movimento, quello ortodosso per antonomasia, è assolutamente segreto, e la ricerca si svolge senza la partecipazione di alcun maestro, ed è soltanto orale.
Il simbolo della rosa è più che mai significativo. La rosa è la bellezza elevata al massimo fino a comprendere la grazia, la dolcezza, la purezza; il suo profumo evoca il sentimento ed esalta lo spirito. Nella sua breve durata c’è l’invito a riflettere sulla brevità della vita stessa. In particolare, la forma della corolla può essere un simbolo della concordia e d’amore: infatti intorno ad essa si stringono i petali e i sepali...
Da sempre la rosa viene cantata dai poeti, scolpita dagli scultori, raffigurata dai pittori, e la sua presenza ha un significato altamente simbolico. La croce è considerata l’incontro fra i quattro

elementi (acqua e aria in orizzontale, terra e fuoco in verticale), nel cui centro, inteso come punto di perfetto equilibrio, può fiorire la rosa simbolo a sua volta della perfezione, della bellezza, dell’amore e della vita.
Portare la croce è un’altra versione del ‘conosci te stesso’. Tutti gli elementi che sono nella nostra croce, vale a dire nel nostro essere, vanno studiati poiché ci si deve occupare della croce vivente. Non serve un gran che portare al collo una croce o mettere delle croci nelle chiese e nei cimiteri, finché non si capirà che l’uomo stesso è la croce. Egli è la croce e con essa deve lavorare. Quando un iniziato prega egli si gira verso i quattro punti cardinali dell’universo: traccia in tal modo una croce per indicare che il suo spirito intraprenderà un lavoro sulla materia.
Ciascun punto è presieduto da un Arcangelo: ad est Michele, ad ovest Gabriele, a nord Uriel e a sud Raffaele. Quando il cristiano porta la sua mano destra prima alla fronte e poi al plesso solare, alla spalla sinistra e poi alla destra, entra in contatto con i quattro punti dello spazio, materia sulla quale deve lavorare con il proprio pensiero e con il proprio amore.
Il simbolo dei Rosa-Croce è una Rosa Rossa (talvolta) al centro di una croce. La rosa rappresenta il cuore, il chakra del cuore perfettamente sviluppato nell’uomo considerato come la croce sublimata. L’uomo sviluppa questo chakra con l’amore, il cui colore e profumo sono quelli della rosa. La Rosa-Croce è dunque il simbolo dell’iniziato, il quale, grazie al lavoro che ha realizzato su se stesso, è riuscito a sviluppare in sé l’amore di Cristo, l’amore divino, l’amore che vivifica e trasforma la natura. Essere un Rosa-Croce significa conoscere tutti i segreti legati alla croce ma anche tutti quelli della rosa al centro della croce. La rosa sulla croce è l’essere perfetto che non solo conosce tutti gli elementi di cui è costituito e la sua relazione con il cosmo, ma è anche capace di far scaturire e fluire l’amore di Cristo. Colui che avanza sul cammino cristico diventa un Rosa-Croce, anche se non iscritto a questo movimento. La rosa al centro della croce è, perciò, l’uomo perfetto che ha sviluppato il chakra del cuore.
Si può fare un collegamento tra il simbolo Rosa-Croce ed il Santo Graal, quella coppa di smeraldo che contiene il sangue di Cristo. La coppa che deve riempirsi di questa quintessenza divina, il sangue di Cristo, è l’essere umano, il quale grazie al suo lavoro di purificazione permette al sangue di Cristo di depositarsi in lui. Ma egli è anche la croce, perché la croce, come anche la coppa, è sempre l’uomo, ed è su questa croce che deve sbocciare la rosa: cioè la vita e l’amore di Cristo.