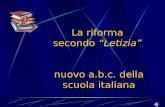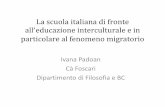la scuola italiana: quanto siamo lontani dai Paesi più avanzati?
La scuola italiana
-
Upload
nadine-benedetti -
Category
Education
-
view
62 -
download
0
Transcript of La scuola italiana

LA SCUOLA ITALIANA (leggermente ampliato il 30 novembre)
Dovendo parlare della scuola italiana, cosa si potrebbe dire di rassicurante? Nei libri di Storia di elementari, scuole medie e superiori e nei testi universitari di Storia (anche contemporanea) non si fa che ripetere lo stesso programma, che può essere definito un’accozzaglia di inutili date di
battaglie e nomi e un elenco di fatti storici che non arriva nemmeno lontanamente all’attualità e inoltre edulcorato e quindi falso con poche eccezioni
rilevabili dove si consigliano saggi e opere letterarie integrative (questa soluzione ha un carattere davvero d’eccezione e inoltre si dà a questi testi un qualche inquadramento e rilievo generalmente solo all’Università): in classe e nei libri di testo non si parla certo delle torture e degli stupri di gruppo
in pubblico compiuti dai fascisti, ma sono messi in rilievo gli occasionali confini e l’uso dell’olio di ricino (invece limitato) e peraltro tralasciando di
descrivere quei dati che rendevano anche questa pratiche distruttive, come del governo di Giolitti del resto si fa qualche accenno all’indirizzo generale e se ne elencano alcune date e non si fa nessun riferimento alle violenze compiute dai criminali da lui pagati e per le quali la gente lo considerava un
capomafia; davvero poco spazio è dedicato ai motivi reali del successo di individui ignoranti, falliti e con poche doti quali erano Mussolini e Hitler,
ma spesso viene dedicato quasi un intero capitolo a quell’episodio in realtà ridicolo che fu la Marcia su Roma; vengono dati molti dettagli sulle bonifiche del governo fasciste ma si fa solo qualche accenno alla povertà e disperazione delle masse soprattutto agricole e nessun riferimento agli
operai pestati per il semplice fatto di essere operai, ai furti dei gruppi fascisti nei negozi, alla decadenza delle scuole di ogni livello, alla conseguenze
anche economiche della guerra in africa nei dettagli (se poi libri come Un mare di nulla prendono spunto da alcuni fatti reali e davvero aziende dove lavorare implicava il contatto con materiali tossici venivano fatte funzionare senza il materiale di protezione per i dipendenti, di certo non lo veniamo
a sapere a scuola)… Al metodo di analisi storico non si dedica una riga.
Perfino sui lager si fa leggere poco e male, (almeno nelle scuole dell’obbligo e alle superiori: poche riflessioni sul come e perché, nessuna sui legami dei fatti con l’attualità… E poi da quale testo scolastico o insegnante veniamo a sapere che l’origine delle camere a gas nei lager è da ricercare negli
omicidi di malati “mentali” e non compiuti dagli psichiatri tedeschi? Non sia mai che qualche studente sia portato a indagare sugli omicidi e le torture
compiuti dagli psichiatri italiani in tempi recenti e oggi o sull’effettiva ragionevolezza della caccia agli emotivi o “stupidi” che sembra lo sport preferito di studenti e lavoratori di ogni genere…) dato che si dà come riferimento Se questo è un uomo (che traumatizza o addolora e basta), e
magari La tregua (inutile) ma non I sommersi e i salvati e la prefazione dell’autore del 1976 a Se questo è un uomo, che invece fanno riflettere e
riportano informazioni relative a un periodo vicino a noi – gli anni ’80 o La banalità del male (testo fondamentale). Non c’è da stupirsi che ragazzini girino nelle scuole facendosi indicare serenamente indicare dagli altri come nuovi Fascisti, che un autista di autobus
scriva “W W Mussolini” al posto dell’indicazione della fermata e che nei pub ci si dilunghi sulle “grandi” bonifiche delle paludi…
E al di là dei libri di storia, libri utili come I Promessi Sposi vengono resi noiosi e insignificanti da decine di schede tematiche del tutto prive di riferimenti all’attualità e dal modo di leggerlo e di parlarne in classe; tantissimo tempo viene sprecato con testi che non dovrebbero avere niente a che
vedere con l’istruzione pubblica (come l’opera di Dante, di Tasso, di Petrarca, degli esponenti dello Stil Novo, di D’Annunzio ecc.); interpretazioni a
senso unico obbligate e spesso devianti di classici della letteratura (specie contemporanea) confondono nelle antologie, che inoltre vengono indicate come sostituto dei capolavori della letteratura che esse smembrano e di cui spesso non indicano i passi più formativi per un ragazzo o quelli che
trattano di qualità dell’istruzione o di esperienze vissute direttamente o meno da giovani (ad esempio, perché non si parla di Martin Eden o Il giovane
Holden? Perché non si parla abbastanza e per tempo di Ritratto di un artista da giovane? Perché il capitolo sulla scuola di I Buddenbrook non viene sottolineato? Perché si parla di Leopardi in modo così stupido e ripetendo sempre le stesse affermazioni dalle elementari all’università e senza dare il
rilevo doveroso a opere come Il Parini ovvero della gloria e Senofonte e Machiavelli in Operette Morali, né inquadrare il suo pessimismo in modo
ampio e obiettivo? Che senso ha non introdurre un testo come I fratelli Karamazov? Perché trattando Pavese si parla di tutto tranne che di La bella estate o di Il compagno? Perché non far conoscere Jovine? Perché non si accenna nemmeno a una letteratura di formazione spesso valida come quella
di Ende o fantasy in generale?) Perché di Seneca e di Fedro si fa leggere solo qualche inutile brano per le versioni di latino? E perché I 36
stratagemmi è sconosciuto a quasi tutti gli studenti italiani? Nessun cenno viene fatto solitamente a molti testi letterari di grande valore morale e ricchi di lucide analisi di situazioni sociali e politiche e psicologiche ancora molto attuali, testi molto importanti anche per il carattere indipendente
dell’azione degli autori (chi parla mai di Orwell, Ignazio Silone, Hemingway, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Arthur Koestler ecc.? Perfino un classico come I demoni di Dostoevskij è snobbato da antologie e insegnanti).
I manuali di Filosofia sono poi davvero odiosi e scritti col chiaro intento di diffondere tra chi li legge un’ignoranza peggiore di quella di chi non ne
studia a scuola e di mettere in ridicolo l’opera di studiosi e pensatori che hanno avuto un’influenza un’influenza enorme sulla cultura, sulla società e su fatti storici fondamentali: basti confrontare il capitolo dedicato a Hegel di un manuale liceale di Filosofia con il capitolo su questo filosofo in
L’uomo in rivolta di Camus per rendersi conto fino a che punto chi scrive questi manuali e chi stabilisce i programmi scolastici ci prendano per il
culo…Quel libro di Camus, così importante per conoscere lo sviluppo del pensiero occidentale è del resto sconosciuto alla maggioranza degli studenti (nemmeno a chi si appresta a fare una tesina di Filosofia spesso viene fatto conoscere). Ci sono manuali di Filosofia che addirittura prepongono al
capitolo relativo a un autore un riassuntino di una superficialità disarmante e in alcune scuole chi osa, nel compito in classe, fare più di trascrivere
quel riassunto, viene tormentato dai compagni decisi a dare il minimo sindacale. E i filosofi citati? Io, come molti, a scuola ho udito parlare molto di S. Tommaso, S. Agostino e Pascal, ma di Heidegger non ho udito il professore parlare più di un’ora e non mi è giunta una parola che si discostasse
anche di poco dalla trattazione schematizzata e banalizzante del manuale, nonostante non ci sia forse un “filosofo” più utile a un adolescente! E Jung?
A me non fu quasi nemmeno nominata questa personalità cui fanno riferimento migliaia di scritti di età contemporanea e che raccoglie informazioni e teorie dal meglio di ogni epoca e fondamentali per l’educazione trattando ampiamente del processo di individuazione di/del Sé (Archetipi e inconscio
collettivo e Lo sviluppo della personalità sono testi molto utili per chiunque, ma lo sono in modo particolare per un ragazzo).
Nei licei scientifico e classico anche un’insistenza assurda e a volte deleteria su operazioni di per sé totalmente fuori posto in una scuola pubblica come le versioni di Greco e Latino e nessuna informazione viene detta circa sbocchi lavorativi e sviluppo dei programmi negli anni scolastici
successivi. Allo Scientifico, inoltre, una matematica astratta e assurda che si rivela poi inutile a chiunque non si iscriva a Ingegneria e simili (cosa c’è
di più astratto della geometria non euclidea e del tipo di algebra cui si insiste dalla 3ª classe compresa in poi?) I criteri assurdi di valutazione dell’esame della Maturità dimostrano una volta di più quanto poco l’istruzione conti per il governo, che li stabilisce, e
per chi li approva: non c’è dubbio che se essa avesse qualche valore, il voto finale sarebbe calcolato anche in base agli esiti di tutti gli anni scolastici
precedenti e che l’esito dell’esame finale sarebbe considerato solo per dare una decina di punti in più o in meno; inoltre si pretenderebbe o premierebbe solo in base a indicazioni fornite dagli insegnanti di letture e compiti obbligatori e facoltativi e non certo in base a quanto dipende solo
dalla fortuna degli studenti (la buona tesina e il buon esito di quei quattro esami finali non dimostrano tanto intelligenza e conoscenza quanto che lo
studente ha avuto la possibilità di controllare la propria emotività e ricevuto quell’anno e nel tempo stimoli e informazioni dalla famiglia o da amicizie preparate dalle condizioni di vita familiari e frutto del caso, quando attestano anche un’intelligenza pronta o particolare in ogni caso non
dimostrano che chi la possiede sia istruito).
Ovunque si vedono almeno alcuni professori poco competenti negli aspetti dell’istruzione umanistica meno formali e superficiali, a volte davvero instabili, quasi sempre aggressivi, ignoranti nel giudicare i ragazzi e indifferenti rispetto alle loro condizioni di vita e reali possibilità: il loro
comportamento è continuamente in contraddizione con i messaggi dei testi e dei programmi.
E dell’Università in genere che dire? In tutte le Facoltà che devono preparare a professioni di enorme responsabilità (a cominciare da Medicina, Scienze Infermieristiche, Psicologia, Scienze dell’Educazione, Giurisprudenza, Scienze Sociali ecc.), manca l’obbligo di leggere tutta una serie di
opere indispensabili a ogni formazione che si elevi dai rozzi pregiudizi comuni. Nelle Facoltà “umanistiche” corsi formalistici aridi e gli stessi
programmi di Letteratura e Storia e la stessa indifferenza riguardo alla lettura dei libri citati e metodo di giudizio che si trovano alle Superiori, oltre a una separazione stupida dei corsi di Filosofia dagli altri rami fondamentali della cultura e, dal 2000 in poi, anche un isolamento di opere teatrali e
cinematografiche molto importanti per influenza esercitata e per qualità e inoltre l’obbligo odioso e rallentante di fare una tesina in più e, in alcuni
casi, la difficoltà o l’impossibilità di avere la propria laurea riconosciuta all’estero. E poi in ogni settore la povertà dei programmi viene messa in

ridicolo da un’infinità di master e specializzazioni, che proliferano anche per attività che s’imparano facilmente o in breve tempo semplicemente
svolgendole? A queste condizioni diventa difficile per chi studia non solo aver tempo ed energia per lavorare tanto da pagare un affitto, ma anche per
ottenere la vera cultura per conto proprio grazie a ricerche o a indicazioni come quelle fornite da documenti come questi. Vorrei invitare a considerare che informarsi sulle scuole è sempre utile anche per chi non ne ha personalmente bisogno: può cambiare del tutto la vita
di un ragazzo informarlo riguardo agli sbocchi lavorativi e sui programmi di ogni anno di università e scuole superiori e in particolare dei Licei, che
dalla terza classe compresa in poi si impoveriscono molto, diventando astratti e ridicoli, mentre fiaccano sempre di più: molto più che ottenere un diploma liceale o frequentare certe scuole o del diploma in sé, conta arrivare ai 18 anni nella migliore salute fisica e psicologica possibile e con una
base adeguata di informazioni reperibili non tanto a scuola quanto per esempio al sito http://www.slideshare.com/leggere-per-vivere e soprattutto al
sito http://www.slideshare.com/citazioni-molto-utili , dove si possono leggere molte citazioni da capolavori letterari e da testi di altro genere che aiutano a riflettere da punti di vista validi, non scontati e lontani dai pregiudizi rozzi dei più, su molte questioni fondamentali. È utile raccogliere
informazioni su programmi e prospettive lavorative reali di laureati in Filosofia e in Lettere (in particolare chi ha bisogno di essere indipendente dalla
famiglia d’origine per le più varie ragioni, dovrebbe certamente evitarle, soprattutto se non ha il carattere o l’aspetto adatto a lavori di segreteria o a dare ripetizioni o se crede di ottenere davvero così una cultura umanistica o ancora se pensa di scegliere l’indirizzo di Arte e Spettacolo). Ricordare
che è molto sconsigliabile comunque proporsi di laurearsi in generale se non si può contare su un rapporto di grande fiducia e serenità con la famiglia:
tutte le Facoltà, comprese quelle più semplici e prive di obbligo di frequenza, richiedono che si abbia la certezza di pagare non solo tasse e libri fino alla laurea, ma anche una residenza serena e che si possa inserire nel curriculum esperienze lavorative importanti e diversificate contemporaneamente
allo studio e ricavare dei risparmi per ovviare a imprevisti che possono risultare altrimenti deleteri e vanificare anni d’impegno: almeno nel periodo
più vicino agli esami quasi tutti gli studenti trovano difficile studiare in aula studio e se vivono altrove si recano a casa dei genitori; inoltre non si può contare sulle possibilità concesse dalla laurea abbastanza da studiare senza fare altro; riviste e forum online confermano che oggi pagare un affitto
tutti i mesi senza il contributo dei genitori è impossibile per la maggioranza delle persone giovani e non giovani e con tanto di curriculum adeguato,
figurarsi per studenti; infine la tesi di laurea non è una formalità per molti, dato che ci si stanca tra lavoretti e studio con il tempo e che a forza di esami orali e basati su una selezione piccola e precisata di testi ci si disabitua con gli anni allo scritto e a lavori di ampio respiro (molti infatti si fanno
fare la tesi da altri a pagamento anche se hanno una media alta, e ciò richiede prudenza, fortuna e denaro – 1.000 Euro almeno per la tesina di un
corso triennale). Chi vuole iscriversi a licei e Facoltà umanistiche per coltivare certi interessi e abitualmente risponde alle critiche altrui in proposito che eventualmente poi si adatterà a svolgere lavori umili, come se facesse così una concessione al mondo, consideri che lavorare come operaio
semplice o babysitter o dare ripetizioni non è affatto cosa facile o possibile per tutti, perché quasi per ogni cosa si richiede esperienza, un carattere e
un aspetto conformati secondo stereotipi e pregiudizi o almeno la disponibilità ad assecondarli esteriormente e una certa facilità nel rapportarsi agli altri, inoltre, per quanto riguarda le ultime due attività, sono indispensabili conoscenti adatti e, spesso, il far parte di gruppi o associazioni (ci sono
gruppi di (ex) universitari che danno ripetizioni in ogni città e chi cerca una babysitter si rivolge ad associazioni che le raggruppano e ne organizzano
in molte province), mentre un operaio deve spesso poter lavorare in ambienti rumorosissimi o magari a contatto con sostanze cancerogene o tossiche e avere un’auto propria, per i turni di notte, i quali peraltro possono generare gravi insonnie. Anche fare le pulizie non è semplice come sembra, dato
che: 1) occorre l’auto per il materiale, soprattutto se si tratta di farlo per ditte specializzate nella pulizia; 2) chi organizza la pulizia di ospedali,
condomìni, stazioni, strade, ecc… spesso utilizza “pazienti” della Psichiatria; 3) per pulire case private occorre affidarsi a conoscenti da ingraziarsi con il conformismo più assoluto e sopportare, spesso, di essere umiliati, pagati poco e in nero e di venire fisicamente troppo affaticati. È utile anche
una raccolta di testimonianze su chi ha cambiato scuola superiore in seconda o terza classe e facoltà dopo aver sostenuto alcuni esami. Vorrei anche
ricordare ai ragazzini che vivono sulle nuvole che qualsiasi lavoro è preferibile a fare il cameriere, il barista, il commesso o il cassiere (di locali, bar, gelaterie, créperie o negozi diversi dai supermercati) se si ha poca salute e forza fisica o poco autocontrollo o anche solo se si ha particolarmente
bisogno di essere prudenti – magari non potendo fare molto affidamento sulla famiglia - o se non si sa tacere o si soffre a contatto con persone pronte
alla malevolenza, ai giudizi settari e ignoranti, a comportamenti aggressivi verso gli altri dagli esiti anche estremi. Ricordo infine a tutti coloro che hanno problemi familiari e/o economici di qualche genere e agli anticonformisti che senza un guardaroba e un aspetto curati e in linea con i gusti e le
convenzioni della maggioranza, è pressoché impossibile lavorare quasi ovunque, soprattutto – ma non solo – se si è donne o dopo i 20 anni. Consiglio infine di raccogliere in una cartella qualche informazione sulle scuole private di CL e consigli onesti al riguardo (ad esempio, si dovrebbe
almeno confrontarsi con chi, non essendo ciellino e non sapendo nulla del movimento, è stato spinto a iscriversi a queste scuole magari dopo aver
frequentato scuole normali per i primi anni delle superiori: queste scuole sono aperte a tutti solo formalmente e per raccogliere le rette, ma gli studenti e i professori sono perlopiù ciellini spesso benestanti che si frequentano fuori dalla scuola da anni e sono assolutamente intolleranti nei confronti di
chi non è parte del movimento e non lo apprezza, hanno una mentalità molto chiusa e molto esigente in fatto di abiti e aspetto fisico e la tendenza ad
approfittarsi di chi è solo e non sta bene per “il bene del movimento”, come dicono tra loro, e sono inoltre di solito molto aggressivi in gruppo con chi non piace a uno di loro (e ciò del tutto indipendentemente da chi ha ragione dei due). Le conseguenze dell’ostilità di CL sono gravi perché questo
movimento è di fatto una casta formata da persone benestanti, che occupano posizioni importanti all’Università, nei collegi universitari, in uffici e
posti di lavoro di rilievo, in politica, ecc…: sebbene buone relazioni con CL possano significare lavoro sicuro, bisogna che sia chiaro che chi è sensibile, molto emotivo o impossibilitato a curare molto l’aspetto, dovrebbe senz’altro evitare di iscriversi alle loro scuole e badare alle relazioni con
CL delle persone appena conosciute. A livello di istruzione comunque le scuole private sono spesso inferiori a quelle pubbliche a causa della tendenza
dei docenti a essere larghi di voti con chi paga la retta da sempre e riscuote simpatie in certi ambienti e soprattutto a causa delle maggiori difficoltà per i privati di trovare insegnanti competenti disposti a lavorarci (lo stipendio è più basso e ci sono anche altre limitazioni a livello economico).