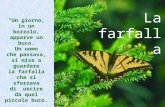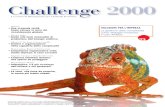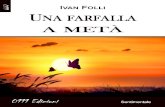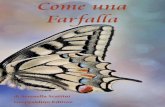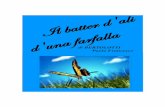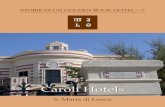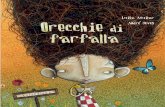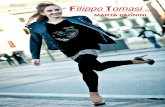La Ragnatela e la Farfalla
Transcript of La Ragnatela e la Farfalla
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 1/12
LA RAGNATELA E LA FARFALLA
La storia del pensiero politico occidentale, in particolare moderno, sembra dipanarsi tra due poli opposti di riferimento, che potremmo sinteticamente definire come contrattualismo da una parte e organicismo dall’altra. Questa opposizione sembra 1 2
tradursi in una domanda che delinea due alternative inconciliabili: è il riconoscimento dell’originaria libertà dell’uomo ciò che rende libera la società, o è lo sviluppo di una società libera a liberare l’uomo?
Un falso bivio Ad uno sguardo più attento, l’opposizione tra organicismo e individualismo si rivela, in realtà, meno netta e antitetica.Particolarmente significativo in questo senso è il percorso politico di J.-J. Rousseau. Pur
ritenendo che il punto di partenza sia lo stato di natura , formato da individui atomizzati , 3 4
tuttavia, per il pensatore ginevrino, la libertà naturale originaria è ormai perduta e l’uomo civilizzato deve costruire una libertà politica che non sia una semplice aggregazione, ma una vera e propria associazione
, in cui l’individuo non costituisce più una realtà 5
assoluta e autonoma, ma è parte di un grande tutto.
1 Si definiscono “contrattualistiche” quelle teorie politiche che individuano la nascita dello Stato giuridico in un patto, o “contratto”, che gli uomini stabiliscono tra loro, rinunciando all’originario “stato di natura”. Il
presupposto è che, in questa originaria condizione, gli uomini, non essendo associati tra loro e disciplinati da una serie di leggi positive e comuni, siano guidati esclusivamente dal proprio egoismo e dal mero istinto di autoconservazione, anche a scapito del bene e dell’incolumità altrui. Il “contratto” nascerebbe, allora, proprio al fine di uscire dallo stato incessante di bellum omnium contra omnes ( Thomas Hobbes, Elementa
philophica De cive, Amsterdam, Boom, 1742 ). 2 L’organicismo si contrappone all’individualismo in quanto concepisce i singoli individui non come realtà originarie e autonome, ma come cellule in relazione di interdipendenza fra di loro, alle quali solo l’organismo politico conferisce significato e valore. Nella concezione organicistica lo Stato è indipendente dagli individui e precedente ad essi in quanto simile ad un organismo vivente. Secondo questa concezione “il tutto precede necessariamente la parte, perché tolto il tutto, non ci sarà più né il piede né la mano”, di conseguenza “la città è per natura anteriore all'individuo” ( Aristotele, Politica , cit. in nota a p. 62, di N. Bobbio, Liberalismo e democrazia, Simonelli, 2006 ). Questa concezione giustifica la soggezione degli individui rispetto al tutto, in
quanto implica la superiorità della collettività sul singolo.3 Si vedano, a questo proposito, ad esempio, le riflessioni di Diego Fusaro in h ttps://www.youtube.com/watch?v=cMWxIRGXUDc .4 Cfr. C. Taylor, Atomism, in Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers, University Press, Cambridge 1985, pp. 187-210 .5 “ Ci sarà sempre una gran differenza fra sottomettere una moltitudine e governare una società. Se degli uomini sparsi, quanto si voglia numerosi, vengono successivamente asserviti a uno solo, io vedo, in questo caso, solo un padrone e degli schiavi; non ci vedo un popolo e il suo capo; si tratta, se vogliamo, d’un aggregato, non di una associazione; non c’è in esso né bene pubblico né corpo politico.” ( J.J. Rousseau, “Il Contratto sociale”, Laterza, 2010, p. 19 ).
1
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 2/12
Nella democrazia rousseauiana, ragione e vera libertà coincidono nella volontà generale , al punto che il ginevrino afferma che il singolo deve essere "forzato ad 6
essere libero" . Paradossalmente, nell’intento di superare il diritto del più forte ,
il 7 8
contrattualismo rousseauiano
sfocia in una "democrazia totalitaria", caratterizzata dall’alienazione definitiva, per quanto volontaria, delle libertà individuali .9
Il contrattualismo individualista e l’organicismo totalitarista sembrano così rivelare una sorprendente parentela, un terreno comune. Si configurano, in definitiva, più che come due antipodi, come le Scilla e Cariddi del pensiero politico, ovvero i due “mostri”, speculari e complementari più che contrapposti, che presidiano e costituiscono la medesima strettoia del pensiero.Da un lato, il contrattualismo o individualismo tende ad assolutizzare e ipostatizzare il 10
soggetto , che al contrario è sempre “in situazione”, ovvero si costituisce nell’intreccio 11
delle strutture materiali, inconsce, linguistiche, ecc. L’individuo isolato è impossibile dal punto di vista effettivo e impensabile dal punto di vista logico. Il singolo non è mai un
atomo pre-sociale, ma è costitutivamente immerso in un tessuto storico-sociale, che ne
6 La volontà generale non è la somma delle volontà di tutti i componenti, né la volontà della maggioranza, ma la volontà unica ed unanime che scaturisce dalla rinuncia di ognuno ai propri interessi a favore della collettività e dall’elevazione del singolo al moi commun : “A l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté” ( J.-J. Rousseau, Du Contract social ou Principles du droit politique, Amsterdam, 1762, Ch. 6 ).7 “Ma, si chiede, come può un uomo essere libero e contemporaneamente forzato a conformarsi a voleri che non sono i suoi? Come possono gli oppositori essere liberi e sottoposti a leggi, cui non han dato il loro consenso? Rispondo facendo notare che il problema è posto male. Il cittadino dà il suo consenso a tutte le leggi, anche a quelle approvate suo malgrado, e anche a quelle che lo puniscono quando osa violarne qualcuna. La volontà costante di tutti i membri dello stato la volontà generale: è
in base a questa che essi sono cittadini e liberi” ( J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, Cap. II ). Si noti come l’espressione che abbiamo messo in corsivo faccia affiorare una prospettiva di tipo organicistico.8 Rousseau definisce il diritto del più forte un “diritto per ironia”, poiché è un diritto infondato, contro le leggi e
contro la razionalità: “la forza non fa il diritto e si è obbligati ad obbedire solo ai poteri legittimi” (J.J. Rousseau, Il contratto sociale, BUR, 2005, I, Cap. 3 ).9 In modo, si noti, non troppo dissimile da quanto concludeva T. Hobbes.10 Il contrattualismo viene solitamente concepito in stretta connessione con una visione individualistica, in realtà è essenzialmente Locke a istituire questo nesso, per il quale la difesa dei diritti individuali è il vero e unico fine del contratto e di per sé l’antidoto sicuro e imprescindibile contro l'arbitrio del potere ( J. Locke, Second Treatise of Civil Government, 1690, Ch. 9, Sec. 124 ). Hobbes e Rousseau, invece, ritengono
l’individualismo una dimensione animale e pre-umana. Nel tentativo di superare quella che ritengono non
vera libertà, ma mero arbitrio, entrambi, pur con modalità e intenti diversi, giungono a concezioni schiettamente organicistiche.11 La teoria contrattualistica si fonda su due finzioni concettuali, lo Stato di Natura e il Contratto, che non
costituiscono non realtà storiche. Se ne era già reso conto quello che possiamo considerare il più sottile e profondo tra i padri del contrattualismo: “(Lo Stato di Natura) non esiste più, forse non è mai esistito e
probabilmente non esisterà mai” ( J.J. Rousseau, Discorso sull'origine e i fondamenti della diseguaglianza, Laterza, 1994, prefazione ). Questi due presupposti servono, oltre che a fondare la legittimità dello Stato,
proprio ad affermare come evidente e naturale la specifica antropologia contrattualistica, che concepisce l’individuo come un originario atomo isolato che agisce guidato da una razionalità egoistica.
2
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 3/12
determina lo statuto giuridico e ontologico, nonché la stessa identità . In questo senso, 12
possiamo affermare che non vi è individuo alcuno senza un organismo sociale che lo abbia generato e cresciuto.Dall’altro lato, l’organicismo concepisce il soggetto come creazione sociale ex nihilo
, ponendo così tutto il peso sull’unico elemento reale e razionale , quello sociale, 13
rimuovendo la “realtà” del soggetto, ovvero la sua capacità di retroagire sull'intreccio di relazioni che lo costituiscono, nel tentativo di disinnescare il soggetto come punto di resistenza.Insomma, “non si può parlare di società escludendo gli individui: l'opposizione individuo-società è falsa” . Entrambe le visioni si rivelano, allora, delle astrazioni più o 14
meno consapevoli che non riescono e non vogliono spiegare
come
in concreto funzioni il potere.
La gabbia d’acciaio
Questa complementarietà tra le due concezioni emerge in modo netto e preciso dall’analisi minuziosa e lucida del sistema liberale e capitalistico condotta da Max Weber, il quale mise in luce proprio come il sistema individualista per eccellenza sia (o possa essere) invece un impercettibile totalitarismo.Weber sottolinea come nel capitalismo avanzato, una volta persa l’originaria cornice religiosa protestante che vedeva nel successo materiale un segno della grazia divina , 15
l'accumulo di denaro sia diventato fine a se stesso. Il senso dell'agire umano si è spostato così completamente ad un livello di mera efficienza tecnica.La rapidità e la complessità del sistema ne celano l’autoreferenzialità. Il sistema si
pretende naturale e razionale, e quindi caratterizzato da un’invalicabile autoevidenza, che non prevede alternative. Il singolo ritiene di muoversi razionalmente in esso per perseguire scopi liberamente scelti, mentre, in realtà, è prigioniero di una “gabbia d’acciaio” , che, lungi dal significare garanzia di libertà, incarna invece la forma più 16
compiuta e perfetta di totalitarismo, capace di pervadere totalmente la vita degli uomini, determinandone il senso e illudendo i propri sudditi di scegliere liberamente ciò che invece è loro imposto.Nella società industrializzata e tecnologicamente avanzata, la razionalità connessa con il potere è diventata uno strumento di controllo e di dominio degli uomini e del loro
12 In questo senso, l’uomo è davvero e costitutivamente “animale sociale” ( Aristotele, Politica, I, 1253a ).13 Presupponendo, quindi, si noti, la stessa identica concezione dell’individuo “naturale”, come atomo egoistico e pre-razionale, che caratterizza il contrattualismo.14 http://www.societalibera.org/it/librisoclibera/testi/carlomonaco/02_temiragcm.htm15 M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904-05.16 M. Weber, Sociologia della religione, Milano, Comunità, 1982, vol. I, pp. 191-192 .
3
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 4/12
pensiero in ogni campo della vita sociale . Perciò “l'umanità, invece di entrare in uno 17
stato veramente umano”, sta sprofondando in “un nuovo genere di barbarie”, in una nuova specie di totalitarismo: “l'illuminismo totalitario” .18
Pier Paolo Pasolini descrisse con impareggiabile lucidità la dimensione totalitaria del capitalismo. Analizzando i nessi tra il consumismo globale, l’industria culturale e 19
l’omologazione di massa, Pasolini mise in luce la capacità di questo sistema di produrre un’adesione totale e incondizionata e stigmatizzò la “tolleranza” dell’ideologia edonistica, voluta dal nuovo potere, come la peggiore delle repressioni della storia umana. La caratteristica profonda dell’edonismo neolaico è, infatti, il pretendere che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo .20
17 Il riferimento è, ovviamente, alle analisi condotte dalla scuola di Francoforte: “l'illuminismo, nel senso più
ampio di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre l'obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni. Ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura” ( M.
Horkheimer, T.W. Adorno, Dialettica dell'Illuminismo, Torino 1967, p.11
).18 Cfr. M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialettica dell'illuminismo, Einaudi, Torino 1997, premessa.19 In questo contesto, l’industria culturale fa della cultura da un lato un raffinato strumento di propaganda, dall’altro un surrogato di realizzazione e di soddisfazione ( E. Morin, Lo spirito del tempo, Milano, Meltemi,
2005 (1962 ), un’arma di distrazione di massa, che assorbe e pervade tutti gli aspetti della vita dell’individuo, relegandoli in una sorta di “tubo catodico” ( Noam Chomsky, Il potere dei media, Firenze, Vallecchi, 1996 ).
Come aveva intuito Guy Debord, la “società dello spettacolo” costituisce un’evoluzione raffinata del capitalismo in una direzione nettamente totalitaria, in quanto tesa ad assorbire e pervadere tutti gli aspetti
della vita dell’individuo senza alcun residuo ( Guy Debord, La società dello spettacolo, 1967 ).20 “Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava a ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal centro è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. [...] Come si è potuta esercitare tale repressione?
Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al Centro. Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della televisione il Centro ha assimilato a sé l’intero Paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e
ciecamente estraneo alle scienze umane. La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto “mezzo tecnico”, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. E’ il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove collocare. E’ attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere. [...] Non c’è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo”.Questo ormai celebre articolo era apparso sul "Corriere della Sera" il 9 dicembre 1973 con il titolo "Sfida ai dirigenti della televisione" e venne poi raccolto in P.P. Pasolini, Scritti corsari ( Garzanti, Milano, 1975-76 ). (L'ultima parte dell'articolo, la "sfida", appunto, non appare in Scritti corsari , può essere reperita in P.P. Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, Meridiani, Mondadori 1999 ).
4
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 5/12
Quest’opera di massificazione e controllo poggia su un’ideologia più profonda e inavvertita, che potremmo definire “economicismo”, ovvero la riduzione della vita sociale, politica, culturale ai principi economici considerati preminenti su tutti gli aspetti della vita umana . Per il totalitarismo economico il senso e il valore si riducono a 21
profitto, utilità, efficienza, gestione delle energie, rapporto costi/benefici. L’affermazione, ormai incontrastata, di questa concezione impone un pensiero unico, autoevidente e ipostatizzato, che, ponendosi come naturale e razionale, esclude la possibilità di comprendere il sistema in cui si è immersi e, quindi, a maggior ragione, di elaborare una qualsivoglia alternativa. Per rompere questa gabbia d’acciaio è necessario, dunque, ripensare in modo radicale l'aspetto economico su cui si fonda il sistema globale contemporaneo, ricodificandone, anche radicalmente, le leggi . Bisogna, in altri 22
termini,
desacralizzare l’economia , riconducendola al suo significato etimologico , per 23 24
tornare ad essere consapevoli di come essa trovi il suo fondamento nella dimensione del “reciproco aiuto” .25
Soggetti e potere La rapida analisi fin qui condotta mette in luce come l’originaria e costitutiva radice individualistica del capitalismo tenda a capovolgersi in un inavvertito totalitarismo organicistico e tecnocratico. Questo accade perché il capitalismo, così come tutto il suo retroterra filosofico, si fonda e si impernia sul soggetto cartesiano, cosciente e razionale, naturale e autoevidente, che dietro la cortina dell’ontologia metafisica cela e
21 La mondializzazione dell'economia ha comportato il suo opposto complementare, l'economizzazione del mondo, la trasformazione di tutti gli aspetti della vita in questioni economiche, se non in merci. La globalizzazione disegna così un'avanzata inaudita nell'onnimercantizzazione del mondo (
S. Latouche, La mondializzazione e la fine della politica, Relazione alla 16^ scuola di formazione politica della Rosa Bianca
Polsa di Brentonico (Tn), 28 agosto 1996, http://www.edscuola.it/archivio/interlinea/lat3.html ). Un riduzionismo, si noti, che caratterizza, pur con obiettivi antitetici, anche il marxismo, cui si richiamavano, in modi diversi, gli autori qui citati e lo stesso Pasolini.22 “I contributi recenti di economisti ‘illuminati’ e critici verso questo tipo di globalizzazione mettono in luce la necessità (non l’esigenza) per la sopravvivenza di tutti di ricodificare le leggi dell’economia secondo principi di sostenibilità per tutti. [...] Una inversione di rotta impone cambiamenti radicali dello stile di vita e dei consumi occidentali attraverso scelte coraggiose” (A ntonella Sapio, Per una psicologia della pace, Franco
Angeli, 2004, p. 118 ). Significativamente, l’economia vive oggi una stagione di ripensamento anche radicale
e diverse sono le teorie alternative in discussione. Si pensi, per fare un solo esempio, al tema della della decrescita felice, sviluppato da Nicholas Georgescu-Roegen e poi da Serge Latouche, in aperta
contrapposizione con l’idea che ci sia sempre una correlazione necessaria e positiva tra crescita economica e qualità della vita.23 “L'economia ormai è una religione. Tutto viene visto e interpretato attraverso il prisma dell'economia. Se vogliamo che l'umanità abbia un futuro dobbiamo uscire da questa logica. C'è bisogno di creare [...] un movimento di ateismo economico”. Sono parole pronunciate da Serge Latouche durante il suo intervento, intitolato Il paradigma della decrescita e la dimensione spirituale, nell'ambito del convegno L'economista
mistico organizzato a Milano da Fondazione Arbor nel novembre 2012.24 Dal greco οἴ κος , "casa" inteso anche come "beni di famiglia", e νόμος , "norma" o "legge".25 Cfr. quella che P.A. Kropotkin definiva “coscienza del reciproco aiuto come fondamento"( Il mutuo appoggio ,1902 ).
5
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 6/12
rimuove la materialità e la storicità degli individui concreti. La riflessione di Michel Foucault, a partire dalla constatazione della morte di questo soggetto cartesiano, si è 26
mossa nella direzione di una genealogia del soggetto moderno , che ci permette di 27
comprendere il funzionamento concreto del potere al di là delle finzioni ideologiche .28
Foucault ridefinisce il concetto di potere: esso non è il dominio, non è la semplice repressione o proibizione, ma l'energia relazionale presente ovunque negli interstizi e nei pori della società, della sessualità, della famiglia, dei saperi, delle tecniche. Il potere, dunque, non è qualcosa che alcuni gruppi hanno e altri non hanno: tutti siamo costantemente immersi nelle relazioni di potere, non sono possibili divisioni manichee tra dominanti e dominati, poiché ognuno è simultaneamente l'uno e l'altro . 29
Il potere non è una semplice oppressione, che si esercita sulla libertà di un soggetto inteso come dato naturale pre-esistente. Al contrario:
il potere è produttivo . E, in primo luogo, produce proprio soggettività. Potere e libertà, allora, non stanno in una
26 “Ai nostri giorni, [...] si afferma non tanto l’assenza o la morte di Dio, quanto la fine dell’uomo (quel sottile, impercettibile scarto, quell’arretramento nella forma dell’identità, che hanno portato la finitudine dell’uomo a
convertirsi nella sua fine) [...] Più che la morte di Dio – o meglio nella scia di tale morte e in una correlazione profonda con essa – il pensiero di Nietzsche annuncia la fine del suo uccisore: ossia l’esplosione del volto
dell’uomo nel riso, e il ritorno delle maschere: la dispersione della profonda colata del tempo da cui l’uomo si sentiva portato e di cui sospettava la pressione nell’essere stesso delle cose; l’identità tra il ritorno del
Medesimo e l’assoluta dispersione dell’uomo. Durante l’intero XIX secolo, la fine della filosofia e la promessa d’una cultura prossima coincidevano probabilmente con il pensiero della finitudine e l’apparizione
dell’uomo nel sapere; oggi il fatto che la filosofia sia sempre e ancora sul punto di scomparire, e il fatto che forse in essa, ma più ancora fuori di essa e contro di essa, nella letteratura come nella riflessione formale, si
pone il problema del linguaggio, dimostrano probabilmente che l’uomo sta sparendo” ( M. Foucault, Le
parole e le cose, Rizzoli, Milano, 1977, pp.411-412
).27 “L’oggetto della mia ricerca sono stati i tre problemi tradizionali: ’’primo, quali siano i rapporti che noi instauriamo con la verità tramite quei “giochi di verità” che sono così importanti per la civiltà e nei quali
fungiamo sia da soggetto che da oggetto; secondo, quali rapporti abbiamo con gli altri attraverso quelle strane strategie e quegli strani rapporti di potere; e terzo, quali siano le relazioni tra verità, potere e sé. […]
cosa c’è di più classico di queste domande e di più sistematico del passaggio dal primo problema al secondo e poi al terzo per ritornare infine al primo? ( M. Foucault, Tecnologie del sé. Bollati Boringhieri,
Torino 2005, p.10 ).28 La filosofia politica moderna, ha sottolineato Foucault, si è interrogata sull’essenza del potere, in modo da rimuovere, attraverso una serie di finzioni concettuali (lo stato di natura, il contratto, i diritti naturali inviolabili,
i limiti del potere e la sua legittimità), il fenomeno storico della guerra, della lotta e della dominazione, che invece ha fondato concretamente gli equilibri storici tra i poteri. La teoria classica del potere è quindi un
dispositivo concettuale funzionale all'affermazione dello Stato monarchico moderno tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età moderna. Di conseguenza, questo “sistema di pensiero” si rivela del tutto autoreferenziale
nel suo intrappolare in una serie di domande tipiche (“Chi” esercita il potere? Chi sono i “dominanti” e chi i “dominati”? Quali sono i “limiti” del potere? Dove comincia la libertà? Attraverso quale “diritto” può fondarsi
la resistenza?), tese a rimuovere il concreto funzionamento del potere.29 “Il potere non è un’istituzione, e non è una struttura, non è una certa potenza di cui alcuni sarebbero
dotati: è il nome che si dà a una situazione strategica in una società data” ( M. Foucault, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 2004, p.83 ).
6
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 7/12
contrapposizione netta; il potere si esercita a condizione che esistano delle libertà : è 30
esso stesso a determinarle e ad attribuirle ai soggetti, generando quindi un campo di risposte possibili, rispetto alle quali il soggetto è autonomo.Insomma, esercitare il potere significa istituire un regime di verità, capace di orientare la soggettivazione degli individui . L’istituzione di un regime di verità, in apparenza 31
neutrale, obiettivo, scientificamente fondato, fa sì che i soggetti assoggettati diano forma alle proprie credenze interiorizzando un discorso che ritengono vero, plasmando la propria soggettività sulla base di un principio di realtà socialmente convalidato. In altri termini, se gli uomini governano secondo le regole dell’evidenza, non saranno più loro a governare, ma le cose stesse . Il soggetto è costantemente e contemporaneamente 32
soggetto di e soggetto a
un determinato dispositivo di sapere e potere ,
e si pensa, si 33
dice, si forma in uno specifico “regime di verità”, in cui acquista un senso la stessa nozione di soggetto .34
30 “Il potere viene esercitato soltanto su soggetti liberi, e solo nella misura in cui sono liberi. Con ciò intendiamo individui e soggetti collettivi che hanno davanti un campo di possibilità in cui parecchi modi di
condotta, numerose reazioni, diversi tipi di comportamento possano essere realizzati […] la libertà [… è] la condizione di esercizio del potere” ( Michel Foucault, Il soggetto e il potere, in H.L. Dreyfus – P. Rabinow, La
ricerca di Michel Foucault, Ponte alle Grazie, Firenze 1989, p. 249 ).31 “Questa forma di potere [ il governo] viene esercitata sulla vita quotidiana immediata e classifica gli individui in categorie, li marca attraverso la loro propria individualità, li fissa alla loro identità, impone loro una legge di verità che essi devono riconoscere e che gli altri devono riconoscere in loro.” ( Michel Foucault, Il soggetto e il potere, p. 241 ).32 “Se il governo governa alla verità, esso dovrà governare tanto meno. Più indirizzerà la sua azione alla
verità, meno avrà bisogno di governare. […] Se la verità può arrivare a costituire il clima comune ai governanti e ai governati […] deve arrivare un momento in cui l’impero della verità potrà far regnare il suo
ordine senza che le decisioni di un’autorità debbano intervenire. […] L’esercizio del potere non sarà nient’altro che l’indicatore della verità […] e al limite non sarà più necessario avere un governo [… perché] governanti e governati saranno in qualche modo co-autori simultanei di una trama che essi giocano in
comune” ( M. Foucault, Le gouvernement des vivants, lezione del 9 gennaio 1980 ). Si veda anche ibidem,
lezione del 6 febbraio 1980 .33 Foucault gioca sull’ambiguità del termine francese “sujet”, che significa tanto individuo soggetto al potere, e dunque “assoggettato”, quanto soggetto padrone di sé, libero di una libertà intesa come autoproduzione della propria soggettività: soggetto di e soggetto a. “Ci sono due significati della parola soggetto: soggetto a qualcun altro, attraverso il controllo e la dipendenza, e soggetto vincolato alla sua propria identità dalla coscienza o dalla conoscenza di sé ( M. Foucault, Il soggetto e il potere , p. 241).34
“Secondo me è pericoloso considerare l’identità e la soggettività come delle componenti profonde e naturali, che non sarebbero determinate da fattori politici e sociali” ( M. Foucault, Examines Reason in Service of State Power , intervista pubblicata nel 1979, trad. it. Studiare la ragion di Stato, in Biopolitica e
liberalismo, a cura di O.Marzocca, Milano 2001, pp. 149-150 ).
7
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 8/12
Il soggetto transindividuale
Il soggetto si colloca, dunque, in una dimensione “transindividuale” , piuttosto che 35
individuale, intendendo con questo termine la complessa trama di relazioni che costituisce il tempo dell'individuazione psichica e collettiva.L’individuo, lungi dall’essere un sostrato ontologico “ constitué et donné ”, è il risultato di un processo, che è costitutivamente trama di relazioni . L’individuo
non esiste mai in 36
totale isolamento , ma solo e sempre in relazione con il preindividuale e con l'ambiente 37
. E, d’altra parte, la società non è data dalla presenza di tanti individui, ma neanche è una "realtà sostanziale da sovrapporre agli esseri individuali, quasi fosse indipendente da essi". È invece una condizione operativa che determina un modo di presenza complesso . L’essere psichico e quello collettivo sono reciproci, in relazione. Il 38
transindividuale è una “relazione di relazioni” , ovvero relazione di una relazione 39
interna all’individuo e una esterna ad esso.
35 Questo concetto è stato elaborato da Gilbert Simondon negli anni Cinquanta, in una tesi di dottorato, poipubblicata con il nome L'individuation psychique et collective, ma riscoperto solo in anni recenti. Attraverso
la mediazione di G. Canguilhem, Simondon esercitò un’influenza indiretta sul giovane Foucault (Notre Dame
Philosophical Reviews. An electronic journal. Cfr. la recensione di “AA.VV., Gilbert Simondon: BeingandTechnology 2013.07.28, http://ndpr.nd.edu/news/41310-gilbert-simondon-being-and-technology/).36 Quella di “soggetto” è una categoria che ha a che vedere con l’ontologia, prima ancora che con l’antropologia, perché presuppone l’esistenza di un ente incondizionato, di un fondamento: il sub-jectum , ciò che precede e permane (come tale coincidente con la substantia ), ciò che sta alla base e che, dunque, fonda tutto il resto. A tale paradigma si contrappone quello della realtà quale complesso di interazioni, in cui ciascun ente è, allo stesso tempo, condizionato e condizionante rispetto al “resto”. Bisogna, insomma, sostituire ad una filosofia della sostanza una filosofia della relazione, che pensa il soggetto come una composizione proteiforme e mai definitiva di forze.37 “Nell’individuo passa qualcosa di quel preindividuale, che è insieme ambiente e individuo: a partire da ciò, da questo irrisolto, da questa carica di realtà ancora non individuata, l’uomo cerca il suo simile per creare un gruppo in cui troverà la presenza grazie a una seconda individuazione” ( G. Simondon, L’individuation
psychique et collective, tr. it. cit., p. 155
).38 “Le relazioni tra individui, basate sulla loro ‘natura comune’, costituiscono un ‘collettivo’ o un individuo superiore senza sopprimere l’autonomia dei singoli. Anzi tali relazioni aumentano la potentia agendi degli individui (includendo, di certo, la loro capacità di pensare o conoscere), e di conseguenza la loro capacità di esistenza [...]. Considerata la potenza 'naturalmente superiore' delle forze esterne ( Spinoza, Eth IV, ax. ), questo significa che un'unità di individui reciprocamente convenienti è la condizione intrinseca perché ognuno di loro mantenga la propria autonomia e singolarità” ( http://www.fogliospinoziano.it/articolispinoza/balibar1.PDF , p. 118 ).39 Cfr. M. Cumbes, La relazione transindividuale , in Il transindividuale. Soggetti, relazioni, mutazioni, Mimesis, 2014 ).
8
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 9/12
Si dissolve nuovamente, in questo modo, la pretesa opposizione tra sostanzialismi : 40
“psicologismo” e “sociologismo” , così come individualismo e organicismo, 41
misconoscono il fatto che la realtà è sistema di relazioni.
La filosofia come cura di sé
Quale ruolo può, dunque, svolgere la filosofia nell’ottica di un ripensamento della soggettività e dei suoi spazi di libertà? La concezione foucaultiana non si esaurisce nell’analisi compiaciuta di un potere senza residui, ma giunge a riconsegnare un ruolo etico e pedagogico alla filosofia, intesa non solo come teoria critica , ma anche e 42
soprattutto come pratica di vita. La filosofia, abbandonata la pretesa profetica, pedagogica o legislativa, deve essere tutt’uno con l’esercizio ascetico di autocostituzione del soggetto .43
In questo senso, Foucault dedicò i suoi ultimi lavori alle “pratiche di sé”, attraverso le quali l’individuo dà forma alla propria vita, a partire dagli schemi reperibili nella propria
cultura. La libertà diviene così riflessione consapevole e critica dell’individuo intorno alle proprie pratiche di sé. “Le persone, osserva il filosofo, sono più libere di quello che
40 Come ha notato E. Balibar ( http://www.fogliospinoziano.it/articolispinoza/balibar1.PDF , pp. 9-10 ), sullo sfondo sta la metafisica relazionale di ascendenza spinoziana: “Ogni cosa singolare, ossia qualunque cosa che è finita e ha una determinata esistenza, non può esistere né essere determinata ad agire se non sia determinata ad esistere e ad agire da un’altra causa che è anche finita e ha una determinata esistenza: e anche questa causa non può a sua volta esistere né essere determinata ad agire se non sia determinata ad esistere e ad agire da un’altra causa che è anch’essa finita e ha una determinata esistenza, e così all’infinito” ( B. Spinoza, Ethica, I, pr. 28 ). All’interno di tale prospettiva il vivente è concepito quale
configurazione complessa di carattere dinamico e prospettico, perché la vita, la realtà sono un divenire “senza-fondo”, in cui “non c’è sopra né sotto”, poiché “tutte le cose sono incatenate, intrecciate, innamorate” ( V. Sorrentino, Michel Foucault: il limite, l’altro, la libertà, pp. 5-6, in Lo sguardo. Rivista di filosofia, n. 4,
2010 ).41 Lo psicologismo concepisce il gruppo come un agglomerato di individui, il sociologismo “prende la realtà dei gruppi come un fatto” ( G. Simondon, L’individuation psychique et collective, pp. 201 e 209 della tr. it. cit.).42 “Ma che cosa è dunque la filosofia, oggi – voglio dire l’attività filosofica – se non è lavoro critico del
pensiero su se stesso? Se non consiste, invece di legittimare ciò che si sa già, nel cominciare a sapere come e fino a che punto sarebbe possibile pensare in modo diverso?" ( M. Foucault, L’uso dei piaceri, Feltrinelli, Milano, 2011 (1984), p.14 ).43 “Che cos'è la filosofia moderna? È una pratica che trova l'oggetto del proprio esercizio nella trasformazione del soggetto da parte di se stesso e del soggetto da parte dell'altro. [...] la filosofia come ascesi, cioè autocostituzione del soggetto: tutto questo, mi sembra, costituisce l'essere moderno della filosofia” ( Michel Foucault, Il governo di sé e degli altri – Corso al Collège de France (1982-1983), Feltrinelli,
Milano, 2009 (2008), p.336 ). E ancora: “è nel rapporto a sé, nel lavoro di se stessi su se stessi […] che il
reale della filosofia sarà in effetti manifestato e attestato […] il lavoro di sé su se stessi è il reale della filosofia" ( ibidem, p. 234 ).
9
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 10/12
pensano, libere di creare se stesse come un’opera d’arte : è proprio in questa nozione 44
di libertà che troviamo l’ethos della modernità” .45
L'eclissi della politica e la fuga dal mondo
La dimensione globale dell’impero capitalistico annulla la dimensione politica, riducendola da un lato alla mera amministrazione tecnocratica e dall’altro alla fuga del singolo dal mondo .46
La politica tramonta nella sottomissione degli apparati dello Stato alle costrizioni della "megamacchina" tecno-economica e nella depoliticizzazione dei cittadini, in una dissoluzione del tessuto sociale, che fa riapparire lo stato di guerra di tutti contro tutti.La complessità dei problemi e la loro semplificazione manipolatoria proposta dai media fanno sì che gli elettori, e spesso anche gli eletti, abdichino alla possibilità di conoscere e di decidere, svuotando la cittadinanza di qualsiasi potere .47
La società contemporanea globalizzata ipertrofizza l’io, proponendogli infinite
possibilità, ma, in realtà, essendo queste tutte superflue ed equivalenti, così come superflui ed equivalenti sono i singoli individui, rende assai ardua l’opera di riappropriazione di sé e della propria libertà proposta da Foucault. La libertà torna ad essere mero arbitrio e l’individuo un semplice
zephirus
, vuoto
flatus vocis
, che si 48
percepisce come uno spettatore passivo e impotente. Abdicando al proprio essere cittadino, la sua percezione diviene una profezia che si autoavvera . Davanti 49
all’onnipervasività dell’impero la ricerca di sé ritrova l’antica forma dell’eremitaggio nel deserto.
44 “Ogni nostra vita, in quanto linguaggio dell’azione, o semplicemente, della presenza fisica, è un ‘esempio’: in quanto tale, ogni nostra vita è un’opera: con il suo stile e la sua morale: il suo messaggio. Rispetto al codice, cioè alla media delle vite umane, la nostra vita può essere inventata, com’è inventato, appunto, “un messaggio” ( P.P. Pasolini, Appendice a Porno Theo Kolossal, in Pasolini. Per il cinema, p.2758 ).45 V. Sorrentino, Michel Foucault: il limite, l’altro, la libertà, p. 8 , in Lo sguardo. Rivista di filosofia, n. 4, 2010 .46
A. Koestler aveva brillantemente intuito questa antitesi nel suo Lo yogi e il commissario (Bompiani, 1947).47 S. Latouche, La mondializzazione e la fine della politica, Relazione alla 16^ scuola di formazione politica
della Rosa Bianca. Polsa di Brentonico (Tn), 28 agosto 1996,
http://www.edscuola.it/archivio/interlinea/lat3.html .48 L'etimologia della parola zero è da ricondursi al sanscrito śūnyá (vuoto, zero), da cui deriva l'arabo ف
(sifr) (nulla, zero), da cui, a sua volta, per adattamento, il latino medievale zèphyrum ed infine il veneziano zevero , onde l'italiano zero ( http://www.etimoitaliano.it/2014/04/zero.html ).49 R. Walsch (cit. in E.P. Cela, Psicologia e nonviolenza , Edizioni Gruppo Abele , 1991 ) ha osservato che convinzioni autolimitanti quali “Non c’è niente che io possa fare” e “Non è mia responsabilità” supportano il sistema di credenze (quelle che forse Marx chiamerebbe ideologie) ostacolando il cambiamento.
10
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 11/12
Un battito di farfalla
Tuttavia, l’impero tecnocratico si caratterizza per un’inedita geometria del potere. Mentre gli antichi imperi avevano una struttura rigorosamente verticistica, piramidale e monocentrica, oggi il potere si configura come una rete policentrica, rispetto alla quale gli individui non sono solo soggetti ad essa , ma anche soggetti di essa e quindi dotati di una virtuale possibilità di azione del tutto inedita. Come aveva intuito Foucault, laddove il potere si esercita con maggior intensità, proprio là si costituisce il punto di resistenza al potere stesso .50
La transindividualità del soggetto implica che, mentre la rete lo controlla e lo attraversa, allo stesso tempo amplifica in modo esponenziale la risonanza delle sue azioni. Il soggetto si troverà, allora, nella condizione di poter generare “effetti farfalla” , gravidi di 51
un impatto abnorme rispetto all’origine dell’azione . Perché la rete (
net ) non diventi una 52
ragnatela (
web
), diventa determinante abitarne la complessità con una profonda 53
consapevolezza dei dispositivi (tecnologici, economici, sociali, politici, culturali) di
sapere-potere in cui i soggetti sono immersi e, ancor più, delle procedure di soggettivazione che questi implicano.
A partire da questa consapevolezza sarà, allora, possibile intendere la filosofia come arte di vivere , ovvero come cura di sé, che riconduca l’economia e la tecnica al loro 54
50 “Dove c’è potere, c’è resistenza” ( M. Foucault, La volontà di sapere, 1976, p. 84 ).51
Può il battito d'ali di una farfalla scatenare un uragano a migliaia di chilometri di distanza? Il primo ad
analizzare il cosiddetto “effetto farfalla” fu Edward Lorenz, meteorologo del Massachusetts Institute of Technology di Boston (MIT), in uno scritto del 1963 preparato per la New York Academy of Sciences. L'espressione si ritiene sia stata ispirata da uno dei più celebri racconti fantascientifici di Ray Bradbury: Rumore di tuono ( A Sound of Thunder , in R is for Rocket ) del 1952, in cui si immagina che nel futuro, grazie ad una macchina del tempo, vengano organizzati dei safari temporali per turisti. In una remota epoca preistorica un escursionista del futuro calpesta una farfalla e questo fatto provoca una catena di allucinanti conseguenze per la storia umana.52 Numerosi sono, ormai, i casi di singole persone che, grazie all’unione tra competenze tecniche e lucida consapevolezza dei meccanismi della rete, sono state in grado di produrre effetti di incredibile risonanza. Un caso per tutti è la vicenda di Aaron Swartz, il finale tragico della quale non smentisce, bensì conferma il potere abnorme che un individuo può acquisire (si veda, al proposito, il film The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz , del 2014) .53 L'assunto comune di individualismo e organicismo può essere anche individuato nel concepire il sistema politico come un sistema fisico newtoniano, costituito di particelle e forze e caratterizzato da un
funzionamento semplice (per quanto magari complicato) e lineare di tipo deterministico. In questo modo, tanto quando si punti l'attenzione sulle particelle in gioco, quanto quando si ponga invece l'accento sul sistema complessivo di forze, non si esce dal medesimo schema descrittivo. Le teorie della complessità, con la rivoluzione epistemologica che comportano, spostano l'attenzione dagli elementi alle relazioni, dalla linearità alla circolarità complessa delle interazioni, dagli apici del dispositivo di potere ai “corpi intermedi” che moltiplicano e riorganizzano le relazioni. La distinzione tra azione pedagogica della società costitutiva degli individui e azione politica degli individui costitutiva della società (intreccio che costituisce il nodo problematico e profondo tanto del pensiero platonico quanto di quello rousseauiano) in questo modo si dissolve o perlomeno subisce una risignificazione profonda.54 Cfr. W. Schmid, Filosofia dell’arte di vivere, Fazi, 2014.
11
7/24/2019 La Ragnatela e la Farfalla
http://slidepdf.com/reader/full/la-ragnatela-e-la-farfalla 12/12
ruolo di mezzi per l’uomo , ricostruendo l’
agorà del dibattito pubblico . Cura di sé non 55 56
significherà, infatti, ripiegamento solipsistico, ma costruzione di un nuovo animale sociale , che possa riconquistare un orizzonte “affermativo” e non solo “difensivo” nei 57
confronti del potere.
55 Cfr. S. Latouche, Decolonizzare l'immaginario. Il pensiero creativo contro l'economia dell'assurdo, EMI, 2004 .56 Si veda, ad es., Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli, 2000 .57 La dimensione del “noi”, scriveva Foucault, non è qualcosa che ci sia stato assegnato preliminarmente, per natura, ma un obiettivo da problematizzare di continuo per renderne possibile la “futura costruzione”. Lo “animale sociale” non è un dato naturale, ma un progetto continuamente in progress ( V.Sorrentino, Il
pensiero politico di Foucault, Meltemi, 2008 ) .
12