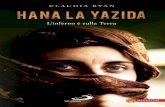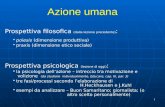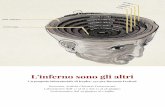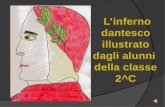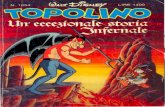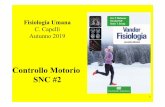La malvagità della natura umana e l'inferno dell'anarchia
Click here to load reader
description
Transcript of La malvagità della natura umana e l'inferno dell'anarchia

La malvagità della natura umana e l’inferno dell’anarchia
Il titolo1 un po’ stravagante mette in evidenza un rapporto che la filo-sofia non ha mai smesso di frequentare, quello tra la natura e la cultu-ra, e in pari tempo mostra l’accostamento ‘tradizionale’ di tale rappor-to: nella natura, in particolare nella natura umana, s’intravede qualco-sa di sbagliato che deve essere corretto dal lavorio paziente della cul-tura, ossia di quel vasto armamentario teoretico e pratico in cui sono annoverate la politica, l’arte, la religione e la filosofia.
Nella tradizione occidentale è indubbiamente maggioritaria (A) la posizione che giudica natura e cultura come istanze contrapposte, è minoritaria (B) la corrente alternativa secondo cui natura e cultura sono ambiti coincidenti. Occorre chiarire in linea generale le ragioni a sostegno della prima e della seconda opzione, riconoscere gli autori dietro tali opzioni e metterli in relazione. Alla fine la posizione mag-gioritaria (in cui natura e cultura ci contrappongono) e quella minori-
1 Per approfondire i temi affrontati si veda, ad esempio: Agostino, Le confessioni, Einau-di, Torino 2005; Agostino, La città di Dio, Bompiani, Milano 2001; M.A. Bakunin, Stato e anarchia, Feltrinelli, Milano 2000; G. Bataille, L’erotismo, ES, Milano 2009; Id.,Teoria della religione, SE, Milano 2008; Esiodo, Teogonia, Mondadori, Milano 2004; M. Fou-cault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 2005; S. Freud, Il disagio della civiltà, Einau-di, Torino 2010; W. Golding, Il signore delle mosche, Mondadori, Milano 2001; Th. Hob-bes, Leviatano, Laterza, Roma-Bari, 2008; Id., De cive, Editori Riuniti, Roma 2005; K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 2004; F.W. Nietzsche, Umano, troppo umano, Newton & Compton, Roma 2010; Id., La volontà di potenza, Bompiani, Milano 2001; M. Sahlins, Un grosso sbaglio. L’idea occidentale di natura uma-na, Elèuthera, Milano 2010; Tucidide, La guerra del Peloponneso, Mondadori, Milano 2007.

FILOSOFIA E POLITICA
taria (in cui natura e cultura convergono) verranno ricondotte a un minimo comune multiplo, dalla cui implosione, forse, trarremo qual-che insegnamento.
1. Repressione e sfruttamento
(A) La corrente secondo cui natura e cultura si contrappongono è in realtà duplice. Ci sono due modi in cui natura e cultura si scontra-no: l’obiettivo della cultura può essere o (A1) quello di reprimere la natura malvagia dell’uomo oppure (A2) quello di sfruttare al meglio la malvagità della natura umana in una direzione insperata.
Il punto fermo per entrambi i modi rimane la qualità della natura umana: che si tratti di un germe mai estirpato di bestialità, di ferocia o di selvatichezza, oppure che si tratti di un peccato o di una colpa ori-ginali commessi in epoca primordiale o fuori dal tempo, in ogni caso un elemento corrompente impedisce all’uomo di vivere dando libero corso alla propria natura. Infatti tale natura appare, per così dire, come innaturale: se il resto dei viventi può prosperare assecondando le caratteristiche naturali che più gli sono proprie e obbedendo agli istinti che una natura pura gli ha scritto nel DNA, al contrario la natu-ra umana non sembra permettere una pratica analoga.
Accettando la contrapposizione di natura e cultura, indipendente-mente dalla modalità dello scontro (la repressione o lo sfruttamento), si dice sovente che l’uomo lasciato a se stesso non combinerebbe nulla di buono, ma ricadrebbe assai facilmente nella barbarie, smarrirebbe l’ordine civile e affonderebbe nel caos fatale dell’anarchia preistorica (riaffiorante talvolta, si dice in tono di rimprovero, nel Medioevo e nel Far West)2. Con questo presupposto, oggi più che mai siamo atterriti di fronte alla possibilità che i controlli vengano meno o si allentino, che la sorveglianza da parte di chi presiede l’ordine civico abbia dei punti ciechi, giacché ogni occasione sembra buona per l’erompere del-la bassezza della natura umana. Si possono citare alcuni esempi lette-rari, storici, filosofici e persino scientifici improntati a questa visione.
2 A riguardo, si veda anche nella filmografia il filone cosiddetto ‘post-apocalittico’, da Mad Max. Oltre la sfera del tuono a La strada, da The book of Eli [tradotto in italiano come Codice Genesi] a 28 giorni dopo, ecc.
18

LA MALVAGITÀ DELLA NATURA UMANA E L’INFERNO DELL’ANARCHIA
Ribadendo la medesima contrapposizione tra natura e cultura e il medesimo timore, nel romanzo Il signore delle mosche (1954) William Golding racconta come un gruppo di bambini inglesi naufragati su un’isola deserta degeneri rapidamente nell’orrore presociale e nelle logiche perverse della superstizione: i bambini, che rappresentano per antonomasia un’umanità a digiuno di cultura e vicina alla natu-ra, risultano nondimeno i più suscettibili a regredire nell’elemento barbarico e nella spietatezza, qualora non si ostacoli il marchio di Caino o l’intrinseca malvagità dell’essenza umana e qualora manchi-no la guardia e la punizione pedagogica degli adulti. Il romanzo si chiude con due ammonimenti: con quello da parte dell’ufficiale di marina che, dopo aver trovato i bambini superstiti, esterna loro la sua delusione nel costatare tra inglesi un simile degrado di maniere; e con quello da parte del narratore che si rivolge al lettore con que-ste parole:
In mezzo a loro, col capo sudicio, i capelli sulla fronte e il naso da pulire, Ralph [il protagonista] piangeva per la fine dell’innocenza, la durezza del cuore umano, e la caduta nel vuoto del vero amico, l’a-mico saggio chiamato Piggy [il bimbo grassoccio ucciso dai barbari lattanti].
I due sistemi con cui la cultura contrasta la natura, ossia la re-pressione e lo sfruttamento, considerano unanimemente l’essere umano come contrassegnato senza scampo dalla malvagia perversio-ne e dall’egoismo innato. Quando Tucidide ne La guerra del Pelopon-neso descrive la guerra civile (la stasis) di Corcira, in realtà rappre-senta la corruzione a cui è sottoposta la civiltà una volta che la natu-ra umana sia lasciata a briglie sciolte e il potere costituito non vi ponga più freno. Quando, prima di Tucidide, Esiodo racconta nella Teogonia in quale modo Zeus instaurò l’ordine sull’anarchia indivi-dualistica dei Titani, in realtà ci sta parlando della natura titanica gli uomini. E anche Platone, quando riporta nel Fedro il mito della biga alata e nella Repubblica il discorso politico a grandi lettere, spiega che se nell’anima dell’uomo il giogo della parte razionale (cioè del-
19

FILOSOFIA E POLITICA
l’auriga della biga o del governatore filosofo della città) si allenta, al-lora la meschinità della parte «concupiscibile» prende il sopravvento e vanifica le conquiste sociali e culturali della civiltà3.
Tradizionalmente il contrasto tra natura e cultura può essere risol-to in soli due modi: (A1) o la cultura vale come camicia di forza in grado di reprimere la natura malvagia dell’uomo, fondando su tale re-pressione lo Stato, (A2) oppure essa vale come arte di incanalamento di tutta l’energia distruttrice volta però in positivo, fondando così la vita civile sullo sfruttamento razionale dell’egoismo, anziché sulla sua repressione.
(A1) Nel caso della repressione della natura da parte della cultura, lo Stato potrà essere retto da una monarchia assoluta se un despota prevale sulla lotta disgregatrice dei poteri privati, o in alternativa po-trà essere retto da una repubblica se la costituzione prevede il bilan-ciamento dei poteri dei vari ceti sociali e dei vari individui contro l’e-goismo privato.
(A2) Nel caso invece dello sfruttamento della natura da parte della cultura, lo Stato sarà istituito sulla base di un calcolo razionale egoisti-co che sancisce l’utilità e il vantaggio delle gerarchie, delle divisioni sociali e dell’apparato statale come baluardi contro l’inferno anarchi-co.
2. I Padri Fondatori, Hobbes e i salassi
(A1) Più di vent’anni prima di scrivere il Leviatano (1651), nel 1628 Thomas Hobbes aveva già tradotto in inglese l’opera del suo maestro: La guerra del Peloponneso di Tucidide. Ed è proprio parafrasando Tu-cidide che Hobbes formula la massima della sua filosofia politica: homo homini lupus (l’uomo è un lupo per l’altro uomo4). Per Hobbes, infatti, l’uomo persegue in ogni modo il proprio interesse personale a scapito di tutti gli altri5. Nella guerra presociale del tutti contro tutti
3 Coerentemente con la sua fisiologia dell’anima, Platone ritiene che il punto più basso tra le modalità di organizzazione sociale sia la democrazia, la quale però somiglia a una forma radicalmente deteriore di anarchia in cui non esiste un potere in grado di frena -re le pulsioni dell’uomo.
4 Questa formulazione è precisamente di Plauto.5 «L’indole naturale degli uomini è tale» – scrive – «che, se non vengono trattenuti dal
timore di una potenza comune, diffidano l’uno dell’altro e si temono a vicenda» (De cive)
20

LA MALVAGITÀ DELLA NATURA UMANA E L’INFERNO DELL’ANARCHIA
(bellum omnium contra omnes), l’uomo è segnato da un tarlo che non riguarda gli altri animali: poiché egli è dominato dall’infinità del de-siderio e poiché c’è una penuria cronica dei mezzi per soddisfarlo, l’uomo è costretto a usare violenza contro l’altro uomo al fine di massimizzare le proprie risorse.
Spinto dalla paura, però, l’uomo inizia a ragionare e a capire che la via più efficace per sopravvivere è porre fine alla guerra di tutti contro tutti e di porre un limite al proprio desiderio, per quanto sia impossibile estirpare l’egoismo dal cuore dell’uomo. L’unico modo per superare l’inferno anarchico è cedere il proprio diritto naturale, cioè il diritto all’immediato perseguimento del proprio interesse, a favore di un terzo (un’assemblea o, molto meglio, un monarca) che disarmando tutti possa difendere la società neonata dalle spinte egoi-stiche. Dunque la cultura, che segue allo stato naturale, sorge dalla paura e funge da argine razionale contro l’istinto predatore e antiso-ciale della natura umana.
Circa mezzo millennio prima delle opere di Hobbes, nell’Italia ri-nascimentale sorgevano le prime repubbliche ‘egualitarie’ fondate sul convincimento dell’uguaglianza tra gli uomini e sulla loro capaci-tà legislatrice: sia che la natura umana fosse concepita come intrin-secamente buona o ‘adamitica’, sia come intrinsecamente predispo-sta alle virtù civiche, gli uomini rinascimentali repubblicani ritene-vano superflua la sudditanza a un principe, poiché il compito della legge pareva loro quello di garantire l’interesse di tutti i cittadini. Era in voga l’idea espressa nella Politica di Aristotele secondo cui gli uomini devono essere a turno governanti e governati, in modo che l’armonia tra le parti sia conservata.
(A2) Nella repubblica fiorentina Leonardo Bruni (1370-1444), umanista di grande fama e cancelliere della città nel primo Quattro-cento, si opponeva caparbiamente al cesarismo. Egli riteneva che una repubblica potesse durare a lungo soltanto se la contrapposizio-ne degli interessi, che naturalmente si genera all’interno di una città, venisse istituzionalizzata anziché combattuta. Niccolò Machiavelli (1469-1527), vissuto un secolo dopo Leonardo Bruni, consolidò l’idea della stabilità di uno stato ottenuta dalla lotta tra gli interessi parti-giani, e anzi fece di questa lotta una vera e propria virtù.
21

FILOSOFIA E POLITICA
Grazie a questi pensatori diventa sempre più chiaro il passaggio da una repubblica volta alla repressione della natura umana malvagia a una repubblica che sfrutta la malvagità di questa natura trasforman-dola in virtù. Secondo Machiavelli i sudditi, tanto in repubblica quan-to in monarchia, rimangono essenzialmente immorali, ma in ambiente repubblicano tale malignità può produrre effetti positivi e assicurare l’interesse comune.
Quarant’anni dopo Machiavelli, Bernardino Telesio (1509-1588), ispirandosi ad Anassimandro, trasformò l’interesse personale in prin-cipio naturale della dinamica dell’universo. Con tale estensione la coerenza del Tutto, ottenuta da una conflittualità auto-regolata degli interessi, raggiungeva una portata non solo politica ma addirittura co-smica. Dunque in quest’ottica la rincorsa egoistica dell’individuo non era semplicemente il male da sedare e da chiudere in gabbia (da repri-mere), ma l’unica strategia di composizione armonica degli esseri (da sfruttare).
Dopo l’applicazione della strategia di sfruttamento dell’egoismo virtuoso ai campi dell’etica, della politica e della metafisica naturale, all’appello manca solo un campo: quello economico. Con la sua teoria della «mano invisibile», lo scozzese Adam Smith (1723-1790) rispose a quest’appello ponendosi nella scia aperta dai suoi predecessori rina-scimentali. Secondo lui l’interesse economico generale si sarebbe rea-lizzato spontaneamente, se ognuno si fosse occupato dei propri inte-ressi particolari.
Il discorso fatto finora non è campato in aria né esteriore rispetto alla vita sociale, civile e politica che noi tutti, volenti o nolenti, ogni giorno conduciamo. Se anche le argomentazioni e i presupposti porta-ti qui al vaglio non significassero niente per noi, non possiamo co-munque ignorare che la tanto celebrata democrazia statunitense, mo-dello per ogni altra democrazia contemporanea e modello di vita or-mai copiato in tutto il mondo da decenni, si fonda storicamente e filo-soficamente proprio sulle argomentazioni e sui presupposti di cui an-diamo discorrendo.
John Adams (1735-1826), redattore della Dichiarazione di Indipen-denza, vicepresidente al fianco di George Washington e secondo pre-sidente degli Stati Uniti (1797-1801), era senza mezzi termini un ammi-ratore di Tucidide e di Hobbes. Non era l’unico, visto che circa tutti i capi della rivoluzione americana e i padri fondatori erano impregnati
22

LA MALVAGITÀ DELLA NATURA UMANA E L’INFERNO DELL’ANARCHIA
della retorica classica latina e greca sulla natura umana. Basti pensa-re per esempio che Thomas Jefferson (1743-1826), terzo presidente degli Stati Uniti (1801-1808), immaginava che il tema della schiavitù avrebbe scatenato nel paese una sorta di guerra del Peloponneso tra commercianti del Nord (gli Ateniesi) e agricoltori del Sud (gli Sparta-ni). Dunque il fosco pessimismo degli antichi, la cupa visione della tradizione calvinista e il realismo feroce di Hobbes influenzarono profondamente la visione dei padri fondatori statunitensi, per i quali la guerra è la condizione naturale dell’umanità e lo spirito umano è ben più incline al male che al bene. Sintomatica di questo clima è l’affermazione del quarto presidente degli Stati Uniti (1809-1817), Ja-mes Madison (1751-1836): «se gli uomini fossero angeli, non ci sareb-be bisogno di alcun governo».
Ma angeli non sono e pertanto il governo è assolutamente neces-sario affinché le malvagità dei più siano incanalate e fatte fruttare. Lo stesso Madison giudicava fondamentale per l’azione di governo tutelare la proprietà privata dalla furia democratica delle masse indi-sciplinate ed essenzialmente malvagie. Il popolo era sì il depositario della sovranità, ma non doveva in nessun caso governare: il modello ammirato da Madison, da Adams e da Alexander Hamilton, primo segretario del tesoro statunitense e volto prestato alle banconote da 10 dollari, era quello di Polibio, storico greco del II secolo a.C.: un’a-ristocrazia per natura deve tenere in scacco una Camera bassa eletta dal popolo.
La soluzione a cui di fatto si giunse fu quella dell’equilibrio dei poteri in modo che un potere, un interesse e una passione si oppo-nessero a un altro potere, a un altro interesse e a un’altra passione. In questa scelta i padri fondatori erano incoraggiati dalle teorie co-smologiche dell’epoca ispirate al modello razionale newtoniano, ove le forze celesti rimangono in stabile equilibrio tra loro: l’ideale era dunque quello di creare un ordine politico ispirato ai semplici princi-pi della natura. Il modello della giustapposizione delle forze non era solo cosmico e politico, ma anche fisiologico: Benjamin Rush, firma-tario della Dichiarazione di Indipendenza e medico, diffuse in ambito clinico la pratica dei salassi grazie ai quali sembrava possibile curare la cosiddette «febbri» con il ripristino dell’equilibrio fisiologico del corpo.
23

FILOSOFIA E POLITICA
Nel XX secolo ormai l’idea che l’egoismo sia iscritto nel DNA del-l’uomo pare un assunto indiscutibile, al punto che alcuni sociobiologi rincorrono il cosiddetto «gene dell’egoismo». Ma a differenza dei se-coli precedenti, l’egoismo non è visto semplicemente come un istinto da reprimere o un’occasione da sfruttare, bensì si presenta come la condizione della libertà umana: quello che un tempo era il peggio di noi stessi, diviene infine il nostro lato migliore poiché rappresenta la capacità da parte di ognuno di agire nel proprio interesse. Tutte le po-litiche liberiste e neoliberiste, ossia le politiche oggi dominanti, batto-no sempre su questo punto.
3. Biologismo e culturalismo
(B) Nondimeno tanto le politiche quanto le idee vigenti non sono le uniche possibili. La storia della cultura occidentale ha prodotto an-che un’alternativa illustre, benché perdente, attorno al rapporto tra natura e cultura. Anziché antagoniste, esse possono pensarsi come so-vrapponibili: la natura è una struttura biologico-culturale in divenire e la cultura un fattore determinante la natura, in modo tale che esse si co-determinano.
Se il primo corollario dell’opposizione tra natura e cultura era l’in-commensurabilità tra mondo animale e mondo umano, tuttavia è oggi assodato che in molte regioni del pianeta sono esistite ed esistono tut-tora società ove umani e non umani non sono incomparabili né ri-spondono a principi differenti. In queste società uomini e animali (o piante o rocce ecc.) non stanno in nicchie ontologiche distinte, ma hanno i tratti caratteristici della persona. Gli enti che abitano il cosmo non vengono affatto oggettivati e enticizzati, ma comunicano da pari con gli esseri umani in senso stretto: tra la sfera umana e la natura s’instaura una vera e propria relazione sociale.
Se anzi nel mondo occidentale il cosmo è senz’anima e impersona-le, l’unica persona non umana che insiste è il Dio cristiano. Sappiamo molto bene, però, che il cristianesimo e prima di lui l’ebraismo si sono distinti dalle cosiddette religioni «pagane» per la condanna dell’adora-zione della natura: il dio biblico diventa trascendente e da un punto di vista ontologico taglia i legami con il mondo materiale. Nelle Confes-sioni Sant’Agostino interroga le cose del mondo sull’identità di Dio, ma ciascuna risponde: «non sono io». Secondo la stessa logica, ne La
24

LA MALVAGITÀ DELLA NATURA UMANA E L’INFERNO DELL’ANARCHIA
città di Dio Agostino condanna le dottrine panteistiche argomentan-do che se Dio fosse in ogni cosa, a ogni passo pesteremmo un pezzo di Dio e a ogni pranzo uccideremmo un pezzo di Dio. La stessa con-siderazione, giudicata da Agostino empia, è invece presso i Maori la prima delle verità: a ogni passo, l’uomo lascia la sua impronta sulla Madre Terra, a ogni abbattimento di alberi e a ogni caccia, l’uomo ferisce la Madre Terra. L’universo maori, infatti, è costituito di per-sone discendenti dai primi genitori divini, la Terra e il Cielo: ogni cosa vivente e non vivente possiede quindi una precisa genealogia che imparenta tra loro tutti i membri della famiglia cosmica.
Quel che voglio dire è questo: perlopiù l’Occidente ha pensato l’uomo come invischiato, in parte o completamente, nella natura ani-male, considerata malvagia ed egoista – con le conseguenze che ab-biamo visto; ma esistono concezioni per le quali, al contrario, sono gli animali insieme al resto dei viventi a possedere una natura uma-na. Il medesimo rispetto dimostrato per un uomo, anzi per un mem-bro della propria famiglia, deve essere così dimostrato per ogni vi-vente. Molte delle società che adottano una visione del genere fanno a meno dei concetti di animalità e di bestialità.
Se per costoro il lato feroce della natura non è caratterizzante né per l’essenza dell’uomo né per quella dell’animale, i quali hanno una natura comune, al contrario ne Il disagio della civiltà il padre della psicanalisi Sigmund Freud riprende a chiare lettere l’adagio homo homini lupus, riallacciandosi a Hobbes, ad Agostino e a Tucidide: come per Agostino i bambini sono innocenti non per volontà ma per impotenza, così per Freud nel bambino si annidano i primitivi istinti antisociali e aggressivi che, potremmo dire, se non vengono repressi da un super-io padre-padrone o in generale dalla cultura, innescano quel processo catastrofico che conduce all’anarchia o alla situazione deprecabile dei monelli de Il signore delle mosche. In moltissime cul-ture extra-europee, però, i bambini non sono affatto considerati come mostri da addomesticare.
In breve, lo scontro sulla relazione tra cultura e natura s’incentra su questo punto: (A) la corrente che giudica cultura e natura avver-sarie, e per cui il sottofondo naturale dell’uomo è malvagio, assume la cultura come una struttura repressiva o sfruttatrice della natura umana; (B) la corrente che giudica cultura e natura contigue e con-generi, e per cui lo sfondo naturale dell’uomo e del cosmo è la socia-
25

FILOSOFIA E POLITICA
lità, assume la cultura come un processo di crescita della natura uma-na. In un caso il bambino appare freudianamente come un mostro, nell’altro come una persona (un abitante del cosmo) non ancora com-pleta. Possiamo riassumere questa alternativa utilizzando due termini: la prima corrente è «biologista», la seconda è «culturalista». Ciò signi-fica che per la prima, quella occidentale e vincente, nell’uomo c’è una animalità da sopraffare, mentre per la seconda, quella diffusa in varie parti del mondo ma perdente nella cultura occidentale, nell’uomo c’è una umanità in divenire.
Finora ho detto che in Occidente il culturalismo è stato minorita-rio: ma in che senso? Nel sottobosco della sapienza occidentale si è più volte aggirata una concezione che valuta la cultura come lo stato originale dell’esistenza umana e la biologia come lo stato soltanto se-condario. Quest’idea è riemersa ultimamente in campo antropologico con la scoperta che la cultura ‘umana’ è molto più antica dell’homo sapiens: poiché la cultura risale a circa 3 milioni di anni fa e l’attuale forma umana risale invece a circa 400 mila anni fa, la cultura deve aver influenzato lo sviluppo anatomico dell’homo sapiens. In altre pa-role: per quasi 3 milioni di anni gli uomini si sono evoluti biologica-mente in base a una selezione culturale. Da questa prospettiva la cul-tura è la natura umana, e si può anche dire che l’umanità è l’effetto culturale sulla nostra animalità6.
Qui e là esistono degli antecedenti filosofici per il culturalismo: a esempio, lo stesso Platone affermava che il nomos (la legge e quindi la cultura) precede la physis (la natura) sia da un punto di vista ontologi-co che cronologico. Anche Pico della Mirandola (1463-1494) con il suo Discorso sulla dignità dell’uomo del 1486 riteneva che l’uomo fosse sta-to creato con una «natura indefinita», cioè in divenire e aperta all’au-toplasmazione culturale. La questione centrale per la nostra discussio-ne non è quindi stabilire se da un punto di vista biologico la natura umana sia buona o malvagia, come invece hanno tentato di fare nel corso della storia i vari critici della posizione di Hobbes & Co.; piutto-sto il problema è il biologismo in sé, cioè l’idea che la natura biologica preceda e determini l’essere dell’uomo.
6 Questa è la tesi attorno a cui ruota l’intero saggio di M. Sahlins, Un grosso sbaglio. L’i-dea occidentale di natura umana, Elèuthera, Milano 2010, p. 123.
26

LA MALVAGITÀ DELLA NATURA UMANA E L’INFERNO DELL’ANARCHIA
Possiamo annoverare tra i culturalisti anche Marx e Bakunin. Con i dovuti distinguo, per entrambi l’essenza dell’uomo risiede nei rap-porti storico-sociali: questa è la ‘materia’ del materialismo storico. Le spiegazioni biologiste sono chiamate da Marx «robinsonate», cioè falsi scenari in cui s’aggirano falsi uomini naturali. Sia per Marx che per Bakunin l’uomo è dotato di un’essenza in divenire, che si auto-crea attraverso l’azione sociale: l’uomo deve acquistare la pienezza attraverso un processo culturale, sociale e politico che pretende una rivoluzione economica. Il sistema capitalistico è la causa del perver-timento o dell’alienazione della natura umana e deve essere abbattu-to per far spazio all’autenticità dell’Uomo. In merito alla natura uma-na, l’unica differenza rilevante tra il comunismo di Marx e l’anarchi-smo di Bakunin è la collocazione della pienezza essenziale dell’uo-mo: per Marx essa si situa a monte del processo rivoluzionario e gui-da il proletariato alla riconquista di sé, per Bakunin essa è perlopiù ignota e si pone a conclusione del processo rivoluzionario, quasi come una rivelazione che si renderà manifesta solo dopo l’annienta-mento dello status quo espropriante.
4. Contro l’umanismo
Veniamo ora alla conclusione. (A) Il biologismo è quella concezio-ne intorno alla natura umana che investe la cultura del compito di so-praffare l’animalità congenita all’uomo, secondo la duplice possibili-tà della repressione e dello sfruttamento della natura umana malva-gia. (B) Il culturalismo è invece l’altra concezione che ritiene la natu-ra dell’uomo indistinguibile dalla sua cultura e che quindi vede come compenetrantisi i due elementi tradizionalmente antagonisti, poiché la cultura viene investita del compito di sviluppare l’umanità nel suo divenire.
Potremmo anche affermare che il (A) biologismo si preoccupa di ricercare il proprio dell’uomo, cioè di scrostare al di sotto della pati-na animale, del marchio di Caino o dell’intrinseco egoismo, una pro-prietà superiore che faccia dell’uomo naturale, cioè bestiale, un Uomo a tutti gli effetti, cioè un uomo civile. Su questa falsa riga, (B) il culturalismo si preoccupa invece di ricercare la pienezza dell’uo-mo, di guidare l’uomo là dove non è ancora giunto (secondo quanto
27

FILOSOFIA E POLITICA
prescritto da un progetto di Uomo ben preciso) e di renderlo così un Uomo vero e proprio, un Uomo come si deve, reale o immaginario che sia.
Ambedue i programmi, tuttavia, quello biologista e quello cultura-lista, ritengono l’uomo un essere insufficiente: sottolineano in lui una carenza specifica che lo allontana dall’umanità propria o piena. È come se dicessimo: «l’uomo non è propriamente un Uomo finché l’e-ducazione culturale non seda in lui la sua natura animale» (questa è la variante biologista), oppure «l’uomo non è pienamente un Uomo fin-ché la cultura non lo plasma a immagine di una certa idealità di uomo» (questa è la variante culturalista).
Per quanto io creda che l’alternativa culturalista sia da preferire a quella biologista, comunque tanto l’una quanto l’altra, se rispondono alla logica dell’appropriazione o del riempimento, rappresentano an-cora due istanze perfettamente umanistiche e quindi metafisiche, per le quali esiste la ricetta incontrovertibile dell’Uomo. La pretesa dell’u-manismo è di scavare e in pari tempo di colmare il buco metafisico nell’essere dell’uomo, ma questa pretesa è in quanto tale illusoria.
In ambito filosofico l’umanismo così inteso è ormai ampiamente superato: in particolare, Nietzsche ha smascherato l’insensatezza e la violenza dell’umanismo del proprio insinuando il dubbio sull’esistenza dell’Uomo; e Bataille d’altronde ha reso paradossale l’approfondimen-to della pienezza dell’uomo nella ricerca della «esperienza interiore», facendo implodere la pienezza dell’uomo sovrano nel vuoto assoluto.
Infine, se è sicuramente inconsistente l’idea di una natura umana biologicamente malvagia o buona, nondimeno lo è anche l’idea di una cultura volta al perfezionamento dell’essere umano, poiché nella sto-ria e nella preistoria decretare l’Essenza dell’Uomo ha sempre com-portato due azioni violente non escludentisi: (A) la sottomissione dei non propriamente umani, o addirittura il loro sterminio; (B) l’esclusio-ne dei non pienamente umani dal cerchio civile, o addirittura la loro reclusione. Se in ciò riconosciamo, oltre che qualcosa di infondato, an-che qualcosa di spregevole, allora dovremo fare a meno dei due gran-di paradigmi che, sancendo la malvagità della natura umana o la san-tità della cultura, condannano senza riserve l’inferno dell’anarchia.
28