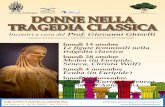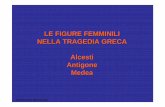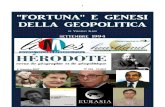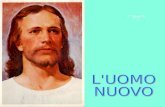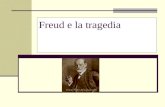La Genesi Della Tragedia
Transcript of La Genesi Della Tragedia

8/13/2019 La Genesi Della Tragedia
http://slidepdf.com/reader/full/la-genesi-della-tragedia 1/2
La genesi del genere tragico
Questo genere di rappresentazione drammatica ebbe origine verso il VI sec. a.C. in Grecia . Dal primitivo
carattere sacro, legato al culto degli dei e al mito degli eroi, si evolse rapidamente per abbracciare nel
contenuto, sempre di tono elevato, avvenimenti luttuosi che avessero per protagonisti personaggi illustri,
per lo più mitici, portati sulla scena per interessare lo spettatore a problemi morali, religiosi, politici.
Il problema delle origini della tragedia
Quello delle origini della tragedia è stato un problema molto dibattuto dai filologi, a iniziare dall'incertainterpretazione del termine tragodìa (da trágos, capro, e oidé, canto), ora inteso come “canto per il capro”
(cioè “per il sacrificio di un capro” o “per ottenere in premio un capro”) ora come “canto del capro”, cioè
dell'attore mascherato da capro. ccogliendo !uesta seconda lettura, la tragedia si legherebbe al ditirambo,
il canto lirico in onore di Dioniso, i cui interpreti erano appunto uomini mascherati da capro. " 'origine
dionisiaca della tragedia si fonderebbe anche su un passo della Poetica di Aristotele, in cui si afferma
che la tragedia nac!ue “da coloro che guidavano il ditirambo”. #n ogni caso, se si prescinde dal fatto che i
concorsi drammatici avevano luogo durante le festivit$ dionisiache, le radici del fenomeno tragico non sono
pi% rintracciabili nei grandi testi di &schilo, ofocle ed &uripide e nulla sembra rimanere in essi di
propriamente dionisiaco. ertanto alcuni studiosi, prescindendo dalla testimonianza aristotelica sopra
citata, ricollegano la tragedia a origini misteriche o ad antichi riti della fecondità o ancora al culto deglieroi. na famosa interpretazione, pi% rilevante tuttavia sul piano storico*filosofico che filologico, è !uella
di F. iet!scheche, nell'opera La nascita della tragedia (+-), individu" la genesi del fenomeno tragico
nella fusione dell'elemento dionisiaco (inteso come vitalit$, passionalit$, disordine) con l'elemento
apollineo (ordine, chiarezza, armonia), presenti, prima che nella tragedia, nello spirito stesso dell'uomo
greco.
#ragedia e dramma satiresco
Del tutto incerto è anche il rapporto fra tragedia e dramma satiresco (cos/ chiamato perch0 il coro era
costituito da satiri). #l dramma satiresco seguiva la trilogia della tragedia (le tragedie venivano presentate al
pubblico in cicli di tre opere alla volta) e, coi toni scherzosi o ludici dei suoi temi e dei suoi
personaggi,assolveva forse a una fun!ione distensiva . econdo una tradizione antica, il dramma satiresco
rappresenterebbe una ripresa dell'elemento propriamente dionisiaco, venuto meno nel testo tragico e
reclamato con forza dal pubblico.
L'evoluzione del genere tragico
l musico e citarista Arione, attivo nella # met$ del sec. 1# a. 2., la tradizione attribuisce ora l'invenzione
ora una non meglio identificata riforma del ditirambo, in cui avrebbe introdotto temi mitici diversi da !uelli
tipicamente dionisiaci. #espi, del demo attico di #caria, avrebbe introdotto, per primo, un attore contrapposto
al coro con cui dialogava in metri giambici3 avrebbe anche partecipato per primo a un concorso tragico.
$ratina di Fliunte (sec.1#) è attribuita la prima composizione di drammi satireschi. 4otizie pi% sicure si
hanno di Frinico, che nei suoi drammi introdusse temi storici, precorrendo &schilo.
%a grande triade& schilo, (ofocle ed uripide
2on la triade dei drammaturgi ateniesi, dopo la lunga !uanto oscura fase dei primordi, la tragedia
raggiunge la sua compiute!!a, sia sotto il profilo formale sia, soprattutto, per altezza poetica. %'argomento
dei loro drammi ) tratto dal repertorio mitico , ben noto allo spettatore antico, a cui il poeta tragico
attingeva per esporre la propria visione del mondo e dell'esistenza.
#n schilo, la concatenazione fatale tra colpa e pena, destinata a protrarsi lungo l'arco di pi% generazioni,
trova uno sbocco di pacificazione nel disegno superiore della divinit$.
#n (ofocle, l'eroe tragico, paradigma dell'umana sofferenza, si misura, nella solitudine e nella grandezza, con
il proprio destino, giungendo al pessimismo radicale, che addita nel “non essere nato” la sorte migliore per
l'uomo.
2on uripide, il dramma si fa contrasto doloroso tra forze opposte che dilaniano il cuore dell'uomo5 la
divinit$ sembra incomprensibile o lontana. "a sublimit$ tragica si sfaccetta nel gioco fortuito del caso o si
svilisce nell'atmosfera !uotidiana degli eventi. #l mito stesso viene sottoposto a revisione, con esiti soventeinaspettati.

8/13/2019 La Genesi Della Tragedia
http://slidepdf.com/reader/full/la-genesi-della-tragedia 2/2
La struttura della tragedia classica
e pure con !ualche variazione nei diversi testi, l'opera tragica ) scandita secondo una parti!ione
costante5 prologo (discorso o scena introduttiva), parodo (canto di ingresso del coro
nell'orchestra), episodi (cioè atti, in numero variabile da tre a cin!ue), stasimi (canti corali che separano gli
episodi), esodo (scena finale).
Il prologo pu" essere costituito da un monologo di un personaggio oppure da una scena dialogata 3 in
&schilo e in ofocle ha il compito di iniziare l'azione drammatica, mentre in &uripide riveste una funzione
e6tra*drammaturgica poich0 viene narrato l'antefatto del dramma da un personaggio che non rientrer$ pi% inscena, spesso una divinit$.
%a parodo inizialmente rappresentava il momento centrale della tragedia3 il coro arrivava
nell'orchestradalle p$rodoi (corridoi laterali) e intonava un lungo canto d'ini!io accompagnato da danze e
balletti.
"e vere e proprie parti recitate dagli attori costituivano gli episodi durante i !uali i protagonisti usavano
diverse tecniche interpretative5 la résis (recitazione monologica di un personaggio), la sticomitía (scambio di
battute di un solo verso tra i personaggi in scena) e la monodía (canto “a solo” di un attore). 7re!uenti, ma
non canonici, sono anche i commi (dialoghi lirici tra il coro e un attore) e gli agoni amebei (dialoghi tra due
attori “a botta e risposta”).
8ra un episodio e l'altro gli attori escono di scena e il coro intona una melodia di lunghezza variabile, lo
stasimo, in cui si commentano le vicende finora rappresentate sul palcoscenico3 generalmente l'interme!!ocorale ha un legame soprattutto simbolico con l'azione.
%'esodo ) la scena finale della tragedia che si conclude con l'uscita del coro. pesso sia i personaggi sia i
coreuti rimangono in scena per contribuire allo scioglimento dell'azione drammatica3 tuttavia a volte 9
soprattutto in &uripide 9 la vicenda è cos/ intricata da richiede l'intervento del deus ex machina, un
personaggio divino calato dall'alto da una macchina teatrale, che scioglie l'intreccio.
I metri sono, per le parti dialogate, il trimetro giambico (secondo ristotele, il pi% vicino al parlato) e,
meno fre!uentemente, il tetrametro trocaico (forse con effetti di maggior movimento). # cori si articolano in
larghe partiture di versi lirici scandite nella successione di strofe e antistrofe seguite da un epodo.
Evoluzioni di forme e contenuto
*opo la fase ini!iale, in cui un solo attore dialogava col coro, gli attori divennero due e poi
tre(l'introduzione del terzo attore è dovuta a ofocle, ma l'innovazione fu accolta anche da &schilo) eciascuno di essi poteva rappresentare più di un personaggio. empre con ofocle il coro pass: da + a +;
elementi. Di grande rilievo, non solo sotto il profilo strutturale, ma anche come riflesso del mondo
concettuale dell'autore, è il rapporto fra i tre drammi della trilogia5 in &schilo la trilogia è “legata”, cioè le
tre tragedie mettono in scena tre momenti diversi, ma intimamente connessi, di una medesima “saga” mitica,
mentre gi$ in ofocle esse sono autonome, e ciascuna sviluppa un mito diverso, mentre l'accento è posto non
pi% sul destino di un'intera casata nell'arco delle generazioni, ma sull'eroico agire e patire di un personaggio5
in tal modo si apre il cammino per !uella definizione dell'eroe tragico che è alla base della drammaturgia
moderna. 4elle tragedie di &uripide, infine, il legame della trilogia è del tutto sciolto.
Teoria aristotelica della tragedia
4ella Poetica, ristotele riprende le antiche teorie sulla tragedia focalizzando l'attenzione su due concetti5
!uello di mìmesis (imitazione) e di kàtharsis (purificazione). #l primo si riferisce al valore e alla finalit$ della
poesia e dell'arte in genere, in modo particolare della tragedia5 tutti gli artisti sono “imitatori”(cfr. Repubblica di latone) perch0 creano una realt$ fantastica, modellata sulla realt$ ma tuttavia diversa da
essa. “2i sembra che due siano le cause, entrambe d'ordine naturale, che in sostanza danno origine all'arte
poetica. nzitutto è connaturato negli uomini sin da fanciulli l'istinto d'imitare3 in ci: si distingue l'uomo
dagli altri animali, perch0 la sua natura è estremamente imitativa e si procura per imitazione i primi
apprendimenti. oi c'è il piacere che tutti provano davanti alle opere5 !uelle cose che ci fanno soffrire !uando
le vediamo nella realt$, ci recano piacere se le osserviamo in immagini che siano il pi% possibile fedeli, come
i disegni delle bestie pi% sordide o dei cadaveri.” ( Poetica, ++< b <*+) Quest'illusione attira e suggestiona il
pubblico favorendo l'identificazione dello spettatore con i personaggi e una forte compartecipazione emotiva.
u !uesta profonda empatia si innesta il processo della catarsi5 l'ascoltatore si immedesima a tal punto nelle
vicende rappresentate da liberarsi dalle passioni portate in scena. 2os/ ristotele definisce la tragedia5
“8ragedia è opera imitativa di un'azione seria, completa, con certa estensione3 eseguita con linguaggioadorno distintamente nelle sue parti per ciascuna delle forme che impiega3 condotta da personaggi in azione,
e non esposta in maniera narrativa3 adatta a suscitare piet$ e paura, producendo tali sentimenti la
purificazione che i patimenti rappresentati comportano.” ( Poetica, ++<= b <* )