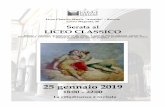LA DIDATTICA CON LE - capitello.it · Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo Brani Sara...
Transcript of LA DIDATTICA CON LE - capitello.it · Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo Brani Sara...
LA DIDATTICA CON LEUNITÀ DI APPRENDIMENTO
In queste pagine e nelle successive si presentano: – le mappe delle 5 unità di apprendimento per la classe seconda, declinate attorno a unabase di partenza, i nuclei tematici per gli alunni di questa fascia d’età, intesi come i nucleidelle capacità dei bambini, da sviluppare e potenziare all’interno delle unità di apprendimen-to. Ogni mappa comprende anche gli obiettivi generali del processo educativo e gli obiettivispecifici di apprendimento che confluiranno negli obiettivi formativi;– le proposte per percorsi di apprendimento individualizzati secondo le esigenze del grup-po classe e dell’organizzazione delle attività.
UA 1: MAPPA E OBIETTIVINucleo tematico: esperienze e scoperte tra realtà e fantasia.Obiettivi generali: saper riferire le proprie esperienze. Comprendere il contenuto e la struttu-ra di un testo narrativo. Sapersi muovere in spazi vicini.
16
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Laboratorio arcobaleno:scienze
scienze motorie e sportive
Letture: testo realistico-fantastico
Laboratorio arcobaleno:geografia
Letture: testi fantastici
e realistici
Educazione alla convivenza:affettivitàPagine per il portfolio
A
B
CD
E
F
Obiettivi specifici della UA 1
Educazione linguistica– attivare le capacità di lettura ad alta voce e di lettura silenziosa; – attivare le capacità di rielaborazione di un testo e comprenderne la struttura;– distinguere testi realistici e fantastici e parti realistiche e fantastiche di uno stesso testo.
MultidisciplineGeografia– tracciare e confrontare percorsi;– saper utilizzare gli indicatori spaziali;– saper utilizzare punti di riferimento personali.
Scienze– riconoscere e classificare le fasi di vita di una pianta.
Scienze motorie e sportive– saper fare giochi imitativi che richiedono abilità motorie.
Educazione alla convivenza civile: affettività– sviluppare atteggiamenti mentali di curiosità, interesse, iniziativa personale;– attivare confronti costruttivi con gli altri nell’ambito della tolleranza e del rispetto reciproco.
Dagli obiettivi specifici agli obiettivi formativiGli obiettivi specifici linguistici, multidisciplinari e dell’educazione alla convivenza civile (affet-tività) sono strettamente correlati: il loro raggiungimento confluisce in quello degli obiettiviformativi della prima unità di apprendimento.
17
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
UA 1: PERCORSI DI APPRENDIMENTOINDIVIDUALIZZATI
La struttura del progetto, suddivisa in unità di apprendimento linguistiche, multidisciplinari edi educazione alla convivenza civile e rispondente alla logica dell’ologramma, permette di co-struire, all’interno di ciascuna unità, percorsi di apprendimento individualizzati.
Percorso 1: dalla conoscenza delle esperienze altrui alla verbalizzazione delle proprie
Primo momento: apertura e brani di letturaApertura, p. 3
18
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
La pagina di apertura è stata pensata per accogliere i bambi-ni, per metterli a proprio agio e per permettere all’inse-gnante di stabilire un primo livello di preconoscenza.
BraniSara e il mare, p. 6La roccia del folletto, p. 7Avventura in bicicletta, p. 8Piove!, p. 9Picnic in… cucina, pp. 14-15
La lettura di semplici testi, in cui i bambini sono protagoni-sti di esperienze, facilita la verbalizzazione delle proprie einduce a parlare di sé. Dal punto di vista dell’educazionelinguistica, i brani, proprio per la loro semplicità, permetto-no di riprendere in modo graduale il percorso finalizzato al-le abilità di lettura, di comprensione e di rielaborazione, fi-no al raggiungimento della conoscenza della struttura di untesto narrativo.
Secondo momento: educazione all’affettivitàEducazione all’affettività Ti piace o non ti piace?, pp. 4-5
Terzo momento: laboratori multidisciplinariGeografiaIl viaggio di Pesciolino Blu, p. 10I folletti tornano a casa, p. 11Parole… nello spazio!, p. 12Scoperte in cantina, p. 13
ScienzeLa storia di un fagiolo, pp. 16-17
Scienze motorie e sportiveGiocare a «fare finta», pp. 18-19
19
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Le due pagine di educazione all’affettivitàcreano un momento di riflessione: i bambini,sulla base di quanto hanno letto e interioriz-zato, sono indotti a parlare di sé, riferendo iloro gusti e le loro emozioni.
In modo graduale si porta il bambino a sco-prire lo spazio vicino e la sua codificazioneconvenzionale (indicatori spaziali) per preci-sarlo, capirlo e farsi capire. Lo spazio intornoa sé inteso come insieme di elementi (perso-ne, oggetti, animali, piante). Il brano, Picnicin… cucina, alle pp. 14 e 15 crea lo spuntoper approfondire la conoscenza delle piante(ciclo vitale) e iniziare il percorso nelle scien-ze. Il gioco motorio, proposto alle pagine 18e 19, verifica l’interiorizzazione, da parte delbambino, di quanto ha appreso stimolandola creatività e la capacità di «agire» con di-sinvoltura nello spazio.
Portfolio, pp. 20–21 Le proposte operative, presentate in forma digiochi, verificano le capacità di attenzione,memorizzazione e rielaborazione personale.Gli smile emotivi aiutano il bambino a com-piere i primi passi nel processo di autovaluta-zione facendo leva sul maggiore o minoregradimento delle attività svolte. Sarà l’inse-gnante a «leggere oltre» le risposte date, in-dividuando le eventuali correlazioni tra i li-velli del gradimento personale e l’esattezzadelle performance.
Percorso 2: da sé agli altri e allo spazio intorno
Primo momento: apertura, educazione all’affettività, brani di letturaApertura, p. 3
Educazione all’affettivitàTi piace o non ti piace?, pp. 4-5
Secondo momento: laboratori multidisciplinari
20
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
L’apertura e l’educazione all’affettività con-sentono una prima valutazione d’ingresso inordine, rispettivamente, alle preconoscenzedei bambini e alla capacità di «mettersi in gio-co» e di saper rielaborare positivamente i pro-pri vissuti emotivi.
BraniSara e il mare, p. 6La roccia del folletto, p. 7Avventura in bicicletta, p. 8Piove!, p. 9
La lettura dei brani permette di confrontare leemozioni personali proiettandole sui propri si-mili, concorrendo così a sviluppare un proces-so di identificazione (mettersi nei panni di…)che, proprio perché coinvolge e facilita la rie-laborazione del proprio vissuto, stimola anchela riflessione e la rielaborazione sul piano piùstrettamente linguistico.
GeografiaIl viaggio di Pesciolino Blu, p. 10I folletti tornano a casa, p. 11Parole… nello spazio!, p. 12Scoperte in cantina, p. 13
L’atteggiamento positivo di curiosità e interes-se, attivato nel primo momento, permette diseguire lo spunto offerto dai brani per ap-profondire le conoscenze dal punto di vistageografico: lo spazio e le parole per definirlo.
21
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Terzo momento: brani di lettura e laboratori multidisciplinari
BraniPicnic in… cucina, pp. 14-15
ScienzeLa storia di un fagiolo, pp. 16-17
Scienze motorie e sportiveGiocare a «fare finta», pp. 18-19
Portfolio finale, pp. 20-21
Il brano alle pp. 14 e 15 «apre» l’ulteriorepassaggio all’ambito scientifico. Innestandosisul piano emotivo, precedentemente attivato,coinvolge i bambini per l’aspetto fantasticodella situazione narrata e, contemporanea-mente, pone le basi per riflettere sulle piantecome elementi dell’ambiente vicino, concor-rendo a sviluppare un atteggiamento di curio-sità che le pagine di scienze, prima, e discienze motorie e sportive, poi, possono sod-disfare positivamente. Dal punto di vista piùstrettamente linguistico, il brano permette diriconoscere gli aspetti realistici e fantastici diun racconto.
Percorso 3: guardarsi intorno
Primo momento: apertura, brani di lettura, multidisciplineApertura, p. 3
BraniLa roccia del folletto, p. 7Piove!, p. 9
La pagina di apertura, prima, e i due brani, poi, costituisco-no lo spunto per introdurre alle prime conoscenze dell’ar-gomento «spazio».
MultidisciplineGeografiaIl viaggio di Pesciolino Blu, p. 10I folletti tornano a casa, p. 11Parole… nello spazio!, p. 12Scoperte in cantina, p. 13
22
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Le proposte operative sui percorsi potrebbero essere inte-grate da altre assecondando anche la creatività dei bambini:si potrebbe, per esempio, invitare, singolarmente o a piccoligruppi, a inventare situazioni che prevedano la costruzionedi diversi tipi di percorsi, finalizzati a verificare l’obiettivospecifico. Per esempio invitando a individuare il percorsopiù lungo, il più corto, il più lineare, quello più tortuoso…,in situazioni realistiche o fantastiche (aiuta il mago Blu araggiungere l’albero sotto cui si trova la pozione magicaevitando di incontrare la strega Nera; unisciti ai bambininel parco e raggiungi con loro il lago delle anatre passandoprima dal padiglione con la mostra fotografica, poi dall’uffi-cio informazioni, infine dall’area picnic). Un ulteriore «passaggio ologrammatico», offerto da questotipo di proposta, potrebbe essere quello di introdurre, a li-vello logico-matematico (geometria) il discorso sui diversitipi di linee, portando i bambini a innestare il concetto dipercorso su quello di linea.Le proposte operative di p. 12 si possono integrare, peresempio, facendo portare in classe cartoline di paesaggi einvitando i bambini a completarle con gli indicatori spaziali,oppure uscendo dalla classe per una breve passeggiata allascoperta degli elementi dello spazio circostante, da precisa-re utilizzando gli indicatori spaziali…Le proposte operative di p. 13 si possono integrare invitandoun gruppo di alunni a mettersi in posa per una «fotografia vi-vente» per poi chiedere agli altri bambini di descrivere la «fo-tografia» utilizzando i termini «destra» e «sinistra» rispetto asé. Oppure ponendo al centro dell’aula una sedia e chiedere,per esempio, di mettere sul pavimento, alla propria destra oalla propria sinistra, davanti o dietro, sopra o sotto, oggetticome uno zainetto, un portapenne, un gesso…
Secondo momento: brani di lettura, multidiscipline
23
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
BraniSara e il mare, p. 6Avventura in bicicletta, p. 8Picnic in… cucina, pp. 14-15
MultidisciplineScienzeLa storia di un fagiolo, pp. 16-17
Scienze motorie e sportiveGiocare a «fare finta», pp. 18-19
Portfolio finale, pp. 20-21
Dopo il primo momento, piuttosto impegnativo, in cuiil bambino ha iniziato a esplorare lo spazio vicino, lalettura di altri brani crea «un’uscita», un intermezzogradevole, con cui riprendere il filo delle emozioni at-traverso la scoperta delle esperienze, reali o fantasti-che, dei bambini protagonisti dei racconti, esperienzeche avvengono in ambienti e in situazioni familiari (almare, in cucina, in bicicletta) sviluppando così un pro-cesso di identificazione (mettersi nei panni di…) che,come già detto, coinvolge e facilita la rielaborazione delproprio vissuto stimolando anche la riflessione e la rie-laborazione sul piano più strettamente linguistico. Con la lettura del brano alle pagine 14 e 15 i bambini«rientrano» nell’ambito disciplinare per riflettere sullepiante come elementi dello spazio.
24
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
RACCONTO A COLORI: Storia del ponte arcobaleno
Tra la prima unità di apprendimento e la seconda è inserita la prima puntata del Racconto acolori, la cui lettura è affidata all’insegnante. È stata fatta la scelta di proporre alcuni brani diun racconto inedito, Il Pianeta Faidate, di Gina Labriola, in via di pubblicazione presso le Edi-zioni il capitello.Obiettivo generale: sviluppare nei bambini il gusto dell’ascolto.Obiettivo specifico: promuovere le competenze previste per l’educazione all’ascolto, qualil’attenzione e la memorizzazione, la comprensione e la rielaborazione, anche in forma perso-nale, dei contenuti.
I motivi della scelta di letturaDal punto di vista stilistico, il racconto si caratterizza per freschezza e comprensibilità dilinguaggio. Il giusto equilibrio tra le parti dialogate, descrittive e narrative, facilita la letturaorale, rendendo dunque gradevole l’ascolto da parte dei bambini.Dal punto di vista del contenuto, il racconto risponde appieno agli obiettivi che sono alla basedel progetto I colori dell’arcobaleno:– offrire un prodotto rigoroso ed esauriente, dal punto di vista linguistico e multidisciplinare;– contribuire a trasmettere e a diffondere valori come il rispetto e la tolleranza, la convivenzapacifica, attiva e costruttiva, dal punto di vista dell’educazione alla convivenza civile.
25
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Notizie utiliL’autrice, Gina Labriola, di origini lucane, ha vissuto undici anni in Iran, occupandosi dellarealtà socioculturale di quel popolo. Ha lavorato presso l’Istituto Italiano di Cultura di Teheran,come collaboratrice dell’IsMEO (Istituto per il Medio ed Estremo Oriente), è stata corrispon-dente dell’ANSA e lettrice presso l’università di Teheran. Oggi vive a Parigi.Il periodo vissuto in Iran ha contribuito a sviluppare in lei una profonda sensibilità verso lacondizione dei bambini, delle donne e dell’aspetto multietnico della società odierna: tutto ciòl’ha resa consapevole della necessità irrinunciabile di contribuire a trasmettere valori come latolleranza, l’amicizia, la cooperazione e il rispetto reciproco. Gli Omini colorati, ciascuno deiquali vive in una zona ben definita del Pianeta Faidate, altro non rappresentano se non l’aspet-to multirazziale della società umana che popola la Terra e la sua grande varietà di paesaggi; iloro comportamenti, se da un lato rivelano la tentazione a chiudersi entro i propri confini, a«far da sé», dall’altro sottintendono il messaggio che sta alla base di tutto il racconto: il bisognodi conoscersi e di aiutarsi a vicenda per costruire insieme un mondo migliore, basato sulla con-vivenza pacifica di tutti gli esseri umani e sulla tutela dell’ambiente.
LABORATORIO arcobalenoINFORMATICA CON DESK TOP
Obiettivi generali: conoscere i principali termini specifici del linguaggio informatico. Acquisirela consapevolezza dell’importanza dell’utilizzo del computer come strumento per apprendere.
Obiettivi specifici: saper completare e rielaborare testi. Saper inviare e-mail.Gli obiettivi previsti per l’informatica sono da considerarsi trasversali, non solo ai contenuti ealle proposte della prima unità di apprendimento, ma anche ai contenuti e alle proposte di tut-te le altre unità. L’avvio alla videoscrittura, infatti, può essere utilizzato:– per il completamento di racconti (cloze);– per la ricomposizione delle parti fondamentali di un testo;– per la produzione di semplici testi da arricchire, eventualmente, con immagini;– per familiarizzare con il linguaggio logico-matematico.L’efficacia dell’uso del computer è particolarmente rilevabile nel caso di alunni in difficoltà,che presentano ritmi «faticosi» nel processo di apprendimento: la macchina costituisce, infatti,una specie di transfert positivo e funziona un po’ da filtro alle loro carenze. Il fatto stesso divedere immediatamente i frutti del loro lavoro, oltre tutto ben organizzati sullo schermo, è gra-tificante e stimola, predispone, l’acquisizione di abilità, altrimenti difficoltosa con i mezzi «tradi-zionali». Sui contenuti e sulle modalità di utilizzo del CD-ROM Desk Top alla conquista delweb, si veda anche il Laboratorio informatico, all’interno del Libro dell’insegnante, ambito lo-gico-matematico.
UA 2: MAPPA E OBIETTIVINucleo tematico: ricercare i «segnali» del tempo nello spazio vicino e lontano.Obiettivi generali: acquisire la consapevolezza del trascorrere del tempo (durata di un’azio-ne, periodizzazioni convenzionali, ciclicità e contemporaneità). Saper leggere e rielaborare te-sti realistici e fantastici.
26
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Pagine stagionali:collage d’autunno
A
Letture: testi fantastici
C
Laboratorio arcobaleno: storia
D
Letture: testi fantastici
E
Letture: testi fantastici
e realistici
G
Laboratorio arcobaleno:storia e geografia
scienze e tecnologia
B
Laboratorio arcobaleno:storia
storia e tecnologia
F
Educazione alla convivenza civile: affettività, cittadinanza
H
Obiettivi specifici della UA 2
Educazione linguistica – riconoscere sequenze narrative e dialogate, riordinare sequenze, rielaborare un testo;– riconoscere le caratteristiche del mito; – riconoscere le onomatopee;– distinguere parti fantastiche e parti realistiche in un testo narrativo, riconoscere personaggi,
luoghi e tempi;– riconoscere la rima in un testo poetico;– riconoscere la struttura di un testo regolativo (istruzioni).
MultidisciplineScienze e tecnologia– classificare materiali in base a caratteristiche di pesantezza, leggerezza, consistenza, elasticità.
Storia– utilizzare gli indicatori temporali per descrivere una situazione;– riconoscere la contemporaneità di azioni;– riconoscere la maggiore o minore durata di un’azione;– comprendere il concetto di ciclicità, in rapporto all’esperienza personale;– comprendere la periodizzazione convenzionale (settimane, mesi, anni).
Storia e geografia– acquisire la consapevolezza dell’ambiente naturale come spazio di vita e delle sue trasforma-
zioni in base all’alternanza delle stagioni.
Educazione alla convivenza civile (ambientale, alla salute, all’affettività, alla cittadinanza)– saper utilizzare le esperienze personali per rilevare i cambiamenti stagionali;– essere consapevoli della necessità di un regime alimentare equilibrato;– attivare modalità relazionali positive con adulti e compagni;– saper mettere in atto comportamenti responsabili.
27
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
UA 2: PERCORSI DI APPRENDIMENTOINDIVIDUALIZZATI
Percorso 1: consapevolezza del trascorrere del tempo, confronto di esperienze
Primo momento: apertura, brani di lettura, laboratori multidisciplinari
Le proposte contenute nella pagina di aperturaguidano con gradualità alla riflessione sulla basedelle preconoscenze: il gioco, attraverso la scoper-ta di elementi «temporali», apre alla riflessione ealla sua verbalizzazione. Infine, la richiesta di for-mulare ipotesi crea la base per introdurre la tema-tica e suscita l’aspettativa adatta a facilitare l’ac-quisizione dei contenuti.La lettura dei brani sviluppa atteggiamenti positividi curiosità e di scoperta in grado di favorire an-che il raggiungimento degli obiettivi linguistici at-traverso le proposte di analisi, di rielaborazione edi produzione personale.I due laboratori, che si collegano agli spunti creatidai brani di lettura, fanno riferimento all’esperien-za personale e, attraverso il metodo induttivo, fa-cilitano la comprensione dei concetti di contempo-raneità e di durata, e l’acquisizione dell’abilità diutilizzo degli indicatori temporali.
Apertura, p. 27
Brani e testi poeticiLa filastrocca del vino, p. 35Una sveglia diligente, pp. 36-37Come addomesticare le sveglie, p. 38La bambina perditempo, p. 39Il tempo passa e va, p. 40Il tempo passa per tutti, p. 41Dove abita il tempo?, pp. 42-43
StoriaLe parole del tempo, pp. 44-45«Quanto» dura un’azione?, p. 46
28
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Secondo momento: brani di lettura, laboratori multidisciplinari
29
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Il percorso di lettura prosegue con argomenti piùspecifici, sia per creare lo spunto ai laboratori mul-tidisciplinari, sia per continuare l’analisi testuale(riconoscere il diverso modo di trattare lo stessoargomento in un semplice testo informativo e inun testo narrativo; riordinare sequenze, riconosce-re onomatopee).
Brani e testi poeticiNotte e dì, p. 47Un vaso pieno di buio, pp. 48-49Nel silenzio della notte, pp. 50-51
StoriaBuona notte e buon giorno!, pp. 52-53Sette giorni speciali, pp. 54-55Il tempo… sulla carta!, pp. 56-57
Storia e geografiaCostruisci tu la notte e il dì, p. 58
Terzo momento: brani di lettura, educazioni
Il laboratorio di storia e geografia (Costruisci tu lanotte e il dì ) apre un’ulteriore sezione di brani, ditipo fantastico e realistico, che hanno come argo-mento le esperienze di bambini. La lettura dei pri-mi tre può avere anche una valenza positiva, dalpunto di vista psicologico (aiutare a superare lapaura del buio); si passa poi a brani che fanno rife-rimento a piccole conflittualità (capricci, senti-menti di rabbia) e, per contrasto, ad atteggiamentipositivi nei confronti di se stessi e degli altri (buo-numore, gentilezza, affetto). Le pagine di educa-zioni riprendono il filone comportamentale ap-profondendo la riflessione e il confronto nell’otticadi stimolare atteggiamenti positivi verso gli altri.
Brani Rosso di sera, p. 59Viaggiare, sognare p. 60Sergio Pirata Feroce, p. 61Il grande capriccio, pp. 62-63Le dolci parole, pp. 64-65Che rabbia!, p. 66Lo scultore Riccardo, pp. 70-71La vecchia automobile, pp. 72-73
Educazione all’affettivitàNon è giusto!, p. 67Io farei così!, p. 68Questione di responsabilità, p. 69
30
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Quarto momento: pagine stagionali, laboratori multidisciplinari, educazioni, portfolio
Le pagine stagionali creano il collegamento adatto tra le co-noscenze precedenti e quelle che seguiranno. Per mezzo didue tavole autunnali, ottimamente illustrate, i bambini han-no la possibilità di mettere a frutto le proprie esperienze at-traverso l’osservazione dei particolari e il loro riconosci-mento. I laboratori, poi, riprendono e fissano le conoscenze(autunno → ambienti e stagioni → ciclicità temporale).Con la proposta di scienze e tecnologia, mentre modellanoe fanno esperienza con i materiali, i bambini completano ilpercorso stagionale.Le pagine per il portfolio verificano le competenze raggiun-te nell’elaborazione linguistica.
Collage d’autunnoI segnali dell’autunno, pp. 28-29
Geografia e storiaUn mondo di ambienti, p. 30Le stagioni, p. 31
Educazione ambientaleModa autunno, p. 32
Educazione alla saluteGusto autunno, p. 33
Scienze e tecnologiaFoglie come statue!, p. 34
Portfolio finale, pp. 74-75
Percorso 2: scoperta dei cambiamenti stagionali e del temponella sua dimensione reale e fantastica
Primo momento: apertura, pagine stagionali, multidiscipline, educazioni
31
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Le proposte contenute nella pagina di apertura guidano congradualità alla riflessione sulla base delle preconoscenze: ilgioco, attraverso la scoperta di elementi «temporali», aprealla riflessione e alla sua verbalizzazione. Infine, la richiestadi formulare ipotesi crea la base per introdurre la tematicae suscita l’aspettativa adatta a facilitare l’acquisizione deicontenuti.La ricerca dei segnali del tempo si occupa subito dei cam-biamenti stagionali invitando all’osservazione dei particolariche caratterizzano l’autunno. I laboratori fissano le cono-scenze (autunno → alternanza delle stagioni → ciclicitàtemporale). Le pagine di educazioni invitano a utilizzare leesperienze personali, per rilevare i cambiamenti stagionali ead acquisire la consapevolezza della necessità di un regimealimentare equilibrato.Con la proposta di scienze e tecnologia, mentre modellanoe fanno esperienza con i materiali, i bambini completano ilpercorso stagionale.
Apertura, p. 27
Collage d’autunnoI segnali dell’autunno, pp. 28-29
Geografia e storiaUn mondo di ambienti, p. 30Le stagioni, p. 31
Educazione ambientaleModa autunno, p. 32
Educazione alla saluteGusto autunno, p. 33
Scienze e tecnologiaFoglie come statue!, p. 34
Secondo momento: multidiscipline, brani di lettura
I due laboratori, attraverso il metodo induttivo, facilitano lacomprensione dei concetti di contemporaneità e di durata,e l’acquisizione dell’abilità di utilizzo degli indicatori tem-porali.La lettura dei brani, collegati agli argomenti dei laboratori,sviluppa atteggiamenti positivi di curiosità e scoperta in gra-do di favorire anche il raggiungimento degli obiettivi lingui-stici attraverso le proposte di analisi, rielaborazione e pro-duzione personale.
StoriaLe parole del tempo, pp. 44-45«Quanto» dura un’azione?, p. 46
Brani e testi poeticiLa filastrocca del vino, p. 35Una sveglia diligente, pp. 36-37Come addomesticare le sveglie,p. 38La bambina perditempo, p. 39Il tempo passa e va, p. 40Il tempo passa per tutti, p. 41Dove abita il tempo?, pp. 42-43
32
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Terzo momento: multidiscipline, brani di lettura
I laboratori approfondiscono i contenuti e li fissa-no attraverso la proposta operativa di p. 58. Il con-seguente percorso di lettura continua l’analisi te-stuale (riconoscere il diverso modo di trattare lostesso argomento in un semplice testo informativoe in un testo narrativo; riordinare sequenze, rico-noscere onomatopee).
StoriaBuona notte e buon giorno!, pp. 52-53Sette giorni speciali, pp. 54-55Il tempo… sulla carta!, pp. 56-57
Storia e geografiaCostruisci tu la notte e il dì, p. 58
Brani e testi poeticiNotte e dì, p. 47Un vaso pieno di buio, pp. 48-49Nel silenzio della notte, pp. 50-51
Quarto momento: brani di lettura, educazioni
I brani fanno riferimento a piccole conflittualità(capricci, sentimenti di rabbia) e, per contrasto, adatteggiamenti positivi nei confronti di se stessi edegli altri (buonumore, gentilezza, affetto). Le pa-gine di educazioni riprendono il filone comporta-mentale approfondendo la riflessione e il confron-to nell’ottica di stimolare atteggiamenti positiviverso adulti e compagni.
Brani Rosso di sera, p. 59Viaggiare, sognare, p. 60Sergio Pirata Feroce, p. 61Il grande capriccio, pp. 62-63Le dolci parole, pp. 64-65Che rabbia!, p. 66
Educazione all’affettivitàNon è giusto!, p. 67Io farei così!, p. 68Questione di responsabilità, p. 69
Quinto momento: brani di lettura, racconto a colori, multidiscipline, portfolio
I due brani, di tipo fantastico, concludono in modogradevole il percorso di lettura. Il Racconto a colo-ri rielabora, in modo fantastico, la scoperta di am-bienti diversi in relazione allo scorrere del tempoche è scandito dai successivi incontri degli Omini;il laboratorio mette in moto la fantasia perché, ri-prendendo l’argomento sonno/buio, invita ad«animizzare» un oggetto ad esso legato, per esem-pio un cuscino, rivestendolo di contenuti fantastici. Le pagine per il portfolio verificano le competenzeraggiunte nell’elaborazione linguistica.
BraniLo scultore Riccardo, pp. 70-71La vecchia automobile, pp. 72-73
Racconto a coloriUn nuovo amico, Omino Giallo, p. 76
Scienze motorie e sportiveFai finta che…, p. 78
Portfolio finale, pp. 74-75
UA 3: MAPPA E OBIETTIVINucleo tematico: scoperta degli «abitanti» dello spazio e del tempo percepiti con la fantasia.Obiettivi generali: acquisire la consapevolezza della tutela dell’ambiente, sia attraverso lascoperta degli elementi che lo abitano, sia attraverso la loro rielaborazione fantastica (miti delleorigini).
33
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Pagine stagionali:collage d’inverno
A
Educazione ambientale
Educazione alla salute
B
Laboratorio arcobaleno:storia, geografia, scienze
C
Letture:testi fantastici
D
Educazione ambientale
E
Laboratorio arcobaleno:scienze,
scienze e tecnologia
F
Letture: favoleG
Laboratorio arcobaleno:scienze, scienze motorie
e sportive
H
Letture: fiabeI
Laboratorio arcobaleno: italiano
L
Letture: mitiM
PortfolioN
Racconto a colori
OEducazione alla salute
P
34
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Obiettivi specifici della UA 3
Educazione linguistica – riconoscere il messaggio di un testo poetico;– riconoscere la narrazione in prima persona; – comprendere la struttura di un testo narrativo e saper utilizzare i connettivi;– comprendere il contenuto di un testo narrativo ed esporlo con l’aiuto di uno schema;– attribuire titoli alle sequenze; – riconoscere le caratteristiche di una favola;– riordinare le sequenze di una favola;– riconoscere le caratteristiche di una fiaba;– ricostruire una fiaba collegando le diverse parti (avvio alla sintesi);– saper scrivere una fiaba sulla base di una traccia.
MultidisciplineStoria, geografia, scienze– applicare il concetto di ciclicità per comprendere i cambiamenti stagionali nell’ambiente;– comprendere le modalità che scandiscono le attività umane (la festa);– localizzare gli spazi;– riconoscere la maggiore o minore durata di un’azione;– comprendere l’importanza dell’elemento acqua per la nostra vita;– comprendere la varietà del mondo animale rispetto all’ambiente. Saper osservare comporta-
menti e segnali e operare confronti con l’uomo;– comprendere il ciclo vitale dei mammiferi.
Scienze e tecnologia, scienze motorie e sportive– operare su materiali allo stato solido (modellare); classificare materiali in base alle caratteristi-
che di pesantezza, leggerezza, consistenza, elasticità;– acquisire il concetto di materia e di materiale; solidi e liquidi nell’esperienza quotidiana;– classificare materiali in base alle caratteristiche di morbidezza, elasticità, flessibilità;– muoversi con disinvoltura; utilizzare linguaggi gestuali e motori per realizzare giochi imitativi.
Educazione alla convivenza (ambientale, alla salute, all’affettività, alla cittadinanza)– saper utilizzare le esperienze personali per rilevare i cambiamenti stagionali;– essere consapevoli della necessità di un regime alimentare equilibrato;– capire l’importanza della raccolta differenziata;– acquisire la consapevolezza della tutela ambientale;– imparare a rispettare i diversi punti di vista e a risolvere piccoli conflitti.
UA 3: PERCORSI DI APPRENDIMENTOINDIVIDUALIZZATI
Percorso 1: consapevolezza del trascorrere del tempo,confronto di esperienze
Primo momento: apertura, brani di lettura, multidiscipline
35
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Attraverso un gioco linguistico, i bambini sono sol-lecitati a compiere semplici deduzioni e a formula-re ipotesi sui contenuti della terza unità.La lettura dei miti delle origini sviluppa atteggia-menti positivi di curiosità e di scoperta, allarga laloro percezione spaziale e introduce sia la temati-ca della diversità delle razze, sia il valore della dif-ferenza come arricchimento personale.La leggenda introduce un’altra tipologia testuale,la favola. Le proposte di riflessione, basate soprat-tutto sulla morale, aiutano a rielaborare e a con-frontare i propri vissuti, trasmettendo, implicita-mente, valori di convivenza.Il laboratorio di scienze offre ai bambini un ap-proccio realistico al mondo animale. Il gioco mo-torio chiude il primo momento con una propostadivertente riferita al mondo degli animali.
Apertura, p. 79
BraniManitù e gli alberi, p. 132I giganti e le stelle, p. 133I colori della pelle, pp. 134-135Come sono nati l’uomo e la donna, p. 136La renna e la balena, p. 137Il lupo che aveva paura, p. 106La tartaruga e la lepre, p. 107Il leone e il topolino, pp. 108-109Il coccodrillo e la volpe, p. 110La zanzara e il toro, p. 111
ScienzeNel mondo degli animali, pp. 112-113La storia di Bubolina, pp. 114-115
Scienze motorie e sportiveL’arca di Noè, pp. 116-117
Secondo momento: brani di lettura, educazioni, laboratori multidisciplinari
Gli ultimi tre racconti, che hanno gli animali co-me protagonisti, creano lo spunto per introdurrel’educazione ambientale, i laboratori di scienze edi scienze e tecnologia. Tutti e tre i brani hanno,come «sfondo», l’ambiente naturale che funzionaanche come filo conduttore per invitare a riflette-re: sulle diversità che caratterizzano gli elementi
BraniI sogni di un uccellino, pp. 94-95Gufo saggio, pp. 96-97
Educazione ambientaleVia i rifiuti con intelligenza!, p. 98L’ambiente va difeso!, p. 99
dell’ambiente e creano varietà di specie (necessa-rie le une alle altre) sulla necessità della tutela am-bientale (per rendere possibile la vita stessa dellespecie che lo popolano) sull’elemento acqua, es-senziale per l’esistenza. Le educazioni, presentateattraverso proposte operative introducono il con-cetto di riciclaggio dei rifiuti e invitano a scegliere,in situazioni pratiche, i comportamenti più adattia difendere l’ambiente.Il laboratorio di p.102 fa riferimento al raccontoprecedente e induce i bambini a costruire, in pri-ma persona, lo schema del ciclo dell’acqua; il la-boratorio di p.103 fissa e approfondisce le cono-scenze sull’elemento acqua e sulla sua necessa-rietà per la vita di tutti gli esseri viventi. Dalla ma-teria acqua, si passa poi a scoprire la materia orga-nica e inorganica e, attraverso la visualizzazionedi una semplice esperienza, i bambini scoprono leprincipali proprietà dei materiali liquidi e solidi.
BraniLa rana e la goccia di pioggia, pp. 100-101
ScienzeUna storia «rotonda», p. 102Risorsa acqua, p. 103
Scienze e tecnologiaDi che cosa siamo fatti?, pp. 104-105.
36
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Terzo momento: pagine stagionali, educazione ambientale, educazione allasalute, laboratori multidisciplinari, brani di lettura, educazione all’affettività
Prosegue la ricerca dei segnali del tempo attraver-so i cambiamenti stagionali e invitando all’osserva-zione dei particolari che caratterizzano l’inverno. Ilaboratori fissano le conoscenze (inverno → alter-nanza delle stagioni → ciclicità temporale). Le pa-gine di educazioni invitano a utilizzare le espe-rienze personali per rilevare i cambiamenti stagio-nali e a diventare consapevoli della necessità di unregime alimentare equilibrato. Il laboratorio dellepagine 84 e 85 approfondisce l’argomento stagio-nale, riprendendo il concetto di contemporaneità.Il laboratorio delle pagine 86 e 87 invita a riflette-re sulle feste (Natale) come modalità che regolanole attività umane e a localizzare gli spazi. Con laproposta di scienze e tecnologia, mentre modella-
Collage d’invernoI segnali dell’inverno, pp. 80-81
Educazione ambientaleModa inverno, p. 82
Educazione alla saluteGusto inverno, p. 83
Geografia, storia, scienzeMa quanto gira la Terra!, pp. 84-85
Geografia e storiaMara e Meo alla scoperta del Natale, pp. 86-87
no e fanno esperienza con i materiali, i bambinicompletano il percorso stagionale. La poesia e ilbrano di argomento natalizio invitano alla riflessio-ne sui messaggi di pace e di tolleranza, che trova-no la loro applicazione nella pagina di educazioneall’affettività.
Scienze e tecnologiaPupazzi di neve, p. 88
Brani e testi poeticiNatale, p. 89Messaggio di pace, pp. 90-91
Educazione all’affettivitàLitigare, fare pace, p. 92
37
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Quarto momento: brani di lettura, laboratori multidisciplinari, educazionealla salute, racconto a colori, portfolio
L’ultimo racconto del terzo momento «apre» alla ti-pologia della fiaba. I brani offrono una ricca sceltadi fiabe tradizionali e moderne; le proposte operati-ve sono state pensate sia per la comprensione e larielaborazione della struttura e delle caratteristichedel genere, sia per stimolare la riflessione e il con-fronto. Il laboratorio di italiano offre spunti per larielaborazione e la produzione personale. Il percor-so testuale, tutto all’insegna della fantasia, si chiudecon la terza puntata del Racconto a colori. Il portfo-lio verifica le capacità di memorizzazione e di riela-borazione delle tipologie presentate nell’unità (fia-ba, favola, mito). La pagina di educazione alla salu-te offre lo spunto per affrontare la quarta unità.
BraniStrega Betega, pp. 118-119Il mago, il bambino e il canguro, pp. 120-121Un sonno… di cento anni, pp. 122-123La principessa Birichina, pp. 124-125Ciuffetto Rosso e il lupo, pp. 126-127Una fata pasticciona, pp. 128-129
ItalianoSulle tracce della fantasia!, p. 130L’angolo delle fiabe, p. 131
Racconto a coloriAltri Omini, altri incontri, p. 140
Educazione alla saluteIl gioco della merenda, p. 142
Portfolio, pp. 138-139
Percorso 2: le letture come spunto per conoscere e scoprire
Primo momento: apertura, brani di lettura, educazione ambientale, multidiscipline
38
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Attraverso un gioco linguistico, i bambini sono sol-lecitati a compiere semplici deduzioni e a formula-re ipotesi sui contenuti della terza unità.I racconti in apertura, che hanno gli animali comeprotagonisti, creano lo spunto per introdurre l’e-ducazione ambientale, i laboratori di scienze e discienze e tecnologia. Tutti e tre i brani hanno, co-me «sfondo», l’ambiente naturale che funzionaanche come filo conduttore per invitare a rifletteresulle diversità che caratterizzano gli elementi del-l’ambiente e creano varietà di specie (necessarie leune alle altre), sulla necessità della tutela ambien-tale (per rendere possibile la vita stessa delle spe-cie che lo popolano), sull’elemento acqua, essen-ziale per l’esistenza. Le educazioni, presentate at-traverso proposte operative introducono il concet-to di riciclaggio dei rifiuti e invitano a scegliere, insituazioni pratiche, i comportamenti più adatti adifendere l’ambiente.Il laboratorio di p. 102 fa riferimento al raccontoprecedente e induce i bambini a costruire, in pri-
ma persona, lo schema del ciclo del-l’acqua; il laboratorio di p. 103 fissae approfondisce le conoscenze sul-l’elemento acqua e sulla sua neces-sarietà per la vita di tutti gli esseriviventi. Dalla materia acqua, sipassa poi a scoprire la materia or-ganica e inorganica e, attraversola visualizzazione di una sempliceesperienza, i bambini scoprono leprincipali proprietà dei materialiliquidi e solidi.
Apertura, p. 79
BraniI sogni di un uccellino, pp. 94-95Gufo saggio, pp. 96-97La rana e la goccia di pioggia, pp. 100-101
Educazione ambientaleVia i rifiuti con intelligenza!, p. 98L’ambiente va difeso!, p. 99
ScienzeUna storia «rotonda», p. 102Risorsa acqua, p. 103
Scienze e tecnologiaDi che cosa siamo fatti?, pp. 104-105
Secondo momento: brani di lettura, multidiscipline
39
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
La presentazione dei brani, che vedono gli animalicome protagonisti, prosegue con le favole. Le pro-poste di riflessione, basate soprattutto sulle morali,aiutano a rielaborare e a confrontare i propri vissuti,trasmettendo, implicitamente, valori di convivenza.Il laboratorio di scienze offre ai bambini un ap-proccio realistico al mondo animale. Il gioco mo-torio chiude il primo momento con una propostadivertente sempre riferita al mondo degli animali.
BraniIl lupo che aveva paura, p. 106La tartaruga e la lepre, p. 107Il leone e il topolino, pp. 108-109Il coccodrillo e la volpe, p. 110La zanzara e il toro, p. 111
ScienzeNel mondo degli animali, pp. 112-113La storia di Bubolina, pp. 114-115
Scienze motorie e sportiveL’arca di Noè, pp. 116-117
Terzo momento: pagine stagionali, educazione ambientale, educazione allasalute, multidiscipline, brani di lettura, educazione all’affettività
Prosegue la ricerca dei segnali del tempo attraver-so i cambiamenti stagionali e invitando all’osserva-zione dei particolari che caratterizzano l’inverno.I laboratori fissano le conoscenze (inverno → al-ternanza delle stagioni → ciclicità temporale). Lepagine di educazioni invitano a utilizzare le espe-rienze personali per rilevare i cambiamenti stagio-nali e a diventare consapevoli della necessità di unregime alimentare equilibrato. Il laboratorio dellepagine 84 e 85 approfondisce l’argomento stagio-nale, riprendendo il concetto di contemporaneità.Il laboratorio delle pagine 86 e 87 invita a riflette-re sulle feste (Natale) come modalità che regolanole attività umane e a localizzare gli spazi. Con laproposta di scienze e tecnologia, mentre modella-no e fanno esperienza con i materiali, i bambinicompletano il percorso stagionale. La poesia e ilbrano di argomento natalizio invitano alla riflessio-ne sui messaggi di pace e di tolleranza, che trova-no la loro applicazione nella pagina di educazioneall’affettività.
Collage d’invernoI segnali dell’inverno, pp. 80-81
Educazione ambientaleModa inverno, p. 82
Educazione alla saluteGusto inverno, p. 83
Geografia, storia, scienzeMa quanto gira la Terra!, pp. 84-85
Geografia e storiaMara e Meo alla scoperta del Natale, pp. 86-87
Scienze e tecnologiaPupazzi di neve, p. 88
Brani e testi poeticiNatale, p. 89Messaggio di pace, pp. 90-91
Educazione all’affettivitàLitigare, fare pace, p. 92
40
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Quarto momento: brani di lettura, multidiscipline, racconto a colori, portfolio
L’ultimo racconto del terzo momento «apre» allatipologia della fiaba. I brani offrono una ricca scel-ta di fiabe tradizionali e moderne; le proposte ope-rative sono state pensate sia per la comprensione ela rielaborazione della struttura e delle caratteristi-che del genere, sia per stimolare la riflessione e ilconfronto. Il percorso testuale, tutto all’insegnadella fantasia, prosegue con la presentazione deimiti delle origini, che sviluppa atteggiamenti posi-tivi di curiosità e di scoperta, allarga la percezionespaziale dei bambini e introduce, da un lato, la te-matica della diversità delle razze, dall’altro, il valo-re della differenza come arricchimento personale.Il laboratorio di italiano offre spunti per la rielabo-razione e la produzione personale.Infine, dopo le proposte per la verifica dell’ascolto,il portfolio verifica le capacità di memorizzazionee di rielaborazione delle tipologie presentate nel-l’unità.
BraniStrega Betega, pp. 118-119Il mago, il bambino e il canguro, pp. 120-121Un sonno… di cento anni, pp. 122-123La principessa Birichina, pp. 124-125Ciuffetto Rosso e il lupo, pp. 126-127Una fata pasticciona, pp. 128-129Manitù e gli alberi, p. 132I giganti e le stelle, p. 133I colori della pelle, pp. 134-135Come sono nati l’uomo e la donna, p. 136La renna e la balena, p. 137
ItalianoSulle tracce della fantasia!, p. 130L’angolo delle fiabe, p. 131
Racconto a coloriAltri Omini, altri incontri, p. 140
Portfolio, pp. 138-139
UA 4: MAPPA E OBIETTIVINucleo tematico: esperienze a confronto per conoscersi e vivere bene insieme.Obiettivi generali: conoscere e comprendere i propri bisogni in relazione a quelli degli altri.Imparare a risolvere piccole conflittualità e situazioni di disagio. Aprirsi alla convivenza tolle-rante e rispettosa dell’altro. Sviluppare atteggiamenti di riflessione e di confronto, a partire dal-la storia personale.
41
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Pagine stagionali:collage di primavera
A
Educazione ambientale
Educazione alla salute
B
Laboratorio arcobaleno:scienze
C
Letture: testi fantastici e realistici
D
Letture: testi realistici
H
Letture: testi fantastici e realistici
F
Educazione alla cittadinanza
ELaboratorio
arcobaleno: italianoG
Educazione allacittadinanza
I
Laboratorio arcobaleno: storia
L
Racconto a coloriM
PortfolioN
Obiettivi specifici della UA 4
Educazione linguistica – riconoscere il messaggio di un testo poetico;– riconoscere la narrazione in prima persona; – riflettere sul messaggio di un testo narrativo;– saper rielaborare un testo basandosi sul proprio vissuto.
MultidisciplineScienze– riconoscere piante comuni e saper distinguere tra pianta spontanea e pianta coltivata;– comprendere il concetto di riproduzione, sia come effetto di un rapporto affettivo, sia come
esempio di complementarità tra i sessi.
Italiano– possedere un bagaglio lessicale adatto all’età e saperlo utilizzare in semplici giochi linguistici.
Storia– comprendere il significato di fonte riferito alla storia personale; saper riordinare in senso cro-
nologico fonti materiali, scritte e orali.
Educazione alla convivenza civile (ambientale, alla salute, alla cittadinanza)– saper utilizzare le esperienze personali per rilevare i cambiamenti stagionali;– essere consapevoli della necessità di un regime alimentare equilibrato;– acquisire la consapevolezza di culture diverse dalla propria attraverso la conoscenza di feste
legate alle tradizioni popolari;– acquisire la consapevolezza dei propri bisogni in relazione a quelli degli altri;– comprendere l’importanza delle regole di comportamento; elaborare e scrivere il regolamen-
to di classe;– acquisire la consapevolezza dell’importanza delle regole di comportamento per una convi-
venza rispettosa dell’altro;– accettare e rispettare le diversità; riconoscere il valore della diversità come arricchimento.
42
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
UA 4: PERCORSI DI APPRENDIMENTOINDIVIDUALIZZATI
Percorso 1: dalla consapevolezza di sé a quella degli altriintorno a sé
Primo momento: apertura, brani di lettura, multidiscipline, educazioni
43
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
La pagina di apertura invita a scoprire l’argomentogenerale della terza unità: il gioco proposto puòservire anche per valutare l’abilità di gestione spa-ziale raggiunta dai bambini (lateralizzazione). Conil testo poetico e i brani si invitano i bambini allariflessione su sé (sfera affettiva e aspettative). Conle pagine di scienze, acquisiscono le conoscenzesulla riproduzione umana e, contemporaneamen-te, sul suo significato profondo. Le pagine di edu-cazione alla cittadinanza invitano i bambini acompiere un passo in più e a farsi consapevoli deipropri bisogni in relazione a quelli degli altri.
Apertura, p. 143
Brani e testi poeticiIo sono importante!, p. 152Che bello quando sarò grande!, p. 153Dentro la mamma, pp. 154-155
ScienzeNascita di Emma, pp. 156-157
Educazione alla cittadinanzaHo bisogno di… , pp. 158-159Chiacchierando con la maestra, pp. 160-161
Secondo momento: brani di lettura, multidiscipline, brani di lettura, educazioni
Il percorso prosegue da sé agli altri: i bambini con-frontano le proprie esperienze e i propri vissuticon quelli dei protagonisti dei racconti, sono in-dotti a riflettere e a esprimere le proprie opinioni,a «mettersi in gioco» e a consapevolizzarsi rispettoalla diversità, attraverso il laboratorio e le paginedi educazione alla cittadinanza.
BraniI nomi… viaggiano!, p. 164Un nome per tre, p. 165Margherita, p. 166
ItalianoNomi in gioco, p. 167
BraniLui ha sempre ragione!, pp. 168-169È un’ingiustizia!, pp. 170-171La battaglia dei cuscini, pp. 172-173Tutti a scuola!, pp. 174-175
Terzo momento: pagine stagionali, educazione ambientale, educazione allasalute, educazione alla cittadinanza, multidiscipline
44
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
L’intermezzo stagionale riprende il filone ambiente-tempo e crea lo spunto per favorire la conoscenzadi spazi e tradizioni diversi e lontani dal proprio(educazione alla cittadinanza) e di elementi del-l’ambiente vicino (scienze). Il laboratorio finale distoria riprende l’argomento dell’unità (spazi in rela-zione) e, proponendo ai bambini di ricostruire il lo-ro passato, trasmette il concetto di storia personale.
Collage di primaveraI segnali della primavera, pp. 144-145
Educazione ambientaleModa primavera, p. 146
Educazione alla saluteGusto primavera, p. 147
Educazione alla cittadinanzaFeste di primavera, pp. 148-149
ScienzeQuanti fiori in primavera!, pp. 150-151
StoriaRicordi… in scatola, pp. 184-185
Quarto momento: Racconto a colori, portfolio
La pagina per il portfolio invita, attraverso un gio-co linguistico (la cornice), a scrivere il messaggioche sta alla base della quarta unità.
Racconto a coloriOmino Rosso e Omino Trasparente, p. 186Portfolio, p. 188
Percorso 2: più «ricchi» perché diversiPrimo momento: apertura, brani di lettura, educazioni
La pagina di apertura invita a scoprire l’argomentogenerale della terza unità: il gioco proposto (ri-composizione di tasselli per scoprire l’immaginenascosta) può servire anche per valutare l’abilità
Apertura, p. 143
BraniLui ha sempre ragione!, pp. 168-169È un’ingiustizia!, pp. 170-171
Il primo giorno di scuola, pp. 176-177Piccole paure, pp. 178-179Il compagno nuovo, pp. 180-181
Educazione alla cittadinanzaDiversi è bello!, pp. 182-183
45
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Secondo momento: brani di lettura, multidiscipline, educazioniCon il testo poetico e i brani si invitano i bambinialla riflessione su sé (sfera affettiva e aspettative).Con le pagine di scienze, acquisiscono le conoscen-ze sulla riproduzione umana e, contemporanea-mente, sul suo significato profondo. Le pagine dieducazione alla cittadinanza invitano i bambini acompiere un passo in più e a diventare consapevolidei propri bisogni in relazione a quelli degli altri.
Brani e testi poeticiIo sono importante!, p. 152Che bello quando sarò grande!, p. 153Dentro la mamma, pp. 154-155
ScienzeNascita di Emma, pp. 156-157
Educazione alla cittadinanzaHo bisogno di…, pp. 158-159Chiacchierando con la maestra…, pp. 160-161
Terzo momento: multidiscipline, Racconto a coloriIl laboratorio finale di storia riprende l’argomentodell’unità (spazi in relazione) e, proponendo aibambini di ricostruire il loro passato, trasmette ilconcetto di storia personale.
StoriaRicordi… in scatola, pp. 184-185
Racconto a coloriOmino Rosso e Omino Trasparente, p. 186
Quarto momento: pagine stagionali, educazioni, multidiscipline, portfolioIl collage di stagione riprende il filone ambiente-tempo e crea lo spunto per favorire la conoscenzadi spazi e tradizioni diversi (educazione alla citta-dinanza) e di elementi dell’ambiente vicino (scien-ze). La pagina per il portfolio invita a scrivere ilmessaggio che sta alla base della quarta unità.
Collage di primaveraI segnali della primavera, pp. 144-145
Educazione ambientale e alla saluteModa primavera, p. 146Gusto primavera, p. 147
Educazione alla cittadinanzaFeste di primavera, pp. 148-149
ScienzeQuanti fiori in primavera!, pp. 150-151
Portfolio, p. 188
di gestione spaziale raggiunta dai bambini (latera-lizzazione). Subito dopo, essi confrontano le pro-prie esperienze e i propri vissuti con quelli dei pro-tagonisti dei racconti, sono indotti a riflettere e aesprimere le proprie opinioni, a «mettersi in gioco»e a consapevolizzarsi rispetto alla diversità, attra-verso le pagine di educazione alla cittadinanza.
La battaglia dei cuscini, pp. 172-173Tutti a scuola!, pp. 174-175Il primo giorno di scuola, pp. 176-177Piccole paure, pp. 178-179Il compagno nuovo, pp. 180-181
Educazione alla cittadinanzaDiversi è bello!, pp. 182-183
UA 5: MAPPA E OBIETTIVINucleo tematico: scoprire come orientarsi in ambienti vicini; esplorare la strada. Obiettivi generali: acquisire la consapevolezza della tutela dell’ambiente; imparare a rappre-sentare ambienti (avvio alla cartografia); imparare a muoversi nell’ambiente vicino utilizzandopunti di riferimento personali e convenzionali.
46
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Pagine stagionali:collage d’estate
A
Educazione ambientale
Educazione alla salute
B
Letture: testi fantastici e realistici
C
Laboratorio arcobaleno:geografia
D
Laboratorio musica - arte e immagine
L
Educazione stradale
F
Letture: testi realistici
E
Laboratorio arcobaleno:geografia, tecnologia e
informatica
G
Racconto a coloriH
PortfolioI
PortfolioI
Obiettivi specifici della UA 5Educazione linguistica – riconoscere e utilizzare gli indicatori temporali;– riconoscere e utilizzare gli indicatori spaziali;– comprendere la struttura di un testo narrativo e saper utilizzare i connettivi;– comprendere il contenuto di un testo narrativo e saperlo esporre;– comprendere i significati di termini specifici; – riconoscere le caratteristiche di un testo descrittivo d’ambiente.
MultidisciplineGeografia– saper leggere alcune rappresentazioni cartografiche di uno stesso territorio;– saper utilizzare una legenda;– cogliere lo scopo delle rappresentazioni cartografiche;– distinguere i punti di riferimento spaziali di tipo personale e di tipo convenzionale;– utilizzare i punti cardinali.
Tecnologia e informatica– acquisire la consapevolezza dell’uso del computer per scrivere e inviare messaggi; – saper utilizzare la terminologia specifica.
Educazione alla convivenza civile (ambientale, stradale)– saper utilizzare le esperienze personali per rilevare i cambiamenti stagionali;– essere consapevoli della necessità di un regime alimentare equilibrato;– riconoscere i principali comportamenti corretti, in qualità di pedone, di ciclista e di passeggero.
47
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
L’ultima parte della quinta unità di apprendimento, da p. 210 a p. 223, è riservata al laboratorioespressivo di arte e musica. Il motivo alla base della scelta di presentare contenuti artistici emusicali in chiusura del testo deriva dalla considerazione che il laboratorio espressivo, sviluppan-do e potenziando soprattutto atteggiamenti mentali di creatività e di curiosità (spirito di osserva-zione), da parte dei bambini, trova una rispondenza e un interesse maggiori dopo un percorsograduale, per mezzo del quale gli alunni hanno avuto modo di sviluppare atteggiamenti e compe-tenze adeguati ad apprezzare le proposte e, dunque, ad accettarle «con lo spirito giusto».Il laboratorio espressivo, infatti, è stato progettato per attivare e potenziare tutte le abilità mes-se in atto attraverso le letture e i laboratori disciplinari precedentemente presentati. Nulla vie-ta, però, che l’insegnante decida di metterlo alla base della sua didattica, per esempio, fram-mentandolo in parti e presentandolo prima, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità diapprendimento. In questo modo, il laboratorio espressivo potrebbe affiancarsi al percorso emo-tivo dei bambini. Da p. 81 a p. 128 del Libro dell’insegnante - ambito linguistico, si fornisco-no i materiali e gli spunti per ampliare il laboratorio espressivo.
UA 5: PERCORSI DI APPRENDIMENTOINDIVIDUALIZZATI
Percorso 1: dalle letture alla rappresentazione dello spazioper muoversi al suo interno con sicurezza
Primo momento: apertura, brani di lettura, educazione stradale, multidiscipline
48
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
La pagina di apertura propone un gioco linguisticoper scoprire la parola chiave dell’ultima unità:orientarsi. Anche questa, come le altre aperture,può essere utilizzata come una sorta di accerta-mento delle preconoscenze e della capacità di for-mulare semplici ragionamenti. I brani creano lo spunto per l’educazione stradalee per il laboratorio geografico.
Apertura, p. 189BraniUn regno… sulla carta, p. 194Boscoverde, p. 195Nasce una città, p. 198A far spese con mamma, p. 199
Educazione stradalePer strada in sicurezza, pp. 200-201
GeografiaLe carte di Boscoverde, pp. 196-197Punti di riferimento per orientarsi, pp. 202-203
IL LABORATORIO ESPRESSIVO DI ARTE E MUSICA
Secondo momento: pagine stagionali, educazione ambientale, educazionealla salute
49
Caratteristiche e modalità di utilizzo del testo
Le pagine stagionali possono collegarsi all’orienta-mento spaziale: dopo aver completato la tavoladell’estate, si potrebbe invitare i bambini a descri-vere il percorso da casa a scuola, evidenziando isegnali dell’estate nell’ambiente vicino alla loroquotidianità. La descrizione potrebbe essere pro-posta sia in forma orale, sia in forma scritta, invi-tandoli anche a costruire una «carta» del percorsocon una legenda orientativa.Il collage si completa con le pagine di educazioni.
Collage d’estateI segnali dell’estate, pp. 190-191
Educazione ambientaleModa estate, p. 192
Educazione alla saluteGusto estate, p. 193
Terzo momento: multidiscipline, racconto a colori, portfolio
Il laboratorio potrebbe prendere spunto dalla fineimminente delle lezioni e dalla possibilità di invia-re biglietti o lettere agli amici, con l’uso del com-puter, per augurare loro buone vacanze. Le propo-ste dell’ascolto hanno come obiettivo la rielabora-zione personale dei contenuti ascoltati.Le pagine per il portfolio sono state progettate sem-pre nell’ottica della conclusione dell’anno scolasti-co e, parallelamente, per verificare, in forma di gio-co, l’acquisizione di abilità di osservazione e di rie-laborazione.
Scienze e tecnologiaComunicare… con Desk Top, pp. 204-205
Racconto a coloriDestinazione Terra, p. 206
Portfolio, p. 209Portfolio, p. 224
65
Il PORTFOLIOdelle competenze
individuali
Questa sezione integra gli strumenti di verifica già presenti nel Progetto didattico dellibro di testo, pensati per documentare il percorso formativo di ogni alunno nel corsodel secondo anno di scuola primaria. La nuova scuola, infatti, si indirizza verso formepiù ampie e complete di valutazione che tengono conto, oltre che dei prerequisiti dibase e dei livelli di competenza accertati dall’insegnante, del coinvolgimento dell’a-lunno e della famiglia nel cammino di formazione.Per tali motivi questo Portfolio si articola in tre parti:
1.La prima sezione si rivolge all’insegnante, fornendo indicazioni e griglie utili per:– spiegare che cos’è il Portfolio e come articolarne l’elaborazione;– registrare e organizzare il quadro delle competenze raggiunte dall’alunno.
2.Una seconda sezione è dedicata all’autovalutazione da parte dell’alunno, con loscopo di:– definire la percezione del proprio stare a scuola, di spazio e tempo, le proprie abi-
tudini;– registrare il gradimento e l’interesse per le attività dei diversi ambiti;– verificare l’eventuale consapevolezza delle proprie difficoltà.
3.Una terza sezione si rivolge ai genitori, con l’obiettivo di:– raccogliere informazioni utili all’insegnante per impostare al meglio il piano di
studio personalizzato dell’alunno;– raccogliere le loro opinioni sul percorso di lavoro svolto dal proprio figlio.
Si tratta di materiali duttili, semplici piste di lavoro e spunti di riflessione, che i docen-ti potranno adattare alle proprie necessità, ampliandoli o articolandoli tenendo contodel Piano dell’Offerta Formativa elaborato dalla scuola.
66
ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
L’elaborazione del PORTFOLIO
Che cos’è il Portfolio delle competenze?La parola portfolio indica comunemente la raccolta significativa di ciò che un soggettosa fare: una sorta di catalogo dei propri «prodotti» per dimostrare l’abilità in un determi-nato settore.I diversi materiali possono essere raccolti in una cartella, in una busta, in un raccoglito-re ad anelli…Il Portfolio delle competenze individuali è una raccolta di: – materiali prodotti dall’allievo, individualmente o in gruppo, capaci di descrivere le
più spiccate competenze del soggetto;– prove scolastiche significative, relative alla padronanza degli obiettivi specifici di ap-
prendimento, contestualizzate alle circostanze;– osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento del bambino,
con la rilevazione dei suoi tratti caratteristici originali nelle diverse esperienze forma-tive affrontate;
– commenti su lavori personali ed elaborati significativi, scelti sia dall’alunno, sia indi-cati dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esemplificativi delle sue capacità e aspirazio-ni personali;
– indicazioni che emergono dall’osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-geni-tori, da colloqui con l’alunno e anche da questionari o test in ordine alle attitudinipersonali e agli interessi più marcati.
Concludendo, il Portfolio è un metodo di valutazione coerente con la centralità dellapersona, consente di responsabilizzare i protagonisti del processo educativo-didattico,favorendo anche forme di autovalutazione, e offre nuove opportunità di dialogo e dicollaborazione tra la scuola e la famiglia.
Quali sono gli scopi generali del Portfolio?La riflessione critica sui materiali costituisce un’occasione per migliorare la pratica del-l’insegnamento, stimolare l’alunno all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vistadella costruzione di un personale progetto di vita e, infine, coinvolgere direttamente igenitori a partecipare ai processi educativi diventandone corresponsabili.Il Portfolio delle competenze individuali della scuola primaria, che s’innesta su quelloportato dai bambini dalla scuola dell’infanzia, accompagnandoli nel passaggio alla scuo-la secondaria di primo grado, ha precisi scopi generali:– documenta lo sviluppo e l’ampiezza con cui sono stati trattati e appresi gli argomenti
curricolari;– promuove l’interesse e la motivazione dell’alunno verso particolari aree del sapere;
– responsabilizza e rende consapevole l’alunno nel suo processo di apprendi-mento sviluppando in lui una graduale capacità di autovalutazione, prima ditipo emozionale (mi piace/non mi piace), poi sempre più dettagliata e finaliz-zata all’acquisizione delle competenze (da dove è partito, dov’è e che cosa de-ve fare subito, dove vuole arrivare);
67
– individualizza e orienta il processo di apprendimento conferendogli autonomia (per-corsi individualizzati);
– offre una base concreta per un dialogo diretto e costruttivo tra alunno, insegnante efamiglia;
– permette una valutazione dell’alunno più completa e precisa;– costituisce una reale continuità nei momenti di transizione tra scuole di diversi gradi.
Riguardo all’ultimo punto, occorre insistere sul principio di continuità educativa che“… esige che gli alunni siano ben monitorati e che i docenti, nell’anno precedente e in quellosuccessivo al passaggio, collaborino, in termini di scambio di informazioni, di progettazione e diverifica di attività educative e didattiche, con la famiglia, con il personale che ha seguito i bam-bini nella scuola dell’infanzia o che li accoglierà nella scuola secondaria di primo grado. È utile,comunque, che la scuola primaria segua, negli anni successivi, in collaborazione con la scuolasecondaria di primo grado, l’evoluzione del percorso scolastico degli alunni perché possa miglio-rare il proprio complessivo metodo formativo e orientativo e affinare, in base alla riflessione cri-tica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali d’intuizione e di giudizio pe-dagogico e le proprie pratiche autovalutative” (dalle Indicazioni nazionali).
Chi compila il Portfolio?Il Portfolio delle competenze individuali della scuola primaria è compilato e aggiornatodal docente coordinatore o dal tutor, in collaborazione con tutte le figure che si fannocarico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun alunno, a partire dai genitori edagli alunni stessi, chiamati a essere protagonisti consapevoli della propria crescita.
Che cosa deve essere il Portfolio?Il Portfolio delle competenze individuali deve essere la traccia, l’impronta lasciata dal-l’alunno di qualcosa fatto da lui. Il «qualcosa» potrà riguardare:– l’interesse, l’impegno e la motivazione;– l’orientamento di stile cognitivo;– la padronanza (o competenza nell’uso) di strategie e processi;– la disposizione della mente;– la capacità metacognitiva;– il livello di apprendimento;– l’autoregolazione e lo sviluppo del proprio apprendimento.
Come organizzare i diversi materiali?Il Portfolio di ogni alunno può essere organizzato in due parti:
dove si trascrivono e si registrano le informazioni e le indicazioni relativealla valutazione (in questa parte possono trovare spazio anche le registrazioni dei modipersonali di apprendimento dell’alunno, gli esiti dei colloqui con le famiglie, le propostedi attività integrative, le esperienze extrascolastiche);
e dove si raccolgono elaborati significativi, mate-riali prodotti dall’alunno, individualmente e in gruppo, per documentare il per-corso formativo effettuato.
documentazioneraccolta
valutazione
ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
68
PO
RT
FOLI
Odell’insegnante
Competenze predisciplinari inizialiGRIGLIA DI REGISTRAZIONE
ambito linguistico ambito linguistico
a) L’ASCOLTOTempi e comprensioneHa tempi buoni adeguati limitati di ascolto
Ascolta, comprende ed esegue una consegnaAscolta ma non comprende la consegnaAscolta Non ascolta l’insegnante che racconta Ascolta Non ascolta l’insegnante che legge
Sa esprimere il contenuto globale del racconto ascoltato con buona adeguata parziale correttezza
b) LA COMUNICAZIONE ORALEStrutturazione del linguaggioUtilizza frasi strutturate poco strutturate
Permangono difficoltà di pronuncia per i suoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sequenzialità e lessicoEspone in modo sequenziale in sequenza se guidatoUtilizza un lessico ricco adeguato povero
c) GLI APPRENDIMENTI STRUMENTALILegge/Scrive
parole bi-trisillabe pianeparole con sillabe complesseC e G nei suoni duri e dolcii digrammiparole apostrofateparole accentateparole con doppia consonante
d) LA LETTURALegge ed espone il contenuto globale di brevi testiLegge e risponde a domande inerenti il testo lettoLegge ma non sa esporre il contenuto globale di brevi frasi
e) I TESTIFormula e scrive frasi in modo autonomo
Formula e scrive frasi se aiutatoScrive due o più frasi in sequenzaArticola un breve testo
69
PORTFOLIO de
ll’inse
gn
ant
e
Competenze disciplinariGRIGLIA DI REGISTRAZIONE
ambito linguisticoambito linguistico
a) L’ASCOLTOTempi e comprensione Ascolta secondo i tempi richiesti
Ha tempi adeguati di ascoltoHa tempi limitati di ascoltoNon ascoltaHa Non ha saputo migliorare i tempi di ascoltoAscolta e comprende Ascolta ma non sempre comprendePone domande utili alla comprensioneHa difficoltà di comprensione
b) LA COMUNICAZIONE ORALEIl linguaggio e il lessico Utilizza frasi: strutturate e articolate
ben strutturate ma poco articolate parzialmente strutturatePronuncia ancora con difficoltà alcuni suoni
Utilizza un lessico ricco adeguato poveroUsa i nuovi termini imparatiEspone in modo sequenzialeL’esposizione deve essere supportata
c) LA LETTURALa strumentalità Legge con buona sicurezza con adeguata sicurezza
Legge rispettando le pause e con espressivitàLa lettura è sillabica faticosa
Non legge i seguenti grafemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inverte le lettere
La comprensione Legge i testi e comprende il senso globaleSa rispondere a domande sul contenutoIndividua personaggi, ambienti, elementiHa necessità di essere aiutato a capire ciò che legge
d) LA SCRITTURALa strumentalità Scrive in modo ortograficamente sicuro
Ha difficoltà con i seguenti suoni/lettere e/o digrammi . . . . . . . . . . .
Usa correttamente apostrofo accentoUsa correttamente «h» nelle voci del verbo avere
I testi Scrive frasi strutturate in modo autonomoFormula e scrive frasi se aiutatoElabora brevi testi in modo autonomoNecessita di aiuto nelle produzioni scritte
La grammatica Sa ordinare una fraseSa usare le concordanze di genere e di numeroRiconosce i primi elementi morfologici
70
PO
RT
FOLI
Odell’insegnante
Competenze predisciplinari inizialiGRIGLIA DI REGISTRAZIONE
ambito multidisciplinareambito multidisciplinare
a) STORIALa sequenzialità, gli ordinatori temporali, le parole del tempo
Sa ordinare cronologicamente tre o più sequenzeSa raccontare usando i termini temporali PRIMA, DOPO, INFINEConosce la successione delle parti del giornoConosce la successione dei giorni della settimanaConosce la successione dei mesiRiconosce situazioni di contemporaneità nell’esperienza personale
b) GEOGRAFIARiconosce le posizioni
sopra sotto davanti dietrovicino lontano dentro fuori rispetto a sé
Riconosce la propria destra e la propria sinistraUsa i binomi locativi
in situazioni concrete nelle rappresentazioniEsegue e descrive un percorso usando gli indicatori spaziali
c) SCIENZE E TECNOLOGIASa compiere classificazioni mettendo in azione gli organi di senso (colore, forma, suoni, sapori,odori, osservazioni tattili)Sa associare un’osservazione sensoriale al rispettivo organo di senso utilizzatoSa classificare oggetti secondo le caratteristiche del materiale di costruzioneSa classificare oggetti secondo le caratteristiche della funzioneSa classificare piante secondo le caratteristiche più evidentiSa classificare animali secondo le caratteristiche più evidenti
71
PORTFOLIO de
ll’inse
gn
ant
e
Competenze disciplinariGRIGLIA DI REGISTRAZIONE
ambito multidisciplinareambito multidisciplinare
a) STORIALa sequenzialità, gli ordinatori temporali e le parole del tempo
Sa ordinare cronologicamente sequenze di immaginiSa ordinare cronologicamente le sequenze di un vissuto o di una storia Sa raccontare usando termini temporaliRiconosce la contemporaneità in situazioni concreteRiconosce la ciclicità delle stagioni e la periodicità delle ricorrenzeRileva le trasformazioni del tempo sulle cose e sugli esseri viventi
La misura del tempoLegge il calendarioLegge l’orologio
b) GEOGRAFIAGli indicatori spaziali e i percorsi
Si muove nello spazio riconoscendo luoghi e posizioniUsa correttamente i termini spazialiRiconosce la propria destra e la propria sinistraIndividua posizioni rispetto a séIndividua posizioni rispetto ad altri punti di riferimentoCompie percorsi seguendo le indicazioni forniteSa fornire indicazioni per compiere percorsi
Usa i binomi locativi in situazioni concrete nelle rappresentazioniAvvio alla cartografia
Traccia percorsi sul foglio seguendo le indicazioni forniteRipercorre mentalmente e traccia percorsi a mano liberaOpera riduzioni e ingrandimenti a mano liberaLegge e interpreta una legenda
c) SCIENZE E TECNOLOGIAL’osservazione e la sperimentazione
Pone attenzioneCoglie caratteristicheOpera confrontiCollabora nella conduzione di un’esperienza Rappresenta e descrive le fasi di un’esperienza
I contenuti e il linguaggioConosce il funzionamento di semplici strumenti presenti nell’ambiente scolastico e domesticoSa compiere osservazioni nell’ambiente, organizzando le informazioni raccolte secondo indicazioni date Distingue viventi e non viventiClassifica gli animali in base alle caratteristiche e ai comportamentiClassifica le piante in base alle caratteristiche e ai comportamentiInizia a utilizzare termini propri dell’ambito scientifico e tecnologicoSa indicare comportamenti rispettosi dell’ambiente
72 Modello di scheda per la conoscenza di sé
PO
RT
FOLI
Odegli alunni ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
COME MI VEDO
– Scrivo il mio nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Scrivo il mio cognome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– La classe che frequento è: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disegno il mio ritratto.
– Scelgo e segno con X le paroleadatte a me:
tranquillo/a. agitato/a.allegro/a. silenzioso/a.goloso/a. ordinato/a.disordinato/a. obbediente.disobbediente. timido/a.chiacchierone/a.
– Scelgo e segno che cosa mipiace di più:
leggere. giocare all’aria aperta.giocare con giochi da tavolo. giocare da solo/a.giocare con gli amici. fare sport.prendermi cura di qualche animale. disegnare.guardare i programmi alla TV. andare a scuola.fare viaggi. ascoltare musica.
Confronto le mie risposte con quelle della classe prima:Ho usato parole diverse adatte a me? Quali? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi piace qualcosa di diverso rispetto alle scelte che avevo fatto lo scorsoanno? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
✎
73
IO E LA SCUOLA
PORTFOLIO de
gli
alun
niSCELGO E SEGNO CON UNA X LE MIE RISPOSTE
– La scuola che frequento mi piace perché:è moderna. è vicina a casa mia.è luminosa. è allegra.ha molti spazi per giocare.
– La scuola che frequento non mi piace molto perché:è vecchia. è un po’ lontana da casa mia.è poco luminosa. ha pochi spazi per giocare.
– In classe sto volentieri perché:sono con compagni che conosco.gli insegnanti sono simpatici. le lezioni sono spesso divertenti.
– In classe non sto troppo volentieri perché:i compagni mi aiutano poco.gli insegnanti mi sgridano spesso. devo stare seduto/a per troppo tempo.non capisco bene che cosa spiegano gli insegnanti.l’insegnante va troppo veloce. devo stare sempre zitto/a.
– La cosa che faccio meno volentieri è:mettermi in fila. stare seduto/a.parlare solo quando è il mio turno. scrivere alla lavagna.svolgere incarichi in altre classi. fare gli esercizi scritti.
– Mi piace di più:lavorare in gruppo. lavorare da solo/a.
ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
Modello di scheda per le modalità relazionali
74
PO
RT
FOLI
Odegli alunni ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
Modello di scheda sulle abilità di orientamento
I MIEI TEMPI, I MIEI SPAZI
– Scrivo la mia data di nascita:giorno . . . . . . . . . . . . . . . . mese . . . . . . . . . . . . . . . . anno . . . . . . . . . . . . . . . .
– Scrivo la data di nascita di una persona della mia famiglia:
giorno . . . . . . . . . . . . . . . . mese . . . . . . . . . . . . . . . . anno . . . . . . . . . . . . . . . .
(la persona che ho scelto è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
– Riordino i nomi delle stagioni: scrivo i numeri nei quadratini, da 1 a 4.
– Completo i nomi dei mesi:
Gennaio, Febbraio, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Aprile, Maggio, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Luglio,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Settembre, Ottobre, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Dicembre.
– Coloro in rosso la freccia che va verso la mia destra; coloro in blu lafreccia che va verso la mia sinistra.
– Descrivo il percorso che faccio da casa a scuola:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIMAVERA ESTATE
INVERNO AUTUNNO
IO SONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E QUESTA È LA MIA PAGELLA PER IL MESE DI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MI È PIACIUTO TANTO…DISEGNO E SCRIVO
✎
Se è vero che gli alunni delle prime classi non possiedono ancora un’adeguata capacitàdi riflessione sui propri percorsi di apprendimento, è altrettanto vero che essi sanno co-munque esprimere il proprio interesse e gradimento per le attività svolte.Si tratta spesso di giudizi espressi spontaneamente nel corso di un lavoro e perciò diffi-cilmente registrabili dall’insegnante.Può essere utile e interessante allora proporre a cadenze prefissate (mensilmente, adesempio) un momento comune alla classe nel quale, sfogliando i quaderni e rivedendo imateriali prodotti, i bambini abbiano la possibilità di ripensare al percorso svolto e diesprimere i loro giudizi.Si potrà proporre una semplice scheda, sull’esempio della seguente, nella quale essi po-tranno manifestare i loro interessi e il loro gradimento.La lettura di queste semplici «pagelline» sarà un’occasione per l’insegnante per acquisi-re input interessanti per l’organizzazione delle lezioni e delle attività successive.
75
PORTFOLIO de
gli
alun
ni
ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
Modello di scheda per l’autovalutazione
L’interesse e il gradimento
✂
76
PO
RT
FOLI
Odegli alunni ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
Modello di scheda per l’autovalutazione
Successi e difficoltà
La raccolta delle opinioni degli alunni, anche se piccoli, a proposito delle difficoltà in-contrate durante il percorso di apprendimento, può essere molto utile.Oltre a costituire un momento di espressione dei bambini, nel quale essi possono mani-festare entusiasmi, gratificazione ma anche disagio e difficoltà, si tratta anche di un im-portante termometro per il docente attraverso il quale misurare, almeno in parte, la va-lidità delle strategie didattiche adottate.Il confronto, poi, tra il giudizio espresso dall’alunno sulle proprie difficoltà nell’affronta-re una prova e il risultato raggiunto, permette di evidenziare la sua reale consapevolezzacirca la bontà del compito svolto.Pur non enfatizzando il significato di questo momento di riflessione, l’introduzione ditale forma di autovalutazione può rivelarsi comunque una buona pratica, utile alla for-mazione degli alunni e qualificante per il lavoro del docente.
A conclusione di alcune prove di verifica o di alcune attività particolarmente significa-tive l’insegnante potrà, perciò, proporre un mini questionario sull’esempio di quello chesegue.
DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROVA DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATTIVITÀ PROPOSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
io penso che…SCRIVO IL NUMERO O IL TITOLO DELL’ESERCIZIOPIÙ FACILE PER ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCRIVO IL NUMERO O IL TITOLO DELL’ESERCIZIOPIÙ DIFFICILE PER ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
penso di…
AVER FATTO TUTTO BENE AVER FATTO COSÌ COSÌ
NON AVER FATTO BENE
✂
77
PORTFOLIO de
gli
alun
ni
ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
Modello di scheda per le abitudini sociolinguistiche
Test di fine anno di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alla fine della seconda, posso dire che…
SCELGO E SEGNO CON UNA X LE MIE RISPOSTE
– Mi piace di più: ascoltare. parlare.
– Quando l’insegnante spiega, mi sembra:di capire subito tutto quello che dice.di capire quasi tutto.di capire poco.
– Quando non capisco qualcosa:chiedo all’insegnante di spiegarmelo un’altra volta.chiedo a un compagno o a una compagna di spiegarmelo.quando torno a casa, chiedo a qualcuno di spiegarmelo.lascio perdere.
– Quando devo dire qualcosa in classe:mi vergogno un po’ e parlo a bassa voce.parlo ad alta voce perché tutti sentano.parlo con un tono di voce normale.
– Mentre parlo in classe mi sembra che:mi capiscano tutti.non mi capiscano.mi capisca solo l’insegnante.mi capiscano solo i compagni.
– Quando parlo a casa, le persone della mia famiglia:correggono sempre i miei errori (nel pronunciare le parole, nel formu-lare le frasi).correggono a volte i miei errori.non correggono quasi mai i miei errori.
Elenco i miei lavori
78
PO
RT
FOLI
Odegli alunni ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
Modello di scheda per l’autovalutazione
CHI L’HA SCELTOPER IL MIO PORTFOLIO
(io, l’insegnante,persone della mia famiglia)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPO DI LAVORO(disegno, ricerca, verifica, gioco-
test, questionario, compito a casa,fotografia, collage, racconto…)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUANDOL’HO FATTO
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
Classe . . . . . . . . . . .
79
PORTFOLIO de
ig
en
ito
riambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
La parola ai genitori
All’inizio dell’anno scolastico, accanto alla raccolta delle notizie generali sull’alunno,per la compilazione del Portfolio gli insegnanti potranno valutare se proporre anchequestionari specifici sull’esempio del seguente.
Questionario di inizio annoAi genitori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allo scopo di conoscere meglio il vostro bambino e con l’obiettivo di strutturare per lui un percorsoformativo realmente rispondente ai suoi punti di partenza, offrendo stimoli adeguati al suo apprendi-mento, vi chiediamo di compilare questo breve questionario indicando le risposte con una X.
1. Il vostro bambino/la vostra bambina quale atteggiamento ha dimostrato neiconfronti del secondo anno di scuola primaria?
Curiosità e interesse. Interesse e un po’ d’ansia. Timore e preoccupazione.
2. Secondo voi, la scuola:ha attivato le iniziative giuste per metterlo/a a proprio agio.non ha attivato le iniziative giuste per metterlo/a a proprio agio.
3. In generale, il bambino/la bambina:racconta volentieri la sua giornata a scuola.racconta solo se invitato/a a farlo.
4. Conoscete le aspettative del bambino/della bambina nei confronti della scuola?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. In generale, come definite l’esperienza vostra e del vostro bambino/della vostrabambina nei confronti della scuola fin qui frequentata?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Quali aspetti dovrebbero essere migliorati, secondo voi, nella scuola?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringraziamo per la collaborazioneData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
✂
80
PO
RT
FOLI
Odei genitori
Le rilevazioni periodiche - I laboratori
ambito linguistico e multidisciplinareambito linguistico e multidisciplinare
Una volta intrapreso il percorso di apprendimento e allo scopo di individuare tutte le stra-tegie utili per aggiornare il Piano di Studio Personalizzato degli alunni, può essere impor-tante «fare il punto della situazione» insieme ai genitori, almeno quadrimestralmente.
Questionario periodicoAi genitori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Con riferimento al percorso formativo svolto finora, allo scopo di proseguire con un itinerario di lavo-ro rispondente ai reali bisogni di vostro/a figlio/a vi chiediamo di compilare quanto segue.
A casa, parlando con vostro/a figlio/a delle attività scolastiche, avete riscontrato che dimostra:gradimento. entusiasmo. indifferenza.disagio. disinteresse. rifiuto.
Svolge i compiti affidati con: piacere interesse.cura. disinteresse. disimpegno. fatica.
Nell’esecuzione dei compiti:è autonomo e sicuro. è insicuro. ha difficoltà e deve essere aiutato.
Ritenete che:fino a questo momento abbia imparato bene.abbia bisogno di imparare meglio a (elencare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non abbia ancora imparato a (elencare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quest’anno il/la vostro/a bambino/a ha frequentato il LABORATORIO di . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La scelta è stata fatta tenendo conto:delle attitudini del bambino/della bambina.delle vostre personali convinzioni circa l’opportunità della frequenza.
Il bambino/la bambina come ha reagito all’esperienza fatta?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorreste, se possibile: che il vostro bambino/a ripetesse un’esperienza analoga.che il vostro bambino/a non ripeta più un’esperienza analoga.
Altre osservazioni ed eventuali proposte:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringraziamo per la collaborazioneData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
✂




















































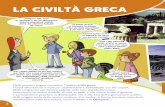





![Etty Hillesum Brani scelti - istitutodegasperibologna.it · Etty Hillesum Brani scelti (*) [Venerdi] 4 luglio [1941] Sono agitata, di una bizzarra, diabolica irrequietezza che potrebbe](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5e5450582d1c9e01d966b276/etty-hillesum-brani-scelti-isti-etty-hillesum-brani-scelti-venerdi-4-luglio.jpg)