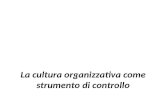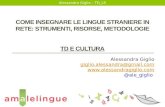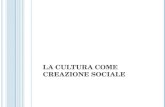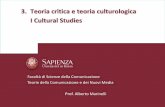La Cultura Come Produzione
Transcript of La Cultura Come Produzione

— 471 —
STUDI CULTURALI - ANNO IV, N. 3, DICEMBRE 2007
La cultura come produzioneIntervista a Richard A. Peterson
di Marco Santoro
interLoqui
Introduzione. La produzione della sociologia culturale
1. L’intervista che segue trae origine da una serie di domande indipendenti che ho rivolto tra la fine del 2005 e i primi mesi del 2006 a Richard «Pete» Peterson per un libro sulla «produzione culturale» a cui sto da tempo lavorando. Mi in-teressava raccogliere informazioni di prima mano, da uno dei suoi protagonisti (se non il protagonista), su quello che considero, insieme a molti altri, uno dei principali e più produttivi filoni di studi culturali sviluppatisi in ambito socio-logico. Dopo qualche scambio di email, ho però capito che stavo raccogliendo con le mie domande – puntuali ma non per questo prive di valore e interesse generale – materiale interessante che avrebbe forse dovuto, e di certo potuto, trasformarsi in un testo più ampio ed organico, con tutte le caratteristiche di una vera e propria intervista benché non fosse originariamente stato concepito e prodotto come tale. Peterson acconsentì a intervenire su una bozza che avevo messo insieme da quei primi materiali, e iniziammo così a lavorare a quattro mani in modo da produrre un racconto non solo più coerente ma anche più ricco emotivamente e storicamente circostanziato.
Il risultato, mi pare, è una ricostruzione piuttosto ampia e articolata della carriera intellettuale del sociologo americano: una carriera, come vedremo, che per quanto dispiegatasi senza troppi clamori negli spazi assolati della Vanderbilt University di Nashville, Tennessee – la capitale della musica country americana immortalata da Robert Altman nell’omonimo film – ha prodotto nell’arco di un trentennio alcuni dei più influenti studi nel campo della sociologia della cultura
Ringrazio per l’aiuto, i suggerimenti e il sostegno Howard S. Becker, Paul DiMaggio, Timothy Dowd, Gary Alan Fine, David Inglis, Jennifer Lena, Roberta Sassatelli, Paul Willis – e naturalmente Richard «Pete» Peterson. La versione originale di questa intervista, con una più ampia introduzione, è in corso di pubblicazione in «Cultural Sociology», 1/2008. Grazie alla rivista e alla casa editrice Sage per la cortese autorizzazione a pubblicarne una edizione italiana, e a Paolo Magaudda e Marco Solaroli per avermi aiutato a realizzarla in tempi utili.

MARCO sANTORO
— 472 —
o sociologia culturale1, una specializzazione della disciplina alla cui formazione e legittimazione, tra gli anni settanta e ottanta del secolo appena finito, hanno direttamente contribuito. Ma anche una carriera, aggiungo subito, che ha con-tribuito essa stessa indirettamente al riconoscimento della possibilità concreta di uno studio specificamente sociologico della cultura, da molti preconizzato ma, ancora negli anni sessanta e settanta, poco e male coltivato.
sono almeno due i grandi temi a cui il nome di Richard Peterson è oggi associato2: l’idea della «produzione di cultura» (production of culture) – probabil-mente ancora il suo più importante contributo alla sociologia contemporanea – e l’ipotesi dell’onnivorismo culturale, attualmente al centro della ricerca empirica sui modelli del consumo culturale e i suoi rapporti con la stratificazione sociale (si veda Warde et al. 2007; Chan e Goldthorpe, 2007; si veda anche Peterson, 2005b). Entrambi questi temi, e il primo soprattutto, vengono ampiamente discussi nell’intervista che segue, insieme a questioni più specifiche e speciali-stiche, per lo più connesse al suo lavoro – altrettanto seminale ed influente, in ogni caso – nel campo della sociologia della musica.
Come spero apparirà chiaro al lettore, questa intervista aggiunge un nuovo, importante tassello al lavoro di recupero, approfondimento e divulgazione al pubblico italiano che «studi Culturali« sta svolgendo da tempo sulle ragioni, i risultati e le promesse della sociologia culturale americana, di cui sono traccia gli articoli già pubblicati di Howard Becker, Jeffrey Alexander, Gary Alan Fine, Ron Eyerman, Jennifer Lena e naturalmente lo speciale dedicato alla teoria culturale di Talcott Parsons. Né dovrebbe scordarsi in questo elenco il nome di Bourdieu, che per quanto francese ha però trovato soprattutto nel campo sociologico angloamericano – anche tramite la mediazione di Peterson, come vedremo – un terreno propizio e strategico alla diffusione globale del proprio pensiero e lavoro di ricerca.
Come si vedrà, molti di questi autori vengono richiamati da Peterson – autonomamente o perché stimolato dal suo intervistatore – mostrando effica-cemente, mi pare, come i loro pur differenti percorsi intellettuali (e molti altri, inclusi alcuni da cui è emersa, nella Gran Bretagna degli anni sessanta e settanta, la stessa idea e soprattutto la pratica degli «studi culturali») si siano intrecciati tra loro per formare quello che può ben considerarsi come un unico grande
1 In queste pagine userò le due espressioni come equivalenti, a meno che non sia specificato diversamente. In questo caso, l’espressione «sociologia culturale» varrà ad indicare quel tipo di approc-cio sociologico allo studio della cultura oggi associato a Jeffrey Alexander e alla sua scuola (Alexander, 2003; 2004).
2 L’opera di Peterson è stata oggetto di un numero speciale della rivista «Poetics», uscito nel 2000, con contributi, tra gli altri, di Paul Hirsch, Paul DiMaggio, Vera Zolberg e John R. Hall. Questa resta la migliore introduzione al suo lavoro. si veda Ryan (2000) per una presentazione.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 473 —
«episodio» della storia intellettuale di fine secolo3. Quello che l’intervista fa, in fondo, è proprio questo: rintracciare a distanza di tempo il senso di un lavoro collettivo, disegnando l’immagine di una storia multivocale di cui ancora siamo parte.
2. L’idea della «produzione di cultura» (d’ora in avanti PdC) è stata originaria-mente proposta da Peterson al congresso del 1974 dell’American sociological Association, e ulteriormente illustrata e perfezionata l’anno successivo nel corso di una conferenza alla Vanderbilt University di Nashville, dove Peterson era da qualche tempo professore (e dove è tuttora Emeritus). A partire dai materiali di questa conferenza – sponsorizzata dalla National science Foundation e a cui perteciparono studiosi di una certa fama come il francofortese Leo Lowenthal e il chicagoano Howard s. Becker – fu realizzato un numero speciale dell’influente rivista «American Behavioral scientist». successivamente pubblicata anche come libro (Peterson, 1976), questa raccolta di saggi sarebbe diventata un «lavoro fondativo per la nuova sociologia della cultura emersa nel corso degli anni settanta» (Di Maggio, 2000, p. 108), nonché un manifesto del nuovo movimento accademico che Peterson prese allora a costruire, senza mai imporre la propria leadership, ma senza nemmeno tralasciare alcuna opportunità di svilupparne la portata e di radicarlo nel sistema accademico statunitense.
È piuttosto interessante notare che le origini di questo approccio allo studio della cultura risalgono ad alcuni articoli sulla musica – jazz e popular music – che Peterson aveva scritto nel decennio precedente (si vedano Peterson, 1967; 1972; Peterson e Berger, 1971; 1972). Formato come sociologo industriale da Alvin Gouldner – l’autore di Patterns of Industrial Bureaucracy e di Wil-dcat Strike, ancor prima che dell’influente e polemico La crisi della sociologia (Gouldner, 1954a; 1954b; 1970) – Peterson cercò e infine trovò una chiave per lo studio sociologico della musica nell’applicazione della teoria organizzativa a materiali estetici, confrontandosi non solamente con la questione della loro legittimazione, ma anche con interrogativi su contenuti, forme e soprattutto varietà (si veda Dowd, 2007). sebbene puramente personale e contingente, la scelta della musica come campo sostantivo fu decisamente felice, sia perché questa sfera era già una delle principali forze culturali capaci di influenzare tanto la gente comune quanto le elite (comprese quelle accademiche) e tale quindi da attirare l’attenzione, sia perchè la musica costituisce indubbiamente – con le sue proprietà fenomenologiche, la sua ricca storia e il suo impatto nella vita quotidiana – un campo particolarmente congeniale e strategico per studiare e
3 Per una più ampia discussione di questo punto rimando a santoro (2008), soprattutto ai primi due capitoli.

MARCO sANTORO
— 474 —
rendere quindi più comprensibile il funzionamento della cultura e dell’industria culturale nel suo complesso (Hennion, 1993; DeNora, 2000)4.
Per come originariamente concepita, la PdC può descriversi come un ap-proccio o una prospettiva (non una teoria formale) per lo studio della «cultura», che concepisce quest’ultima come un insieme (generalmente incoerente) di ele-menti simbolici il cui contenuto e la cui forma rappresentano, in via ipotetica, una funzione del contesto sociale (o milieux) della propria creazione, fabbricazione, marketing, uso e valutazione. La cultura – intesa come insieme di beni simbolici – può dunque essere interpretata sociologicamente attraverso una dettagliata analisi proprio di quei contesti e delle loro variazioni. Questa definizione delinea le coordinate di questa prospettiva, che sono così enucleabili: a) l’attenzione verso i simboli formalmente prodotti, cioè quei simboli esplicitamente prodotti e usati in organizzazioni dedicate specificatamente a questo scopo; b) una priorità riconosciuta a fattori (strutturali, organizzativi, istituzionali, economici) esterni all’atto creativo. Insieme, queste due scelte hanno aiutato a differenziare l’ap-proccio della produzione sia dalla tradizione dell’interazionismo simbolico – che ha sviluppato negli stessi anni una specifica prospettiva sociologica sull’arte e gli oggetti culturali attraverso il lavoro di Howard s. Becker5 – che dalla teoria critica dell’industria culturale (Adorno in primis) – il cui sguardo è sempre stato concentrato più su generali forze sociali (come il capitalismo e il fascismo…) che sugli aspetti contingenti dell’organizzazione. Rispetto alla tradizione critica (che comprende sia la scuola di Francoforte che gli studi culturali britannici), la PdC si è distinta anche per una posizione più neutrale nei confronti della cultura (di massa) e dell’industria, analizzate non in quanto problemi sociali, ma innanzitutto come fatti sociali. Questa «depoliticizzazione» degli studi culturali (Hirsch e Fiss, 2000) fu doppiamente strategica: in primo luogo perché aiutò a legittimare lo studio della cultura nella sociologia mainstream dell’epoca, e poi perché contribuì a chiarire come fosse possibile studiare le questioni estetiche da un punto di vista sociologico, senza scivolare in quadri di riferimento propri di altre discipline, come l’estetica o la critica d’arte.
4 Non è un caso che tre dei più importanti approcci analitici negli studi culturali di impronta so-ciologica provengano da esperienze di studio il cui centro di gravità è costituito dal campo della musica: penso alla teoria critica di Adorno (2006), all’approccio dei mondi dell’arte di H.s. Becker (1982; 2005) e a quello, appunto, della produzione di cultura di Peterson. Ovviamente la musica ha rivestito un ruolo centrale anche nello sviluppo dei Cultural Studies britannici, come attestano gli influenti lavori di Willis (1978), Hebdige (1979) e più recentemente Gilroy (1993).
5 Questo non è il luogo adatto – se mai ve n’è uno – per discutere della relazione tra Peterson e Becker. Basti dire però che Becker è sempre stato molto attento, nei suoi scritti, a non confondere la prospettiva della produzione di cultura (l’etichetta di Peterson) con il suo approccio ai mondi dell’arte – nonostante il parere contrario di diversi interpreti (si vedano per esempio sanders, 1982; van Rees, 1985; Eyerman e McCormick, 2006). È vero, bisogna comunque ammettere, che l’approccio (o l’etichetta) dei mondi dell’arte ha avuto apparentemente più successo di quello della PdC, quanto meno se consideriamo il semplice ma significativo indicatore del numero di citazioni nelle riviste accademiche.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 475 —
Ma Peterson – come il suo maestro Gouldner – ha sempre dimostrato un grande eclettismo nella scelta delle proprie fonti di ispirazione. Tra di esse troviamo non solamente sociologi mainstream come Robert K. Merton e Paul Lazarsfeld con i loro numerosi allievi (tra cui figura naturalmente anche Gould-ner), ma anche la ricca tradizione sociologica di Chicago, nonché taluni studiosi della tradizione critica europea come T.W. Adorno (egli stesso collaboratore del lazarsfeldiano Radio Research Project alla fine degli anni trenta oltre che originario formulatore della categoria di «industria culturale»)6 e Leo Lowenthal (anch’egli professore alla Columbia prima di passare a Berkeley)7. Fuori dagli stati Uniti, troviamo influenze importanti passate non attraverso legami accade-mici ma attraverso la lettura di libri e articoli. È il caso della tradizione britan-nica di Cultural Studies, da Raymond Williams (una delle principali ispirazioni di Peterson per «rivitalizzare il concetto di cultura»: si veda Peterson, 1979) a Dick Hebdige e Paul Willis, i cui lavori sulle sottoculture hanno contribuito significativamente alla ricerca di Peterson sulla musica e il consumo culturale. Ma è anche il caso di Pierre Bourdieu, che aveva abbracciato la «metafora della produzione» sin dai primi anni settanta in uno dei suoi pionieristici studi di so-ciologia dell’arte e della cultura (Bourdieu, 1971), successivamente sviluppato in un articolo del 1977 tradotto anche in inglese dalla rivista «Media, Culture & society» (Bourdieu, 1980).
In effetti, è proprio da Bourdieu – le cui ricerche antropologiche sull’Al-geria8, a quanto pare, erano note a Peterson ben prima che venisse introdotto nella sociologia americana negli anni ottanta il suo lavoro nel campo dell’edu-cazione e l’arte (si veda sallaz e Zavisca, 2007) – che il sociologo di Nashville ha ricavato sia quello che lui stesso ha chiamato un concetto genetico di cultura intesa come matrice della struttura sociale (Peterson, 1976), sia – a quanto ci dice nell’intervista – la convinzione che fosse possibile fondere differenti percorsi della ricerca sociologica sui processi culturali (come l’educazione, la religione, la scienza, l’arte, etc.) nel quadro di un sistema unificato di pensiero e di un unico programma di ricerca9.
6 Rimando ad Adorno (2004) per qualche ragguaglio ulteriore sul punto.7 Lowenthal non è stato solo un importante collegamento tra Peterson e la tradizione di Fran-
coforte, ma anche una figura di rilievo nella nascita della sociologia della cultura Americana, grazie ad Ann swidler, che ha messo in relazione questo studioso critico che faceva base a Berkeley con il gruppo di dottorandi di Harvard – tra i quali DiMaggio e Grinswold – che stavano costruendo questo nuovo campo di studi con l’aiuto della stessa swidler e sotto la guida di studiosi come Harrison White – già allora ritenuto sociologo dotato di un «notevole capitale scientifico» (Convert e Heilbron, 2007, pp. 34-35) – e appunto Peterson.
8 Rimando per una presentazione generale di queste ricerche, con importanti riferimenti di metodo, a Bourdieu (2005), e all’introduzione a quel testo a cura di chi scrive.
9 Come ha notato Paul DiMaggio (basandosi anche sulla propria esperienza di professore negli anni ottanta a Yale, come è noto uno dei luoghi centrali della recente storia delle discipline umanistiche americane, e in particolare della critica letteraria), Peterson è stato un mediatore influente per quanto indiretto, dell’opera di Bourdieu nel mondo culturale americano, sia attraverso l’appropriazione e la

MARCO sANTORO
— 476 —
È difficile sovrastimare l’impatto della proposta dell’approccio della pro-duzione sull’evoluzione della sociologia della cultura come campo di ricerca. Come ha scritto una volta Paul Di Maggio (2000, p. 133), «oggi siamo tutti teorici della produzione di cultura». In particolare, nonostante la crescente varietà di prospettive sociologiche sulle questioni culturali, la sua centralità nel campo della sociologia della cultura è stata più volte sottolineata e riconosciuta, non solo da chi la praticava ma, paradossalmente, anche da chi l’ha pesantemente criticata in quanto sociologia empiricista (si vedano Denzin, 1991; Zaret, 1992; smith, 1998; Alexander e smith, 2001; Edles, 2002; Eyerman e McCormick, 2006). Lentamente, negli anni novanta, la prospettiva della PdC si è diffusa anche in Europa, e Peterson è stato indubbiamente strumentale per questo passaggio. Nel 1989 egli scrisse un lungo review essay sulla nuova sociologia dell’arte e della cultura americana per una rivista francese di primo piano come l’«Anné sociologique» (Peterson, 1989). Anche se non vi è oggigiorno in Francia una tradizione riconoscibile della produzione-di-cultura, è tuttavia chiaro come i suoi semi siano stati ben disseminati, grazie al tenue ma importante legame con l’approccio bourdesiano e alle assonanze con l’approccio dei modi dell’arte che ha influenzato profondamente la sociologia dell’arte francese (si veda Becker e Pessin 2006)10. In Italia, i primi tentativi di utilizzare la letteratura della PdC risalgono agli inizi degli anni novanta (santoro, 1995)11.
È però spontaneo la rivista interdisciplinare «Poetics», con base in Olanda ma di lingua inglese, ad avere probabilmente fornito il ponte di collegamento più solido negli ultimi quindici anni tra il movimento della PdC e i sociologi europei della cultura, almeno quelli coinvolti nello studio della produzione artistica e mediale. In Gran Bretagna, questo impatto è stato paradossalmente ritardato dalla forte tradizione britannica degli studi culturali e di sociologia (neo)marxista, che ha trovato un modo di studiare la cultura anche come una questione di produzione muovendo dalla tradizione critica o dalla political eco-nomy (see Barrett et al., 1979; Williams, 1981; Wolff, 1981; Negus, 1999; Jones, 2003). Ma alcuni semi erano già stati sparsi in precedenza, attraverso riviste come «Media, Culture and society» (DiMaggio, 1982; schudson, 1989), e si sono facilmente diffusi grazie alla presenza ben radicata di una sociologia della po-pular music (Frith e Goodwin, 1990; Negus, 1992; Bennett e Peterson, 2004) e
riformulazione che egli stesso fece delle idee di Bourdieu, sia in quanto maestro di sociologi che hanno lavorato per la ricezione di Bourdieu negli UsA (come lo stesso DiMaggio: si veda DiMaggio, 1979).
10 Ma questa relazione passa anche attraverso l’influente scuola francese di sociologia della musica, e le sue iniziali ricerche sull’industria discografica: si veda Hennion (1981; 1993).
11 Tuttavia la sociologia della cultura in quanto campo è nel nostro paese ancora egemonizzata dalla teoria sociale europea (Habermas, Baudrillard, Bauman), dalla fenomenologia (schutz, Berger) e dagli studi culturali britannici (e quindi gramsciani). Né Peterson né Bourdieu, e neppure Becker, rappresentano oggigiorno delle influenze di particolare rilievo, anche se la situazione sta lentamente modificandosi.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 477 —
dell’arte (Wolff, 1981; Inglis e Hughson, 2005). Anche il crescente interesse nei confronti del funzionamento delle industrie culturali ha, più di recente, rafforzato l’appropriazione della PdC nel contesto della sociologia della cultura britannica (si veda Lury, 1993; Lash e Urry, 1994; Hesmondhalgh, 2002).
3. Esiste peraltro una seconda linea di pensiero e di ricerca alla quale Peterson ha legato il proprio nome e la propria reputazione. Poiché essa riguarda il consumo e non la produzione, essa potrebbe sembrare e interpretarsi come un filone autonomo ed indipendente dal precedente lavoro. Ma è lo stesso Peterson a suggerirci una chiave di lettura alternativa, presentando le sue ricerche sul consumo culturale come una sorta di espansione della ricerca sulla produzione, un’espansione verso i territori costituiti da quello che egli stesso ha definito recentemente come «autoproduzione» (Peterson, 2000; Peterson e Anand, 2004). si è così messo in luce – secondo una prospettiva che riecheggia motivi cari ai Cultural Studies britannici (vedi Willis, 1978, 2000; Hebdige, 1979) – che ogni atto di consumo è al contempo anche un atto di creazione di significato e, dunque, di produzione simbolica, e culturale (si veda anche sassatelli, 2007).
Come già suggerito, Peterson ha spesso incluso retrospettivamente la scuola di Birmingham tra le sue fonti principali di ispirazione proprio per questa pista di ricerca (si vedano Peterson, 1994; Peterson e Anand, 2004, e l’intervista che segue). È però opportuna una precisazione. Mentre è assodato che Williams costituì un’importante risorsa per la riconcettualizzazione operata da Peterson della nozione sociologica di cultura, il lavoro sulle sottoculture giovanili sem-bra aver offerto suggestioni e intuizioni piuttosto che veri e propri strumenti concettuali e tanto meno metodologici per fare ricerca empirica sulla musica. Volendo assumere uno sguardo genealogico, è l’antropologia la più sicura e solida fonte di questo secondo filone di ricerche petersoniane (e non a caso, però, l’antropologia – soprattutto quella britannica – è una fonte cruciale anche per Hebdige e Willis). Da Ruth Benedict (e dunque dalla tradizione boasiana), egli recuperò l’idea dei «modelli culturali» (Peterson, 1983) per dare origine prima al concetto di «modelli di scelta culturale» quindi – attraverso l’analisi di ricchi materiali empirici provenienti da National Endowment for the Art americana, per la quale lavorava come consulente negli anni ottanta – ad una significativa critica del modello dell’omologia culturale teorizzato da Bourdieu nell’ormai classico La distinzione (Bourdieu, 1979).
Da qui la nuova ipotesi circa la relazione tra gusti culturali e stratificazione sociale: non più una corrispondenza lineare tra gerarchia sociale e gerarchia culturale (tanto più alto lo status o la classe sociale, tanto più alto, in termini di legittimità, il prodotto culturale apprezzato e consumato), ma una divaricazione tra un modello che accetta e coltiva una pluralità di beni culturali (alti e bassi)

MARCO sANTORO
— 478 —
– che Peterson chiama, con una evidente metafora zoologica, onnivoro – ed uno invece più focalizzato su pochi items, se non proprio monotematico (sia esso basso, o alto) – e denominato, in modo simmetrico al precedente, univoro. È verso il primo modello che tenderebbero gli strati sociali a più alto capitale economico, sociale e soprattutto culturale, mentre i membri degli strati sociali a minore dotazione di capitale continuerebbero ad apprezzare un unico tipo di cultura (normalmente quella popular, ma talvolta, ed è un ulteriore elemento di novità, anche quella «alta»): in sintesi, la transizione in corso può catturarsi, secondo Peterson, con l’efficace formula «dallo snob all’onnivoro» (Peterson, 1992; Peterson e simkus, 1992; Peterson e Kern, 1996)12.
Questa ipotesi è stato testata così tante volte dalla sua prima formulazione – con dati provenienti non solo dagli stati Uniti, ma anche dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dalla Russia, dall’Olanda, e dalla Cina tra gli altri – che può ormai considerarsi una pietra miliare per il filone oggi in grande espansione della ricerca sociale sui consumi culturali – un campo che solo qualche anno addietro era abbandonato alla speculazione puramente filosofica o all’astrattezza empiricista delle descrizioni statistiche. Naturalmente, c’era Bourdieu, la cui Distinzione ha rappresentato un primo catalizzatore dell’attenzione nei confronti delle dimen-sioni teoriche e delle potenzialità analitiche di questo oggetto. Ma Peterson ha contribuito a rivitalizzare anche questo ambito, in primo luogo offrendo una solida ipotesi alternativa alla teoria di Bourdieu delle determinanti sociali (ov-vero di classe) del gusto, e, in secondo luogo, mostrando come ci sia ancora molto lavoro sociologico da fare sfruttando la grande quantità di dati ufficiali (e aggiornati) disponibili anche con l’aiuto di tecniche standardizzate di analisi multivariata (vedi Peterson, 2005b; Warde et al., 2007; Chan e Goldthorpe, 2007; sullivan e Katz-Gerro, 2007)13.
Come già detto, per quanto questo filone di ricerca si sia sviluppato in modo indipendente dal lavoro sulla produzione di cultura, esso mantiene tutta-via chiari e forti collegamenti concettuali con quest’ultimo, enfatizzati dalla già ricordata categoria di «autoproduzione». Possiamo dunque considerare questa linea di ricerca come un’estensione della prospettiva della PdC allo studio della produzione informale di cultura nella vita quotidiana, complementare all’inda-gine su quella che è stata a suo tempo chiamata «immagine del prodotto» (Ryan e Peterson, 1982), lo strumento originario attraverso il quale la PdC ha tentato di confrontarsi direttamente sia con il tema della creatività, sia con le preferenze
12 Vale la pena notare che in questo modo si spezza anche la corrispondenza tra la degerar-chizzazione culturale – su cui ha molto insistito la teoria postmoderna e che trova numerose conferme empiriche – e una presunta inevitabile tendenza alla individualizzazione di gusti e stili di vita, anch’essa enfatizzata dalle correnti postmoderniste di ricerca sociale: vedi sul punto Chan e Goldthorpe (2007).
13 Per una succosa critica di ordine metodologico della tesi «dallo snob all’onnivoro», su cui non possiamo però soffermarci, si veda Lahire (2004).

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 479 —
dei consumatori: vale a dire attraverso l’endogenizzazione di queste ultime nel processo produttivo (Di Maggio, 2000).
Tentativi di spiegare le trasformazioni dei processi e dei prodotti culturali attraverso i cambiamenti delle strutture sociali e «contestualmente» delle attività di produzione di senso delle audience (attive) hanno comunque accompagnato sin dalle origini il lavoro di Peterson sulla popular music – dal jazz al country e al rock – e costituiscono l’oggetto specifico di uno dei primi lavori nella storia dell’approccio della PdC (Peterson e DiMaggio, 1975; ma si veda anche Peterson, 1972; 1978; 1990; 1997)14. Tutto ciò rende assai meno fondata di quanto si creda l’usuale rappresentazione della PdC – a volte fatta propria e diffusa dai suoi stessi proponenti, Peterson incluso – quale prospettiva unicamente focalizzata sugli effetti generati dai fattori istituzionali e organizzativi sui prodotti culturali. Invece di basarsi su un semplicistico modello di causalità unidirezionale (dalla struttura sociale alla cultura), la PdC sembra piuttosto fondarsi su un approccio molto più complesso, di tipo «duale», nel quale la struttura e la cultura si defi-niscono e si influenzano (ed evolvono) reciprocamente15.
4. Come spesso accade, il successo di queste piste di ricerca è in parte dovu-to – oltre che al loro contenuto sostantivo – al dibattito che hanno acceso, e naturalmente anche alle critiche che hanno saputo stimolare. sia la PdC che la tesi sul consumo onnivoro hanno in effetti attirato, nel corso degli ultimi quin-dici anni, un discreto numero di critiche all’interno sia della sociologia che dei Cultural Studies. Vorrei quindi brevemente discutere, per completare questa mia presentazione, quelle che sembrano essere le due principali obiezioni al lavoro di Peterson: 1) una obiezione teorico-epistemologica, secondo cui la PdC resta estranea sia alla sfera del significato che all’interpretazione culturale; e 2) una obiezione politica, che rimprovera alla PdC di non assumere una posizione critica nei confronti né della cultura né dell’industria culturale.
Il fatto di trascurare il momento interpretativo, la decifrazione del significato e la decodifica dei testi a favore di una strategia di misurazione degli effetti di fattori sociali sugli oggetti culturali (Wolff, 1981, 1999; Jensen, 1984; Gottdiener, 1985; Denzin, 1990, 1991; Negus 1997; Alexander e smith, 2001; Eyerman e
14 DiMaggio (2000, p. 129) ha proposto di chiamare «quadro concettuale co-evolutivo» questa attenzione nei confronti della mutua evoluzione di audience e produzione, sottolineando la sua cen-tralità nel progetto della PdC «sin dal suo inizio», ovvero a partire dai primi lavori di Peterson sul jazz (Peterson, 1965).
15 Ciò fa si che la PdC abbia assonanze sia con l’epistemologia relazionale di Bourdieu, sia con la teoria della strutturazione di Giddens, e aiuta inoltre a spiegare il collegamento storico tra la PdC e il neoistituzionalismo in sociologia. Possiamo interpretare, in questo modo, la PdC come una declinazio-ne di quel «nuovo strutturalismo» che considera gli schemi culturali come un elemento integrante delle strutture sociali, con l’intento di superare la tradizionale opposizione tra materiale e simbolico (si veda Lounsbury e Ventresca, 2003).

MARCO sANTORO
— 480 —
McCormick, 2006)16 sembra in effetti un sicuro limite per la sociologia quando il suo oggetto sia la «cultura» – oggi comunemente concepita, almeno a partire da Geertz, come una complessa rete di simboli e significati (vedi swidler, 1986; Griswold, 1994; sewell, 1999). Ciò farebbe della PdC un esempio paradigmatico di quella sociologia della cultura intesa come programma «debole» di ricerca culturale, da superarsi con l’elaborazione di una autentica sociologia culturale intesa come, appunto, un programma forte di analisi sociologica della cultura (si veda Alexander e smith, 2001). Nella PdC, la cultura sarebbe solo una varia-bile dipendente, anche piuttosto astratta, mentre il compito di svolgere tutto il lavoro esplicativo verrebbe lasciato alla struttura sociale (cioè all’organizzazione sociale e alle sue istituzioni). Ma è proprio così? Il significato è un elemento costitutivo di ciascun simbolo, che è il vero oggetto di studio dei promotori della PdC. Dunque, nella misura in cui la PdC cerca di spiegare il come e il perché dei sistemi simbolici nel loro specifico contesto sociale, non può sottrarsi dal compito di identificare anche i significati localmente rilevanti. Come ha ben scritto DiMaggio: «l’interpretazione sembra essere un momento inevitabile nello sviluppo di un approccio istituzionale alla sociologia della cultura, non un fat-tore in concorrenza con questo» (DiMaggio, 2000, p. 131; si veda anche Mohr, 1998). In altri termini, se la misurazione del significato è parte integrante della PdC, ogni atto di misurazione presuppone però intrinsecamente uno sforzo interpretativo17.
È vero – come negarlo? – che quanti hanno lavorato in questa prospettiva hanno tradizionalmente appuntato un’attenzione maggiore al contesto piuttosto che al testo culturale; questo non è però qualcosa di intrinseco alla prospettiva, ma solo al modo in cui è stata storicamente applicata ed usata. La prospettiva della produzione non preclude lo studio dei contesti di produzione culturale nelle loro tessiture culturali e simboliche, e degli stessi prodotti culturali nelle loro forme espressive – cioè come (esempi di) «culture di produzione» (così Fine, 1992). Basti dire che lo stesso Peterson ha lavorato, nel corso della sua vita, ad una nutrita serie di progetti di ricerca di stampo interpretativo, generalmente etnografico, sulle istituzioni e organizzazioni di produzione culturale (ad es. Peterson, 1972; Peterson e White, 1979, 1981; Peterson e Ryan, 1983; Peterson, 1997; Ryan e Peterson, 2001) – un dato non particolarmente sorprendente nella biografia intellettuale di uno studioso che si è formato, come chiarisce l’inter-
16 Per un primo (e autorevole) esempio di queste critiche dal campo degli studi letterari (britan-nici) vedi Eagleton (1976, p. 48).
17 La potenziale rilevanza della misurazione e dei metodi quantitativi per la ricostruzione dei parametri delle pratiche culturali e per stabilire la loro autonomia dai testi o dalle strutture sociali è stata recentemente sottolineata anche all’interno dello stesso campo dei Cultural Studies: vedi Lewis (1997) e Kim (2004).

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 481 —
vista, in larga parte sulla letteratura antropologica e proviene dalla sociologia industriale à la Gouldner (quindi di taglio etnografico)18.
Naturalmente, si può sostenere che il tipo di analisi del significato condotta da Peterson e dai suoi colleghi, collaboratori o seguaci, è comunque molto di-verso dall’interpretazione ermeneutica e/o strutturalista celebrata da Alexander e dalla sua scuola. L’approccio interpretativo di Peterson è più vicino ai classici antropologici che alla (cosiddetta) French Theory o all’ermeneutica tedesca. In altre parole, potrebbe trattarsi di un problema non di fuoco (nella fattispecie, di significato), ma di metodo.
Indubbiamente, né il post-strutturalismo né l’ermeneutica sono entrati a far parte della cassetta degli attrezzi di Peterson – né di quelle dei suoi più stretti colleghi, colaboratori e allievi, anche se questo non significa che essi non fossero a conoscenza di tali tendenze intellettuali. Questo vuol dire, allora, che la PdC è positivista? In qualche modo, sì – e ciò fu esplicitamente riconosciuto alcuni anni fa, anche se con la precisazione che si trattava di un positivismo meramente strategico, locale e temporaneo (Griswold, 1990). La PdC non è un’impresa che si definisce post-positivista, come fa la sociologia culturale à la Alexander, o, per quanto conta, i Cultural Studies di tradizione britannica (anche se dobbiamo aggiungere che in questi ultimi, o nelle loro immediate vicinanze, si danno posizioni assai meno post-positiviste di quella di Alexander: vedi McLennan, 2006).
Ma possiamo identificare il lavoro svolto sotto l’insegna della PdC come positivista solo in termini molto approssimativi e all’interno di un dibattito epi-stemologico estremamente polarizzato (che oggigiorno solitamente si traduce in una polarizzazione tra positivismo ad un estremo e postmodernismo all’altro con numerose opzioni nel mezzo: si veda steinmetz, 2005). La PdC è identificabile come positivista per quel tanto che ambisce a misurare i fatti sociali traducen-doli in variabili. Il linguaggio delle variabili, tuttavia, non è certo il migliore per descrivere la prospettiva, che molto spesso adotta un approccio narrativo, cioè una delle più solide alternative ai metodi centrati sulle variabili (si veda Abell, 2004). si potrebbe forse considerare la PdC come ispirata dal realismo analitico piuttosto che dal positivismo stricto sensu. Ciò potrebbe contribuire a spiegare la presenza di una forte tensione analitico-concettuale nei lavori ispirati dalla PdC, e l’inclinazione dei suoi promotori a descriversi come studiosi alla ricerca dei «meccanismi» (si veda per questo concetto Hedstrom, 2005). Eppure, una
18 È da notare che Peterson ha poco per volta trasformato la ricerca sull’industria della musica country, a cui ha dedicato quasi l’intera sua vita di sociologo, in uno studio focalizzato sulla costruzione sociale e sulle molteplici interpretazioni di un concetto specifico, cioè l’«autenticità» – qualcosa che sembra lontano dai suoi interessi iniziali legati a mercati e organizzazioni, anche se fortemente dipendente da essi (vedi Hughes, 2000). Ciò ha favorito lo sviluppo di un nuovo programma di ricerca sull’«economia culturale dell’autenticità» al momento promosso da sociologi e studiosi di management (vedi Peterson, 2005a; Karpik, 2007).

MARCO sANTORO
— 482 —
qualche debole forma di costruzionismo è una postura epistemologica quasi intrinseca ad un approccio apertamente mirato a rivelare e descrivere nel det-taglio la produzione (o fabbricazione) della cultura19. Insomma, non è affatto operazione semplice quella di localizzare epistemologicamente la PdC una volta per tutte, e molto di ciò che possiamo dire al riguardo dipende più dalla nostra posizione nel campo e dai nostri obiettivi intellettuali che dalla sua costituzione che si presume interna e «fissa»20.
Passiamo a considerare brevemente la critica politica, la supposta mancan-za di spirito critico della PdC, e il suo presunto atteggiamento professionistico, ortodosso e conservatore (si veda Tuchman, 1983; Gottdiener, 1985; Denzin, 1990; 1991). È certo un fatto che Peterson non si è mai neppure avvicinato alla svolta radicale intrapresa dal suo mentore, Alvin Gouldner21. Egli è viceversa sempre rimasto fedele all’approccio (autoproclamantesi) avalutativo della scuola classica di Columbia (Merton più Lazarsfeld), da cui si distanziava solamente in quanto la sua attenzione era riposta su oggetti culturali ed estetici piuttosto che, per dire, comportamenti di voto, strutture di disuguaglianza, processi di diffusione e così via.
È vero che la «produzione», come categoria d’analisi sociale, possiede una forte aura marxista. Ma quella di «produzione» – nella prospettiva della PdC – è chiaramente più una metafora che una categoria analitica. E una metafora a cui viene richiesto di svolgere una gran quantità di lavoro: viene applicata ad una serie completa di processi diversi, dalla creazione alla fabbricazione materiale sino alla distribuzione e allo stesso consumo. Inoltre, Peterson non ha mai ra-gionato sociologicamente – a parte forse i primi studi sul jazz e sull’alienazione del musicista, peraltro successivamente sconfessati – né in termini di classe né in termini di sfruttamento. La sua visione della società sembra più funzionalista: un sistema di stratificazione basato sul ceto o su gruppi sociali, non una strut-tura di classe. I gruppi sociali, gli strati e i ceti sono i tipici concetti sociologici con cui interpreta il proprio materiale di ricerca sia sulla produzione che sul consumo (vedi Peterson, 1990; Peterson e simkus, 1992).
19 Anche Robert K. Merton ha lavorato (e scritto) come costruzionista – come esponente di quel che Abbott (2001, p. 63) chiama «costruzionismo ideologico», posizione sottostante a buona parte della sociologia della conoscenza. A ciò possiamo aggiungere che il costruzionismo in quanto tale non è incompatibile con la misurazione (presupposta come elemento positivista), dal momento che esso «non implica necessariamente che [i simboli sociali] non possano essere costruiti con significati specifici e misurabili» (ivi, p. 65). È ancora Abbott a ricordare che anche l’ermeneutica iniziò come tecnica positivista nella storiografia tedesca del diciannovesimo secolo (ad es. Leopold von Ranke).
20 sto accettando qui – chiaramente – ciò che Abbott (2001; 2004) ha qualificato come la natura frattale del dibattito epistemologico, cioè la continua riproduzione a livelli diversi delle stesse dicotomie apparentemente stabili – il cui esatto significato è viceversa totalmente contingente rispetto ai contesti individuali in cui queste vengono evocate.
21 Per una prima testimonianza delle divergenze intellettuali su questo fronte tra maestro e allievo, dal punto di vista di quest’ultimo, si veda Peterson (1971).

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 483 —
Ma ciò non significa, a ben vedere, che non esista tensione critica all’interno della PdC, né che sia impossibile iniettare stimoli più riflessivi nella sua pratica. Anzi, come rivela l’intervista, Peterson è stato molto attento alle implicazioni politiche della propria ricerca ed è molto critico verso la «ricerca amministra-tiva» di adorniana memoria. Quella che è stata identificata come una forma di «depoliticizzazione» è stata una mossa strategica più che una scelta politica o morale: più una sospensione di un orientamento esplicitamente critico verso il mondo al fine di afferrarlo dettagliatamente, che un’accettazione conservatrice dello status quo. senza contare, come Abbott (2007) ha recentemente sostenuto – contro il sociologo critico Burawoy (2005) – che una conoscenza puramente professionale (cioè strumentale), totalmente distaccata da una posizione critica (cioè morale e/o politica) risulta semplicemente impossibile poiché il mondo sociale è intrinsecamente composto di valori e giudizi di valore. Ciò apre ad una lettura meno rigida della prospettiva della PdC, in base alla quale la posta in gioco non è più la critica in quanto tale, ma una valutazione dei diversi gradi di riflessività (politica) con cui i suoi autori hanno condotto le proprie ricerche.
5. È mia convinzione che l’approccio della PdC rappresenti una importante, se non necessaria, integrazione – in una scienza sociale dei processi culturali che voglia essere davvero multidimensionale – sia ai filoni più umanistici, letterari, testualistici e postmodernisti degli studi culturali, sia ad una «sociologia culturale» radicalmente concepita in termini strutturalisti ed ermeneutici (Alexander, 2003). Ciò è ancor più vero dal momento che Richard Peterson non ha mai promosso l’approccio della produzione-di-cultura come paradigma dai confini chiusi, lasciando sempre spazio perché altre prospettive fiorissero e dialogassero con esso. Come ha efficacemente osservato Paul DiMaggio (2000), ciò che Peterson ha cercato di costruire e promuovere non era una «setta», ma un movimento intellettuale inclusivo. In verità, questo potrebbe essere considerato un effetto collaterale, non intenzionale, del carattere relativamente ateoretico dell’approccio o del suo dichiarato agnosticismo verso questioni ontologiche ed anche epistemo-logiche. Tuttavia, la strategia di ricerca a medio raggio sviluppata dall’approccio e il suo solido orientamento empirico verso la comprensione delle fondamenta «sociali» e «istituzionali» della cultura ha chiaramente costituito una risorsa nello studio degli oggetti culturali, troppo spesso percepiti come volatili, o puramente «decorativi», dai suoi stessi promotori più critici (Rojek e Turner, 2000). È questa forza originale che rende a mio giudizio la prospettiva della produzione-di-cultura una condizione imprescindibile per praticare una sociologia culturale rispettosa della sua identità e della sua missione come sociologia.
Come è immaginabile, Peterson è stato solo uno – anche se alquanto in-fluente – dei vari imprenditori accademici che negli anni settanta «inventarono»

MARCO sANTORO
— 484 —
ciò che è stato retrospettivamente definito «sociologia della cultura» – e in se-guito «sociologia culturale»22. In altre parole, il campo della sociologia culturale in formazione è stato sempre più ampio e più densamente popolato del circolo della produzione-di-cultura raccolto intorno a Peterson. Ma sembra corretto – ed equo – pensare che senza la sua opera, la sua imprenditorialità, e il suo appello verso uno studio sociologico della cultura che fosse fermamente radicato al centro della disciplina, la sociologia della cultura sarebbe probabilmente oggi ancora ai margini, o dispersa in una pluralità di sottocampi diversi e tra loro non comunicanti – dall’arte ai media alla religione alla scienza. Il suo contributo complessivo alla tradizione sociologica può essere catturato da una semplice considerazione: quando Peterson fondò la sua prospettiva sulla produzione, la sociologia della cultura non esisteva (vedi DiMaggio, 2000, p. 133).
Perché la «cultura» diventasse «il tropo dominante per l’analisi della vita sociale» (Abbott, 2001, p. 20), era strategico – se non necessario – impacchet-tarla con una metafora che potesse sfidare (o provocare) il mainstream della disciplina, ed essere allo stesso tempo da questo riconoscibile (e leggibile). Alla stregua di un gambetto euristico, cioè una mossa intellettuale strategica mirata a produrre nuove idee e ricerche, inevitabilmente sacrificandone altre, la metafora della produzione di cultura ha offerto un tale pacchetto, e il lavoro svolto sotto la sua insegna gli ha donato sostanza, l’ha cioè trasformata in un oggetto reale sotto forma di articoli e testi da discutere, valutare, premiare, e ovviamente anche criticare all’interno della comunità sociologica. Possiamo inoltre specu-lare sul fatto che la «produzione» fosse una metafora davvero molto adatta per costruire un programma di ricerca sulla cultura, dal momento che quel termine racchiude le radici etimologiche (latine) del concetto di «cultura» che rimandano a processi squisitamente «produttivi» come l’edificazione e la coltivazione (si veda Williams, 1983)23. Cosa ne sarebbe oggi della sociologia culturale – nel senso di un programma forte nello studio sociologico della cultura – se non ci fosse stata alcuna sociologia della cultura?
Inoltre, con il suo fuoco empirico sui processi e meccanismi della produ-zione materiale di sistemi simbolici e oggetti culturali, la ricerca sociologica di Peterson e di chi ne ha seguito le orme ha storicamente offerto un importate
22 È interessante notare come questo processo d’imprenditorialità accademica fu quasi parallelo a quello da cui nacque la «nuova sociologia economica»: si veda swedberg (1997) e Convert e Heilbron (2007). Altrettanto interessante, e quasi mai notato, è il fatto che i due processi si sono sovrapposti in alcuni punti cruciali – grazie a figure come Paul DiMaggio, W.W. Powell, Paul Hirsch, Viviana Zelizer, Roger Friedland e lo stesso Harrison C. White, uno degli attori chiave nel movimento della sociologia economica, ma anche una fonte d’ispirazione riconosciuta da Peterson (e DiMaggio, che era formal-mente stato, come si è detto, uno studente di dottorato di White ad Harvard) e un affermato sociologo dell’arte. sulle dimensioni culturali «nascoste» del lavoro di White su economia e struttura sociale vedi Brint (1991).
23 Come mi ha fatto notare Tim Dowd, la forza di questa metafora potrebbe spiegare anche il successo del concetto di cultura come «cassetta degli attrezzi» di swidler (1986).

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 485 —
contrappunto allo sviluppo degli stessi Cultural Studies britannici – soprattutto nel campo degli studi sui media e sulle arti – contribuendo non solo alla precisa-zione riflessiva della loro stessa identità trans-disciplinare (per lo più nei termini di una rivendicata maggior sensibilità per la questione della «rappresentazione» e per le implicazioni politiche del lavoro intellettuale: si veda ad esempio Wolff, 1999) ma anche, e soprattutto direi, alla realizzazione e allo sviluppo ulteriore di quel programma di integrazione tra studi umanistici e scienze sociali che era alla base del progetto originario dei Cultural Studies, così come immaginato (e per molti versi già praticato) da Richard Hoggart e Raymond Williams24.
* * *
Marco Santoro: Puoi raccontarmi come hai deciso di dedicarti quasi a tempo pieno, in veste di sociologo, allo studio della popular music – una scelta che, se oggi è ancora relativamente insolita, immagino fosse addirittura impensabile negli anni in cui l’hai compiuta?
Richard A. Peterson: È accaduto in effetti tanto, tanto tempo fa. In tutta onestà, non ho preso una decisione cosciente di dedicarmi allo studio della musica o della sua cultura. All’inizio stavo semplicemente cercando di capire quale tipo di sociologia non volevo praticare. si potrebbe dire che l’odissea è iniziata nella primavera del 1960, quando mi sono trovato per la prima volta sul mercato del lavoro accademico. Mi era stata offerta una posizione alla Co-lumbia University con l’aspettativa che mi sarei occupato di un progetto sulla «diffusione dell’innovazione»25. Non accettai perché quello che volevo fare era soprattutto ricerca sulle occupazioni nelle organizzazioni industriali, e la «diffu-sione dell’innovazione» riguardava gli individui piuttosto che le organizzazioni. Riposi le mie speranze sulla possibilità di un posto a stanford e a Berkeley che però non ottenni. Feci altri colloqui in diversi posti, rifiutai qualche offerta e in un caso fui respinto. Quando l’università del Winsconsin mi chiamò in aprile non ero troppo eccitato, per via della sua reputazione di luogo segnato da pesanti conflitti interni. Mi fu detto: «Nessuno ti chiederà “perché?” quando lascerai il posto», ma in quella stagione non facevo il gioco duro per riuscire a ottenere qualcosa, e accettai.
MS: Per quali insegnamenti e ricerche eri stato assunto a Winsconsin?
24 Per un esempio emblematico, vedi Negus (1992, 1999). sui legami tra la sociologia di Williams e la prospettiva della produzione di cultura vedi adesso Jones (2004), che accentua però a mio giudizio eccessivamente gli elementi di distanza.
25 Per l’esito, ormai classico, di quel progetto, vedi Coleman et al. (1966).

MARCO sANTORO
— 486 —
RAP: In quanto allievo di Alvin Gouldner, ero stato assunto in qualità di specialista delle organizzazioni e delle occupazioni industriali, nonché per inse-gnare al corso fondamentale di teoria post-laurea. Howard Becker (il vecchio)26 era il teorico del posto, e i giovani professori associati in ascesa raccolti attorno alla figura di Bill sewell (il vecchio)27, che stavano subentrando alla guida del dipartimento, avevano creato un corso di teoria con un programma che Becker si sarebbe rifiutato di insegnare, decretandolo come il corso fondamentale. Con Becker e diversi altri baroni vecchio stampo il colloquio di lavoro non fu diver-tente, ma accettai l’offerta. In effetti il colloquio non era poi così importante. La politica del Wisconsin consisteva nel contattare quattro o cinque sociologi di spicco e assumere poi i loro migliori studenti. Il colloquio serviva solamente per capire se il candidato poteva camminare a testa alta. Di conseguenza il corpo insegnante di livello inferiore era un mondo estremamente variegato, brillante e aggressivo. Tenendo all’oscuro la Junior Jury28, tenevamo incontri regolari per leggere e criticare severamente reciprocamente le nostre bozze. Una lista parziale dei membri di questo gruppo dovrebbe includere Mike Aiken, Robert Alford, Milt Bloombaum, Jay Demerath, Jerry Hague, Jerry Marwell, Tom scheff, Dave schmitt, Alan silver, Maurice Zeitlin e David Mechanic, più Nelson Polsby dalla scienza politica. Interagendo con loro ho ricevuto il mio apprendistato da sociologo.
Arrivai in Winsconsin senza un’agenda di ricerca prefissata e nemmeno con un libro a cui pensare ricavandolo dalla mia tesi, ma questa è un’altra storia. Quale «sociologo industriale» avevo bisogno di una industria da studiare. Tutte le grandi industrie americane del tempo, automobilistiche, metallurgiche e pe-trolifere, erano già impegnate! scrissi una proposta sull’organizzazione sociale dell’industria dell’educazione, ma Bill sewell (il vecchio) non ci capì nulla – voglio dire, proprio nulla! È ironico che, in un mondo che era allora lontano, Pierre Bourdieu stesse allora già sviluppando le sue idee in campo educativo.
MS: Fu allora che hai iniziato a interessarti all’industria della musica?
RAP: No. In un primo momento fui attratto dall’industria dell’autotrasporto e dalle sue associazioni sindacali. A differenza delle industrie manifatturiere
26 Il riferimento è a Howard P. Becker, sociologo di una certa notorietà nei decenni centrali del secolo ma oggi praticamente dimenticato, a lungo docente all’università del Wisconsin. Nessun legame con l’oggi assai più celebre Howard s. Becker, l’autore di Outsiders e di I mondi dell’arte, a cui si farà riferimento più avanti nell’intervista.
27 Per distinguerlo dal figlio William H. sewell jr., storico sociale e culturale, autore nei primi anni novanta di alcuni saggi seminali anche nel campo della sociologia culturale, adesso raccolti in sewell (2005).
28 È la commissione incaricata di valutare, nelle università americane, l’attività scientifica dei giovani professori.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 487 —
pesanti, dove il consolidamento di grandi corporations determinavano la for-mazione di grandi sindacati, nel trasporto su gomma fu un grande sindacato – i Teamster – a produrre il consolidamento di un’industria frammentata. Ero affascinato dal modo in cui un gruppo dei «socialisti del Minnesota» (Minnesota Socialists) aveva ristrutturato completamente il sindacato, portandolo da una situazione di forti localismi e debole convergenza centrale all’esatto opposto. Una strategia seguita da un gruppo di uomini nerboruti di Detroit guidati da Jimmie Hoffa, il quale la utilizzò per farsi strada nel sindacato generale. La benedizione del sindacato sembrava essere un buon inizio, ma le cose presero subito una brutta piega quando compresi che ci si attendeva dei favori in cam-bio dell’accesso, come, ad esempio, attestare il buon carattere di Jimmie Hoffa. E pretendevano di approvare in anticipo qualsiasi cosa scrivessi. Io non ero certo lì per registrare e rendere pubbliche le attività illegali del sindacato, ma i suoi funzionari potevano comunque impedire la pubblicazione di qualunque cosa io scrivessi. Mi sembrava che il motto del Junior Jury, «Pubblicare o perire» in questo caso diventasse «Pubblicare e perire!». I soli frutti di questo progetto furono uno studio che, prendendo in considerazione i camionisti autonomi e confrontandoli con quelli dipendenti, testava la predizione weberiana secondo cui l’imprenditorialità nasce dai valori protestanti e via dicendo. Fu eccitante mostrare che questa teoria non si adattava a questo caso.
MS: Naturalmente il ruolo dell’agency in situazioni altamente strutturate è stato un tema ricorrente del tuo lavoro sull’industria musicale…
RAP: sì, è vero. Ma, per arrivare finalmente alla mia «scoperta» della musica come industria, il fatto è che alcuni miei studenti erano preoccupati per la mia (mancanza di) direzione professionale. Così un giorno Alan Orenstein mi disse «Pete, tu vuoi studiare l’industria, ma sei molto eccitato quando parli di musica. Perché non studi allora l’industria della musica?». Avevo già pubblicato, a dire il vero, diversi pezzi sulla situazione del jazz (si veda Peterson, 1965, 1966) ma, essendo io bianco e residente a Madison nel Winsconsin nel momento in cui il movimento del Black pride era quasi all’apice, non c’era alcun modo di tenere il passo della scena di New York, né mi sentivo autorizzato, in quanto ragazzo bianco, a scrivere di quella che stava per identificata come la Black music. Inoltre, essendo un fan appassionato di jazz, ciò che conoscevo dell’in-dustria di questo genere musicale mi deprimeva e mi pareva anche che non mi indicasse nessuna altra direzione di ricerca sociologica oltre a quella già seguita da Howard Becker (il giovane) e dagli altri che interpretavano il jazz a partire dallo studio della devianza (si veda Becker, 1963).
MS: Insomma, come sei giunto allo studio della popular music?

MARCO sANTORO
— 488 —
RAP: sostanzialmente attraverso la scuola di Francoforte. Alla fine degli anni cinquanta e all’inizio degli anni sessanta la popular music si era trasfor-mata radicalmente. Il campo della musica pop, prima dominato dalle grandi swing bands e dalla conciliante vocalità crooner di Perry Como, Frank sinatra e Tony Bennett, era invaso dalle sonorità rock basate sul sanguigno Rythm & Blues di Bill Haley, Chuck Berry, Fats Domino, Elvis Presley e simili. I detrattori accusavano questa nuova musica di stimolare la delinquenza giovanile e gli eccessi sessuali, e due sociologi di primo piano, Robert Merton e Paul Lazar-sfeld, avevano ripreso le idee di Theodor Adorno, ipotizzando che le giovani generazioni fossero narcotizzate dalla ripetitività dei suoni delle canzoni rock trasmesse via radio e finissero inevitabilmente con il preferire questa musica «inferiore» rispetto a quella di maggior livello delle swing bands. Biasimava-no questo «lavaggio del cervello» condotto su alcuni elementi dell’industria discografica. Un tale scenario si accordava con i miei pregiudizi da jazzista e così decisi di studiare l’industria della musica per capire come funzionava questo processo. Basandomi su osservazioni e interviste, mi fu subito chiaro che i giovani sceglievano entusiasticamente il rock a dispetto degli intensi sforzi delle grandi etichette di registrazione nella promozione dei crooners. Tanto bastava per chiudere con Adorno, Lazarsfeld e Merton. Ma questa scor-reria nel mondo della musica pop mi spalancò una serie di questioni che da allora hanno alimentato gran parte della mia ricerca. Inizialmente diedero a me e a Dave Berger l’opportunità di studiare l’imprenditorialità nelle grandi organizzazioni burocratiche e mi fornirono un caso paradigmatico per quello che divenne poi la prospettiva della «produzione della cultura» (PdC) (si veda Peterson e Berger, 1971, 1975)
MS: Capisco da quel che dici che il tuo interesse per la musica, e per il jazz in particolare, preceda comunque il tuo incarico nel Wisconsin…
RAP: Oh, sì. Guardando al mio passato è chiaro che la musica è sempre stata centrale in ciò che sono, anche se allora presumevo che non mi riguar-dasse personalmente. Ad otto anni rimanevo alzato fino a tardi con mia sorella, una ragazzina fanatica di divi, ascoltando «La tua hit parade» alla radio. Nei miei difficili anni delle medie la musica mi coinvolgeva, tanto da indurmi a cantare anche come solista nei cori della scuola. Nella mia compagnia, però, la musica non era presa seriamente in considerazione. Per noi mocciosi il Messia di Han-del era memorabile per il verso che cantavamo così: «We like sheep and have gone astray.» sin dalle superiori la mia musica preferita è stata il jazz tradizio-nale (che in quel periodo stava vivendo un grande revival a New York) e poi il be-bop, il jazz moderno del tempo. In particolare ricordo Dizzy [Gillespie], Monk e Mingus. Vivendo a New York, le ultime innovazioni del be-bop che i

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 489 —
bianchi potevano ascoltare erano a una fermata di metropolitana di distanza dalla cinquantaduesima strada.
Gli inattesi volteggi e torsioni della musica erano pura felicità, ma per un dislessico (non riconosciuto) quale io ero la scuola era una tortura e non avevo alcun amico. Di conseguenza era facile identificarsi con l’attitudine Black di persecuzione, alienazione e orgoglio. Abbigliato con un abito a doppiopetto zoot29, lunghe catene, un coltello a serramanico, il gergo e il giusto «atteggia-mento» (mi fa ridere il solo pensare a una tale tenuta!), mi credevo hip e cool, in perfetto stile da appassionato di jazz, un ragazzino del jazz noncurante delle aspettative dei genitori e della scuola. Nell’autunno del 1948, andai in un college rurale quacchero dove mi capitò di vivere quello che ancora oggi considero il mio primo giorno di vita. Là mi unii ad una band ribelle di jazz-dance tradizionale come contrabbassista. Cantai in tre operette di Gilbert e sullivan. Il pezzo di musica classica che preferivo era il secondo concerto per piano di Rachmaninoff.
Il college di Oberlin, vicino a Cleveland, in Ohio, dove mi laureai, ospi-tava anche un conservatorio di musica e vi erano molti complessi di musica classica che suonavano. Attraverso il mio compagno di stanza, un trombettista, fui introdotto alle meraviglie dei concerti sinfonici. La Cleveland symphony Orchestra diretta dal grande George szell si esibiva regolarmente nel campus e noi sedevamo nel coro, dietro l’orchestra, osservando szell e ascoltando le parti di tutte le sezioni. Mi dedicai all’operetta per diversi anni, anche in una compagnia estiva di Oberlin a Cape Cod, nel Massachusetts. suonare il basso mi fece accedere alla Musicians Union dei complessi da ballo e alle after-hour jazz sessions, anche se poi una occhiata tagliente di un batterista mi fece capire una notte che era giunta l’ora di smettere.
Facevo parte del gruppo che organizzò l’esibizione di Pete seeger nel campus. Il colpaccio, però, avvenne quando portammo Dave Brubeck e il suo gruppo ad esibirsi in un concerto elettrificato che è stato registrato e conservato su disco, «Jazz at Oberlin» (È su CD ora e dovresti davvero dagli un ascolto). In qualche modo presi l’iniziativa di portare nel campus un gruppo vocale pop, un quartetto, i Four Aces, che erano in tour con il loro successo del momento, Three Coins in the Fountain. Per la prima volta, a Cleveland, vidi un disk jockey mettere in scena la sua magia ed ebbi modo di gettare uno sguardo nella mac-china della promozione musicale in azione. Ricordo anche che nel mio corso di apprezzamento della musica mi venne detto che la musica classica è morta con Beethoven – il che mi sembrò allora un’idea assurda, anche se ora, qualche volta, mi trova d’accordo. La mia partecipazione al mondo della musica terminò
29 Molto di moda negli stati Uniti degli anni quaranta, lo zoot è un vestito completo con pantaloni lunghi e larghi e una giacca anch’essa abbondante con vistose spalline (NdT).

MARCO sANTORO
— 490 —
comunque definitivamente nel 1955, con il matrimonio, poiché la mia prima moglie non aveva alcun gusto per alcun genere musicale. Da allora sono stato confinato al mero apprezzamento e alla ricerca sulla musica.
MS: La tua prima pista di ricerca era dunque sul jazz…
RAP: sì, ma nessuno di quei lavori era buono. Riflettevano la mia ango-scia verso l’eclissi del jazz e, per quanto fossero sociologici, si concentravano sull’alienazione, un argomento che, sebbene fosse caldo negli anni cinquanta, stava rapidamente divenendo passé già nei primi anni sessanta.
MS: Ma pensi così anche del tuo articolo su A Process Model of the Folk,
Pop, and Fine Art Phases of Jazz, apparso se ben ricordo in un volume collet-taneo sulla musica americana nel ’72?
RAP: Non proprio. Quello fu pubblicato quasi dieci anni dopo rispetto agli altri pezzi sul jazz, cui facevo riferimento. Comunque alla conferenza da cui fu poi tratta l’antologia che citi, il pezzo fu attaccato sia da Howard Becker che da Irving Louis Horowitz, i quali pensavano entrambi che non stessi ponendomi le giuste domande nel rivolgermi al jazz.
MS: Quali sono state le obiezioni?
RAP: Come ho già menzionato, Becker voleva che lavorassi in un modo più consono al suo stile e che parlassi a partire dalla prospettiva dei musicisti lavoratori, mentre Horowitz sfruttava l’occasione per strombazzare le sue pre-occupazioni ideologiche del momento sulla «razza». Letto oggi, il saggio può essere interpretato come uno studio sul ruolo del tempo, della gente creativa, dei critici, del pubblico, dei cambiamenti ideologici e delle dinamiche dell’industria musicale nell’istituzionalizzazione di una forma d’arte. Allora, però, era per me solo un tentativo di illustrare in che modo e perché, in solo mezzo secolo, una forma musicala denigrata e di matrice folk fosse divenuta prima popular music e stesse poi per trasformarsi in una forma d’arte consacrata.
MS: Era il 1972, lo stesso anno in cui uscì Sounds of Social Change, il libro che curasti assieme al sociologo serge Denisoff. Credo si possa dire si tratti di uno dei primi libri di sociologia della musica mai pubblicati…
RAP: Be’, forse, ma allora non pensavamo che fosse «sociologia della musica». Era piuttosto un’opportunità di esplorare il ruolo della musica nel modellare i movimenti sociali, un argomento a cui ho avuto solo recentemente

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 491 —
la possibilità di ritornare lavorando con la mia giovane collega Jennifer Lena, esperta di hip hop30.
MS: Preceduto dal già citato articolo del 1971 sull’imprenditorialità nell’in-dustria musicale, scritto a quattro mani con David Berger, Cycles in Symbol Production, il tuo saggio del 1975 uscito sull’«American sociological Review», è stato una pietra miliare nello sviluppo sia della sociologia empirica della musica, sia della sociologia della cultura. Cosa ricordi di quel lavoro?
RAP: Questi articoli scritti con Dave [Berger] rappresentano il primo esempio di quanto il mio lavoro sia stato influenzato nel corso degli anni dal lavoro a fianco di numerosi brillanti sociologi più giovani. Entrambi gli studi da te menzionati provengono dall’osservazione di alcune anomalie nei dati. Nel primo caso, è successo che, osservando diverse sessioni di registrazioni prima a New York, poi a Nashville, ci siamo resi conto del ruolo dell’imprenditorialità al cuore di organizzazioni grandi, verticalmente integrate e burocratiche. Ci siamo proposti di scoprire perchè là essa fosse presente e abbiamo descritto il meccanismo che la proteggeva in un ambiente così ostile. Nel secondo caso, tutto è nato dalla meraviglia che abbiamo provato notando come un numero di piccole etichette indipendenti avesse potuto strappare il controllo del set-tore mainstream dell’industria musicale alle potenti oligarchie che erano state a lungo dominanti. Questi studi non hanno ricevuto molta attenzione in un primo momento, perché gli altri sociologi erano interessati alle grandi industrie manifatturiere e alle burocrazie del settore pubblico. Per loro, quindi, è stato facile leggere l’industria della musica come una anomalia irrilevante. Ma que-sto è completamente cambiato negli ultimi anni, nell’attuale era del computer delle organizzazioni flessibili e delle carriere caotiche dove l’informazione è il prodotto principale. Io e Dave siano profondamente felice che i nostri sforzi iniziali siano ora apprezzati da sociologi, economisti e teorici delle organizza-zioni contemporanei.
MS: Ma in quegli stessi anni hai fatto anche un’altra scelta, dedicarti allo studio della musica country. Trovarti alla Vanderbilt University nel Nashville, la capitale del country, è l’unica ragione dietro a questa decisione?
RAP: Il trasferimento a Nashville ha facilitato sicuramente lo studio della musica country, anche se all’inizio l’ho utilizzato semplicemente come luogo privilegiato per apprendere qualcosa di più dei processi dell’industria della musica e capire meglio i mestieri del produttore, del promotore, del musicista,
30 Vedi ad esempio Lena (2006).

MARCO sANTORO
— 492 —
del disk jockey, dell’ingegnere del suono e dell’autore di canzoni. Molto del lavoro fu svolto con un altro mio allievo, John Ryan e, in seconda battuta, con Paul DiMaggio, nonché con Russ Davis, Jack Esco, Marcus Gowan e Howard White.
MS: Ma ti piaceva, o ti piace, la musica country?
Fig. 1. Il Grand Ole Opry di Nashville, negli anni trenta.
RAP: In un primo momento no, ma ricordo perfettamente il momento in cui iniziò ad interessarmi. stavo parlando con Don Light, un promoter che mi aveva appena portato dietro alle quinte del Grand Ole Opry31, quando mi presentò a Bill Monroe, il fondatore della musica bluegrass. Nella mia igno-
31 La principale manifestazione nel campo della musica country, che si tiene a Nashville dagli anni venti.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 493 —
ranza, non avevo idea chi egli fosse e, con fare snob, domandai a Light come si poteva riconoscere il buon country da quello scadente. La sua replica fu rapida, «Guarda il pubblico». Una risposta che non avresti mai potuto sentire per definire il jazz. Un responso, però, seducente per un sociologo. Come nel caso del rock, indagare la musica country significava osservare e scrivere senza essere ideologicamente intrappolati in pregiudizi estetici positivi, come accadeva quando studiavo jazz.
MS: Quando hai iniziato a pensare più in generale alla «cultura», al di là della musica?
RAP: Probabilmente intorno al 1970. Non ricordo la data esatta, ma solo che il nostro direttore di dipartimento a Vanderbilt di quel periodo, Mayer Zald, mi presentò a un gruppo di sociologi come uno che si interessava di popular culture, di «cultura popolare». Interpretai la loro reazione come una falsa con-discendenza per un tema che, dandoti la possibilità di divertirti, potevi ancora chiamare sociologia. Potevo essere d’accordo sul fatto che ci si dovrebbe di-vertire quando si fa ricerca, altrimenti è meglio abbandonare il campo, ma non sopportavo davvero l’implicazione secondo cui quel che stavo facendo era triviale. Dunque, cosa c’era di sbagliato con il termine «cultura popolare»? Pen-sandoci anche solo un po’, è chiaro che era l’aggettivo «popolare» (popular). È una triste riflessione sui pregiudizi del settore di quei tempi, ma devo dire che quando iniziai a dichiarare che io mi interessavo di «cultura», tutti sembravano positivamente colpiti.
Dopo di che ho dovuto solamente comprendere cosa la «cultura» signifi-casse in sociologia e in che modo i miei specifici interessi potevano adattarsi all’interno di quel campo. Il teorico della cultura che dominava nei due decenni successivi alla seconda guerra mondiale era Talcott Parsons. Mentre l’influenza della sua teoria sociale sfumò rapidamente dall’inizio degli anni sessanta, in America non c’era nessuna chiara alternativa a questa teoria generale della cultura, per cui la visione della cultura che Parsons rappresentava era ancora quella diffusamente insegnata negli stati Uniti. Per Parsons la «cultura» costituiva uno dei sistemi dominanti che componevano la società. La cultura era per lui un insieme disincarnato e coerente di norme, valori e credenze, che evolveva così lentamente che il mutamento culturale poteva essere osservato solamente su lunghi periodi di tempo. Tale visione, però, risultava poco accettabile ai sociologi ed antropologi emergenti più giovani, da Harrison White, Muriel Cantor e Her-bert Gans a Pierre Bourdieu, Erving Goffman, Clifford Geertz, per non dire poi gli interazionisti simbolici (alla Becker). Per quanto fosse eterogeneo, il lavoro di ognuno di questi studiosi si concentrava sugli oggetti e sulle idee culturali in quanto costruite deliberatamente sia nelle pratiche quotidiane sia nell’arte,

MARCO sANTORO
— 494 —
nella cultura popolare, nella scienza, nella religione, ecc., il macrosettore che comprende ciò che noi chiamiamo industria «culturale» o «creativa».
MS: È questo, mi pare di capire, proprio ciò che hai realizzato mentre stavi scrivendo per lo «Annual Review of sociology» l’articolo Revitalizing the Culture Concept (Peterson, 1979)…
RAP: Esattamente. E quel pezzo ha piazzato saldamente l’idea emergente della prospettiva della produzione della cultura (PdC) nel pantheon dei nuovi approcci allo studio della cultura in sociologia.
MS: Ma in quell’articolo programmatico tu parti da una concettualizzazione della cultura – come valori, norme, credenze e simboli espressivi – che appare molto parsonsiana nella sua ispirazione di fondo…
RAP: Io non pensavo che Parsons avesse sbagliato tutto, solo credevo che egli, ponendo esclusivamente l’enfasi sugli elementi valoriali e normativi, invitava ad una visione basata sulla fede che era al di là della portata della scienza empirica. Ricordo una lezione di Parsons all’Università del Wisconsin nel 1963 circa, in cui diceva che non c’erano stati cambiamenti significativi nei valori occidentali da Gesù di Nazareth32. A differenza di altri elementi, i simboli espressivi sono tangibili. Mentre nella mia visione gli altri elementi potevano cambiare rapidamente, era facile vedere periodi di rapido mutamento e pe-riodi di lento mutamento nel caso dei simboli espressivi. È chiaro inoltre che la fabbricazione e il significato attribuito ai simboli espressivi possono essere facilmente osservati.
MS: È tempo di passare alla «produzione della cultura», ma vorrei farlo innestando il discorso sulla tua formazione sociologica. sei stato un allievo di Alvin Gouldner, una delle più controverse figure, direi, nella storia recente del-la sociologia americana, un «marxista fuorilegge», come si dice che gli piaceva definirsi, ma anche – un po’ paradossalmente – uno dei più brillanti studenti di Merton e di Lazarsfeld, cioè dei campioni del mainstream sociologico america-no. Vorrei capire meglio la tua relazione con lui e, tramite questa, la possibile relazione di Gouldner con il progetto della produzione della cultura.
RAP: Maurice stein, uno studente di Gouldner che insegnava a Oberlin mentre ero lì studente, mi introdusse ai lavori di Gouldner, in particolare a Lo
32 Per una più ampia discussione della teoria parsonsiana della dottrina cristiana, in cui viene dato risalto alla dimensione simbolica, vedi Parsons (1974).

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 495 —
sciopero a gatto selvaggio e Modelli di burocrazia aziendale (si veda Gouldner, 1954a, 1954b). Di quei libri mi è piaciuto il modo in cui era utilizzata la teoria per analizzare una situazione empirica bene documentata e studiata concreta-mente, sul campo. Gouldner era brillante. Non conosco nessun altro che abbia ricavato due libri così solidi da un’unica tesi di dottorato. Questo è il Gouldner che conoscevo come studente post-laurea all’Università dell’Illinois alla fine degli anni cinquanta, dove mi sono specializzato. La sua ambizione allora era di succedere a Robert Merton come sociologo di punta in America. Però direi che Al non si rappresentava affatto a quei tempi come un «marxista fuorilegge», sebbene invidiasse la popolarità di C. Wright Mills tra gli intellettuali europei di sinistra. La sua fase «fuorilegge» sarebbe arrivata più tardi, dopo il trasferimento a st. Louis, all’Università di Washington. Comunque, lui ci faceva leggere Marx, cosa insolita negli anni a ridosso dell’era McCarthy, ma la sua postura intellet-tuale era chiaramente radicata nella teoria funzionalista del conflitto dell’epoca. se c’era forse qualcosa di davvero inusuale nei suoi corsi, era la gran quantità di antropologia sociale britannica che ci faceva leggere.
MS: A chi stai pensando?
RAP: Be’, da Malinowski a Evans-Prichard e Max Gluckman. In un certo senso sono stato fortunato. C’erano pochi studenti nell’Illinois e io potevo avere Gouldner praticamente solo per me. Dopo un paio di anni, mi ha invitato a diventare il suo assistente di ricerca e mi diede un piccolo ufficio accanto al suo. Pranzavamo insieme quasi tutti i giorni, ma Al difficilmente faceva degli apprezzamenti e lavorare insieme non era sempre facile. Ricordo che un giorno sfogliava rapidamente qualcosa che avevo scritto e disse, «è ovvio che tu non hai mai letto Weber». Odiavo i suoi frequenti rimbrotti e dovetti soffocare la replica «Max o Leo?». Andai a lavorare con lui con il progetto di fare lo stesso tipo di lavoro che lui aveva fatto con Lo sciopero a gatto selvaggio, ma Gouldner aveva già spostato l’attenzione su altre cose, come elementi di una strategia finalizzata a diventare il successore di Merton. Era gentile e amichevole, almeno quanto lo poteva essere uno che si descriveva come uno schizofrenico paranoico, la cui moglie l’aveva appena lasciato per un altro specializzando in sociologia! Dal primo momento, mi trattò comunque più come un apprendista che come uno studente, un atteggiamento che ho apprezzato e che successivamente ho cercato di adottare a mia volta verso i miei colleghi più giovani. Mi ha insegnato Weber, Durkheim, Marx, Parsons e Coser, i funzionalisti e i teorici del conflitto. Mi ha insegnato che tutti dobbiamo sforzarci per diventare meglio di ciò che siamo – per diventare i migliori e non accettare nient’altro da se stesso. Allo stesso tempo, però, egli non era un perfezionista. «C’è un tempo per leggere e un tempo per scrivere», diceva. Il modo in cui sono venuto a patti con questa

MARCO sANTORO
— 496 —
contraddizione è stato di concentrarmi su ciò che era brillante e probabilmente corretto, anche se non completamente documentato. Lavorando editorialmen-te su un libretto nato da una sua grande idea che io avevo sviluppato, mi ha dimostrato come convertire una tediosa monografia in un libro provocatorio accentuando alcuni risultati e ignorandone altri, consolidandoli con un goccio di teoria e un titolo breve, sgargiante ed evocativo di elementi che andavano ben oltre la ricerca.
MS: suppongo che tu stia parlando di Notes on Technology and the Moral Order (vedi Gouldner e Peterson, 1962) un libro che ho scoperto nella tua bibliografia e che ha immediatamente attratto la mia attenzione e anche la mia immaginazione…
RAP: se lo stai leggendo, allora devi essere la prima persona del millen-nio a farlo! Il titolo è puro e semplice stile Gouldner. Accentua i due fattori principali, e teoricamente più rilevanti, da noi investigati, quelli che dividevano le società avanzate da quelle semplici. Ero però furioso riguardo a quel Notes on (Note su) perché enfatizzava la speculazione piuttosto che i risultati della ricerca. Gouldner si è appropriato dei 2/3 dei diritti – menzionando i costi del divorzio! – in un periodo in cui ero un neoaddottorato povero in canna. Inci-dentalmente, segnalo che il libro contiene un’aggiunta scritta da un mio caro amico anche lui studente dell’Illinois, Keith Miller. È una nota metodologica sul modo di determinare la priorità causale tra due variabili. Una cosa che, come il resto del lavoro, ha trovato un posto sicuro tra il «non-letto».
MS: Nei ringraziamenti del Prolegomenon con cui introduci lo special issue sulla «produzione della cultura», di cui presto diremo, menzioni l’aiuto di Gould-ner, anche se a quanto pare egli non si è mai interessato a questa cosa, né, più generalmente, allo studio istituzionale della cultura. Forse perché, ipotizzo, aveva lasciato perdere la sociologia industriale per una storia sociologica di stampo marxiano della teoria sociale occidentale, che mal si adattava al programma mertoniano di studi della cultura che stavi allora lanciando?
RAP: Hai ragione. La PdC non trovava spazio nell’agenda di Gouldner. Ma devo dire che a seguito di una sessione speciale sulla prospettiva della produzio-ne nella cultura che misi insieme in occasione di un congresso della American sociological Association (AsA) a metà degli anni settanta, egli mi confidò che era rimasto colpito per l’interesse mostrato sull’argomento da sociologi di primo rango come Robert Merton, Peter Blau e Philip selznick.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 497 —
MS: sono ancora un po’ incuriosito, ti confesso, del rapporto tra te e Gouldner. Ho letto recentemente il suo Dialectics of Ideology and Technology e il postumo Against Fragmentation (Gouldner, 1976, 1985) e sono stato molto sorpreso di trovare numerosi riferimenti a quella che ben potrebbe dirsi produ-zione culturale (delle idee, soprattutto) senza però vedere mai alcuna citazione dei tuoi lavori! sembra quasi che, pur essendo comunque a conoscenza del tuo lavoro, avesse dei problemi a menzionarlo. È possibile?
RAP: Confesso di non avere mai letto Against Fragmentation, ma devo anche dire che era abbastanza comune in quel periodo che i professori si appropriassero del lavoro dei loro allievi e li «ricompensassero» trovando loro dei buoni lavori. Un esempio di quello che potrebbe essere chiamato «pagare i debiti» nelle cerchie della sociologia. Detto questo, dubito che Al abbia mai letto davvero i miei lavori sulla cultura e, complessivamente, ciò che ho imparato da Al supera ampiamente qualsiasi cosa che egli abbia potuto imparare da me.
MS: È comunque sorprendente che tu non abbia mai pubblicato in «Theory and society», la rivista fondata e diretta da Gouldner nel 1974, su cui hanno trovato spazio nel corso del tempo molti articoli scritti nella tradizione della PdC...
RAP: Nonostante considerassi le mie posizioni radicali per quanto riguarda i temi della pace, del lavoro e della «razza», non ho mai sottoscritto lo spassoso marxismo culturale della New Left del periodo, quando Gouldner godeva ad essere trattato come un guru della sinistra e cercava di attrarre a sé la gioventù della generazione dei baby-boomer. sono stato in rapporti amichevoli, sebbene distanti, con la sua terza moglie, Janet Gouldner. Fu lei a propormi di scrivere per «Theory and society». Io mi offrii per fare un pezzo sull’Alvin Gouldner che io conoscevo [morì nel 1980], ma la proposta non suscitò l’interesse dei direttori della rivista di allora.
MS: Tentando un approccio in stile PdC alla sociologia delle idee, potreb-be essere interessante, credo, comprendere meglio i tuoi legami intellettuali e professionali con gli accademici che ti hanno o ti possono avere influenzato, come Merton e Mills, ma anche con colleghi come Lewis Coser, Howard Be-cker, Harrison White e Randall Collins, che possono avere avuto una qualche influenza sul tuo programma e sul tuo lavoro…
RAP: Per quanto riguarda Merton, l’ho sempre visto come il più notevole sociologo di quel periodo, e ho sempre preferito il suo modo empiricamente fondato di fare teoria rispetto al teorizzare astratto di Talcott Parsons. In diversi

MARCO sANTORO
— 498 —
momenti il suo lavoro è stato il punto di partenza del mio – in modo particolare la sua idea, di ispirazione adorniana, secondo cui la musica pop è una parodia creata e introdotta in modo strisciante dall’attività manipolatoria dell’industria della musica. Di Mills, ho amato l’Immaginazione sociologica per il suo attacco al vuoto teorizzare rappresentato da Parsons e per l’empirismo scevro di ogni teoria. Colletti bianchi e La elite del potere sono due libri meravigliosi, ma il livello dei suoi libri successivi è scaduto bruscamente (Mills, 1951, 1956, 1959). Ho trovato la teoria del conflitto di Coser (1956) molto utile quale alternativa allo struttural-funzionalismo parsonsiano del periodo. sin dal principio, Howie [Becker] è stato importante come modello di ruolo non solo per la sua abilità nel portare la musica in campo sociologico, ma anche per la sua devozione alle cose osservabili, il suo stile chiaro di scrittura e, soprattutto, la sua cortesia. Canvasses and Careers il libro del 1965 di Harrison e Cynthia White, ha mostrato in modo convincente le ragioni strutturali sociali del declino dell’arte in stile accademico e l’ascesa dell’impressionismo: uno studio che, per me, è stato un paradigma di cosa la produzione della cultura poteva diventare. Parlando delle influenze della prospettiva della PdC, devo riconoscere quanto ho appreso da David Berger, Paul DiMaggio, Wendy Griswold e Paul Hirsch quando erano ancora studenti. sono stati di grande incoraggiamento perché hanno visto nelle mie idee qualcosa che la maggioranza dei sociologi dell’epoca ignorava.
MS: Non hai risposto a proposito di Collins… A me sembra – e ti chiedo che ne pensi – che la sua sociologia della scienza e della filosofia (vedi in parti-colare Collins, 1998) sia piuttosto compatibile con la PdC (per quanto giocata a un livello più micro), pur non venendo mai esplicitamente riconosciuto, almeno per quanto ne sappia. Qual è la tua opinione?
RAP: Confesso di non aver mai visto nel suo lavoro qualcosa di nuovo e utile. Forse ciò dipende proprio dal fatto che il suo lavoro rispecchia quello della PdC, ma non mi sono mai soffermato su questo. I primi lavori di Diana Crane sulla scienza, comunque, sono stati vitali allo sviluppo della prospettiva della produzione sulla cultura.
MS: In che senso pensi che il lavoro di Crane è stato vitale? Ti riferisci all’ultimo capitolo del suo Invisible Collages (Crane, 1972) in cui propone una cornice teorica comparativa per lo studio della cultura?
RAP: sì. Penso che gli studiosi dovrebbero essere più familiari con quel libro. Ma lasciami aggiungere una riflessione al riguardo. Quello che è stato detto potrebbe suonare come se avessi creato io la prospettiva della produzione sulla cultura. Che sarebbe un po’ come dire che il bambino della fiaba che ha detto:

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 499 —
«Il re è nudo», abbia inventato la nudità. Quello che ho fatto è stato cogliere gli elementi di continuità e comunanza tra il lavoro di questi studiosi e il mio, e attribuire ad esso un nome che potesse essere utile. Parlando di influenze, dovremmo però anche menzionare il libro di David Riesman, La folla solitaria (Riesman, 1950). È stato un faro per me sin dalla metà degli anni cinquanta, perché ha mostrato come i sistemi sociali organizzativi della società trovino espressione nella cultura quotidiana e come queste rappresentazioni – gli esempi di Riesman spaziavano dai romanzi epici alle storie per bambini – illustrino e al contempo costituiscano le forme della società.
MS: senti, Paul DiMaggio mi ha detto una volta che i tuoi Simplex papers (si veda Peterson e White, 1979, 1981) sono a suo giudizio un bell’esemplare (per quanto implicito) di «nuova sociologia economica»33. Quale relazione hai intrattenuto in questi anni con persone quali Harrison White e il suo allievo Mark Granovetter, il cui nome è fortemente associato al progetto, appunto, di una «nuova» sociologia economica?
RAP: Buona domanda. Penso che esista un legame, anche se la nuova sociologia economica è arrivata ovviamente diverso tempo dopo i Simplex papers. Come la maggioranza del mio lavoro, il concetto è stato ricavato dalle anomalie nei dati. Conosco Harrison sin dalla metà degli anni settanta, e, come ho già avuto modo di ricordare, sono stato profondamente influenzato dal suo Canvasses and Careers. È anche successo che, in un periodo in cui insegnavo ad Harvard, ho preso in affitto la sua casa. Con Mark Granovetter ci siamo in-contrati e abbiamo parlato. È tutto. La sua «forza dei legami deboli» (Granovetter, 1973) è una stupenda idea che continua a informare la PdC. L’idea, devo dire, mi ricorda molto ciò che ho letto nel saggio di Max Gluckman, Peace in the Feud (La pace nella faida), pubblicato nel suo Custom and Conflict in Africa, un libro che ogni sociologo dovrebbe leggere (Gluckman, 1955).
MS: Dando un’occhiata all’altro lato dell’Atlantico, che relazioni hai avuto in quegli anni fondativi con persone come Raymond Williams, stuart Hall, Paul Willis e Dick Hebdige, che stavano allora lavorando – dico tra gli anni settanta e i primi ottanta – allo sviluppo dei Cultural Studies britannici, un movimento intellettuale che, tra i sociologi americani, sei stato certamente tra i primi a notare e almeno in parte ad incorporare nel tuo lavoro...
33 si veda, per maggiori informazioni su questa prospettiva sociologica, l’introduzione alla in-tervista.

MARCO sANTORO
— 500 —
RAP: Di fatto non ho mai instaurato un contatto diretto con loro – cosa che forse risulta incredibile oggi con internet e i regolari viaggi transatlantici. sono profondamente dispiaciuto di non avere avuto la possibilità di conoscere Raymond Williams alla metà degli anni ottanta, quando ho trascorso un anno in Inghilterra.
MS: I loro scritti hanno contribuito, suppongo, alla tua attenzione alle questioni del consumo culturale.
RAP: Oh sì. Ho appreso molto dai loro studi etnografici su come i grup-pi giovanili si avvicinano i generi della musica commerciale sul mercato e li ricostruiscono per adattarli ai loro scopi. L’antologia del 2004, Music Scenes, che ho curato insieme all’inglese Andy Bennett, è un tentativo di comprendere sistematicamente il contesto in cui tali formazioni culturali ordinarie sono create e sfruttate (Bennet e Peterson, 2004). spero di sviluppare ulteriormente questa linea di lavoro.
MS: Vorrei ora concentrarmi più direttamente sulla conferenza a Vanderbilt del 1975, dalla quale nacquero sia il numero speciale dell’«American Behavioral scientist», sia poco dopo il libro The production of culture, che è poi il manifesto originario della prospettiva Quali erano esattamente il tuo programma e le tue aspettative da esso?
RAP: Volevo fare incontrare in uno stesso posto la gente che, pur lavo-rando su diversi temi (dalla scienza all’arte) concepiva la cultura come una costruzione deliberata.
MS: Letto oggi, una delle cose più sorprendenti del tuo Prolegomenon è
il significativo riferimento a Bourdieu e alla sua scuola, in un periodo in cui il suo nome era quasi sconosciuto sia negli states sia in Inghilterra fuori dai circoli ristretti della sociologia dell’educazione. Come sei venuto a conoscenza del suo lavoro?
RAP: Le prime cose che ho letto di suo sono stati i lavori giovanili sull’Al-geria [che erano da tempo disponibili in inglese]. Egli aveva scoperto che le popolazioni tribali algerine avevano regole severe che governavano chi poteva sposare chi, chi poteva ereditare da chi, ma c’erano poi di fatto anche numerose indicazioni tra loro contraddittorie che ampliavano enormemente la gamma delle scelte. Ne concludeva che la cultura non è qualcosa di unitario e immutabile, ma sempre interpretata creativamente dagli individui in modo da adattarsi agli interessi strategici del momento. simili scoperte venivano allora riportate anche

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 501 —
da altri antropologi che studiavano le alleanze e le faide, ad esempio nelle regio-ni montuose del Burma. È stata questa in effetti una delle idee germinali della produzione della cultura. Alquanto più tardi ho incrociato un breve manifesto programmatico scritto da Bourdieu e pubblicato dalla International sociological Association che presentava un programma organico di studi coordinati con lo scopo di integrare la sociologia dell’educazione, la politica, i media, l’arte e la scienza. In effetti, ho poi dimenticato quali fossero effettivamente i campi da lui inclusi, ma il punto è che erano tutti concepiti come legati assieme in modo da formare un sistema sociale tutt’altro che unitario.
Fig. 2. Richard Peterson (al centro) con sua moglie Claire e Leo Lowenthal, Nashville 1975 (Foto gentilmente concessa da Howard s. Becker).
MS: Cosa pensi ora riguardo la relazione tra la tua prospettiva della PdC e la sua teoria del campo della produzione culturale (Bourdieu, 1992, 1993)?
RAP: Come avrai capito da ciò che abbiamo detto, sebbene sia stato formato per la teoria, non ho alcun vero talento per essa, né interesse per le dispute ermeneutiche. Leggo per trovare idee e dati che sono rilevanti, lasciando da parte il resto, per cui penso che dovresti fare questa domanda a qualcun altro. Quel che posso dire è che la metafora del «capitale culturale» può essere molto utile e le idee sulla relazione tra il gusto e lo status sociale sono state

MARCO sANTORO
— 502 —
un importante punto di partenza per tutti i miei lavori a partire dalla fine degli anni ottanta. Pierre Bourdieu mi ha invitato a lavorare nel suo Centro parigino per un mese nel 1991. Mi spiace che proprio in quel periodo il suo tempo era completamente occupato da questioni burocratiche legate a finanziamenti e che non abbiamo avuto molte occasioni di discutere seriamente.
MS: Quali parti del programma originale del PdC – così come l’hai origina-riamente definito nel saggio citato del 1976 – sono state portate a compimento e quali sono ancora da sviluppare?
RAP: Ciò che considero un successo, andato ben al di là di ogni mia aspettativa, è stato lo sforzo di traghettare lo studio sociologico della cultura nel mainstream della disciplina. Cosa è mancato è una più stretta integrazione tra la sociologia della cultura popolare, dell’arte, della scienza, della religione e del diritto. Ci sono state anche altre conseguenze impreviste che ho discusso con Anand in un articolo dell’«Annual Review of sociology» dedicato alla prospettiva della produzione, al quale rimando (Peterson e Anand, 2004).
MS: Tra i partecipanti sia della conferenza, sia del numero speciale della rivista, sia del libro, spicca il nome di Howie Becker, il quale stava allora an-cora lavorando sulle idee che avrebbe poi esposto in modo più organico in I mondi dell’arte, partendo da una prospettiva sociologica che gli derivava dagli insegnamenti del suo maestro, Everett Hughes. Quale era la tua relazione in quel periodo con la tradizione di Chicago, in particolare quella nel campo della sociologia delle occupazioni?
RAP: Gouldner non era interessato alla sociologia delle occupazioni. Mi sono avvicinato a questa tradizione più tardi, sempre ad Illinois, ma da Joe Gusfield e un altro tizio. Ho molto ammirato il lavoro di Everett Hughes34 e del suo allievo Howard Becker (il giovane), così come quello di Arthur stinchcom-be. Apprezzavo il modo in cui essi interpretavano le occupazioni a partire dal contesto delle organizzazioni e non semplicemente come «professioni». Avevo soggezione di Hughes e ho desiderato qualche volta, quando facevo il PhD, di studiare a Chicago. In un primo momento io e Becker ci siamo scontrati per il rispettivo fuoco d’analisi dei jazz studies, ma dalla metà degli anni ottanta devo dire che il nostro rapporto è maturato in una buona amicizia. Detto questo, il mio interesse per la cultura è stato comunque più stimolato da David Riesman, anche lui a Chicago in quel periodo.
34 Per una ricostruzione della figura di Everett C. Hughes, allievo di Robert E. Park, e tra i più influenti sociologi del Dipartimento di Chicago nel secondo dopoguerra, si veda Chapoulie (1996), e la mia introduzione alla raccolta dei suoi saggi più celebri, in Hughes (2008).

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 503 —
MS: Ricordi le circostanze che hanno prodotto il numero speciale sulla PdC della rivista «social Research», quello curato da Lewis Coser nel 1978 giusto due anni dopo il tuo, curato per l’ABs («American Behavioral scientist»)? Quali legami avevi in quel periodo con Coser? suppongo che Charles Kadushin, anche lui partecipante alla conferenza di Vanderbilt e in procinto di lavorare con Coser al grande progetto di ricerca sull’editoria libraria americana (si veda Coser et al. 1982), fosse un importante legame – come, immagino, Gouldner e Merton, che erano rispettivamente amici e insegnante di Coser... in ogni caso, hai mai pensato a Coser come a un praticante della PdC?
RAP: Tutti i nomi che hai fatto sono stati rilevanti, ma effettivamente il collegamento più diretto con Coser è stato per me Paul DiMaggio, un caro amico di Woody Powell che era allora a Yale. Powell voleva fare uscire una antologia sulla prospettiva PdC, e aveva realizzato che essa avrebbe attratto più persone se l’avesse curata Coser, che era il suo mentore. sicuramente in quel periodo Coser aveva una reputazione tale da suscitare attenzione. Negli anni successivi siamo anche diventati buoni amici, ma Coser non ha mai sottoscritto la prospettiva PdC. Conoscevo già Chuck Kadushin ma questo perché mi ave-va assunto tempo prima per un progetto di ricerca che stava conducendo alla Columbia University.
MS: E cosa mi dici del numero speciale del 1982 sulla PdC co-curato dal sociologo americano Michael schudson sulla rivista «Media Culture & society»? Tu non eri tra gli autori, ma ovviamente il tuo nome era nell’aria. In che modo pensi che gli autori che hanno lavorato su quella che è stata chiamata la «pro-duzione delle notizie» – come schudson, appunto, ma anche Gaye Tuchman, Herbert Gans e Todd Gitlin – abbiano contribuito alla PdC, anche considerando il loro atteggiamento ambivalente verso essa e la loro venatura decisamente più critica e politica?
RAP: Dall’inizio ho usato il loro lavoro sul «fare le notizie» (making news) come un’illustrazione del potere che hanno i processi di produzione nel mo-dellare la cultura. Vedo la PdC come una «grande tenda» e sono più ansioso di cooptare lavori anche diversi, piuttosto che impegnarmi per una «piccola tenda» rigidamente ortodossa. L’ambivalenza di questi studiosi – certamente Gitlin e Tuchman lo erano – è in fondo quanto ci si aspetta da chi decide di assumere una posizione critica. In ogni caso, trovo che incoraggiare la discussione e la nuova ricerca sia più gratificante dei tentativi di difendere rigidamente un’orto-dossia o di escludere gli altri

MARCO sANTORO
— 504 —
MS: Uno dei tuoi più influenti studenti è stato Paul DiMaggio, il cui nome è ora profondamente associato a quello del cosiddetto neo-istituzionalismo (si veda Powell e DiMaggio, 1991)… pensi che questo sia uno sviluppo, o un’integrazione conveniente della PdC in quanto prospettiva di analisi istituzionale della cultura, o come Paul Hirsch pensi che il neo-istituzionalismo sia una «sociologia senza struttura» eccessivamente cultural-cognitiva e scarsamente politico-economica? Detto questo, esistono delle ragioni che, nonostante DiMaggio, ti hanno relati-vamente relegato ai margini dello sviluppo di questo movimento?
RAP: Idee guida del neo-istituzionalismo come «omologia» o «campo» sono importanti, ma il loro fuoco è molto concentrato sull’organizzazione bu-rocratica e assai meno sulle forme di organizzazione più fluide e creative che hanno catturato il mio interesse, e quello di Art stinchcombe e Harrison White. Dovrei però precisare che Paul DiMaggio non è mai stato un mio studente nel senso che non ha mai acquisito un titolo di studio sotto la mia supervi-sione. Ho incontrato Paul per la prima volta l’estate successiva alla sua laurea di primo livello, quando ha partecipato a un programma di perfezionamento del National science Foundation che stavo seguendo alla ricerca di laureati di talento. Ha poi trascorso un’altra estate con me a Nashville a un anno circa di distanza, facendo ricerca sull’industria della musica country (si veda Peterson e DiMaggio, 1975). E poi, insieme anche a Wendy Griswold, abbiamo tenuto un seminario informale sulla cultura l’estate in cui ho insegnato ad Harvard. Io e Paul abbiamo pubblicato diverse piccole cose da quella esperienza e da allora siamo rimasti sempre vicini. A conti fatti credo di avere appreso più io da lui, che non lui da me.
MS: Abbiamo parlato del ruolo del libro The production of culture nell’ascesa di un nuovo orientamento di studi sulla cultura in sociologia, e questo mi induce a chiederti qualcosa sulla nascita nel 1986 di una sezione «cultura» nell’ambito della American sociological Association, un progetto di costruzione istituzionale a cui credo tu abbia direttamente contribuito… Quale effetto pensi che abbiano giocato la conferenza del 1975 e le pubblicazioni che sono seguite nel promuovere la «cultura» come un oggetto legittimo della ricerca sociologica?
RAP: sebbene possa essere difficile crederlo ora, all’inizio degli anni ot-tanta non era affatto scontato che ci potesse essere una sezione «cultura» della American sociological Association35. A dire il vero, la «cultura» era sì un capi-
35 sono qui ripresi, con qualche variazione, alcuni passaggi da un testo di Peterson: Early Days: Founding of the ASA Culture Section, pubblicato nella Newsletter dell’AsA Culture section, Culture, nel 2000.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 505 —
tolo nei manuali di introduzione alla sociologia e aveva un posto importante nello schema teorico di Talcott Parsons, ma anche Parsons ha affermato che, in pratica, «le idee e i sentimenti... sono manifestazioni più dipendenti». Come saprai, Parsons ha trascorso molto tempo durante la seconda guerra mondiale nella stesura di un documento per il governo americano su come gestire la Germania nel dopoguerra. È un documento interessante per molte ragioni, tra cui la previsione che sarebbe stato vano cercare di cambiare i valori e che, invece, sarebbe stato molto più produttivo manipolare la generazione futura dei tedeschi istruiti attraverso un sistema di incentivi economici a favore della democrazia e contro il fascismo. Ma questa è una digressione.
Quel che conta è che in quegli anni si stavano formando un po’ ovunque gruppi di studiosi interessati alla sociologia dell’arte, della letteratura, dell’ideo-logia, dei valori, della religione, delle comunicazioni di massa, dell’etnografia, della cultura popolare e dell’interazione simbolica, tanto per nominare solo qualcuna delle tendenze spesso concorrenti che, come sembrava in quel perio-do, si sarebbero unificate felicemente sotto una unica bandiera. Erano presenti piccoli gruppi di lavoro e circolava una Newsletter informale. Detto questo, l’idea di formare una sezione era nell’aria almeno fin dalla fine degli anni set-tanta. Ricordo le conversazioni su questo argomento con Howard Becker, Vera Zolberg, Ann swidler, Paul DiMaggio, Diana Crane, Muriel Cantor, Gary Alan Fine e altri. Molti di noi – inclusi io, Becker e Fine – criticavano il tentativo di formare una sezione separata. Eravamo giù soddisfatti del numero crescente di incontri informali che si stavano tenendo con una certa periodicità (come il ciclo di conferenze su Social Theory, Policy, and the Arts, fondato nel 1975), ma, avendo un profondo sospetto per le organizzazioni formali, pensavamo che se si fosse formata una sezione, la condivisione informale delle idee avrebbe lasciato il posto ai conflitti di potere sugli obiettivi della sezione e alle lotte per il controllo dell’organizzazione. A un livello pratico vi era la questione se si fossero raggiunti i duecento iscritti, il numero magico per formare una sezione della AsA, intenzionati a unirsi alla sezione «cultura». Dopotutto l’interazionismo simbolico era stato emarginato e la sociologia americana si era mostrata a lungo ostile allo studio delle attività simboliche.
Le cose cambiarono nel 1986, quando mi arrivò una lettera da Donna Gai-nes, una brillante e attiva studentessa di Louis Coser – che stava allora a stony Brook (NY) – firmata a nome di una miriade di giovani sociologi che avevano già mandato una petizione alla AsA perché fossero riconosciuti come una «se-zione in divenire» sotto il vessillo della «cultura». Donna motivò la proposta di formare una sezione dicendo che, se per i ricercatori di ruolo non era forse necessaria, essa per la generazione dei giovani a cui anche lei apparteneva era indispensabile per dimostrare a relatori di tesi dubbiosi e a commissioni di re-clutamento scettiche che la «cultura» rappresentava un’area di attività intellettuale

MARCO sANTORO
— 506 —
accettata e ben rappresentata. Con simili premesse, la mia risposta fu semplice: «Naturalmente farò ogni cosa possibile». Quando diversi amici che conoscevano la mia opinione mi chiesero il motivo di un così brusco ripensamento, risposi che oramai la pentola era sul fuoco e che sarebbe stato molto peggio se si fosse scoperto che la «cultura» non attraeva abbastanza membri per formare una sezio-ne. L’obiettivo era divenuto far firmare il maggior numero possibile di aspiranti membri e, allo stesso tempo, rendere la sezione la più aperta possibile.
MS: Questo è stato qualcosa che tu hai sempre perseguito, in effetti. Intendo l’apertura dei gruppi, l’inclusività, quel qualcosa che ha reso la rete dei praticanti della PdC più simile a un movimento sociale piuttosto che a una scuola o a una setta, come ha notato anche Di Maggio (2000)…
RAP: Ti ringrazio per questo. Quando ero studente di dottorato con Gouldner, ho vissuto gli effetti infinitamente distruttivi dei conflitti tra colleghi, mentre diversi anni dopo, quando ero un giovane sociologo a Madison, nel Winsconsin, ho beneficiato molto della competizione intensa ma amichevole che c’era tra noi giovani colleghi. La generazione più vecchia di sociologi inte-ressati alla sfera del simbolico si era divisa in fazioni ostili. Una tale divisione era ora da impedire se volevamo andare avanti. Avevo in realtà già gustato i frutti della riconciliazione. Come notato in precedenza, il mio primo incontro con Howard Becker nel 1968 circa era stato piuttosto difficile, ma come ho detto alla fine degli anni settanta entrambi eravamo ormai giunti a concepire la sua prospettiva dei «mondi dell’arte» allora in fase di formazione (si veda Becker, 1982) come complementare, e non opposta, a quella della PdC. È possibile ve-dere questi schemi rivali come tra loro utilmente collegati, e situati a differenti livelli di analisi. La mia parola d’ordine allora era affermare l’importanza del simbolico, ignorando ciò che non sembrava utile e illuminando tutto quanto c’era di positivo. L’articolo che scrissi per aprire la Newsletter della sezione ne-ocostituita riflette questo tema del riavvicinamento. Il secondo paragrafo inizia con queste parole: «cosa è la cultura e quale tipo di ricercatori dovrebbero essere inclusi nella sezione di sociologia della cultura»? Questi interrogativi erano stati ampiamente dibattuti nel nostro primo business meeting durante la conferenza dell’AsA di New York quell’inverno (1986). Eravamo generalmente d’accordo sul fatto che non c’era alcuna necessità di ergere forti barriere e che potevano essere accolte persone con diversi interessi sia di contenuto, sia metodologici. Chiaramente, però, la sezione era rivolta a coloro interessati allo studio dei valori, dell’arte, della cultura popolare, della cultura materiale, dell’ideologia, della comunicazione, tutti quelli il cui lavoro, di fatto, contiene un’attenzione verso il regno del simbolico. Un eclettismo visibile anche nel primo Consiglio della sezione, che comprendeva stanley Aronowitz, Muriel Cantor, Diana Crane,

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 507 —
Todd Gitlin, Michael schudson, Gaye Tuchman e Vera Zolberg, che sarebbe stata eletta presidente nel secondo anno.
MS: sembra che tu abbia avuto molto a che fare con la Newsletter della sezione nel corso dei primi anni. È una conseguenza di questa tua enfasi sulla «apertura»?
RAP: sì, decisamente. Come ogni leninista sa bene, per costruire un movi-mento sociale è necessario controllare i mezzi di comunicazione e la Newsletter è stato il primo modo di comunicare nei 360 giorni che passavano tra i nostri incontri annuali. L’oggetto della Newsletter erano l’informazione e le attività, evitando di pubblicare ogni pezzo contenente una posizione personale che non fosse già stato pubblicato in riviste con peer review. Ciò che meglio illustra quesa strategia è il modo in cui abbiamo risolto la questione delle recensioni. sembrava corretto pubblicizzare i nuovi lavori nel campo, ma per ogni autore soddisfatto da una recensione, ce ne sarebbero stati molti sdegnati per non avervi trovato spazio. Inoltre, le recensioni non potevano essere tempestive. Una soluzione conveniente è stata menzionare e racchiudere in una frase o due tutti i nuovi libri sul tema della cultura. È stato facile scrivere carpendo qualche frase dalle fascette dei libri che gli editori distribuivano regolarmente. Chiamata Books of Note, è nata come un contenitore strategico, ma è diventata presto una delle rubriche più diffusamente discussi della Newsletter.
MS: La sezione «cultura» ha avuto il seguito che tu ti aspettavi?
RAP: Be’, ora è la seconda maggiore sezione dell’AsA e, quindi, è prospe-rata. Molti sociologi che venticinque anni or sono, quando la sezione è stata costituita, non avrebbero mai aggiunto la «cultura» alla lista dei loro interessi, oggi lo fanno. Guardando alla sostanza, anche alcuni sociologi che studiano le credenze hanno finito per utilizzare la parola «cultura» per descrivere il proprio lavoro, e lo stesso fanno coloro che studiano i gruppi etnici e le identità. Il mio stesso lavoro con Andy Bennett, Bruce Beal e Ken spring sulle scene musicali può essere inteso come una ricerca sulla cultura di un gruppo identitario. In qualche mio lavoro mi piace usare la metafora della «produzione» per mettere in primo piano una concezione della cultura come qualcosa che non è fisso e dato, ma in continuo mutamento. Definisco questi studi esemplari di quello che chiamo «autoproduzione della cultura». «Auto-» nel senso che i gruppi si appro-priano degli elementi della cultura commerciale disponibili nel loro ambiente e successivamente li reimmaginano e li ricombinano per dare vita a espressioni culturali che formano la loro identità distintiva, quella che sta alla base del loro riconoscimento. Gruppi etnici emarginati e gruppi giovanili sviluppano spesso

MARCO sANTORO
— 508 —
le forme più visibili di autoproduzione, ma tutti i gruppi tendono a costruire espressioni culturali che sono in un certo grado distintive. Basta andare in un collegio per le elite o a un club per pensionati per averne una dimostrazione.
MS: Possiamo dire che questo interesse per la autoproduzione è una estensione della prospettiva della PdC?
RAP: Retrospettivamente questo lavoro può essere letto in questo modo, ma la maggior parte del mio programma di ricerca sviluppato su questi temi attorno alla fine del decennio 1970 ruotava intorno al «consumo», come allora appunto si diceva. Ho scritto per questo una ambiziosa richiesta di sovvenzioni per i programmi di «sviluppo della carriera», che appunto prevedeva di studiare sia la produzione sia il consumo della cultura. Ho iniziato a lavorare seriamente su questo fronte a partire dai primi anni ottanta, esaminando con Mike Hughes i dati di una inchiesta sulle attività di consumo nel tempo libero alla ricerca di ciò che chiamavamo «modelli di scelta culturale» (Hughes e Peterson, 1983). Le inchieste a nostra disposizione erano rozze e allora mi rivolsi a quelle fatte da ricercatori di mercato, che in quel periodo stavano sviluppando dei metodi per localizzare alcuni generi specifici di consumatori. Lavorando un po’ in quel campo, mi sono reso conto che se i metodi dei «modelli di cultura» fossero stati perfezionati dalle agenzie governative e, potenzialmente, da altri gruppi con una qualche agenda di sorveglianza, si sarebbero potuto delineare dei profili e dei tipi specifici della popolazione. Oggi tali tecniche, per quanto si possa essere abili nel creare profili, sono ancora poco raffinate. Prendi ad esempio la girandola di uomini immigrati adulti con nomi musulmani coinvolti nell’isteria statunitense successiva all’undici settembre. Con i nuovi computer che possono masticare velocemente immensi data base, però, lo spettro di 1984 diviene un pericolo reale.
Negli anni ottanta, ho messo uno stop ad ogni ulteriore progetto di ricerca sui modelli di scelta culturale per tre ragioni. Primo, perché i dati disponibili erano di pessima qualità; secondo, i metodi statistici e la capacità dei compu-ter di utilizzarli in modo efficiente non erano disponibili; e terzo, non volevo avere niente a che fare con una ricerca che poteva essere utilizzata per scopi così nefasti.
MS: Vorrei discutere ancora un poco, se me lo consenti, le origini intellet-tuali di questo tuo lavoro sul consumo culturale. È corretto affermare che sei giunto ad esso attraverso la tradizione antropologica dei modelli di cultura di Ruth Benedict (1934), dalla quale hai ricavato originariamente l’idea dei «modelli di scelta culturale», nonché dai tuoi precedenti lavori con Gouldner sulla Human Relations Area File (si veda ancora Gouldner e Peterson, 1962)?

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 509 —
RAP: Il libro di Ruth Benedict era usato in un corso che seguivo come assistente nei miei primi due anni alla scuola di dottorato. Ero quindi familiare con la sua idea secondo cui ogni società ha un distintivo insieme di valori cul-turali, credenze, e simboli espressivi, il quale è riflesso della struttura (omolo-ga) della società. Questa idea è stata al cuore della letteratura funzionalista sia antropologica sia sociologica in ascesa negli anni cinquanta. Naturalmente nel periodo in cui ho lavorato all’idea dei «modelli di scelta culturale» a metà degli anni settanta c’era già stato un grande cambiamento. Invece di pensare alla cultura come ad un’unità onnicomprensiva, la nuova generazione a cui appar-tenevo pensava che la cultura di un certo gruppo o società venisse espressa in una miriade di elementi più o meno contraddittori entro cui la gente era però in grado di fare delle scelte. È questa la ragione per cui ho preferito il concet-to di «modelli di scelta culturale». solamente allora ho iniziato a intendere le questioni culturali come strettamente intrecciate alla stratificazione, à la Pierre Bourdieu, perché molte delle scelte che gli individui e i gruppi sono apparen-temente liberi di fare, sono in realtà vincolate dalla classe, il genere, la «razza», ecc. Ho sviluppato ambiziosi disegni di ricerca sui «modelli di scelta culturale», ma piuttosto velocemente mi sono tirato indietro perché erano poi non tanto gli studiosi accademici, bensì i ricercatori di mercato, ad essere i primi utiliz-zatori di qualsiasi cosa potesse essere scoperta, e non volevo prendere parte a un’impresa di ricerca finalizzata alla manipolazione dei gusti, delle attitudini e dei comportamenti della gente.
MS: Ma non credi che il tuo successivo coinvolgimento nel programma di ricerca del National Endowment for the Arts (NEA) sulla partecipazione alle arti fosse comunque del tutto congeniale alla prospettiva dei «modelli di scelta culturale» che hai appena esposto?
RAP: È piuttosto vero. Ma quando nel 1979 mi è stato chiesto di unirmi alla divisione della ricerca della NEA per un anno, non immaginavo che aiutare delle persone interessate ad accrescere la partecipazione nelle arti non sarebbe stato di alcun valore per i ricercatori di mercato. Mi è stato chiesto di studiare gli «indicatori della cultura» che erano stati sviluppati in altri paesi e proporne uno schema per gli stati Uniti. si è rilevato essere un programma piuttosto noioso, che cercava di valutare lo stato di salute culturale di una nazione attraverso le statistiche governative sulle spese e sull’occupazione che erano stati create per motivi piuttosto differenti. L’unico elemento che ha attirato il mio interesse è stata la sfida di creare de novo uno strumento di inchiesta della popolazione da somministrarsi periodicamente. Combinava informazioni sugli atteggiamenti sociali, sulla partecipazione all’arte, le attività del tempo libero e la demografia sociale (genere, istruzione, reddito, etnicità e simili). Non sto qui a dilungarmi

MARCO sANTORO
— 510 —
sulla valle di lacrime che ha preceduto la Survey of Public Participation in the Arts (Inchiesta sulla partecipazione pubblica nelle arti, sPPA), effettuata per la prima volta nel 1982 e ripetuta da allora ogni dieci anni. Basti dire che la sPPA, congiuntamente alla General Social Survey (Inchiesta sociale generale) del 1993, ricavata dalla prima, ha formato la base empirica per il progetto di ricerca sull’onnivorismo, da cui è partita una sfida all’assunto bourdieuiano della stretta omologia tra classe sociale e consumo.
MS: Peraltro, si può dire che anche il lavoro sull’onnivorismo che in questo momento sta ricevendo molta attenzione nel dibattito internazionale è in linea con l’idea della «autoproduzione», no?
RAP: sì, può essere intesa come «autoproduzione» e suppongo che possa essere intesa anch’essa come una indagine sui «profili», ma non ho remore nel fare questo tipo di ricerca perché i risultati non potrebbero essere di alcun interesse per quanti sono interessati a obiettivi di sorveglianza. Dopo tutto la ricerca ha a che fare con la relazione tra lo status sociale delle elite e i gusti culturali. In modo interessante, ciò che i risultati mostrano è che una considerevole frazione delle elite non sono intellettuali snob, come pensavano Pierre Bourdieu e in qualche modo anche i sociologi americani sin dai tempi di Thorstein Veblen. Piuttosto, essi sono abbastanza eclettici nei loro gusti e questa scoperta è stata confermata da indagini in Canada, in Australia e in molti paesi europei.
MS: Pensi che questo abbia qualche connessione anche con la tua rifor-
mulazione del concetto di autenticità, che è uno dei più importanti risultati, a mio avviso, dei tuoi venti anni di ricerca sulla produzione della musica country nonché tema centrale del tuo libro Creating Country Music: Fabricating Au-thenticity (Peterson, 1997)?
RAP: È interessante quel che dici. Paul Di Maggio mi ha detto una volta che la prospettiva della produzione compare in ogni pagina di quel libro. Penso che abbiate entrambi ragione in quanto, più di ogni altro mio lavoro, Fabricating Authenticity mostra come la produzione «industriale», così come essa è rappre-sentata dall’industria della musica, e l’autoproduzione di gruppo, così come essa è rappresentata sia dai musicisti che dai pubblici del country, abbiano interagito finendo per creare l’immagine della musica country autentica.
MS: Negli ultimi anni sei stato molto coinvolto nella European sociolo-gical Association, soprattutto in quella sua articolazione che è il Sociology of Art Network. sei stato molte volte in Europa per parlare con studiosi europei della cultura sulla produzione e sul consumo culturale e, soprattutto, della

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 511 —
«tesi dell’onnivorismo», che sta avendo un forte impatto sui sociologi europei. Credi che, nonostante le ovvie differenze, ci sia di fatto uno spazio per una crescente interpenetrazione tra la sociologia americana della cultura e quella europea?
RAP: sì. sono stato veramente molto colpito dalle nuove generazioni di sociologi europei e australiani che sono al passo con gli sviluppi sia in Nord America che in altri paesi europei, oltre che con quanto avviene nei loro paesi di origine. Questo pan-nazionalismo ha sicuramente numerose cause, non ultime i numerosi incontri e i molti gruppi di lavoro internazionali, il flusso di informazioni che circolano su internet e l’emergere di nuove riviste davvero internazionali, la più importante delle quali, nel campo degli studi sociali sulla cultura, è naturalmente «Poetics», sotto la direzione di Kees van Rees.
MS: Per finire, cosa pensi dell’idea di una «sociologia della cultura» di-stinta da una «sociologia culturale», così come è intesa da Jeffrey Alexander e dalla sua scuola? Loro sono molto critici della tradizione della PdC, come saprai, per il suo fuoco sulle «condizioni» di esistenza della cultura invece che sugli oggetti culturali in senso proprio, il cui studio verrebbe così ancora una volta lasciata agli umanisti, e comunque escluso dal campo di pertinenza della sociologia…
RAP: A volte c’è chi trova conveniente criticare il lavoro di altri, una cosa che facilita la carriera e, dopotutto, anch’io ho usato parole dure per la fonte d’ispirazione di Jeff, il citato Talcott Parsons, nel pezzo del 1979 che abbiamo ricordato. Ma è possibile spingersi sin troppo in là nello sminuire il lavoro altrui, come hanno fatto anche altri sociologi, e rifiutare interamente la prospettiva della PdC giudicandola inadeguata. Però non si critica una forchetta perché questa non è in grado di tagliare il cibo. sin dal principio la prospettiva della produzione è stata concepita e presentata come un utile strumento, e non come una cassetta degli attrezzi completa. Come d’altronde abbiamo già detto, la pro-spettiva della produzione non è stata la base di tutto il mio lavoro e lo stesso vale per numerosi altri praticanti nel campo. Ma per arrivare alla tua domanda, semplificando, direi che la prospettiva della produzione solitamente considera la cultura come la variabile dipendente, mentre la sociologia culturale di Ale-xander vuole focalizzarsi sulla cultura come variabile indipendente. I sociologi ignorano l’una o l’altra a loro pericolo.
MS: Credi che le due prospettive riproducano con nuovi mezzi l’antica dialettica tra un approccio più parsonsiano-durkheimiano (centrato sui valori, le credenze e i codici semiotici) e uno che potremmo dire più mertoniano-

MARCO sANTORO
— 512 —
weberiano (attento alle strutture sociali e normative, alle organizzazioni e alle istituzioni)36?
RAP: Ci sono cose che trovo molto utili nelle opere di tutti e quattro gli studiosi che hai citato, e, allo stesso tempo, altre che trovo mal concepite. Però sì, sono concettualmente d’accordo: queste prospettive complementari si dividono più o meno sulla linea che tu menzioni. sebbene da un punto di vista metodologico ci sia poi – come ben sai – molto di Weber in Parsons e molto di Durkheim in Merton. Ma siccome tu mi vuoi mettere alle strette, per concludere lasciami parafrasare il maestro Karl Marx quando disse: «Je ne suis un Marxist».
MS: Grazie Pete.
RAP: È stato un piacere. Ti ringrazio per avermi spronato nel tentativo di dare un senso alle cose che mi hanno riguardato, anche se non posso che lasciare questo compito a chi ha più gusto per il dibattito accademico ed erudito.
(Traduzione dell’intervista di Mauro Turrini)
Bibliografia
Abbott, A. 2001 Chaos of Disciplines, Chicago, University of Chicago Press.2004 I metodi della scoperta, trad. it. Milano, Mondadori, 2007.2007 For Humanist Sociology, in D. Clawson et al., Public Sociology. Fifteen Eminent
Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-first Century, Berkeley, University of California Press, 2007, pp. 195-212.
Abell, P.2004 Narrative Explanation. An Alternative to Variable-Centered Explanation?’, in «Annual
Review of sociology», 30, pp. 287-310.
Adorno Th. W. 2004 Una critica sociale della musica radiofonica, in «studi Culturali», I (1), pp. 109-122.2006 Current of Music. Elements of a Radio Theory, Frankfurt, suhrkamp.
Alexander, J.C. (a cura di)1988 Durkheimian sociology: cultural studies, Cambridge, Cambridge University Press.
36 Per la definizione della prospettiva della PdC come «approccio weberiano» vedi almeno schudson (1989). sulle radici durkheimiane della sociologia culturale vedi invece Alexander (1988, 2003).

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 513 —
Alexander, J.C.2003 The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology, Oxford, Oxford University Press
(trad. it. parziale La costruzione del male, Bologna, Il Mulino 2006).
Alexander, J.C. e Ph. smith 2001 Il programma forte nella teoria culturale: elementi di ermeneutica strutturale, in M.
santoro e R. sassatelli (a cura di), Studiare la cultura. Prospettive sociologiche, Bolo-gna, Il Mulino, 2008.
Barrett, M., Corrigan, P., Kuhn, A. e Wolff, J. (a cura di) 1979 Ideology and Cultural Production, Londra, Crom Helm.
Becker, H. s. 1963 Outsiders. Saggi di sociologia della devianza, trad. it. Torino, Gruppo Abele, 2003.1982 Mondi dell’arte, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2005.2005 Come ho scritto “I mondi dell’arte”, in «studi culturali», 2 (1), pp. 155-166.
Becker, H.s. e Pessin, A.2006 A Dialogue on the Ideas of «World» and «Field», in «sociological Forum», 21 (2), pp.
275-286.
Benedict, R.1934 Modelli di cultura, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1960.
Bennett, A. e Peterson, R.A. (a cura di) 2004 Music Scenes. Local, Translocal and Virtual, Nashville, Vanderbilt University
Press.
Bourdieu, P.1971 Le marché des biens symboliques, in «L’année sociologique», 22, pp. 49-126.1979 La distinzione, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1982.1980 The Production of Belief. Contribution to an Economy of Symbolic Goods, in «Media,
Culture and society», 2/3, pp. 261-293 (ed. or. 1977).1992 Le regole dell’arte. Genesi e struttura del campo letterario, trad. it. Milano, saggiatore,
2005.1993 The Field of Cultural Production, New York, Columbia University Press. 2005 Fieldwork e colonialismo, in «studi Culturali», 3 (1), pp. 83-102.
Brint, s.1991 Hidden Meanings: Cultural Content and Context in Harrison White’s Structural So-
ciology, in «sociological Theory», 10 (2), pp. 194-208.
Burawoy, M.2005 Per la sociologia pubblica, in «sociologica», 1 (1). Chan, T.W. e Goldthorpe, J.H.2007 Social Stratification and Cultural Consumption: Music in England, in «European
sociological Review», 23 (1), pp. 1-19.

MARCO sANTORO
— 514 —
Chapoulie, J.-M.1996 E.C. Hughes and the Chicago Tradition, in «sociological Theory», 14 (1), pp. 3-29.
Chriss, J.J. 1999 Alvin W. Gouldner: Sociologist and Outlaw Marxist, Alderhsot, Ashgate.
Coleman, J., Katz, E. e Manzel, H. 1966 Medical Innovation: A Diffusion Study, Indianapolis, Bobbs-Merrill.
Collins, R.1998 The Sociology of Philosophies, Cambridge, Havard University Press.
Convert, B. e Heilbron, J.2007 Where did the new economic sociology come from?, in «Theory and society», 36, pp.
31-54.
Coser, L.1956 Le funzioni del conflitto sociale, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1967.
Coser, L., Kadushin, C. e Powell, W.W.1982 Books. The Culture and Commerce of Publishing, Chicago, University of Chicago
Press.
Crane, D. 1972 Invisible Colleges, Chicago, University of Chicago Press.1992 La produzione culturale. Media e arti urbane, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1997.
Crane, D. (a cura di) 1994 The Sociology of Culture, Oxford, Blackwell.
Denisoff, s. e Peterson, R.A. (a cura di) 1972 The Sounds of Social Change: Studies in Popular Culture, Chicago, Rand McNally.
Denzin, N.1990 Reading Cultural Text, in «American Journal of sociology», 95, pp. 1577-1580.1991 Empiricist Cultural Studies in America: A Deconstructive Reading, Current Perspectives,
in «social Theory», 11, pp. 17-39.
DeNora, T.2000 Music in everyday life, Cambridge, Cambridge University Press.
DiMaggio, P. 1979 On Pierre Bourdieu, in «American Journal of sociology», 84 (6), pp. 1460-1474.1987 Imprenditoria culturale nella Boston dell’Ottocento, in Id., L’organizzazione della
cultura, trad. it. Bologna, Il Mulino, in corso di pubblicazione.2000 The production of scientific change: Richard Peterson and the institutional turn in
cultural sociology, in «Poetics», 28, pp. 107-136.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 515 —
Dowd, T.2007 Innovation and diversity in cultural sociology. Notes on Peterson and Berger’s classic
article, in «sociologica», 1 (1), http://www.sociologica.mulino.it/doi/10.2383/24213.
Edles, L.D. 2002 Cultural Sociology in Practice, Oxford, Blackwell.
Eyerman, R. e McCormick, L.2006 Introduction, in R. Eyerman, J. Alexander e L. McCormick (a cura di), Myth, Meaning,
and Performance, Boulder, Paradigm, pp. 1-12.
Fine, G.A. 1992 The Culture of Production: Aesthetic Choices and Constraints in Culinary Work, in
«American Journal of sociology», 97 (5), pp. 1268-1294.
Frith, s. e A. Goodwin (a cura di) 1990 On Record, Londra, Routledge.
Gilroy, P. 1993 The Black Atlantic, trad. it. Roma, Meltemi, 2003.
Gluckman, M.1955 Custom and Conflict in Africa, Oxford, Basil Blackwell.
Gottdiener, M. 1985 Egemonia e cultura di massa: un approccio semiotico, trad. it. in santoro e sassatelli
(2008).
Gouldner, A. 1954a Modelli di burocrazia aziendale, trad. it. in A. Gouldner, Modelli di burocrazia azien-
dale. Lo sciopero a gatto selvaggio, Milano, Etas Kompass, 1970.1954b Lo sciopero a gatto selvaggio, trad. it. in A. Gouldner, Modelli di burocrazia aziendale.
Lo sciopero a gatto selvaggio, trad. it. Milano, Etas Kompass, 1970.1970 La crisi della sociologia, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1970.1976 The Dialectic of Ideology and Technology: The Origins, Grammar, and Future of Ide-
ology, New York, seabury Press. 1985 Against Fragmentation: The Origins of Marxism and the Sociology of Intellectuals,
New York, Oxford University Press.
Gouldner, A. e Peterson, R.A. 1962 Notes on technology and the moral order, Indianapolis, Bobb-Merrills.
Granovetter, M.1973 The Strenght of Weak Ties, in «American Journal of sociology», 78 (6), pp. 1360-
1380.
Griswold, W.1990 Reply to Denzin, in «American Journal of sociology», 95, pp. 1580-1583.

MARCO sANTORO
— 516 —
Hebdige, D.1979 Subcultura. Il fascino di uno stile innaturale, trad. it. Genova, Costa & Nolan, 1990.
Hedstrom, P.2005 Anatomia del sociale. Sui principi della sociologia analitica, trad. it. Milano, Bruno
Mondadori, 2006.
Hennion, A.1981 Les Professionnels du disque, Parigi, Métailié.1993 La mediation musicale, Parigi, Métailié.
Hesmondhalgh, D. 2002 The Cultural Industries, Londra, sage.
Hirsch, P.M. e Fiss, P.C.2000 Doing sociology and culture: Richard Peterson’s quest and contribution, in «Poetics»,
28, pp. 97-105.
Hughes, E.C.2008 L’occhio sociologico, trad. it. a cura di M. santoro, Bologna, Il Mulino. Hughes, M. 2000 Country music as impression management: A meditation on fabricating authenticity,
in «Poetics», 28, pp. 185-205.
Hughes, M. e Peterson, R.A.1983 Isolating Cultural Choice Patterns in the U.S. Population, in «American Behavioral
scientist», 26 (4), pp. 459-478.
Jensen, J. 1984 An interpretative approach to cultural production, in W. Rowland e B. Watkins (a
cura di), Interpreting Television, Londra, sage, pp. 98-118.
Jones, P.2004 Raymond Williams’ Sociology of Culture. A Critical Reconstruction, Basingstoke,
Palgrave.
Karpik, L.2007 L’économie des singularités, Parigi, Gallimard.
Kim, s. 2004 Rereading David Morley’s The Nationwide Audience, in «Cultural studies», 18 (1), pp.
84-108.
Inglis, D. e J. Hughson (a cura di) 2005 The Sociology of Art: Ways of Seeing, Basingstoke, Palgrave.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 517 —
Lahire, B. 2004 La culture des individus, Parigi, La Decouverte.
Lash, s. e Urry, J. 1994 Economies of Signs and Spaces, Londra, sage.
Lena, J.2006 Misure della varietà. Lezioni dalla musica rap, 1979-1995, in «studi Culturali», IV (1),
pp. 137-160.
Lewis, J.1997 What counts in cultural studies, in «Media, Culture & society», 19, pp. 83-97.
Lury, C.1993 Copyright Cultures, Londra, Routledge.
McLennan, G.2006 Sociological Cultural Studies, Basingstoke, Palgrave.
Mills, C.W.1951 Colletti bianchi, trad. it. Torino, Einaudi, 1965.1956 La élite del potere, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1959.1959 L’immaginazione sociologica, trad. it. Milano, saggiatore, 1962.
Mohr, J.W. 1998 Measuring Meaning Structures, in «Annual Review of sociology», 24, pp. 345-370.
Negus, K. 1992 Producing Pop, Londra, Arnold.1997 The Production of Culture, in P. DuGay (a cura di), Production of Culture/Cultures
of Production, Londra, sage, pp. 68-118. 1999 Corporate Culture and Musical Genres, Londra, sage.
Parsons, T.1974 La religione nell’America postindustriale: il problema della secolarzzazione, trad. it.
in «sudi Culturali», IV (1), 2007, pp. 85-114.
Peterson, R.A.1965 Artistic creativity and alienation: The jazz musician versus his audience, in «Arts in
society», 3, pp. 244-248.1967 Market and moralist censors of a rising art form: Jazz, in «Arts in society», 4, pp. 253-
264.1971 Recesione a Gouldner (1970), in «American sociological Review», 36 (2), pp. 326-
328.1972 A process model of the folk, pop, and fine art phase of jazz, in C. Nanry (a cura di),
American Music: From Storyville to Woodstock, New Brunswick, Transaction, pp. 135-151.
1976 The production of culture: A prolegomenon, in «American Behavioral scientist», 19, pp. 669-684.

MARCO sANTORO
— 518 —
1978 The production of cultural change: The case of contemporary country music, in «social Research», 45, pp. 292-314.
1979 Revitalizing the culture concept, in «Annual Review of sociology», 5, pp. 137-166.1983 Patterns of cultural choice: A prolegomenon, in «American Behavioral scientist», 26,
pp. 422-438.1989 La sociologie de l’art et de la culture aux Etats-Unis, in «L’Année sociologique», 39, pp.
153-179.1990 Why 1955? Explaining the advent of rock music, in «Popular Music», 9, pp. 97-116.1992 Understanding audience segmentation: From elite and mass to omnivore and univore,
in «Poetics», 21, pp. 243-258.1994 Culture studies through the production perspective: Progress and prospects, in D. Crane
(a cura di), The Sociology of Culture, Cambridge, MA, Blackwell, pp. 163-90.1997 Creating Country Music: Fabricating Authenticity, Chicago, University of Chicago
Press.2000 Two ways culture is produced, in «Poetics», 28, pp. 225-233.2005a In Search of Authenticity, in «Journal of Management studies», 42 (5), pp. 1083-
1098.2005b Problems in Comparative Research: the Example of Omnivorousness, in «Poetics», 33
(5-6), pp. 257-282.
Peterson, R.A. (a cura di)1976 The Production of Culture, London, sage.
Peterson, R.A. e Anand, N.2004 The Production of Culture Perspective, in «Annual Review of sociology», 30, pp. 311-
334.
Peterson, R.A. e Berger, D.G.1971 Entrepreunership in Organizations: Evidence From the Popular Music Industry, in
«Administrative science Quarterly», 16, pp. 97-106.1972 Three eras in the manufacture of popular music lyrics, in R.s. Denisoff e R.A. Peterson
(a cura di), The Sounds of Social Change: Studies in Popular Culture, Chicago, Rand McNally, pp. 282-303.
1975 Cicli nella produzione simbolica: il caso della popular music, in santoro e sassatelli (2008).
Peterson, R.A. e DiMaggio, P.1975 From Region to Class, The Changing Locus of Country Music: A Test of the Massification
Hypothesis, in «social Forces», 53, 3, pp. 497-506.
Peterson R.A. e Kern, R.M.1996 Changing Highbrow Taste: From Snob to Univore, in «American sociological Review»,
61, pp. 900-907.
Peterson, R.A. e Ryan, J.1983 Success, failure, and anomie in arts and crafts work, in «Research in sociology of
Work», vol. 2, pp. 301-323.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 519 —
Peterson, R.A. e simkus, A.1992 How Musical Taste Groups Mark Occupational Status Groups, in M. Lamont e M.
Fournier (a cura di), Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality, Chicago, University of Chicago Press, pp. 152-186.
Peterson, R.A. e White, H.G.1979 The Simplex Located in Art Worlds, in «Urban Life», 7 (4), pp. 411-439. 1981 Elements of Simplex Structures, in «Urban Life», 10 (1), pp. 3-24.
Powell, W.W. e DiMaggio, P. (a cura di) 1991 Il neoistituzionalismo dell’analisi organizzativa, trad. it. Milano, Comunità, 2000.
van Rees, C.J. 1983 Introduction. Advances in the empirical sociology of literature and the arts: the insti-
tutional approach, in «Poetics», 12, pp. 285-310.
Riesman, D.1950 La folla solitaria, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2001.
Rojek, C. e Turner, B.2000 Decorative sociology: towards a critique of the cultural turn, in «The sociological
Review», 3, pp. 629-648.
Ryan, J.W. 2000 The production and consumption of culture: Essays on Richard A. Peterson’s contri-
butions to cultural sociology: A prolegomenon, in «Poetics», 28, pp. 91-96.
Ryan, J.W. e Peterson, R.A.2001 The guitar as artifact and icon: identity formation in the babyboom generation, in A.
Bennett e K. Dawe (a cura di), Guitar Cultures, Oxford, Berg, pp. 89-116.
sallaz, J.J. e Zavisca, J.2007 Bourdieu in America, 1980-2004, in «Annual Review of sociology», 33, pp. 21-41.
sanders, C.R. 1982 Structural and Interactional Features of Popular Culture Production: An Introduction
to the Production of Culture Perspective, in «Journal of Popular Culture», 16 (2), pp. 66-74.
santoro, M.2008 Cultura e società. Tra sociologia e cultural studies, Bologna, Il Mulino.
santoro, M. (a cura di) 1995 Fare cultura. La produzione culturale nel Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino.
santoro, M. e sassatelli, R. (a cura di)2008 Studiare la cultura. Prospettive sociologiche, Bologna, Il Mulino.

MARCO sANTORO
— 520 —
sassatelli, R. 2007 Consumer Culture. History, Theory and Politics, Londra, sage.
schudson, M.1989 The sociology of news production, in «Media, Culture & society», 11 (3), pp. 263-282.
sewell, W.H. Jr. 2005 Logics of History. Social Theory and Social Transformation, Chicago, University of
Chicago Press.
smith, P. (a cura di) 1998 The New American Cultural Sociology, Cambridge, Cambridge University Press.
steinmetz, G. (a cura di)2005 The Politics of Method in the Human Sciences, Duke, Duke University Press.
sullivan, O. e Katz-Gerro, T.2007 The Omnivore Thesis Revisited: Voracious Cultural Consumers, in «European sociolo-
gical Review», 23 (2), pp. 123-137.
swedberg, R. 1997 New Economic Sociology: What Has Been Accomplished, What Is Ahead?, in «Acta
sociologica», 40, pp. 161-182.
swidler, A. 1986 Culture in Action: Symbols and Strategies, in «American sociological Review», 51 (2),
pp. 273-286.
Tuchman, G.1983 Consciousness Industries and the Production of Culture, in «Journal of Communication»,
33, pp. 330-341.
Warde, A., Wright, D. e Gayo-Cal, M.2007 Understanding Cultural Omnivorousness: Or, the Myth of the Omnivore, in «Cultural
sociology», 1 (29), pp. 143-164.
White, H.C.1997 Careers & Creativity. Social Forces in the Arts, Boulder, Westview Press.
White, H.C. e C. White 1965 Canvases and Careers. Institutional Change in the French Painting World, Chicago,
University of Chicago Press.
Williams, R.1981 Culture, Londra, Fontana.1983 Keywords. A vocabulary of culture and society, Londra, Flamingo.
Willis, P.1978 Profane Culture, London, Hutchinson.

INTERVIsTA A RICHARD A. PETERsON
— 521 —
Wolff, J.1981 Sociologia delle arti, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1993.1999 Cultural Studies and the Sociology of Culture, in «Contemporary sociology», 28 (5),
pp. 499-507.
Zaret, D.1992 Critical Theory and the Sociology of Culture, in «Current Perspectives in social Theory»,
12, pp. 1-28.