L la oggetta - s1810afddcc70b759.jimcontent.com · na”: la Tónna è la sua giostra e la sua...
Transcript of L la oggetta - s1810afddcc70b759.jimcontent.com · na”: la Tónna è la sua giostra e la sua...

66660000
Anno XI, n° 1GENNAIO / FEBBRAIO 2006
LLoggettalala
oggettadi Piansano e la Tuscia
Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 26-2-2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Centro Viterbo
Foto di Luigi Mecorio
Pòrociuco
notiziarionotiziario di Piansano e la Tuscia
PPòòrroocciiuuccoo

4 LoggettaLlagen-feb 2006
La Toscana ci piglia sempre unapista. “Così vicina, così lontana”, èstato scritto; più avanti in tutto.
Sembra che si perpetuino, affiancan-dosi, la sua tradizione granducale e lanostra papalina. E dai nostri paesi,subito a ridosso del confine, ne toc-chiamo con mano le differenze adogni pie’ sospinto, in tutti i campi.Questa del convegno sul somaro,per esempio, è un’idea semplice egeniale, di quelle che t’inchiodanoin testa un rimprovero fisso: Perchénon ci abbiamo pensato anche noi?.Un convegno-raduno nazionale diprim’ordine, il pri mo in assoluto inItalia e in Europa dopo quasi cen-t’anni (il precedente data al 1907).Si è tenuto a Grosseto il 28 e il 29maggio scorso con la partecipazio-ne di associazioni da tutta laPenisola, dalla Svizzera, e di altre23 associazioni europee. Al centromilitare veterinario si sono alterna-te sessioni scientifiche ed espositi-vo-fieristiche per cinque aree tema-tiche: l’asino associato a Bambini,Tradizione, Natura, Salute eSpettacolo. Insomma, tra dimostra-zioni pratiche, conferenze, passeg-giate a dorso d’asino, teatro e can-tastorie, favole e filastrocche intor-no al fuoco, si è proposto il “ritornoa un diverso rapporto con gli ani-mali”, la “riscoperta di tradizioniantiche - anche attraverso la tutela,lo studio e la valorizzazione degliasini - per un benessere psicofisicoda riconquistare in armonia con glialtri esseri viventi e conl’ambiente”. Fategli pure, se volete,un po’ di tara parolaia, a tali pro-grammoni in prungioli, ma lasostanza è che si è parlato vera-mente del somaro, del “nostro”somaro, quello della civiltà conta-dina, ossia di tutti i nostri paesi dicui l’umile bestia ha contribuito ascrivere la storia.
Pòro ciuco. Questa espressione noila riferiamo soprattutto ai bambinicon il significato di povero piccolo,poverino, perché ciuco per asino danoi non si usa, mentre è di impiegocorrente come sinonimo di piccolo(contrazione di ciumèco, ciumechét-to, romanesco ciumachèlla?, o piut-tosto, come mi istruiscono e sem-brerebbe più probabile, da unaradice infantile cicc- - da cui cicco,cicca = piccolo - variamente attesta-ta nel Centritalia e già presente nellatino medievale e nello spagno-lo?). A volte, però, l’espressioneviene dilatata ad esprimere generi-camente pietà e compassione, tan-t’è vero che, scherzosamente efamiliarmente, e talvolta con tonofortemente ironico, pòrociuchìsmodiventa l’atteggiamento arrendevo-le di tutti quei genitori che viziano ifigli soddisfacendo ogni lorocapriccio, pronti sempre a giustifi-care le loro mancanze. In ognimodo, Pòro ciuco c’è sembrato ilcommento ideale alla sorte dell’asi-no, che viene chiamato col suonome ma al tempo stesso vienecommiserato per il destino di faticae per l’estinzione cui l’abbiamocondannato una volta che non neabbiamo più avuto bisogno.E’ ben misera cosa, questa nostraattenzione tardiva e del tutto occa-sionale, ma non potevamo far pas-sare sotto silenzio un evento che,proprio per l’enorme importanzaavuta dall’asino nella civiltàcontadina, meriterebbe da parteno stra un maggiore coinvolgimen-to a vari livelli. Cerchiamo dunquedi fare maldestramente ammendaalmeno con alcuni contributiestemporanei e di sapore lettera-rio, ai quali, se sarà il caso, magaripotranno far seguito altri più medi-tati e significativi.
(am)
Le raje del somaro nun rìveno al cielole voce de le puttane nun dicheno ‘l vero
Così recita un proverbio raccolto aPiansano e ricordato proprio piùavanti da Luigi Cimar ra. Senza
entrare nel merito della singolare simi-litudine proposta, non saprei dire se inquesto caso non arrivare al cielo staper non raggiungere una qualche divi-nità misericordiosa, e quindi non tro-vare ascolto, non ottenere soddisfa-zione per qualche doglianza, ma ècerto che al cie lo i ragli dei somari ciarrivavano eccome! L’aria ne erapiena, e le campagne ne risuonavanodi quando in quando come di millealtre voci di esseri viventi.Detto ciò a giustificazione del titolo,aggiungo che l’avvenimento cultura-le grossetano non poteva non inte-ressare anche gli studiosi e cultori distoria locale, specie chi è nato e vis-suto in una città - Bagnoregio “dalcuore” antico e Civita - in cui l’asinoè storicamente parte integrante del-l’ambiente e ha contribuito, in ma -niera determinante, al “miracolo”della sua salvezza. A titolo di contri-buto - nello spazio consentito in que-sta sede - voglio riproporre due
Pòro ciuco
Quando il ragliodell’asinoarrivava in cielo
a cura diG. Battista Crocoli

5LoggettaLlagen-feb 2006
diversi brani relativi all’argomento.Uno, di Vilma Catar cio ne, nella suasemplicità ha una straordinariainten sità drammatica, mentre quellodi Giu sep pe Medori va segnalato perla ricchezza del vissuto popolanonella rievocazione dialettale dellaTónna. Cominciamo da questo.
Il somaro è l’animale della povera gente,bestia da soma, che arranca “da levata acalata” sempre a testa bassa, come i vil-
lani che puzzano di terra e di sudore. Benaltra cosa è il cavallo, il suo parente ricco.Chi va a cavallo è il fattore, il buttero, ilguardiano della tenuta. Il cavallo è anima-le aristocratico, da parata; l’eleganza delsuo galoppo stupisce ed incanta, è figliodel vento. Il cavallo incede maestoso;quando corre, è arrembante. Il somaro,invece, ha un passo lento e uguale, nonforza mai l’andatura, s’inerpica silenzio-so e tranquillo su per l’erta; è una bestiasemplice e spontanea, la sua pazienza èdivenuta proverbiale, sembra quasi nonsentire le botte, sulla sua groppa diven-tano carezze... un po’ ruvide. La moder-nità dinamica, in moto perpetuo,disprezza il suo aspetto dimesso, quasirinunciatario. Ma sotto la pelle piagata earruffata esso cela una vitalità esplosiva,all’improvviso sprigiona con una caricairrefrenabile la sua voglia di libertà. Unoscrittore raffinato come Tecchi riesce anobilitarne la figura, ne riscatta la grama
esistenza, con umanità ed affetto, rie-vocando i ricordi, dolci e malinconici,della sua infanzia. Ma il somaro è ani-male anarchico e lo dimostra.Quando partecipa alla festa, lo fa allasua maniera, è rumoroso, smodato eincontenibile, è una bestia “popola-na”: la Tónna è la sua giostra e la suacorsa. E’ la corsa degli scavezzacolloe degli spericolati. E’ un’impresa eroi-comica. E per raccontarla, bens’adatta la parlata sanguigna edimmediata del dialetto.La Tónna con Cordalenta ePepa rone, i più anziani del paese
- Calò, eh lai! ch’è ora. Chiama su tutti.[= Calonico, eh via! Calonico è laforma dialettale dissimilata di Cano -nico; è Venturino, animatore di tuttele feste]- Bobbi! Meco! Gianni! Tignino! Dotto’su, che ‘ncomenciamo a pianta’ ‘stipassoni.- Sandro, va’ a pija’ ‘r piccone e ‘r palet-to e quanno venghi qua, sbuca micquì.Si fanno i buchi intorno alla piazzaalla distanza di m. 2,50 per conficca-re i passoni, lasciando, tra la superfi-cie lastricata e questi, lo spazio suffi-ciente per far correre due asini alli-neati. Sandro ha iniziato a fare ibuchi.- Cefa! ma que’ nu’ è quello dell’artran-no, nu’ le senti che sotto adè tosto?- Mbè, pròa più là.- Le vedi che mistì va bene.- Tu, Mariscia’, tira su la terra.- E cun che?- Cu’ le mano, mica dirrai che ti fannomale pe’ li calli?!- Piuttosto, rega’, sbrigàmisi. Tutti‘nsieme facemo su ‘sti buchi che ‘nco-ménciano a ria’ ‘sti bagnoresi e po’ ciso’ anche li furischieri.- Tere’, tu regge ‘sto passone che laCefa ‘ncomencia a ‘nzippi’ giù la terrac’un artro.Sistemati tutti i passoni nelle rispet-tive buche, tutt’intorno si ferma unacorda ben tirata.- Sarà ora di tira’ ‘ste corde, ch’adètardi.

6 LoggettaLlagen-feb 2006
- Oh, Bo’! finisci tu cu’ ‘r Coa, che noiannamo gi’ar Bucone a pija’ li somari.I fantini si recano nella vietta, doveprecedentemente sono stati portati i“purosangue”.- Però senza fa’ la giostra, ‘gnunomonta ‘r su’ somaro.Fantini e asini stanno per giungere inpiazza.- Quanno semo s’ar pontone ‘i piazzaémo da sfila’ dui pe’ dui e fa’ bellafigura.- Però ‘r mio è ‘ndiaolato, nu’ vo’ st’aposto.- Ji putìi da l’addòpio, vidìi che ti ci stia.La sfilata, al completo, è arrivata alpunto di partenza tra gli urli, i fischie gli applausi della folla.- Là, facemo ‘sta conta e vedemo manchi tocca ‘r passone.- Via, per ti. Oh! e nun butti giù?- Porca mado’! stìo a guarda’ la mi’
somara che mi sa che va ar somaro.Senti tu, pe’ falla curra!- Via, ridémij giù.- Arì per ti.- So’ quattro: uno, due, tre, quattro.Tocca ma mi.- Furbo, tu quanno hai visto che nun titoccàa, hai ‘nguattato un deto.- Io nu’ l’ho fatto, però se tu nun ti fidi,rifacémici.- Giù, ‘sta vorta per mi.- Uno, due, tre, quattro e cinque; haivisto che mi toccàa.- Dico, quanno semo ma la girata millìar corso, cercamo da nun anna’ su lepietre, sinnò li somari ci sdrùscichino.Allineati i due somari per la parten-za, la folla incomincia a gridare: dajimena! curre! tene ‘r passone che se tela pija, ti frega! Curre, Calò, che venci!Con questo genere di dialogo, macertamente più vivace e più ricco dilazzi, ha inizio uno dei divertimentipiù popolari, in occasione delle gran-di feste del paese: la corsa degliasini. I sedili intorno alla piazza, igradini del sagrato della chiesa, lelogge e le finestre diventano gli spal-ti del piccolo “anfiteatro”, già merca-to, foro, palestra, campo di battagliefestaiòle fin dal tempo degli etruschi. Oggi, forse come allora, la manifesta-zione richiama gente dalle borgate edai paesi vicini, e la piazza, imban-dierata, ritorna ad essere luogo diincontri, di scambi e di divertimenti.
da Civita di Bagnoregio, guida turisticadi Giuseppe Medori
La letteratura locale ci offre altri bellissi-mi “omaggi” al somaro. A titolo di esem-pio, oltre al racconto di Tecchi si potreb-be ricordare la trilogia dialettale in versidi Nazareno Melaragni, già apparsa nellaLoggetta [L’ultemo rajo de ‘n somarochiamato Rampecone (luglio 1996),L’orazzio ne accorata de ‘n somaro su pe’la salita de le Caciare (settembre 2000),Pietà pe’ ‘n nobbile somaro (gennaio2002)], e diversi riferimenti di Dona toDonati, di cui riportiamo questo curiosopasso della novella Matteo (in Maremmadi ieri): “... E faceva il somararo. Ilsomararo! Non crediate ch’egli di soma-ri ne avesse a centinaia. Neanche uno,vivo: li scorticava da morti. Di questasua professione era orgoglioso. Asseriva,infatti, che il villanaccio e il veterinarioglieli ammazzavano: il primo perchébestia più della bestia, il secondo per-ché carnefice d’un innocente. E lui,Matteo, gli ridava nuova vita: scortican-doli, da una carogna traeva un tambu-ro...[...] Il somararo, dunque, era unaprofessione”.
“... Mai vidi - scrisse in propositoTec chi, autore, tra l’altro, del poeti-cissimo racconto autobiograficoQuan ti anni ha la Giulia?, pubblicatoin Storie di bestie ed al quale ri man -diamo per la bellezza descrittiva del -le suggestioni adolescenziali in tornoa quel nome proprio, condiviso daun’asina e dalla ragazzina del primoingenuo innamo ra men to - ... Mai vidi,neppure negli anni dell’infanzia labella piazza più piena di gente vario-pinta e festosa, venuta da varie parti;mai sentii risate più schiette e clamo-rose di quando, nel bel mezzo dellacorsa, qualcuno degli asini, magariquello in testa, all’improvviso scanto-nava in direzione della stalla o si fer-mava cocciuto o invadeva senz’altrol’area di mezzo, incurante della cordae dei pali messi a segnare il recintodella “tonda”; mai mi sembrò che laporchetta rutilante d’oro, su un trespo-lo, in un angolo della piazza, e i“biscotti”, rosolati d’olio d’oliva pic-chiettati d’anice, i famosi “biscotti diCivita” fossero più a posto che in quel-l’ora, in quel momento... Tutto erapaesano e semplice e intimo...”.

LoggettaLlagen-feb 2006
Dalle memorie di Vilma Catarcioneriportiamo la commovente paginasulla morte dell’asino di famiglia ed isentimenti che legavano l’animalealle persone.
Il somaro scapicollato
Ho già accennato al fatto di quanto,a quei tempi, fossero impor tanti lebestie per la povera gente. Ma ilsomaro lo era in modo partico lare,specie per noi di Civita, essendomezzo di trasporto essenziale. “Be -stia da bastone, da basto e da soma”,specificavano taluni. Nel borgo, ognifamiglia ne aveva uno (tranne il cura-to, la maestra e don Pompeo); i ric-chi possedevano anche un cavallo.Allora, un cavallo, un somaro e due otre porci costituivano segno di ric-chezza. Per mio padre, il somaro,rappresentava un vero mezzo disoprav vivenza per tutta la famiglia.Un giorno ci successe una grandedisgrazia: mentre pasturava su di undirupo, s’impigliò le zampe tra lacavezza. Cadde dall’alto e si ruppe ilbacino. Visse tre giorni ancora, mala-mente, finché si dovette abbat terlo,per porre fine alle sue sofferenze. Miopadre patì uno dei dolori più fortidella sua vita. A nulla valse ro la solle-citudine e le attenzioni di mia madreper tirarlo su da quello sconforto.“Come faremo? Siamo rovinati!! Nonabbiamo soldi per poterlo ricompra-re!” - piangeva. Noi bambinipiangevamo con spiritodiverso dal suo; a noi manca -va di più in senso affettivo chein quello dell’interesseeconomico-pro duttivo.L’episodio era avvenuto disabato, giorno in cui dovevoprendere parte alla recitanella sala dell’azione cattoli-ca. Ero la protagonista di unapiccola tragedia, “La tradita”,adattata dal curato che, qualeregista, aveva assegnato levarie parti. Beh... la recita furimandata al sabato seguente,con tanto di cartello chesegnalava l’accaduto e... ilcom prensibile lutto.
da Nel cuore di CivitaViterbo 1997
Nel trattare delle tradizioni, delleconsuetudini di Grotte di Castro,della sua economia e quindi del-
l’agricoltura, non si può fare a meno didedicare un breve spazio ad un animalesemplice, rude, di scarse esigenze, diu-turno infaticabile collaboratore di mol-teplici generazioni di grottani: l’asinocomune. Il somaro fu un compagno fede-le del villano in ogni momento e situa-zione nell’attività di campagna; si resecosì utile da divenire indispensabile, edoggi che nel nostro paese è del tuttoscomparso, per ricordarne i meriti biso-gnerebbe fargli un monumento. Qualcuno, in modo scherzoso, sole-va dire che il nostro era il paese dovegli asini si affacciavano al terzopiano. Negli anni ‘30 ogni famigliaaveva una stalla ed il numero deisomari fu così elevato che raggiunsela quota di circa mille presenze.L’animale, se addestrato con costan-za, metodo e pazienza, eseguiva con
regolarità tutte le operazioni coman-date; qualora invece era nelle mani diun cattivo maestro e veniva maltrat-tato, diventava testardo, bizzoso, dif-ficile da governare. Il suo impiegoprimeggiava soprattutto nei lavori ditrasporto e per questo era provvistodi un robusto basto di legno, fodera-to in alcune parti di pelle e corredatodi utili accessori: i giaccoli, la stracca,il sottopanza. Con i giaccoli si legava-no i bigonzi, i barili, i sacchi di patatee di frumento ed altri tipi di soma.Quando si effettuavano trasportivoluminosi tipo lolla, faciolume, fienoe paglia, si usavano come contenito-ri i pannoni, che per sicureza eranofissati con la susta, ben tirata e tesa amezzo di un pezzo di legno detto tat-tero. Di norma il somaro, oltre al nor-male carico, trasportava l’uomo,mentre la donna seguiva a piedi e neitratti in salita si attaccava alla codaper fasi trainare. Per poterlo gover-nare, oltre alle sollecitazioni trasmes-se con la capezza, si usavano icomandi a voce che erano semplici ebrevi: l’esclamazione Ah, ripetutaper stimolarlo a muovere; le paroleArrisù e Arrigiù per i movimenti in
Il paesedove gli asini si affacciavanoal terzo piano
di AdelioMarziantonio

8 LoggettaLlagen-feb 2006
salita o in discesa, oppure Arrisutò oArrisutacassutò quando i tratti da per-correre erano più difficili ed impe-gnativi; l’espressione Le come ordineper fermarsi; Arrecà, Arrelà e la paro-la Poggia per gli spostamenti laterali.In un ambiente dove così intensa erala presenza dei ciuchi, non potevamancare l’impiego folcloristico-spor-tivo di questi tenaci servitori. Il gior-no di S. Antonio si svolgeva la corsaa pelo degli asini da Piazza S. Marcolungo la Via Cordelli Scossa; per lafesta della Coroncina erano montatida cavalieri provvisti di bastoni con iquali, al galoppo, dovevano, per vin-cere, infilare e rovesciarsi addossouna mastella piena di acqua appesain alto ad una corda. I premi per i vin-citori erano pagati in natura: agnelli,maialetti, polli e conigli.Credo che il momento migliore delrapporto padrone-somaro si verifi-casse alla sera, quando, rientrandoin paese, era d’obbligo una sosta alfontanile per l’abbeverata; durante labevuta, il contadino accompagnaval’operazione con un fischio particola-re con il quale trasmetteva al somarofiducia, sicurezza e tranquillità.
da Ricordi ed immagini di Grotte di CastroAcquapendente 1998
Da bambino, quando la mia mentefantasticava ed inseguiva i sognicome inseguiva le nuvole e le far-
falle, rimanevo incantato a sentire lafavola dell’asino cacazecchini: mi pia-ceva quella bestia umile e maltrattata,che alla fine colmava d’oro il suo pove-ro padrone, riscattandone la condizio-ne di sfruttamento e di miseria. L’asinoaveva tutta la mia simpatia, anche seper le strade polverose dal suo orifiziocadevano, invece di monete scintillantie sonore, escrementi fumanti dall’odo-re aspro o peti rumorosi e mefitici.E sì, il somaro si è volatilizzato intor-no agli anni ‘60, si è “estinto” dopol’avvento invasivo dei motori a scop-pio, della civiltà meccanizzata, adalta velocità, in perpetuo motosenza meta. L’asino, la bestia da soma, dal passomonotono, sempre uguale, che sem-
bra non avere slanci, non avereespressione, è la personificazionedell’abnegazione e del sacrificio.Compagno di stenti e di fatica delcontadino, animale frugale e senzapretese, sempre curvo sotto pesieccessivi senza un fiotto, senza unminimo lamento. I suoi ragli, chemordevano la luna, erano canti didesiderio e d’amore, erano lo sfogodi un istinto, che l’uomo reprimeva.Quando s’abbeverava alla fontana,allora era avido, sembrava che le sue
“Sua Maestà il somaro”di Francesco Ranucci
“Questo volume termina con l’elogio di “Sua Maestà il somaro”. Non sembri irriverentequesta chiusura! La civiltà di Valentano è incentrata sugli uomini. L’uomo è sog-getto e oggetto del diritto; l’uomo ha costruito qui un genere particolare di civil-
tà in cui noi cittadini ci riconosciamo e di cui andiamo orgogliosi. Ma l’uomo di Valentano,senza somaro, era... un uomo morto. L’acquisto di un somaro era un grande momento difesta familiare ed occasione di liberazione dalla fatica; la morte del somaro era disgraziairreparabile.L’ultimo somaro che ebbe mio padre si chiamava Crastone: un somaro famoso in tutto ilpaese che morì ultraventenne intorno al 1950. Mio padre diceva che l’anno successivoavrebbe fatto il soldato! Era... un gran somaro! Lo ricordo con ammirazione e con rimpian-to; lo ho cavalcato da bambino, mi sono attaccato alla sua coda salendo su per le coste;l’ho visto trasportare indomito sacchi di grano, di fave, di fagioli e bigonzi di uva... Era sem-pre serio: attento al suo lavoro, non ragliava mai... si faceva i fatti suoi e mangiava tutto,senza preferenze. Mio padre gli dava qualche mezzo staio di biada solo quando lo impe-gnava in un lavoro eccessivo e faticoso nell’arco di tutta la giornata.Morì una notte di inverno, nella stalla, all’improvviso. Non fece in tempo a fare il militare! Miopadre lo trovò lì disteso, la testa abbandonata per terra; ci pianse di dispiacere perché avevaperduto un collaboratore prezioso e... un amico. Piansi anch’io quando il veterinario ne constatò la morte e mio padre con i suoi amici locaricarono su un carretto e poi lo portarono ai Felceti, in un luogo appartato, dove giacque abbandonato, insepolto, ma rimpianto!”
da Cultura giuridica e società civile a Valentano nel 1500di Giovanni e Francesco Ranucci, Castelmadama 1994
Perèlle(DomenicoMadrignani)
Qui cascòl’asino mio...in aselli memoriam
di Luigi Cimarra

9LoggettaLlagen-feb 2006
sorsate fossero senza fine, il suomuso s’immergeva nell’acqua frescacome se volesse prosciurgarla. Ognigiorno una povera razione d’orzo euna razione abbondante... di bastona-te. Un’esistenza grama e grigia come ilsuo pelame. Non era bello, il somaro,ma il suo occhio immenso esprimevauna tristezza dimessa e accettata. Di questo animale, che per millenniha servito l’uomo nelle lande piùimpervie e desolate, che cosa è rima-sto nella memoria collettiva? Certa -mente gli apologhi, le favole, le sto-rielle che alla fine contengono uninsegnamento morale, spesso ama ro,non solo per l’animale. Inoltre leespressioni d’ingiuria: Sei un somaro!Sei un asino calzato e vestito! Asinoche sei! Fijjo de ‘na miccia! (= “asina”,donde nella zona cimina: miccétto emicciarèllo, “asinello”). Ma esso la faancora da protagonista in numerosidetti, modi di dire e proverbi:
Qui cascò l’asino mio. Ci-ha la grazzia dell’àsino.L’asino porta la pajja, e ll’asino se lamagna (Viterbo).Capoccia d’asino nun ze pela mmai.‘L zumaro dov’è cascato ‘na vòrta ‘nci casca ppiù (Viterbo).“... zomaro se ne ‘ccorge a mmaggioche nun gi-ha ppiù ‘a coda (CivitaCastellana).Le raje del somaro nun rìveno al cielole voce de le puttane nun dicheno ‘lvero (Piansano).Me pare la mula de Ggènova: se face-va magna’ dae mosche, pe’ nun scac-ciasse coa coda (Civita Castellana).Il somaro del mi’ parente, porta lasoma e ‘n ze la sente.
Sumaro mio, nun perì che mmaggioha da veni’ (Tuscania).Sia dall’asino che ddar mulo sta treppassi distante dar culo (Canepina).E mmèjjo ‘na gamba de cavallo fracioche ‘n asino bbòno (Canepina).Senti’ ‘l mózzico del somaro (= fare unabrutta esperienza, o imparare amara-mente a proprie spese, Piansano)“... cavallo pe’ ccurre’, ‘o mulo pe’ttira’, ‘o somaro pe’ bbiastima’” (Ci -vita Castellana).Vòe ammazza’ ‘r zumaro? Fa’ er por-traccio (Blera).Co somaro ce vo’ ‘a frusta (CivitaCastellana).Chiude la stalla quanno ‘n c’è ppiù ‘lsomaro (Piansano).Sant’Antògno mio, sàrveme ‘r bastoché ‘l zomaro ll’arefàmo (Celleno).‘L bove disse cornuto all’asino, pe’ nu’rimane’ ffregato (Piansano).Lega ll’àsino ‘ndo vo’ ‘l patróne(Tuscania-Piansano).Gola de miccia! (= ghiotto, Piansano).
Se nell’ambito proverbiale, le atte-stazioni sono innumerevoli con va -lenze multiple, le tracce del ciuc-cio/asino compaiono raramente neitoponimi, sebbene la sua presenzaaccanto all’uomo sia stata continuafin dalla remota antichità. Una primatestimonianza viene da Monte fiasco -ne, dove gli abitanti del centro dileg-giavano i contadini con l’appellativodi “villane codone, perchéss’attaccàvano a la coda del somaroquanno salìvono la china p’arrivàfino al paese”. E si capisce che sifacevano trainare dal somaro! Lasera tornavano sfiniti, dopo la durafatica nei campi, per consumare unacena frugale. Ebbene nell’archiviocittadino, in un documento in cui sidescrivono i confini di una proprie-tà, si legge: “Vicino al fosso del Ne spolo, per ilquale fos so andarà sino al braccio didetto fosso, che fa capo alla Fontanel -la nel la Strada Romana in luogo dettoil Salto dell’A sino, e da d(ett)o luogoper linea retta andarà alla casa dettadi S. Rocco, e da d(ett)a casa per li -nea retta andarà alla strada delle Pog -gera”. [Arch. Com. di Monte fiasc., n°30, ff. 147-148, Libro delle Rifor man ze1687-1693 - “Die dom(ini)co 16 Mar tii1692, Macello diligenze, Capitoli eBandita nuova et offe(r)te”].Sempre a Montefiascone sono anco-ra in uso i toponimi come Poggio del-l’asino e Asinello; quest’ultimo con
riscontri altrove nell’Alto Viterbese.A Civita Castellana nella tradizioneorale si registra il curioso microtopo-nimo ‘O paradiso di somari, che indi-cava il pendio scosceso di una valla-ta, dal quale venivano precipitati glianimali vecchi, ormai inutili, o le lorocarcasse, una volta che erano morti.Ad un allevamento di equini (cavallied asini) allo stato brado, soprattut-to nell’area maremmana, rimanda iltermine Polle dra ra, una vasta zona asud di Tuscania. Se mancano nelLazio e nel Viterbese pittoreschi no -mi di luogo, come Apprez za mi l’a -sino della Lucania, rinveniamo ac -canto a Malcavallo (Lanuvio) e Sfer -ra cavallo (Monti della Tolfa), topo-nimi composti come Focalasino(Gal lese) = Affoga la sino (Tarquinia),per indicare i guadi particolarmentedisagevoli, in cui spesso i poveri ani-mali, sempre sovraccarichi, corre-vano il rischio di annegare. In locali-tà prossime al confine con la To -scana ricorrono formazioni del tipoBricco (Canino) e Poggio Bricco(Ischia di Castro), presumibilmenteda bricco, boricco, buricco = asino(forse va qui anche il soprannomeischiano Bricchétto). I somari del Vi -ter bese avrebbero potuto vantareun santo patrono, San Giu mento(Orte). Peccato, però, che essi sisiano pressoché e stinti e che ilnome del santo sia solo la storpiatu-ra di san Clemente. Così non c’èrimasto nessuno a proteggerli!
‘L rajo del sumaroA me m’ha sbalordito sempre ‘l rajjo,quello che fa ‘l sumaro quanno canta:de note ce ne fa più de millantae pare che ‘n ce fa manco ‘no sbajjo;slarga le froce al sole e po’ beatoride come si suo fusse ‘l creato.
Che ce sarà ‘nguattato ‘n quel motivo?S’ariccommannerà de soprassalto(quanno che canta cor quel muso in arto)a chi del monno è stato il creativo,che faccia sta’ più bono ‘l su’ patronequanno affionga per bene sul groppone?
S’è tanto abbituato a tortorateche lue ce canta sopra a squarciagola,e nun lo sa che doppo... la mazzòla(ce so’ sempre de mezzo le sonate!)pure da morto sopra la su’ pelle,sul tamburo je fa veda le stelle.
Chissà si all’aldillà cambie ‘l creatoe chi l’ha prese, mo’ le die benone;ce sie di là la legge del tajjone,e chi l’ha date, lì venghe crocchiato.Però qui ‘n terra è mejjo nun pïalleperciò si pòe, cerca d’evitalle.
Luciano Laici

10 LoggettaLlagen-feb 2006
Questo aspetto, per la verità, non siriferisce propriamente agli asini,perché l’impiego di questi nel-
l’esercito è stato del tutto episodico emarginale. Furono so prattutto muli ecavalli, più robusti ed imponenti, adessere arruolati per scopi militari, ma lapratica della loro selezione testimoniaanch’essa dell’importanza degli equiniin genere nella vita dei nostri paesi finoall’altro ieri. Non solo, dunque, le filemattutine di uomini e animali sulla viadei campi, coi richiami, i cigolii dei carri,le soste per l’abbeverata, i rientri allestalle all’imbrunire con l’andaturaspenta e la stanchezza nelle ossa; nonsolo le benedizioni propiziatorie con lebestie infiocchettate, il fuoco ritualedalle lute alte e scoppiettanti, quel-l’aria da fiera sacra coi ragli, lo ster-co e l’odore di stalla misto al fumo;non solo una quotidianità di rappor-ti fatta di premure e di imprecazioni,di incombenze minute e continue, dipromiscuità, con gli anelli al murofuori delle porte di casa per legarvigli animali..., ma anche le imposizio-ni militari, quelle che periodicamen-te facevano radunare i quadrupediin un campo per la loro visita seletti-va. In date stabilite venivano dei veteri-nari dell’esercito che li esaminava-no, li registravano con le loro carat-teristiche in una anagrafe specialetenuta in municipio, e poi ne annota-vano l’esito a fianco: “non idoneo”,“precettato”, “venduto”, “fuori età”,“trasferito a...”. Un’annotazione piùparticolareggiata, secondo le catego-rie “da sella”, “da tiro” e “da soma”previste dal regolamento, potevaessere “Idoneo sella truppa”, comeper esempio per il cavallo Bicchie -rino del pòro Anselmo Falesiedi, oanche “Idoneo salmerie leggere”,come per il famoso Pippo dei fratelliMelaragni (ricordate l’articolo Il
mulo Melaragni Pippo?). Al contrariopotevano esserci specificazioni dinon idoneità. La Pupa di Chécco de laRosilde, per esempio, era una mulet-ta con “difetti di proporzione”, per-ché, pur mancandole solo la parola,col suo metro e trentacinque di sta-tura a momenti era più larga chealta; così il mulo Pacioso di Candido,
che arrivava a uno e cinquantacin-que ma era una barca. Peperino diGiulio de Règge era un mulo con“tare e difetti all’apparato locomoto-re”, che è un modo serioso di direche procedeva mezzo sciancato e amomenti scalciava di lato come lemucche; così la mula Mora di PèppeMosca telli o la Dora di Pèppe Ciofo.Il mulo Pallottino del Birèllo aveva
l’“artrite tarsica bilaterale”, la mulaRosa di Pippa fòrte “difetti di appiom-bi”, e Pacioso di Pistolone dev’essereche era diventato “pacioso” proprioperché aveva una “malformazionescheletrica” che non gli consentivatante bizzarrìe.Un’anagrafe in piena regola, colnome del proprietario, la decorren-
za del possesso del quadrupede etutti i dati di questo: specie (mulo ocavallo), nome, sesso (conl’indicazione se castrato per imaschi), anno di nascita, statura,mantello ed eventuali segni partico-lari. Se riconosciuto idoneo,l’animale veniva precettato, vale adire tenuto in una sorta di libertàvigilata a disposizione per eventuali
di Antonio Mattei
Soldatia quattro zampe

11LoggettaLlagen-feb 2006
chiamate, e all’occorrenza requisito.Ovviamente in questo caso era pre-visto un indennizzo, ma a prezzi“governativi” che non ripagavanocerto della perdita e dei disagi.“Signor capitano... - imploravano icontadini rivolgendosi indifferente-mente a qualsiasi ufficiale o gradua-to presente - Signor capita’... si melevate ‘sto muletto, so’ rovinato!”. Equei militari, lì, a prendere misure ead annotare, a volte più burbesca-mente e a volte più comprensivi, mapur sempre nel ruolo di “strumentidi occhiuta rapina”. La requisizione - ultimamente moltorara, in verità - non avveniva maiseduta stante, ma il timore era taleche ogni volta bisognava evidenziar-lo a chiare note nei bandi e nelle let-tere di precettazione. Tanto, non gio-vava, e si andava all’appuntamentocon inevitabile apprensione. Chiaveva una bestia anziana o con qual-che difetto, affrontava la prova conminor patema d’animo: semmai, sisarebbe trattato di perdere una mat-tinata di lavoro; ma per chi aveva unbell’animale, era una preoccupazio-ne seria. Sicché i contadini ricorre-vano a qualsiasi stratagemma, maga-ri pungendo l’animale con un ferrosotto lo zoccolo per farlo zoppicare,salvo poi curarlo per giorni dopo larassegna. Alcuni, proprietari di piùanimali - perché nati “in famiglia” aseguito delle monte periodiche eallevati come pollére, puledri - maga-ri avrebbero anche acconsentito avenderne qualcuno, ma certamente
non a quei prezzi. Per cui in caso diprecettazione, proprio per non sen-tirsi sulla testa quella spada diDamocle della requisizione, magaririvendevano immediatamente labestia a forestieri tacendo di quellaparticolare ipoteca. In somma, tuttal’operazione era sicuramente unaltro penoso gravame, ragione nonultima della maggiore diffusione delsomaro, almeno tra gli strati piùpoveri della popolazione e in tempidi più diffusa miseria generale. La rivista periodica di cavalli e mulirisaliva almeno all’unità nazionale,introdotta in contemporanea con lacoscrizione obbligatoria e iniziatacon un censimento generale dispostoda una legge dell’ottobre 1873 (comemi segnala l’informatissimo amicoMarzian to nio, generale di cavalleriain pensione). Inizial mente veniva ese-guita con maggiore frequenza, ma inquest’ultimo dopoguerra si era allun-gata negli intervalli fino a scompariredel tutto dai nostri paesi sul finiredegli anni ‘60, con l’avvento dellamotorizzazione di massa e la definiti-va sostituzione degli animali qualiforza-lavoro (ricordate Addio allacavalleria?, il bell’ar ticolo di AlbertoPorretti pubblicato nella Log getta delmarzo 2003?).Tra le scartoffie dell’archivio comu-nale di Piansano sfuggiteall’“inscatolamento” perdurante, dicui si è già detto tempo fa, mi è capi-tato di imbattermi in un Registro deiquadrupedi; credo l’ultimo dellaserie. Sembre reb be impiantato nel
1950 e riporta i risultati di quelle chedovrebbero essere state le ultimetre visite ispettive militari: del 1954,del 1958 e del 1968, eseguite nel-l’area antistante il campo sportivo.Nell’aprile del ‘54 risultavano ancoraesistenti nel territorio comunale 80muli, di cui furono visitati 63 e rico-nosciuti idonei 25. Nel marzo del ‘58ne furono passati in rassegna 75 eprecettati 13 (sono indicati anchetre bardotti, ossia incroci di un caval-lo con un’asina, anziché di un asinocon una cavalla). Nel novembre del‘68, infine, risultano ancora presenti37 muli, di cui solo uno giudicatoidoneo. Se a questi aggiungiamo inumerosi cavalli (solo i fratelli DeSimoni ne avevano registrati unadecina) e i somari, che come abbia-mo detto erano esclusi dalla rasse-gna, si ha la percezione chiara di unapopolazione animale ancora piutto-sto consistente. D’altra parte, finoalla prima metà del secolo scorsoerano veramente molto poche lefamiglie che potevano fare a meno diuna bestia da lavoro, e dunque dob-biamo stimare, “a regime”, un miglia-io di presenze o giù di lì. Fa uno stra-no effetto, dunque, constatare comeun fenomeno così rilevante fino auna quarantina di anni fa, appaiaoggi quasi preistoria, tanto è lontanoe diverso dal nostro modo di vivere.E’ difficile perfino rintracciarne i pro-tagonisti: i proprietari deiquadrupedi sono an ch’essi tuttiscomparsi o ridotti al lumicino,tanto da far fatica a recuperarne
Immagini della “grande guerra” tratte dal libro Quei morti ci servono dello stesso autore.Nell’ordine: trasporto del rancio, trasporto di sabbia per le trincee, trasporto di artiglieria da montagna(foto scattate dal sergente Giulio Compagnoni)

12 LoggettaLlagen-feb 2006
ricordi personali e testimonianze.C’è rimasto questo registro comeuna reliquia, un elenco di nomi chein realtà è un mondo, reperto di unaciviltà che rivive ormai soltanto nelricordo. Par di rivedere Cèncio Belano conCorallo, un cavallo baio, balzano alpiede destro; Paridino con la cavallaRondinella; Dora del pòro Pòlido,anch’essa baia con una macchia algarrese; il vecchio e curvo Santi -nèlla, che quando la sera risaliva lasalita della Croce a cavallo del suosomaretto sardo, i piedi gli striscia-vano per terra. C’erano le Culopienecon Levantino, Farfalla, Furbetta;Armando del Grambino col muloPacchiarotto e suo fratello Mario conGrigia; Pèppe del pòro Impero con lacavalla baia Vespina; Gigi de laBellamòra col mulo Pavoncello, poiaffiancato da un cavallo montato dalfiglio Ugo... Oltre che un sopranno-me, Baiardo era anche il cavallo diBannitèlla, mentre il mulo di Andreade la Gasparona e il cavallo Fiorellodi suo fratello An ge lo finirono allaPescia con il trasferimento al po -dere... E poi ci sono i “campioni”: ilglorioso Rabicano di Carlo de la Ta -chìna, un baio scuro della clas se1937 che pareva am mae strato;Tauras, il cavallo po mellato di Chéc -co de Diodàto; il famoso Tarzan dei
Fo de rini, cavalcato dal zi’‘Ntògno e vincitore dinumerose cor se; il vecchiostorno del sòr Lauro, Ron -dello; Corallo e Rondi nella diCèncio de le Mastro chec -chétte, che col suo calessinopareva un fattore; il cavalloMer lino del Belnèno; Mada -ma, il morello maltinto diCèn cio de la Leonilde; Silio, ilsauro del Calònico... E poitanti nomi che sembra di riu-dire nei richiami lungo lestrade polverose, ora affet-tuosi ora rabbiosi: Volantino,Carolina, Falchetto, Picchio,Burat ti no, Africano... Lola erala mula di Galardino, che poine comprò uno più giovane elo chiamò Ernesto; Rosignoloera quello di Garibaldi,mezzo baio e mezzo sauro;
Catena aveva una mula che sichiamava Pèppa e Rena to Talucci ilmulo Scala brino; Pietro Veneri avevaun cavallo così focoso che lo chiamòVulcano, Gigget to de Girolamo unbardotto scuro che chiamò Bocca -nera e Stortoni un mulo di nomeSerpente... Dietro questi nomi c’è tut taun’economia di paese, rituali,episodi comici op pure tragicie toccanti: la cavalla diPeppinèllo tirata fuori intossi-cata dalla stalla andata afuoco; lo stesso Peppinèllo -sfortunato con le bestie -rimasto permanentemente in -valido per essere finito sottoil carretto rovesciatosi;Chécco del pòro Brizio mortodopo essere finito sotto ilsomaro con tutto il basto; lacavalla del pòro Narciso -Stella, splendido e intelligen-tissimo esemplare - che per lastrada di Tusca nia tornòindietro con tutto il carrettinodopo essersi accorta che ilpadrone era caduto rimanen-do a terra piuttosto malcon-cio... Bannellóne, invece, era cosìsciagurato che le bestie glimorivano tutte dopo esserediventate pelle e ossa. Unavolta comprò un cavallo che
era le sette bellezze. Lo teneva in unpezzetto di terra all’imbocco dellastrada del Pozzarèllo. Anche questosi ridusse uno scheletro e alla fine lotrovarono “impiccato”. Sicco me ilpadrone tralasciava regolarmente didargli da mangiare, dev’essere che labestia si spingeva a brucare semprepiù sul ciglio di una scarpatella e allafine - o che sia scivolata, o che il ter-reno abbia ceduto - la trovaronopenzoloni, strangolata dalla ca pezza.Natu ral men te la gente ci scherzòsubito su e disse che l’animale si eravoluto “suicidare” per non combatte-re più con quel padrone. Dentro il fosso ci finì una voltaanche il mulo di Lib baratèllo,il quale aveva una di quellemacchinette da carosino eperiodicamente ra deva dasé il pelame folto e setolosodell’animale. Im pa sto rava labe stia le gandola an cheper le zampe, in unospiazzo fuori dellastalla che davaappunto sul fosso,e iniziaval’operazione. Ma
Calendario dell’ultima (?) rivistae precettazione di muli nellaprovincia di Viterbo del novembre 1968
Vecchio sull’asino(Calcata 2003,
foto di Giuseppe Cionco)

13LoggettaLlagen-feb 2006
non doveva avere la mano tanto feli-ce, perché l’animale finì giù proprioper divincolarsi nel tentativo di sot-trarsi a quella tortura.Il somaro di Titta pare di averloancora davanti. Era sano, ossia nonca strato, ‘nvizzìto e ombroso alpunto che il padrone l’aveva chiama-to Nervino. Correva sempre.Spuntava il trotto appena fuori dellastalla e non si fermava se non quan-do era arrivato alle Mandre. Tutte lemattine, all’altezza della fonte delGiglio era una commedia. Quellaconcentrazione di bestie coi carrettiin fila per l’abbeverata provocavastrane reazioni. Il somaro di Titta sistraniva, prendeva via a muso ritto,mezzo di traverso, sfrogiando edigrignando i denti, e il vecchio nonce la faceva a tenerlo nemmeno acapezza. Le imprecazioni! Se poi isomari incrociavano o “sentivano”per strada qualche miccia, era undisastro: strattonavano, cambiava-no improvvisamente direzione, cari-cavano la femmina incuranti deipadroni e del le legnate: una guerra.Anche l’abbeverata mattutina oserale, per alcune bestie, era unacroce. Nonostante il fischio modula-to e rassicurante del padrone, il mu -lo di Stortoni non c’era verso cheappozzasse il muso nella vasca:bisognava scendere e prenderglil’acqua col secchio. Fin ché l’uomo sistufò, e quando la bestia prese a tor-cere la testa dalla parte opposta delfontanile, lui la condusse diretta-mente alla stalla facendole saltare labevuta. L’indo mani si ripeté la stes-sa storia, ma il terzo giorno, fuori disé per la sete, la mula spuntò lacorsa e per la foga finì nella vascaanche con le zampe.Il mulo di Cignalino bisognava attac-carlo al carretto in tre, la mattina:davanti rampava e mordeva, dietrosparava calci. “Lo vedi come lo tengo-no stretto? - diceva qualcuno scher-zando -: hanno paura di trovarne unomigliore!”. Quello di Carlo Mecorio sichiamava Pippo ed era alto e ossutocome il ronzino di don Chisciotte.Tutte le mattine era una scena. Ap -pena si sentiva infilare la testiera e ilpettorale, cominciava a sgroppare ea scalciare ritmicamente. Dura va unpo’, grugnendo e schiumando di rab-
bia, poi pareva calmarsi. Quin di Car -lo metteva il sellino, e via di nuovol’animale con la scomposta e rumo-rosa protesta. Carlo aspettava anco-ra e finalmente attaccava il carretto,che provocava la terza ed ultima rea-zione, la più sgangherata. Per quan-do si mettevano in marcia, bestia epadrone erano già mezzo finiti.E poi c’erano le cicatrici indelebili percalci o morsi dei somari, che quandofacevano presa, non c’era verso difarli mollare nemmeno a bastonate; ilviavai per le fiere per le compravendi-te; il facocchio, e il bastaro, e il veteri-
nario alla dottor Gessi; le liti e le ripa-razioni per i danni arrecati dallebestie che sconfinavano; l’odore distabbio e i ragli dalle stalle in prossi-mità delle case; lo scalpiccìo dei qua-drupedi sul selciato e il puzzo dellozoccolo bruciato per la ferratura dalFabbretto giù in fondo al paese...... Non ci sono più. Niente di tuttoquesto c’è più, travolto dal “progres-so”. E il protettore San Giumento,come dice Cimarra, se anche ci fossestato, sarebbe rimasto disoccupato.

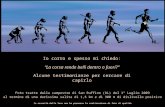









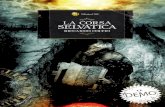







![Nuova Opel Corsa - Moto · Nuova Opel Corsa E FRORU il carattere La nuova Opel Corsa E FRORU WL FRQVHQWH GL SHUVRQDOL]]DUH O¶DVSHWWR GHOOD WXD vettura e di esaltarne la linea dinamica](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5f03dac57e708231d40b17f1/nuova-opel-corsa-moto-nuova-opel-corsa-e-froru-il-carattere-la-nuova-opel-corsa.jpg)