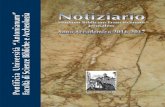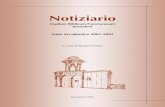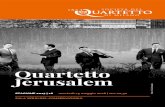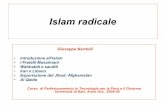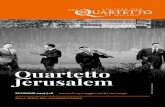Jerusalem
-
Upload
carlo-fiore -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of Jerusalem
Fotografie di:roberta VillaFulvio Gervasonialessandro De lisi
editing e graphic design:Venti caratteruzzi
inDice
stefano macaleDa Auschwitz a Gerusalemme [p. 6]
alessandro De lisiUna lettera da Gerusalemme [p. 14]
Daniele rocchettiRestare terzi [p. 36]
PERCORSI DI EDUCAZIONEE MEMORIA
Questo materiale fotografico e docu-mentario è pensato come testimonian-za del viaggio che la Filca-Cisl Lazio ha compiuto in Israele e Cisgiordania nel febbraio del 2010. è impossibile restitu-ire la bellezza dei luoghi e la ricchezza degli incontri che hanno caratterizza-
to questa esperienza, ma attraverso la parola e le immagini rispondiamo all’impegno di fare memoria, di non smettere di pensare, di continuare a tenere aperti gli interrogativi che una terra così ricca di contraddizioni ha fatto nascere in noi.Se per molti il viaggio in Terra Santa può assumere la forma del pellegrinag-gio, dell’atto di fede e preghiera nei 8
luoghi della vita terrena di Cristo, per un’organizzazione sindacale come la Filca questa esperienza si offre anche come occasione per riflettere su temi che solo apparentemente sembrano lontani.Gerusalemme rappresenta una metafo-ra vivente della co-esistenza tra popoli, culture e religioni differenti. Ci aiuta a confrontarci col tema della diffidenza,
della paura e degli inevitabili pregiudizi verso l’altro da noi, così presenti anche nella nostra società e in un settore, come quello dell’edilizia, che sempre più si confronta con il dato del multi-culturalismo.Ma Gerusalemme ci allena anche a mettere da parte il nostro costante bisogno di schierarci dalla parte degli uni o degli altri, ci chiede lo sforzo di 9
ascoltare senza pretendere di com-prendere tutto, ci mostra quanto poco sappiamo, e quanto poco sia utile la nostra tendenza ad attribuire torti e ragioni e a immaginare facili soluzioni.Questo viaggio, se diventa occasione di ascolto reale, ci insegna la neces-sità assoluta di restare terzi, come ha sottolineato Daniele Rocchetti anche in queste pagine e come più volte ci hanno invitato a fare i testimoni e i volontari che lavorano sul dialogo e la convivenza tra le parti: restare terzi, senza smettere di indignarci di fronte alle ingiustizie e ai soprusi.Questo percorso diventa allora for-mativo nel senso più alto della parola. Interroga le nostre coscienze come uo-mini, come cittadini e come operatori sindacali, anche attraverso il confronto con chi fa sindacato in questi paesi e si
impegna per costruire tutele e condi-zioni di uguaglianza tra lavoratori, a prescindere dalla loro nazionalità.Il viaggio è stato un’ulteriore tappa di un percorso educativo e formativo sui temi della memoria e della responsabilità che la Filca Lazio sta realizzando dal 2008, quando, insieme alla Filca Lombardia, ci siamo recati in Polonia, nei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau.La visita dei luoghi e l’ascolto delle storie della Shoah, accompagnato in quell’occasione dalle parole di Primo Levi e dei sopravvissuti alla deporta-zione, ci ha consegnato la responsa-bilità della testimonianza, dell’essere sentinelle vigili di fronte alle derive e ai rischi – sempre presenti e quanto mai attuali – prodotti dalla cultura dell’intol-leranza, della chiusura e della diffiden-za verso gli altri da noi, trasformati in 10
“stranieri” stereotipati e senza volto. Questa strada da Auschwitz a Geru-salemme rappresenta un’occasione di crescere insieme, dirigenti e operatori, così da riportare a casa una visione nuova, più aperta e per questo più moderna di sindacato, perché sempre più sappia essere luogo e laboratorio di ascolto, dialogo e convivenza tra uomini e storie differenti.11
Gerusalemme è anche la mappa dei limiti italiani. Finita l’epoca delle ideo-logie, crollato il muro, dimessi i partiti storici, in Italia resta il campionato di calcio. Vero centro degli interessi ideali della maggioranza dei nostri concitta-dini, tanto che il sistema degli scontri, dei punti e delle strategie è applicato alla politica e all’economia: il calcismo. La comoda abitudine di casa nostra di dividere tutto in squadre, che quasi mai pareggiano, in Israele non trova possi-bilità di applicazione. Anche ciò che osservi, se stai attento, non risponde alle abitudini nostrane, a cominciare dalle tante opere d’arte.A prima vista, affidandosi esclusiva-mente alla memoria fotografica non selettiva, le icone bizantine sembrano tutte uguali. Stesso fondo oro, panneg-gio delle vesti del santo piuttosto
pittura, di cultura e di rinnovamento storico non può funzionare. Alla parete del tinello della casa di Hanna si trova la copia della Madonna della Tenerezza, immagine assai diffusa nelle case del Mediterraneo orientale. Hanna è madre di quattro ragazzi, seppur essendo lei stessa poco più in là della giovinezza, abbandonata dal marito, aiutata dalla vicina. Hanna lavora sempre, in un albergo e poi a casa per mandare avan-ti la troupe di giovanotti, tanto appas-sionati di calcio. Non sarebbe una storia esemplare se non fossimo nel cuore di Gerusalemme, cento passi e poi a destra, nel vicolo, oltre la porta di Damasco. In questo spicchio di città vive il quartiere cristiano, dove alcune famiglie sono unite sotto la protezione e il commercio di un’associazione che accompagna i turisti più sensibili nelle
legnose, profili emaciati, occhi scuri segnati dal pennello sottile, profili cesellati. Poco altro. Le aureole sopra la testa dei protagonisti possono variare per generosità delle virtù del ritratto o per soldi disponibili della committenza, poiché l’oro in pittura costa più che nel resto del mercato. A prima vista. Ma a seguir bene il suggerimento degli esperti si scopre, un centimetro alla volta, l’universo di differenze, le prospettive molteplici che possono esserci nell’interpretazione del soggetto sacro. Pedrag Matvejevic mi disse, in un caffè di Trieste, che le icone delle chiese orientali non vanno guardate come si fa abitualmente con le figure della pittura italiana, bensì al contrario: devi farti guardare da loro, devi porti al cospetto, lasciarti seguire dallo sguardo del ritratto, altrimenti il gioco di fede e
17
18
loro case. Mangi e parli per una sera con loro, ascolti le storie – in inglese mediorientale – e giochi coi figli. Poi torni in albergo. La storia di Hanna rischierebbe di rimanere un frammento, una cartolina per le buone intenzioni, se adottassimo il registro occidentale dei rapporti, ma se ci poniessimo innanzi senza troppi pregiudizi, se dismettiessimo la logica del museo o
dello zoo, sarebbe più utile. Gerusa-lemme è un’icona orientale, non puoi fissarla come faresti per le altre città; Gerusalemme è dipinta per osservarti, disegnata, costruita, ricostruita, popola-ta, per rendere reale il senso di umiltà. Non esistono tante verità in una sola realtà come a Gerusalemme, perché il catasto della storia ha giocato con i visitatori, per lunghi secoli. Hanna
19
prepara per la cena pollo rosolato nel latte di cocco e curry, cumino e sesamo, riso bollito e condito con ceci e cavolfiore, servito poi in un unico piattone senza reverenza, senza la cura leziosa dei ristoranti etnochic delle nostre pari. Se hai fame mangi, se no ti arrangi. Gerusalemme è al centro della bellezza, circondata dalle mura di Solimano, dai resti dei palazzi erodiani,
bucata dalle porte di Jaffa, di Damasco, del Letame, d’Oro, dei Leoni, di Santo Stefano, di Erode e di Sion; chiude nel ventre i segni urbanistici delle tre religioni monoteiste: il Muro del Pianto – resto ultimo del Tempio di Erode il Grande, e prima del re Salomone -, la moschea di Al Aqsa e i bastioni cristiani del Santo Sepolcro e del Golgota. Puoi farne il tour, inginoc-
20
chiarti più volte e guardare tutto con gli occhi perbene del cittadino educato al rispetto del differenze, ma raramente ricordi che Gerusalemme osserva te. Il figlio più piccolo di Hanna è l’icono-grafia del giovinetto arabo, minuto, vispo, con lo sguardo teso nei tuoi occhi; ride, mangia, gioca e ti parla in fluente arabo, come se il mondo fuori fosse semplicemente la prosecuzione
della sua casa. Gioca con un pallone, non conosce il campionato italiano, ma è ispirato dal Real Madrid. Nella sua stanza, in condivisione con gli altri tre fratelli – non ci sono letti ma dei divanoni ottomani –, mentre resta sempre acceso il computer, sulla pagina di Facebook. Al sabato tutto è fermo, Shabbath. La calamità dei potenti, negozi chiusi, circola un
decimo del numero settimanale delle auto, ma gli alberghi sono pieni di bambini con la kippah sulla testa e i peot, i boccoli, sulle guance. Nella hall trovi le donne con le gonne fino al polpaccio e una cuffia sulla testa, mentre i maschi adulti sono così naturali coi vestaglioni di seta nera, i cappelli di visone grandi come una ruota di utilitaria e il resto da sembrare una scena da film. L’albergo del sabato non è un vezzo, ma se hai soldi a sufficienza, una necessità: se sei ebreo osservante puoi fare un limitato numero di passi, non puoi pigiare il bottone del piano per raggiungere la tua stanza, non puoi lavorare, nessuno può cucinare tranne gli arabi in cucina. Tutto è kosher, puro, secondo il libro del Levitico, e poco importa se il tuo cuoco è arabo. è il risultato evidente ciò che conta. Gerusalemme ti guarda anche dagli occhi del tuo pregiudizio, sfrutta la tua cultura per consegnare i suoi dubbi. Accanto al piatto grande con il riso e con il pollo sulla tavola di Hanna è stato riposto un bidone di yogurt, serve per condire la pietanza, rendendo tutto al contempo acido, ma molto più sfumato. Ecco il Muro del Pianto, superati i controlli al metal detector – il pericolo maggiore è rappresentato dagli ebrei ultraortodossi delle colonie che vorrebbero fare esplodere la moschea e dai kamikaze arabi che vorrebbero far esplodere gli ebrei, dai libanesi che vorrebbero fare esplodere gli israeliani, dagli armeni che volentieri farebbero saltare in aria gli arabi, dagli americani che potrebbe-ro confondersi e dai turisti con le macchine fotografiche – trovi una marea oscillante di uomini in preghiera.
23
Le donne oscillano, anche se mi è sembrato meno dei loro mariti, ma separate da una cortina che delimita il loro settore. Tutti sono rivolti al muro e pregano, tallit sulla testa. La danza, perché nel testo sacro è scritto «pre-gherai Dio con tutto te stesso», sembra sottolineare la fissità del Muro, delle pietre, delle sedie di plastica bianca per i più anziani e i fucili M5, M16 e il
nuovissimo Tavor21, ordinatamente riposti sotto di esse dai giovani che circondano il banco dove il rabbi legge i rotoli della torah. Hanna si alza dalla mensa e va di là per preparare il caffè nero, in attesa di servirlo agli ospiti paganti e molto, molto perplessi sulla qualità delle informazioni messe insieme in Italia. Da noi, Israele è soprattutto arance, pompelmi, pellegrini,
24
Raz Degan, luoghi sacri e pericolo. Arrivati nel tinello di Hanna, al cospet-to della Madonna della Tenerezza, inizia lo sfarinamento progressivo delle tue convinzioni. A Wahat Al Salam Neve Shalom c’è una scommessa. Il villaggio a mezz’ora da Gerusalemme, in pianura, al caldo perenne, è stato edificato per volontà di frate Hussar, che avendo avuto in affitto una collina
dal prossimo monastero di Latrun, insedia una comunità capace in seguito di diventare una cooperativa, un modello di dialogo, un’oasi di pace, una scuola di pace. Vivono nel villag-gio ebrei e arabi musulmani, e decido-no di costruire un fungo tutto bianco, a metà del colle, dove andare ad ascolta-re il silenzio. Eufemismo per dire pregare. Una visone di pace sostenibile
25
in una realtà a pacifismo controllato. Nel fungo non ci sono libri sacri, né altri simboli religiosi, nemmeno sedie. La sottrazione del sacro e la tempora-neità della preghiera per evitare i macelli. Forse questo fungo può essere un confine immateriale di Gerusalem-me, laddove, nel vuoto di una stanza un poco new age, riflettere se pace vuol dire togliere le cause o aggiungere
con più discrezione la propria identità del cielo. Il caffè di Hanna è pronto, forte e sabbioso, si dice alla turca e se lo bevi fuori dall’Italia te ne affezioni, come fosse la dimostrazione che in fondo in fondo sappiamo sopravvivere anche a noi stessi. Il caffè, profumato al cardamomo, ricorda la passione giovanile per l’oriente, quando speravi di andartene in India a piedi, a cercare
26
Siddharta, con i soldi di papà. Poi, guardando Hanna così cortese e dolce coi figli, mentre accetta la devastazio-ne del suo ordine sconvolto dai giochi del più piccolo – calcia a rimbalzo contro la parete del tinello – pensi che in India vanno solo i ricchi e non i figli degli operai o dei cassintegrati, che Siddharta l’ha già scritto Hesse e che il cardamomo non può piacere a tutti.
L’oriente del nostro scontento è a Taibeh Efraim, sui divani di Abuna Raed. Raed è il parroco dell’ultimo insediamento cristiano fuori le mura di Gerusalemme, celebra la messa ma contemporaneamente sfrutta tutta l’energia donatagli dal creato per fare una cooperativa, un centro visita sui mali del villaggio, disoccupazione, emigrazione, impoverimento culturale
29
ai quali oppone anche una radio libera che trasmette grazie ad una maxi antenna ancorata alla croce in ferro del campanile. Raed è uomo di mondo, tanto che ha convinto i francesi a vendere, attraverso la grande distribu-zione, l’olio extravergine d’oliva della sua Taibeh, e sa che non serve piange-re miseria ma investire la carità. Serve, anche a Taibeh, spingere verso un’eco-
nomia dei territori, capace di autoali-mentarsi anche grazie alla consapevo-lezza delle proprie possibilità. Ma per far accadere questo serve un mercato socialmente responsabile. Taibeh è un occhio di Gerusalemme, ti guarda e guarda ciò che può fare il sindacato, quante orecchie può regalare a Raed, quanta attenzione saprà disporre per la terra delle salme e dei santi. Raed,
sosia levantino di John Turturro, rassicura mentre ti appoggia la croce della parola sulla spalla, ricordando ai portatori di non preoccuparsi sull’esi-guo numero dei cristiani di Terra Santa (meno del 1,5% della popolazione) poiché essi sono abituati a resistere, nonostante tutto, da oltre due millenni. Ugualmente dichiara Pierbattista Pizzaballa, il Padre Custode dell’Ordi-ne Francescano Minore, pilastro dei cattolici in Gerusalemme, ricordando che, dopo oltre vent’anni di esperienze in quest’area, le uniche certezze che crescono sono quella del dubbio, dell’umiltà e dell’ascolto. Pizzaballa è un mediano, un diplomatico atletico, un sommo pacifista, e crede in Dio e nella provvidenza, ma soprattutto crede nel senso operoso degli italiani oltre confine, capaci di impegnarsi più per un fratello lontano che per un cugino vicino. Così Pizzaballa più che un occhio di Gerusalemme è la lingua, parla al cervello, non gira con la teologia, non semina parabole e briciole, perché sa che ciò che serve è una cucina e non una vetrina sull’antica città mediorientale. Poi, come nel coro degli angeli – ma angeli pesanti, materiali, fisici – rimane il contralto, la voce più limpida sovraesposta, Madre Donatella, la suora del Caritas Baby Hospital di Betlemme. La parte più dura della tenerezza. A pochi metri dal muro anti Palestina, ad un passo dal check point nord di Gerusalemme, l’ospedale pediatrico cura migliaia di bambini, in una struttura innovativa, capace di ospitare anche le madri rispettando i costumi dell’Islam. Qui i bimbi passano nelle culle riscaldate, tra le braccia delle infermiere e dei medici
– pochi, tanto che esiste un solo pneumologo pediatra in tutta la Cisgiordania – e delle suore, sempre sotto gli sguardi delle madri. A chi si ammala di febbre, di dissenteria, di mali che non necessitano della chirur-gia, né delle terapie intensive di rianimazione, Suor Donatella assicura il possibile. Se il piccolo malato – come per tutti quanti – necessita di specifici interventi inizia il calvario. L’ospedale chiede l’autorizzazione al superamento dei confini nazionali all’autorità israeliana, questa dispone il visto e allerta l’ambulanza, che aspetterà il paziente al check point. Questa procedura può richiedere da quarantot-to ore a quindici giorni, in base alla disponibilità e al buon umore interna-zionale, oppure dalla solerzia, dalla sensibilità del singolo coinvolto nella
catena di informazioni. Risultato, oltre settantacinque decessi soltanto nel 2009, madri incinte o piccoli malati. A Betlemme. Scopri anche così l’orecchio di Gerusalemme, il Museo Nazionale dello Yad Vashem. L’Autorità per la memoria degli eroi e dei martiri dell’Olocausto Yad Vashem è un luogo cocleare, un turbine dove scaraventare l’ignoranza del viaggiatore, straziato dalla difficoltà di essere se stessi in una terra tanto complicata. Il museo, l’edificio del percorso iconografico – architettura della star Libeskind –, la collina con il piccolo bosco dei giusti (tra i quali Schindler e sua moglie Emilie, Giorgio Perlasca, il questore di Fiume Giovanni Palatucci, don Boni Baldoni, don Repetto e altri che da non ebrei hanno salvato i figli di Israele perseguitati dal nazismo) sono le
32
porzioni anatomiche dell’orecchio di Gerusalemme. Misurano la disponibili-tà del viaggiatore a perdere la faccia davanti il limite delle proprie informa-zioni, colpevoli dei tanti libri non letti, dei viaggi non fatti, dell’ignoranza assai diffusa nei confronti del grande Est e di tutta la cultura che da lì genera l’occidente stesso. Finita la cena a casa di Hanna, riprendi la notte nei vicoli di Gerusalemme vecchia, saluti i tuoi amici temporanei, arrivi in fondo, fino alla piazza della fontana e pensi alla Madonna della Tenerezza, al sostegno offerto al bambino dalle mani materne, naturali come sono, senza aspettarsi in cambio nulla. Così scopri, con un poco di fatica che le mani di Gerusalemme sono i campi profughi. Sono i luoghi che offrono senza nulla attendere, hanno smesso di sperare, dopo ses-
sant’anni di precaria esistenza, di limitatissima libertà, di infinita infanzia. Alla fine di Gerusalemme puoi trovarne soltanto un’altra uguale e ricominciare a non capire mai tutto, a non conosce-re abbastanza, a sperare di non fare cattiva figura con chi ti chiederà un racconto. Serve pazienza, tanta, almeno quanta potrà averne il sindaca-to, la Filca-Cisl che ha deciso di usare Gerusalemme quale nodo di sicurezza per tutti i progetti sulla memoria e sulla solidarietà.
33
è difficile scrivere del conflitto israelo-palestinese che ciclicamente, con una sinistra cadenza, entra prepotentemen-te nelle nostre case. è difficile perché ogni qualvolta lo si affronta, il rischio del pregiudizio – ideologico, politico e culturale – è in agguato. Con uguale facilità, i partigiani dell’una e dell’al-tra parte, azzerano ogni complessità, riducono a frammenti grumi di pensie-
ro e di storia che andrebbero sezionati con cura, analizzati con rigore. Quasi sempre, invece, sono scelte di cam-po che non lasciano spazio a dubbi, ostentano certezze, non riconoscono le ragioni dell’altro. Perché questo è il dramma che si trascina sin dal 1948, anno della fondazione dello Stato d’Israele e della naqba (catastrofe) per i palestinesi: il dramma di due popoli 38
39
che hanno entrambi forti ragioni da esibire. Gli ebrei – quando nasce lo Stato d’Israele – ritrovano una terra dopo duemila anni di esilio forzato che ha significato diffidenza, oltraggi, emar-ginazione, segni distintivi, chiusure in ghetti, espulsioni, fino allo sterminio sistematico operato dall’ideologia razziale e biologica nazionalsocialista. Un lungo martirologio, sfociato nella
Shoah, che ha trovato linfa e alimento anche da un sentimento antigiudaico coltivato nel corso dei secoli all’interno delle comunità cristiane. Da “perfidi giudei”, usato, fino al 1958, durante la preghiera universale della liturgia del Venerdì Santo a “fratelli maggio-ri”, il saluto rivolto da Giovanni Paolo II il giorno in cui viene ricevuto dal Rabbino Toaff alla sinagoga di Roma:
41
in questa lunga parabola, ci sta tutto il cammino di conversione della chiesa e dei cristiani. Lo Stato d’Israele nasce da una risoluzione dell’ONU ma su una terra che da secoli vede la presenza di arabi palestinesi. I quali, a partire dal 1948, sono stranieri nella casa che hanno sempre abitato. Centinaia di villaggi distrutti e cancellati dalle carte geografiche, migliaia di profughi illusi
o costretti a lasciare case e terreni, un territorio segnato progressivamen-te – soprattutto dopo la guerra dei sei giorni, del giugno del 1967 – dalla presenza di check point e da numerosi insediamenti in zone occupate e mai più restituite. Nello scacchiere geopoli-tico, i palestinesi non contano: abban-donati al loro destino dai “fratelli” arabi che pure strumentalmente li esibiscono
42
come merce di scambio, in diaspora e divisi, succubi di organizzazioni e sistemi politici poco democratici e cor-rotti, attratti da un uso identitario della religione, rinchiusi in un’impotenza che si trasforma in rabbia e qualche volta in violenza. Basta recarsi Cisgiordania, dove – rispetto all’inferno di Gaza – la situazione è più “normale”, per respi-rare l’aria di paura e di disperazione che vi regna. La gente palestinese resiste da decenni all’occupazione, alla segregazione, all’esproprio di terre, alla mancanza di libertà e dei diritti più elementari. Il muro – garanzia di sicurezza per Israele, vergogna e ele-mento di separazione per i palestinesi – la stringe sempre più in una morsa. La terra viene confiscata, rubata dagli insediamenti sempre più numerosi, dalla ragnatela di strade riservate agli
israeliani, dai check point che control-lano anche i confini interni zone A, B, C (zone palestinesi, a controllo misto, territori ad esclusivo controllo israelia-no). Non esiste la libertà di muoversi da una zona all’altra; serve un permes-so rilasciato dai militari, ma anche con il permesso si può essere fermati ad uno degli infiniti check point; e così si perde il lavoro, non si può andare a scuola, non si può raggiungere l’ospe-dale. Senza un’unità territoriale non rimane nemmeno la speranza di costi-tuire in un futuro uno stato palestinese.La violenza è da condannare da una par-te e dall’altra. Ma certo non si può pre-tendere sicurezza seminando disperazio-ne, occupando territori altrui, umiliando i palestinesi e costringendoli a vivere in condizioni di occupazione permanente. E tutto questo nell’assoluta indifferenza
della comunità internazionale. Di fronte alla fase di violenza a Gaza ed all’attac-co militare israeliano dello scorso anno, ci siamo ritrovati, ancora una volta, senza parole. In bilico tra l’esigenza di intervenire per dire la nostra rabbia e la nostra tristezza e la constatazione dell’inutilità di ogni voce.Una cosa è certa. Non servono le ma-nifestazioni di parte. Agli israeliani ed ai palestinesi non servono degli amici che siano tanto più amici degli uni, quanto più nemici degli altri. L’unilateralismo non aiuta a risolvere alcunché. Come peraltro le manifestazioni di parte, che polarizzano solo chi si schiera contro qualcuno e qualcosa. Proprio le manife-stazioni che si sono svolte in molte città d’Italia ed in Europa, fanno capire che l’occidente non è pronto ad affrontare seriamente la questione mediorientale. E come potrebbe, se manca un’informa-zione corretta ed approfondita, se tutto quanto accade subisce la deformazione delle ideologie e delle parti. Siamo con-vinti che si debba lavorare per, non con-tro. Per la pace e la giustizia, la libertà e i diritti di tutti per tutti, non contro una o l’altra parte. Non si tratta di essere indifferenti alle differenze, di non avere un’idea precisa; si tratta di mantenere una posizione di
equiprossimità, una solidarietà critica che possa aiutare gli uni e gli altri a mantenere aperto il dialogo. Qui, come là. Solo un atteggiamento di mediazione può aiutare la comunicazione. Ed allora le parole vanno ancora più soppesate e pensate. Per non contribuire, qui e là, al conflitto, per non alimentare lo scontro. L’appello da fare è quindi questo. La guerra, l’aggressione armata non risol-vono nulla, anzi potenziano le rabbie e gli estremismi, da una parte e dall’altra.Va finalmente affrontato con decisione e pacatezza il problema storico della convivenza sulla stessa terra di due popoli. Vanno riconosciute le sofferen-ze di entrambi i popoli e le ingiustizie, passate e presenti. Vanno riconosciuti i diritti fondamentali di ogni persona che abita Israele e la Palestina (che sta scomparendo a poco a poco dalle cartine geografiche). Poco noi possiamo fare. Ma almeno questo lo dobbiamo fare. Informarci, sapere cosa accade veramente, ribadire il diritto di tutti ad una vita dignitosa ed in pace. Mantene-re rapporti di amicizia con entrambe le parti, ma allo stesso tempo denunciare con forza le ingiustizie, la sopraffazione, le violazioni dei diritti umani e del dirit-to internazionale. Ma restare terzi. Nella nostra impotenza, questo possiamo fare.
44
PARTECIPANTI
Luciana BoccardiLuigi CardinaleFrancesco CiprianoDomenico ChiarlittiPaolo Ivano CuccelloAlessandro De LisiMario De ProsperisLoredana Faustini
Marco FazioliYuri FracassiFulvio GervasoniClaudio GessiFrancesco IndelicatoGianluca MancaMaurizia MaramieriVincenzo MontiCesare PannozziRodolfo Rinaldi
Elena SassaraAgostino ScacchiaFabrizio ScacciaCarlo SelvagginiMaria SerafiniFabio TurcoAttilio VallocchiaBattista VillaRoberta VillaDaniele Rocchetti (guida)