«IUSTITIA» E «VERITAS»: L'«EXORDIUM» DEGLI SCRITTI APOLOGETICI DI GIUSTINO, ATENAGORA,...
-
Upload
marco-rizzi -
Category
Documents
-
view
216 -
download
2
Transcript of «IUSTITIA» E «VERITAS»: L'«EXORDIUM» DEGLI SCRITTI APOLOGETICI DI GIUSTINO, ATENAGORA,...

«IUSTITIA» E «VERITAS»: L'«EXORDIUM» DEGLI SCRITTI APOLOGETICI DI GIUSTINO,ATENAGORA, TERTULLIANOAuthor(s): Marco RizziSource: Aevum, Anno 65, Fasc. 1 (gennaio-aprile 1991), pp. 125-149Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/20858601 .
Accessed: 14/06/2014 01:16
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Aevum.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

?IUSTITIA? E ?VERITAS?: L,?EXORDIUM? DEGLI SCRITTI APOLOGETICI
DI GIUSTINO, ATENAGORA, TERTULLIANO
II nodo centrale dell'intrapresa dell'apologetica cristiana del II e III secolo risie de nella volontaria accettazione del confronto con Yaltro da se, in funzione missio naria o difensiva, accogliendo la sfida di misurarsi con chi il Cristianesimo avversava od ignorava l. Una simile attitudine pone allo studioso moderno non solo problemi di natura storico-teologica, ma altresi letteraria: la necessita infatti di comunicare con Yaltro dal Cristianesimo imponeva di accettare anzitutto un medio linguistico comune alPinterlocutore, ma anche e soprattutto forme comunicative tali da permet tere che la parola del cristiano, nata nei reciproco ignorarsi, non venisse immediata
mente rigettata, ripiombando in un inefficace silenzio. Cosi, il dibattito critico sulle forme letterarie e sulle strutture argomentative assunte dagli apologisti per la loro opera e ampio ed assai articolato 2. Mi limito a darne un sintetico ragguaglio illu strativo, a modo di introduzione, con riguardo agli scritti che sono oggetto di questo studio: YApologia di Giustino, la Legatio di Atenagora e YApologeticum di Ter tulliano.
Nei caso proprio dell'Apologeticum, che risulta essere tra le tre l'opera piu stu diata da questo punto di vista, una corrente largamente maggioritaria, che va dal
Waltzing e dal Lortz sino al Becker e alia Castillo 3, vi vede un tipico Sixocvtxos X6
yo<;; a questa definizione si e opposto con argomentazioni accurate P. Keresztes4, che ritiene lo scritto di Tertulliano un discorso di tipo epidittico 5, volto non a cam biamenti effettivi nella legislazione avversa ai cristiani, quanto invece ad una dimo strazione della loro innocenza 6.
Le conclusioni di questo studioso sono lungi dalF essere unanimemente accetta
* Vorrei dedicare queste pagine alia memoria di d. Carlo Scaglioni. 1 Mi permetto di rinviare ad un mio precedente contributo che si muove nella stessa direzione del
presente lavoro: M. Rizzi, Amicitia e veritas: il prologo delVOctavius di Minucio Felice, ?Aevum Anti quum?, 3 (1990), pp. 245-268.
2 Segnalo solo due articoli recenti, che mostrano indirizzi differenti in questa indagine: R.M. Grant,
Forrr\s and Occasions of the Greek Apologists, ?Studi e Materiali di Storia delle Religioni?, 10 (1986), pp. 213-226; W. Kinzig, Der 'Sitz im Leben' der Apologie in der Alten Kirche, ?Zeitschrift fur Kirchengeschi chte?, 100 (1989), pp. 291-317.
3 J. Lortz, Tertullian als Apologet, I, Minister 1927, p. 35; J.P. Waltzing, in Tertullien, Apolo getique, Paris 1929, pp. XXXVIII s.; C. Becker, Tertullians Apologeticum. Werden und Leistung, Kosel, Miinchen 1954, pp. 290-293; C. Castillo, El Apologeticum de Tertuliano: estructura y composicion, ?Emerita?, 39 (1967), pp. 315-326; ma i nomi potrebbero essere molti altri.
4 Tertullian's Apologeticus: a Historical and Literary Study, ?Latomus?, 25 (1966), pp. 124-133. 5 Ibid., p. 128: ?To demonstrate the shocking injustice inflicted on the Christians he follows the tra
dition of classical epideictic rhetoric and uses its most effective means, the amplifications, to make this
display all the more powerful)). 6 Ibid., p. 130: ?In brief, the Apologeticus was not aimed at positive changes in the laws affecting
Christians, but was a demonstration or exhibition of Christian innocence)).
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

126 M. RIZZI
te 7; tuttavia si pud dire che una eccessiva rigidita nelPaffrontare il problema tende a trascurare la concretezza del rapporto tra autore ed interlocutore espressamente chia
mato in causa, sacrificandola ad una comparazione con la manualistica astratta e ri
gida dei retori; Papologista cristiano, una volta identificati i suoi destinatari, poteva utilizzare forme ed elementi differenti, anche in commistione tra loro, per raggiunge re il fine di una difesa che fosse al tempo stesso annuncio del Cristianesimo, impe gnandosi nel campo, piu vasto che non la sola considerazione giuridica, del proprio rapporto con Yalterita pagana.
Sul versante poi delParticolazione strutturale delYApologeticum, oltre alle anali si tradizionali di R. Heinze 8, del Waltzing
9 e della Castillo 10, un importante -contri bute e giunto da R.D. Sider 11 che, riprendendo studi precedenti 12, ha evidenziato i caratteri della composizione simmetrica delPopera, che avrebbe cosi come principio generativo delPargomentazione la corrispondenza delle tematiche ai diversi livelli di
sviluppo 13. Differente e il caso di Giustino, in cui al problema della determinazione del ge
nus loquendi si aggiunge quello della relazione tra I e II Apologia. Anche qui il Ke resztes 14, ripreso dal Grant 15, nega che quest'ultima sia semplicemente un'appendice della prima, come invece afferma, tra gli altri, Pultimo editore delle Apologie di Giustino, il Wartelle 16, riallacciandosi ad una tradizione inaugurata da B. Capelle 17. Mi sembra che Pargomentazione piu convincente a questo proposito sia quella offer ta da H.H. Holfelder 18, che affronta il problema della struttura &e\Y Apologia in re lazione alia sua tecnica di scrittura. L'organizzazione del testo di Giustino era sem
pre stata oggetto di critiche da parte degli studiosi per la sua presunta assenza di or
7 In risposta al Keresztes si e espresso successivamente L.J. Swift, Forensic Rhetoric in Tertullian's
Apologeticum, ?Latomus?, 27 (1968), pp. 864-877, che ha utilizzato la categoria retorica della indignatio per interpretare il particolare atteggiamento dell'autore nei cpnfronti dei suoi interlocutori, i giudici. Peral tro, a proposito della questione del genere letterapo, lo Swift afferma (#>/<!, p. 865); ?By demanding too strict a continuity between the literary form of an address and the legal exigencies of the times, we may understimate the advantages of the fictive mode and fail to appreciate fully the way in which it serves the
apologist's broader purpose?. 8 Tertullians Apologeticum, ?Berichte iiber die Verhandlungen der Koniglischen Sachsischen Gesell
schaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-Historische Klasse?, 62 (1910), pp. 281-490. 9 In Tertullien, Apologetique, commentaire analytique, grammatical et historique, Paris 1931, pp.
1-14. 10 El Apologeticum, specialmente pp. 316-326. 11 On Symmetrical Composition in Tertullian, ?The Journal of Theological Studies?, 24 (1973), pp.
405-423. 12 O. Schonberger, Uber die symmetrische Komposition in Tertullians Apologeticum, ?Gymna
sium?, 64 (1957), pp. 335-340; R. Braun, Observations sur Varchitecture de VApologeticum, in Hommages a Jean Bayet, p. M. Renard - R. Schilling, Bruxelles - Berchem 1964 (Coll. Latomus, 70), pp. 114-121.
13 Ulteriori e segnalabili applicazioni analitiche di questo principio sono state sviluppate dallo stesso Sider {Tertullian. On the Shows. An Analysis, ?The Journal of Theological Studies?, 29 [1978], pp. 339-365) e da S. Isetta nella sua edizione di Tertulliano, L'eleganza delle donne, Nardini, Firenze 1986
(Biblioteca Patristica, 6), pp. 14-21. 14 The fso called* Second Apology of Justin, ?Latomus?, 24 (1965), pp. 858-869; The Literary Genre
of Justin's First Apology, ?Vigiliae Christianae?, 19 (1965), pp. 99-110. 15 Forms and Occasions, p. 215. 16 A. Wartelle, in Saint Justin, Apologies, Etudes Augustiniennes, Paris 1987, pp. 29 s. 17 Le rescrit d'Hadrien et Justin, ?Revue Benedictine?, 39 (1927), p. 367. 18 Eusebia kai Philosophia. Literarische Einheit und politischer Kontext von Justins Apologie, ?Zeit
schrift fur die Neutestamentliche Wissenschaft?, 68 (1977), pp. 48-66; pp. 230-251; i risultati dell'Holfelder sono stati ripresi e ampliati da C. Munier, La structure litteraire de I'Apologie de Justin, ?Revue des Sciences Religieuses?, 60 (1986), pp. 34-54; La methode apologetique de Justin le martyr, ?Revue des Sciences Religieuses?, 62 (1988), pp. 90-100; 227-239.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

?IUSTIT1A? E ?VER1TAS) 127
ganicita; gia PAlfonsi 19 aveva proposto un piano di struttura, tuttavia e merito del PHolfelder avere mostrato come essa sia frutto del metodo di esposizione dell'apolo gista, che consiste nel condurre insensibilimente il lettore da un tema alPaltro, pro ponendogli aspetti sempre nuovi nello sviluppo delPargomentazione. Giustino proce de soprattutto per associazione di idee, per variazioni a partire da parole chiave, per sinonimi, per membri di frase; questo procedimento di tipo pedagogico-psicagogico fu assai praticato nelPantichita alPinterno della letteratura di tipo filosofico 20. Que sta tecnica, cosiddetta della Themenfiihrung, viene dalPHolfelder utilizzata per Pana lisi delle sezioni di Ap. 1,13-29 e 1,68-11,9; Pesame di questa seconda testimonierebbe Punita dello scritto ed anche la capacita complessiva di organizzazione della materia da parte di Giustino; sembra cosi, se non di poter liquidare del tutto, almeno di at tenuare il giudizio negativo corrente circa la sua abilita compositiva.
L'importanza di una simile relazione con le tecniche di scrittura della fijosofia non vale solo per Giustino; gia in precedenza A. Malherbe 21 aveva sottolineato la
necessita, per comprendere lo sviluppo contenutistico della Legatio di Atenagora, di metterla a confronto con la manualistica filosofica del II secolo, cosi come e rappre sentata dal AihaonaXinoq, di Albino.
Questo spostamento di attenzione sui referenti filosofici ben si spiega con Pe
splicita professione di filosofia di Giustino e di Atenagora, con la presentazione stes sa del cristianesimo come 'vera filosofia,, e con Pinterpellazione ddV altro proprio a
partire dalla qualifica di filosofo nelle due inscriptiones. Tuttavia cio non toglie che Pinflusso retorico sia presente anche in questi scritti, e che i loro exordia abbiano una articolazione estremamente curata, per favorire Pindividuazione e lo sviluppo dei punti fondamentali della successiva argomentazione.
Anche solo da questo rapido bilancio critico emerge con chiarezza la problema ticita del punto in questione. Un approccio nuovo in questa direzione pud essere ri cercato nel porre particolare attenzione alle strutture esordiali delle opere apologeti che, e in particolare alia caratterizzazione che in esse viene compiuta della figura de
gli interlocutori cui gli scritti sono formalmente destinati22. Certo, opere indirizzate a personaggi specifici potevano avere di mira uditori piu vasti ed intenzioni propa gandistiche piu generali, come la tradizione, da Esiodo in poi, indicava 23. Tuttavia, la scelta di 'intestare' il proprio scritto ad una specifica figura di altro non era priva di implicazioni, che anzi poneva vincoli precisi e condizioni, che risultano natural mente assai cogenti soprattutto nei momenti esordiali.
Proprio partendo dal carattere delPinterlocutore altro cui gli apologisti si rivol gono si e in grado di interpretare in tutta la loro valenza gli elementi stilistici e di contenuto che concorrono alia definizione delle differenti opere apologetiche. Rove
19 La struttura della I Apologia di Giustino, in Paradoxos politeia. Studi patristici in onore di G.
Lazzati, a c. di R. Cantalamessa - L.F. Pizzolato, Vita e Pensiero, Milano 1979 (Studia Patristica Me
diolanensia, 10), pp. 57-76. 20 Holfelder, Eusebeia kai Philosophia, pp. 230-235. 21 The Structure of Athenagoras' Supplicatio pro Christianis, ?Vigiliae Christianae?, 23 (1969), pp.
1-20. 22 Cf. Rizzi, Amicitia e veritas, pp. 246-249. 23 A questo proposito, si veda la notazione dell'antico grammatico autore del riassunto ddVAd De
monicum pseudoisocrateo (nell'ed. Mathieu, p. 121). Ad esempio, circa il Dialogo di Giustino e in atto una vasta discussione sui destinatari e gli obiettivi dello scritto, al di la delle sue connotazioni fittizie; su tutto
questo, si pud vedere l'equilibrata e precisa ricostruzione di G. Visona, nelPIntroduzione a S. Giustino, Dialogo con il giudeo Trifone, Paoline, Alba 1988, pp. 15-80. Cosi per Atenagora anche B. Pouderon, Athenagore d'Athenes, philosophe chretien, Beauchesne, Paris 1989 (Theologie Historique, 82), pp. 57-62.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

128 M. RIZZI
sciando cosi Papproccio consueto, per cui si tende prevalentemente a considerare co me fittizio il genere letterario assunto 24, diviene anche possibile operare dei confron ts che mettano in luce le differenti impostazioni strategiche e le posizioni che gli au tori cristiani assumono nei confronti deWaltro, non piu entita indefinita, ma pun tualmente identificabile.
Non sembra, cosi, azzardato accostare, per una analisi delle loro strutture esor
diali, gli scritti di Giustino, Atenagora, Tertulliano; opere tra loro differenti, sia per il dato linguistico-concettuale, sia per impianto e sviluppo, sia per il contesto storico, immediato e remoto. Esse si dirigono pero ad interlocutori analoghi, caratterizzati dal loro statuto di ufficialita: per i due scrittori greci gli stessi imperatori, per Ter tulliano i magistrati preposti alia tutela delle leggi25. I destinatari formali di questi tre scritti sono quindi interpellati a partire dalla loro funzione di autorita in relazio ne al governo della realta politica e alia amministrazione della giustizia. Proprio sul Puso delPautorita nei confronti del Cristianesimo verte, alPinizio, il discorso dei tre autori.
Naturalmente Pargomentazione apologetica si sviluppa poi secondo le linee con suete della contestazione delle specifiche accuse rivolte al cristianesimo e della dimo strazione epidittica della positivita del fatto cristiano. Tuttavia, proprio perche inter
pellati in quanto tali, imperatori e magistrati sono invitati ad un confronto sul piano racchiuso dai confini dell'auctoritas e della iustitia, concetto comprensivo, ma piu ampio e trascendente di quello della lex 26.
Evidentemente i tre apologisti sostengono le loro posizioni in maniere anche as sai differenti, con un ventaglio di posizioni vasto ed articolato; non mancano altresi nuances nelPuso e nelPinvocazione dei concetti di auctoritas e di iustitia.
Tuttavia proprio in questo senso si comprende il trattamento particolare riserva to al tema del nomen christianum e della connessa valutazione giuridico-comporta
mentale dei pagani nei suoi confronti. Non mancano, certo, anche in altri apologisti accenni a questo problema 27, tuttavia Pampiezza con cui i tre autori dibattono Par gomento e la sua condizione di 'questione preliminare', collocata previamente alia confutazione delle accuse specifiche, e determinata dalla necessita di delimitare un
campo corretto di esercizio dell'auctoritas e di applicazione della iustitia, come con dizione di ogni successivo sviluppo argomentativo.
Inoltre, non e un caso che, anche con un sommario sguardo alia parte proemia le dei tre scritti, si possa cogliere la presenza di uno schema che presenta eguali tratti di articolazione.
Anzitutto, le tre opere presentano un initium ab iudicibus 28. Esso compare in Tertulliano sotto forma di una interpellazione diretta contenuta nelle parole di aper
24 Da ultimo in questa direzione Munier, A propos des Apologies de Justin, ?Revue de Sciences Re
ligieuses?, 61 (1987), pp. 177-186. 25 Potrebbe essere compresa, tra le opere aventi caratteristiche analoghe, anche VApologia di Aristi
de; essa e pero stata esclusa a motivo della incertezza relativa alia esatta conoscenza della sua forma, che in un lavoro tendente ad esaminare soprattutto le strutture letterarie e causa impediente.
26 Tert. Apoi, 1,1: ?...Auctoritas vestra de iustitiae diligentia...?; ibid., 4,3: ?...De legibus prius consistam vobiscum, ut cum tutoribus legum?. Iust. Ap., 1,3,4: uuixepov 8?, ox; octpet Xoyoc;, axouovxocs
drfocOoix; eoptaxeaGat xpixa<;. Athen. Leg., 2,1: ... ufxaiv rfii) epyov xcov pteytaTCov xai 9LXav0pco7tOTaTcov xai (piXo[xa0?axaTcov PaatXecov <X7uoax?uaaai rjptcov vou-w xr)v ?7rr]p?tav.
27 Cf., p.e., Tat. Orat., 27; Theoph. Ad Autol., \,\. 28 Cf., per questa modalita esordiale, Cic. De inv., 1,16,22: ?Benivolentia quattuor ex locis compa
ratur: a nostra, ab adversariorum, ab iudicum persona, a causa... Ab auditorum persona benivolentia cap tabitur... si de iis quam honesta existimatio, quantaque eorum iudicii et auctoritatis exspectatio sit ostende tur?. A questo proposito si noti la polemica di Quint. Inst. orat., IV, 1,6.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

?[UST1TIA? E ?VERITAS? 129
tura: ?Si non licet vobis, Romani imperii antistites...? (Tert. Apol., 1,1)29. In Giustino e Yinscriptio a chiamare in causa gli imperatori, che vengono caratterizza ti con una coppia di aggettivi (euaefki... cptXoaocpco: lust. Ap., 1,1,1) destinati ad essere ripresi e sviluppati compiutamente in seguito 30. Infine, in Atenagora opera il richiamo a cio che e proprio e d'interesse degli interlocutori31: tj u[xex?pa, [xeya Xot (iaaiXecov, otxoufievr)... (Athen. Leg., 1,1); anche questo richiamo sara successi vamente ripreso, prima della introduzione del motivo personale della supplica 32.
Questa comune scelta di iniziare il proprio discorso a partire dalla caratteriz zazione degli interlocutori come 'giudicP (sia pure in un giudizio sui generis) e dal la loro condizione di autorita e confermata dalla successiva ripresa, in tutti e tre
gli autori, del motivo della loro funzione giudiziale, prima della 'questione prelimi nare' rappresentata dal problema del nomen 33. Si noti come non manchi neppure negli sviluppi successivi, almeno in Giustino ed Atenagora, la terza figura tipica del discorso giudiziale, quella delPavversario: in questa categoria rientrano per Ate
nagora i sicofanti (Leg., 1,3) e coloro che danneggiano in vario modo i cristiani
(ibid.); genericamente gli accusatori per Giustino (toc xaTTjyopoujxeva ocutgjv: Ap. 1,3,1).
Secondo carattere comune e, dopo Yinitium ab iudicibus, la trattazione del
problema del nomen, inteso come questione preliminare 34. Essa risulta assai ampia in Tertulliano (Apol., 1,4-3,6), piu ridotta di proporzioni in Atenagora (Leg., 2) e
Giustino (Ap., 1,4). Solo dopo Pescussione di questo primo argomento si pud arrivare alia propo
sitio e alia divisio vera e propria del discorso, cioe alPesposizione sommaria delle
imputazioni e delle strategic di difesa 35 che rappresenta la conclusione della parte introduttiva. Si noti, per6, che in Tertulliano al termine del sommario viene intro
29 La Castillo {El Apologeticum, p. 318 n. 1) interpreta l'inizio dell'Apologeticum come un exor
dium ab adversariis; tuttavia non si puo omettere l'evidenza che tutto il par. 1 si sviluppa come sottoli neatura delle carenze degli interlocutori proprio in quanto giudici. E solo dopo la comparsa della veritas in opposizione alle leges (Tert. Apol., 1,2-3) che viene utilizzato il vos ad esprimere la realta degli av versari del Cristianesimo, un vos pero necessariamente piu ampio dei soli giudici, allargato alia realta
complessiva del paganesimo e di cui i Romani imperil antistites sono solo una parte, o, meglio, strumenti.
30 Iust. Ap., 1,2,1: xou<; xaxd dXrjGetav euaejkls xai cptXoa6cpou<;...; ibid., 1,2,2: upieti; uiv ouv oxi
XeyeaGe euae[ki<; xai 91X600901... 31 E il terzo dei tre campi da cui trarre argomentazioni esordiali (?magna?, ?necessaria? e ?con
iuncta cum ipsis apud quos res agetur?) ricordati da Cic. Part, or., 8,30. 32 Athen. Leg., 1,2-3: ...xai tj aufxrcaaa otxouptevr) xrj ufxexepa auveaei PaGeta? dpr\V7\<; drcoXauou
atv. rifxeti; hi ot Xeyofievoi yjpiaxioivoi... 33 Iust. Ap., 1,3,4-5: ufxexepov hi, a><; atpeT Xoyoi;, axouovxa<; ayaGout; euptaxeaGai xpixd?. ava7co
X6yr)xov yap Xoi7i6v (xaGouaiv, fjv {xrj xa 8txata 7i:oir|aT)xe, U7rap?ei npoq Geov. Athen. Leg., 2,6: u\Lti<; xe yap ou izp6<; dyvoia? e^apLapxTjaexe xai r\\LZiq xd arco xfj? dxptxou xwv 7uoXXwv 9rjfxr)? dTroXuadpievoi TiauaopteGa 7toXe[jLou[jL?voi. Tertulliano presenta questo tema in molteplici occasioni tra Apol., 1,1 e
Apol., 6,10, in specie ad Apol., 2,1: ?...Cur a vobis ipsis aliter tractamur quam pares nostri...??; ad
Apol., 2,10: ?Sed nec in isto ex forma malorum iudicandorum agitis erga nos...?; e soprattutto ad
Apol., 4,3: ?...De legibus prius consistam vobiscum, ut cum tutoribus legum?, i cui caratteri verrranno in seguito analizzati.
34 Tert. Apol., 1,4: ?Hanc igitur primam causam apud vos collocamus iniquitatis odii erga nomen Christianorum?.
35 Tert. Apol., 4,1-2: ?Atque adeo, quasi praefatus haec ad suggillandam odii erga nos publici iniquitatem, iam de causa innocentiae consistam... Respondebimus ad singula...?; Athen. Leg., 3,1: xpia ercupTjfxiCouaiv rj{jiTv EyxXrjfxaxa... In Giustino il passaggio risulta piu sfumato, senza una vera e propria anticipazione dell'argomentazione, ma il terzo capitolo del suo scritto ben svolge questa funzione di tran sizione alia parte centrale del discorso, sia pure attraverso una tecnica espositiva caratteristica che si ve dra piu sotto.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

130 M. RIZZI
dotta ancora una digressione di tipo storico-giuridico sulla legislazione anticristia na, che rappresenta un ulteriore preliminare, connesso al tema del nomen 36.
L'accostamento di queste tre opere, assai diverse tra loro per impostazione teo logica e contesto storico, risulta cosi legittimo sul piano letterario delParticolazione argomentativa e della struttura di composizione: infatti il dispiegamento nelPexor dium di scelte retoriche tra loro simili determina in maniera cogente anche Yinitium argomentativo, e pone interessanti relazioni tra Pinizio e la fine del discorso, non piu visti solo come luoghi topici, ma come perni di un disegno architettonico piu complesso.
Le strutture esordiali delle tre opere risultano dunque omologhe tra loro: e allo ra possibile approfondirne il confronto, seguendo nelPanalisi la scansione dei tre
momenti di articolazione presenti in ciascuna di esse: exordium ab iudicibus, que stione del nomen, propositio/divisio.
E opportuno cominciare dalYApologeticum, in cui piu netta appare Particola zione strutturale.
Retore scaltrito, Tertulliano costruisce le prime battute del suo Apologeticum a partire da una sapiente combinazione di differenti temi e moduli retorici. La scelta delle parole di apertura ci introduce immediatamente nelPambito semantico giuridi co, nel campo della lex: ?Si non licet vobis, Romani imperii antistites, in aperto et edito, in ipso fere vertice civitatis praesidentibus ad iudicandum, palam dispicere et coram examinare...? (Tert. ApoL, 1,1). Poco piu avanti, la ripresa del verbo inizia le, nelPespressione ?liceat veritati?, crea immediatamente una di quelle contrapposi zioni antitetiche cosi caratteristiche del linguaggio e delPespressione di Tertulliano da essere, per la Mohrmann, una vera e propria costante del suo modo di concettualiz zazione 37. Ma questa antitesi si viene a determinare, con maggior precisione, attra verso un processo di distanziamento tra lo spazio iniziale della lex e quello conclusi ve della veritas, che Tertulliano realizza attraverso una costruzione sospensiva assai lunga, basata sulla iterazione della congiunzione ?se? (si): ?Se non e lecito a voi,
magistrati delPimpero romano, che presiedete all'amministrazione della giustizia in un luogo accessibile ed eminente, quasi al sommo stesso della citta, verificare aperta mente ed esaminare in pubblico cosa e'e realmente nel caso dei cristiani; se solo nei confronti di questa specie la vostra autorita teme o si vergogna di inquisire in pub blico con una attenta giustizia; se infine, come e accaduto da poco, Podio per que sta setta, troppo oberato dalle delazioni domestiche, chiude la bocca alia difesa: sia lecito alia verita giungere alle vostre orecchie almeno attraverso la via nascosta di uno scritto silenzioso? 38.
Si forma cosi una climax ascendente, attraverso Pincalzare delPaccumulo asinde tico delle protasi. Questo effetto di accumulo ed accelerazione e messo in movimen
36 Tert. Apol., 4,3: ?Sed quoniam, cum ad omnia occurrit veritas nostra, postremo legum obstrui tur auctoritas ad versus earn, ut aut nihil dicatur ratractandum esse post leges, aut ingratis necessitas obse
quii praeferatur veritati, de legibus prius consistam vobiscum, ut cum tutoribus legum?. 37 C. Mohrmann, Observations sur la langue et le style de Ter tut lien, in Etudes sur le latin des
Chretiens, II, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1961, p. 244: ?L'antithese semble etre la forme naturelle de sa pensee?.
38 Tert. Apol., 1,1: ?Si non licet vobis, Romani imperii antistites, in aperto et edito, in ipso fere vertice civitatis praesidentibus ad iudicandum, palam dispicere et coram examinare, quid sit liquido in causa Christianorum; si ad hanc solam speciem auctoritas vestra de iustitiae diligentia in publico aut timet aut erubescit inquirere; si denique, quod proxime accidit, domesticis indiciis nimis operata infestatio sectae huius os obstruit defensioni: liceat veritati vel occulta via tacitarum litterarum ad aures vestras pervenire?.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

:IUSTITIA? E ?VER1TAS> 131
to, alPinterno della frase iniziale, dalla successione ?in aperto et edito, in ipso fere
vertice?, in cui i due aggettivi di partenza (aperto et edito) vengono ripresi e com
pendiati ad un livello piu alto dalla formula successiva ?in ipso fere vertice?, che viene anch'essa giustapposta in asindeto. La climax ascendente si stempera e si esau risce soltanto nella apodosi conclusiva 39; essa e centrata sulla veritas in opposizione alia lex, che connotava invece le espressioni precedenti, e termina con la clausola ca nonica di spondeo + dicoreo, che assume un tono ancor piu solenne e pacato per la presenza di un ulteriore spondeo: ?aures vestras pervenire? 40.
La condizione di separatezza tra il campo della lex e quello della veritas e cosi
segnata dalla distanza sintattica, creata dalla costruzione asindetica ascendente, che separa i due corni delPantitesi concettuale (?licet vobis... liceat veritati?).
Una separatezza 'spaziale' che anticipa Pimmagine della contrapposizione tra terra e cielo 41: infatti Pantitesi assiologica e concettuale tra lex e veritas viene ripre sa e sviluppata nel secondo paragrafo deAVApologeticum dalla giustapposizione, que sta volta spaziale, tra la terra e il cielo: la dignitas della verita risiede nei cieli, men tre la terra e il regno delle leggi, uno spazio chiuso, questo, che si oppone in toto al ia veritas, che pud sperare non in un successo, quanto invece soltanto ?ne ignorata damnetur?: ?[La verita] non implora a suo vantaggio, perche neppure si stupisce della sua condizione: sa di vivere da pellegrina sulla terra, di trovare facilmente ne mici tra chi le e estraneo, ma che per il resto il suo genere, la sua residenza, la sua
speranza, il suo valore e la sua dignita li ha in cielo; nel frattempo, cerca questa so la cosa: di non essere condannata senza essere conosciuta? 42.
Tertulliano non ama gli exordia lunghi, in questo da buono figlio del suo tem
po 43: nella contrapposizione tra veritas e lex, rafforzata dalla opposizione spaziale tra cielo e terra, si e gia consumato Vexordium nella sua funzione fondamentale di
impostazione tematica; la questione preliminare, incentrata sul problema del nomen, e gia proiettata in direzione della discussione del tema vero e proprio, da cui la sepa ra una ulteriore digressione sulla legislazione anticristiana.
39 Questa frase (?liceat veritati vel occulta via tacitarum litterarum ad aures vestras pervenire?) meri terebbe una puntuale analisi particolareggiata, per il dispiegarsi in essa di una serie di risorse retoriche che ne fanno uno dei piu caratteristici ? e ricercati ? slogan tertullianei.
40 per ie clausole in Tertulliano si possono vedere ancora con utilita i due lavori di H. Hoppe, Sin tassi e stile di Tertulliano, trad, it., Paideia, Brescia 1985 (l'originale e del 1903), pp. 274-280; Beitrage zur
Sprache und Kritik Tertullians, Lund 1932, pp. 54-62. 41 II valore topico di questa prima parte delVexordium e ancor piu enfatizzato dalla anticipazione di
tutta una serie di elementi che verranno poi compiutamente sviluppati nel corpo dell'apologia: la necessita e, al contrario, l'assenza di una puntuale disamina delle specifiche accuse mosse ai cristiani; l'insufficienza e la contradditorieta della legislazione nei loro confronti; l'atteggiamento di odio scomposto da parte della
popolazione; ma soprattutto 1'anticipazione della contrapposizione tra occulto e manifesto che rappresenta l'ossatura strutturale dell'intero Apologeticum (cf. Sider, On Symmetrical, p. 409); palam, coram, in publi co si contrappongono al nesso ?veritati vel occulta via?, in cui la particella vel ha funzione allo stesso tem
po attenuativa ed allitterativa; un nesso che ritroviamo assai simile in Ad Scapulam, 1,4, per evidenziare
Timpossibility del contatto diretto. In entrambi i casi, la formula tende ad enfatizzare la costitutiva diffe renza di qualita.tra la condizione della veritas e le condizioni reali della possibility che essa sia accolta.
42 Tert. Apol., 1,2: ?Nihil de causa sua deprecatur, quia nec de condicione miratur. Scit se peregri nam in terris agere, inter extraneos facile inimicos invenire, ceterum genus, sedem, spem, gratiam, dignita tem in caelis habere. Unum gestit interdum, ne ignorata damnetur?.
43 Cf. Mohrmann, Observations, p. 241; per avere una conferma da una fonte diretta, si pud notare come la tendenza alia contrazione della dimensione dell'esordio da parte dei retori di eta imperiale sia testi moniata dal passo del Dialogus de oratoribus in cui, criticando gli 'anciens', si afferma: ?Iam vero longa principiorum praeparatio et narrationis alte repetita series et multarum divisionum ostentatio et mille argu mentorum gradus, et quidquid aliud aridissimis Hermagorae et Apollodori libris praecipitur, in honore erat? (Dial, de or at., 19,3).
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

132 M. RIZZI
A partire da queste osservazioni si comprende anche il problematico andamento deirindirizzo: la mancanza di una captatio benevolentiae, anzi il diretto attacco ai
magistrati nelPesercizio della loro funzione sono stati utilizzati dal Keresztes 44 per sottolineare il distacco dalPoratoria di stretta impostazione forense; peraltro, nota lo
Swift45, anche nel genere epidittico gli esordi devono contenere elementi elogiativi nei confronti degli uditori, come sottolinea a piu riprese Menandro Retore nella sua manualistica TIeqI im&etxrtxojv.
II Lortz aveva gia in precedenza puntualizzato 46 come questa assenza sia selbst
verstandlich: Patteggiamento di Tertulliano e di assoluta contrapposizione a tutto cio che gli si oppone, tanto che il piu delle volte Pobiettivo dei suoi assalti non paiono essere le accuse, quanto invece gli accusatori47. Tuttavia, a partire dalla antitesi co stitutiva tra lex e veritas sopra esaminata, il problema puo essere meglio illuminator Tertulliano non crede sia possibile la delimitazione di un terreno valoriale comune tra Cristianesimo e impero; quindi Passoluta estraneita di lex e veritas fa si che colo ro che della lex sono i tutori, i garanti del regnum legum (Tert. ApoL, 1,3)48, per questa stessa loro collocazione, non possono essere interpellati positivamente nel no me della verita: che senso potrebbe avere una captatio benevolentiae, quando e pro prio Pantitesi alia veritas che definisce lo spazio della lex e dei suoi tutori, irriduci bilmente altro dal Cristianesimo?
Lo Swift ritiene 49 che la tecnica dell'amplification cosi ricorrente nz\Y Apologeti cum, sia applicata qui ne\Y exordium per realizzare un particolare effetto psicologico, Vindignation una risorsa che i retori latini hanno molto sviluppato, partendo dall'ari stotelica idea di (xtaoc 50. Tuttavia occorre notare come, nel caso del primi paragrafi ddYApologeticum, obiettivo di questa azione volta a far sorgere Pindignazione non siano gli accusatori, quanto i giudici, e l'atteggiamento che oggettivamente si puo ot tenere con un simile attacco non e certo la ciceroniana misericordia, quanto un sen so di fastidio derivante dalla presunzione di chi pretende di interloquire a nome della verita. Uamplificatio invece mi pare sia qui utilizzata da Tertulliano per approfondi re ancor piu il solco che separa lex e veritas, cielo e terra, e Yindignatio che ne puo sorgere e piu sentimento di straniamento e separatezza, di violenta ripulsa, che non strumento di convincimento: per Papologista cartaginese non e in gioco il convincer si, quanto invece il decidersi, Popzione e la scelta non reversibili e non mediabili: ?Fiunt christiani... et incipiunt odisse quod fuerant? (Tert. ApoL, 1,6). Non c'e pos sibility di graduazione ne di gradualita; abbracciare il cristianesimo e odiare Yaltro, Yalteritd pagana, e viceversa.
44 Tertullian's Apologeticus, p. 128: ?From the beginning, Tertullian refuses to ask for any favours or to appeal for the goodwill of his avowed addressees as he would have done if he had written an
apology...?. 45 Forensic rhetoric, p. 865. 46 Tertullian, II (1928), pp. 197 s. 47 Ibid., p. 198: ?Oft ist nicht die Anklage sein Angriffsziel, sondern die Anklager?. 48 Si noti altresi come lo spazio della lex sia connotato da una terminologia politico-giuridica: re
gnum e potestas, mentre quello della veritas da una serie di sostantivi, disposti ancora in asindeto, tratti da uno spettro lessicale ben piu ampio, a rimarcare separazione e differenza sostanziale tra cielo e terra: ge nus, sedem, spent, gratiam, dignitatem (Tert. Apol., 1,2).
49 Forensic Rhetoric, pp. 867-871. 50 Cf., p.e., Cic. De inv., 1,53,100: ?Indignatio est oratio per quam conficitur ut in aliquem homi
nem magnum odium aut in rem gravis offensio concitetur?. Cicerone cosi descrive i luoghi in cui amplifi catio e indignatio possono utilmente comporsi: ?Certus autem locus est accusatoris, per quern auget facti
atrocitatem, et alter, per quern negat malorum misereri oportere: defensoris, per quern calumnia accusato rum cum indignatione ostenditur et per quern cum conquestione misericordia captatur? (De inv., 11,16,51). Su queste basi, lo Swift sviluppa poi la sua argomentazione.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

IUSTITIA? E ?VERITAS; 133
Si spiega cosi anche il fatto che Tertulliano cumuli avversari e giudici in un vos che si oppone al nos dei cristiani, e crei una situazione bipolare di estraneita assolu
ta; ben diversa la situazione tripolare (noi, i cristiani ingiustamente perseguitati; voi, imperatori e giudici; loro, i sicofanti e i persecutori) posta in atto da Giustino ed
Atenagora.
Anzi, Atenagora nelPapertura della Legatio mostra la sua capacita retorica e la sua finezza stilistica proprio nella delimitazione della situazione tripolare tra nos, vos, alii, attento a connotare positivamente i diretti interlocutori. Con le parole ini ziali siamo in presenza di un anacoluto, o meglio di un nominativus pendens, centra to sul vos: ?[Ne]il vostro impero, o grandi tra i re, ciascuno fa uso di differenti co stumi e leggi, e nessuno e forzato dalla legge o dal timore della giustizia a non ono rare i costumi patrii, anche se siano ridicoli...? 51.
Atenagora si attiene ad una delle formule classiche doiVinitium retorico: un si mile incipit ricade infatti nella casistica dei ?coniuncta cum ipsis apud quos res age tun) 52, trattandosi nientemeno che delPimpero stesso, cura dei sovrani cui Atenago ra si rivolge. II nominativus pendens in inizio di frase e cosi utilizzato per enfatizza re il punto di partenza. Ad esso fa pero immediatamente seguito la comparsa di un terzo referente (6cXXo$) distinto dagli interlocutori diretti; Atenagora, subito dopo Pe nunciazione delPelemento di interesse per i propri destinatari, sposta nettamente il tono del discorso: ciascuno e libero di seguire usi e leggi che ritiene opportuni, per quanto possano sembrare ridicoli (xav yeXota rj). L'apologista ottiene cosi il risultato di porre subito con chiarezza alPattenzione dei suoi destinatari un tema che non pud non stare loro a cuore (si tratta del ?vostro impero...?), ma al tempo stesso anticipa come Pincongruenza della situazione giuridico-religiosa di quello stesso impero, da cui si origina la supplica, sia da imputare ad una indistinta terza persona, che piu tardi sara ancora indicata, ma non meglio specificata, con i termini 01 tcoXXoi
(Athen. Leg., 1,3), oi auxocpdcvToci (ibid.), ot apnafyvzzc; 7||xas (ibid.^1,4). A differenza di Tertulliano, Atenagora viene cosi ad identificare un terreno di
comune interesse e di reciproco incontro tra il cristiano e Pinterlocutore altro: Poi
xoufxevY), oggetto delPazione di reggenza degli imperatori e ambito di vita del cristia no. In seguito, questo terreno si ampliera e si specifichera meglio con Pindividuazio ne del vofxoc; quale elemento caratteristico e pertinente per la sua regolamentazione.
Si pud osservare che nei due paragrafi iniziali e presente una strutturazione sim metrica (ma non antitetica come in Tertulliano), significativamente prima anche che siano evocati i cristiani53. Infatti alPespressione di apertura, rj ufxeTepa, fxeyaXoi (3oc atX?cov, oixou[iiv7]... (Athen. Leg., 1,1), corrisponde la frase presente al termine del secondo paragrafo, rj au[A7tocaoc oixouptevr) tt) ufxexepa auveaet Pa6etac, eiprjvrjc, &7coXau
ouatv (ibid., 1,2), in cui si pud rilevare lo spostamento delPaggettivo possessivo dalla
otxoofxevT] alia saggezza degli imperatori. Solo a questo punto sara possibile Pinserzione del soggetto della legatio, i cri
51 Athen. Leg., 1,1: tj ufxexepa, (xeyocXot PaatXecov, oixoufxevrj dXXos dXXois e'Geat xp&vxai xai vo
fjioi<;, xal ouhilq aux&v v6[xa> xai 96(^0) Sixrjc, xav yeXota tj, {jltj axepyeiv xd rcdxpia eipyexat.... 52 Secondo la terminologia ciceroniana, ad esempio di Part, orat., 8,30: ?Nam aut magna quaedam
proponemus, aut necessaria, aut coniuncta cum ipsis apud quos res agetur?; ma il tema e presente in tutta la tradizione retorica da Aristotele in poi.
53 Sembra infatti opportune- accettare l'espunzione, proposta per primo dallo Schwartz, del passag
gio di Leg., 1,2 Tjfjuv hi... xi[Juopia<;, accolta successivamente da tutti gli editori.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

134 M. RIZZI
stiani: ?Noi che siamo chiamati cristiani54, poiche non vi siete dati pensiero anche di noi, lasciate che veniamo ricercati, inseguiti e perseguitati, pur non avendo fatto nulla di male, ma addirittura, come verra mostrato dal procedere del discorso, com
portandoci nella maniera piu rispettosa e giusta sia verso cio che e divino che verso il vostro impero? 55.
Viene pero messo in luce il vantaggio che un corretto trattamento nei loro con fronti apporterebbe, ancora una volta, alia PocatXeioc imperiale, con una puntuale ri presa della terminologia di apertura.
Nel mezzo, tra i due estremi della simmetria ora indicata, la curiositas delle dif ferent! pratiche religiose e cultuali degli alii, i restanti abitanti delPimpero, che ven gono cosi a costituire Pambito e l'ambiente in cui dovrebbero trovare pari dignita anche i cristiani, con eguale liberta di culto 56; il catalogo dei culti non e precipua mente, o solo, sfoggio di erudizione 57 da parte di Atenagora, o intento sarcastico 58, bensi precisa e critica evidenziazione di una molteplicita che ha piu della stranezza e
dell'errore, che non della positivita 59: Papologista si premura subito di mostrare co me il persistere della differenziazione, caratteristica degli alii, sia oggetto di una be nigna concessione da parte degli imperatori60, mentre la positivita della situazione presente deriva invece dalVunita del trattamento legislativo da essi posto in essere, cosi come unico e l'impero 61.
Gli imperatori, pero, ritengono di concedere possibility di esistenza a questa molteplicita religiosa e cultuale perche si tratta comunque di un 'male minore\ Ate nagora, poco prima del passaggio sopra riportato, aveva spiegato le ragioni di que sto atteggiamento: ?Voi e le leggi concedete cio a tutti costoro, poiche ritenete che sia empio ed irreligioso il non credere del tutto in una qualche divinita, e che sia ne cessario considerare come dei quelli che ciascuno vuole, affinche ciascuno sia tratte nuto dall'agire malvagiamente dalla paura verso cio che e divino? 62.
Gli imperatori dunque considerano l'ateismo aaepe^ xal avoaiov; Atenagora ca
ratterizza, per mezzo della ripresa di questa terminologia etico-religiosa, il termine
<ptX6ao<poi dtWinscriptio, che e da interpretarsi nell'accezione, corrente nel II secolo,
54 Si noti come anche in questo caso si sia in presenza di un nominativus pendens corrispettivo a
quello di apertura. 55 Athen. Leg., 1,3: r\[Lzi$ hi ot Xeyou-evoi xpiotiocvoC, oxt [lt\ 7upovevorja0? xai rju-odv, avyx^P^1 ?^
[ATjSev dStxouvxas, dXXd xai rcdvxcov, d><; 7rpot6vxo<; xou Xoyou BeixOrjae-uai, euaePeaxa-ca 5tax?tuivoo<; xai Btxatoxaxa rcp6<; xe xo Getov xat xrjv uu.?x?pav (BaaiXei'av, eXauveaOai xai cpepeaBai xai 8ta>x?aGat.
56 Questo almeno in una fase iniziale: all'interno di questa differenziazione cultuale, per un procedi
mento entimematico a minore ad maius, si precisera il merito maggiore che i cristiani avrebbero per essere tutelati.
57 Cosi il pregevole saggio di N. Scivoletto, Cultura e scoliastica in Atenagora. A proposito del te sto di Leg. 1,1, ?Giornale Italiano di Filologia?, 13 (1960), pp. 231-248.
58 Cf., p.e., P. Ubaldi, in Atenagora, La supplica per i cristiani, Torino s.d. (1920), pp. 4 s. 59 Non a caso analoga formula a quella che caratterizza l'entrata in scena del terzo polo (aXXo<; aX
Xot$: Athen. Leg., 1,1) ricompare a Leg., 25,3 (aXXov aXXax;) per indicare l'azione disgregatrice dei demo ni nella determinazione dei diversi comportamenti negativi (dxaxxoos ?7ctcpopds) degli uomini. II nesso e usato poi sempre con una sfumatura negativa a Leg., 7,2 (dXXov dXXco?), in riferimento all'individualismo della ricerca dei filosofi pagani che non produce conoscenza della verita ne certezza, e a Leg., 22,4 (dXXoi hi dXXcos), ancora in relazione alle diverse ma tutte erronee interpretazioni della divinita da parte dei pagani.
60 Athen. Leg., 1,2: ...?7utxp?7C?x? xai uu.?t<; xai ot vojjloi... 61 Athen. Leg., 1,2: ...oi uiv xaG' ?va taovofjtouvxat, ai hi izoktiq 7cpd<; d?t'av xfjs tar^ [x?x?xouai
xt[xfj<;, xai r\ auu.7uaaa otxouuivr] xfj u(jL?x?pa auviau (3aG?ta<; ?tpr|v7]<; a7uoXauouatv. 62 Athen. Leg., 1,2: xai xouxots rcaatv ?7itxp?ft?x? xai uu.?t<; xai ot voptot, xo uiv ouv (xt)5' oXco<;
Geov rjyaaGat CLGt$i<; xai dvoatov vouiaavx?<;, xo hi olq Exaaxo? (BouX?xat xp^Gat QzoTq dvayxatov, I'va xw 7Tp6<; xo G?tov 8??t draxcovxat xou d8tX?lV.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

;IUSTITIA? E ?VERITAS) 135
di homines ethici. E importante notare che in questo passaggio viene stabilita una
prima diretta relazione tra imperatori e leges, ufxsls xat 01 volaoi, in cui i secondi vengono garantiti dai primi, come il passaggio conclusivo di Leg., 1,2 conferma: e solo per la mitezza e per la mansuetudine, per Panimo pacato e benefico che gli im
peratori mostrano verso tutti che si viene a creare quella situazione di isonomia (tao volaoOvtoci) che e garanzia a sua volta di pace e di prosperity per i singoli come per Pimpero tutto e le citta.
Atenagora ottiene di legare indissolubilmente lo spazio del volaos alia figura de
gli interlocutori imperiali, caricandolo di una valenza immediatamente positiva: la cura stessa per Pecumene, massimo compito degli imperatori, richiede il loro inter vento per realizzare, attraverso lo strumento regolativo del vofxos, il bene dei singoli e delle citta.
Proprio questo accenno alle citta ci offre indicazioni precise sul modello retori co di cui Atenagora fa uso per il suo esordio. Gia F. Millar 63, ritenendo che fosse stato lo stesso Atenagora a dotare il suo scritto del titolo di noeofieia, affermd che cosi ?egli senza ambiguita modula la sua opera sulla forma standard con la quale citta e cor pi sociali organizzati si rivolgevano agli imperatori, attraverso dei rappre sentanti, per tenere un discorso di fronte a loro? 64. A sua volta il Barnes 65 ha rile vato come non manchino esempi di simili artificiose costruzioni retoriche ad esempio in Libanio. Su questa strada si sono mossi anche lo Schoedel66 e il Grant67, rimar cando la relazione esistente tra lo scritto di Atenagora e le indicazioni che Menandro Retore offre a proposito del X6yo<; TCpeapeimxos, il discorso delPambasciatore 68. Possiamo circostanziare meglio questa affermazione notando come Yincipit del Xoyos di Atenagora sia costruito a partire dalla differenziazione cultuale, che pero puo es sere letta anche come differenziazione tra citta (Atene, Sparta e Troia) ed etnico
geografica delle realta costitutive delPimpero. La scansione singoli - citta - intera
ecumene, inoltre, serve ad Atenagora proprio per introdurre e presentare la propria 'citta', quella dei cristiani, elogiando al contempo le virtu degli imperatori, in specie filantropia ed umanita 69: ?Perci6, mentre guardano con ammirazione la vostra no
63 The Emperor in the Roman World, Duckwort, London 1977, pp. 562 s. 64 Ibid., p. 563: ?He unambiguously relates his work to the standard form in which communities
and organized bodies approached the emperors, namely by representatives to make a speech before them?. Non e tuttavia necessario, per convalidare Passunzione del modello letterario, postulare una titolazione di retta di Atenagora; questo problema e connesso a quello phi generale dell'autenticita atenagorea d&M*in
scription per cui cf. T.D. Barnes, The Embassy of Athenagoras, ?The Journal of Theological Studies?, 26
(1975), pp. 111-114. 65 Ibid., p. Ill n. 6. 66 W.R. Schoedel, in Athenagoras, Legatio and De resurrectione, Clarendon, Oxford 1972, p.
XVI. 67 Forms and Occasions, pp. 218-220; Five Apologists and Marcus Aurelius, ?Vigiliae Christianae?,
42 (1988), pp. 1-17. 68 Su questo tema cf. C.W. Woothen, The Ambassador's Speech, ?Quarterly Journal of Speech?,
59 (1973), pp. 209-212; la studiosa tuttavia non esamina la teorizzazione di Menandro Retore, limitandosi ad una selezione dalle opere degli storici greci; soprattutto Schoedel, Apologetic Literature and Ambassa dorial Activities, ?Harvard Theological Review?, 82 (1989), pp. 55-78.
69 Secondo le indicazioni di Menandro Retore, Tleql imSeixnxcbv (p. 423 Spengel): eocv hi urcep nokuxx; xapouarj? 8er) rcpeapeOaai, ipilq uiv xat xauxa a rcpoetprjxat ev xa> axefavcoxtxa), rcavxaxou hi xo
xfjs cpiXav9p<i>7ua<; xou (SaaiXicog au^rjaeu;, xat oxt 9tXotxxt'pfjitov xat eXewv xou; Beouivous, xat oxt 8ta xou xo 6 0eo<; auxov xax?7t?|ic|>?v, oxt rjSet auxov &Xeri(Jiova xat eu 7cotouvxa xou? av0pa>7coo<;. xat oxav ewrrjs xa arcd xfjc avBpeta? ev xoTe, 7toXe[jioi? xal xa amb xfj? ?tpr|vr)<; dyaGa, rfetu; lid xrjv (jtvrjfjtTjv xfjs TCoXeax;, UTcep rjs 7tpea(fetSeis. Su questa topica dell'amplificatio delle virtutes imperiali cf. Schoedel, In Praise of the
King: a Rhetorical Pattern in Athenagoras, in Disciplina Nostra: in Memory of Robert F. Evans, ed. by D.F. Winslow, Philadelphia Patristic Foundation, Cambridge (Mass.) 1979, pp. 69-90.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

136 M. RIZZI
bilta e la vostra cortesia, la vostra disposizione pacifica e la filantropia nei confronti di tutti, i cittadini sono egualmente governati dalle leggi, le citta godono della stessa
dignita secondo il merito, e tutta Pecumene per la vostra saggezza usufruisce di una
profonda pace. Invece noi che siamo detti cristiani...? 70. La scansione privati
- citta sara ripresa, dopo questa presentazione del soggetto collettivo che si esprime con la voce del suo ambasciatore, a Leg., 2,1 e sara ancora incorniciata da un nuovo, reiterato appello alia filantropia e al senso di giustizia de
gli imperatori: ?Dunque e compito vostro, dei sovrani piu grandi, piu umani e piu amanti del sapere, far cessare con la legge la nostra persecuzione, affinche, cosi co me Pintera ecumene e stata accomunata dai vostri benefici sia verso i singoli che verso le citta, anche noi possiamo rendervi grazie perche abbiamo cessato di essere diffamati. Non si addice infatti alia vostra giustizia...? 71.
Passando al nos, Pimmagine dei cristiani che Atenagora offre agli occhi degli imperatori a Leg., 1,3 e tutt'altro che casuale, ed e basata sulla ripresa di tutti gli elementi che in precedenza erano stati utilizzati per disegnare la situazione positiva che Pimpero stava vivendo. Cosi, alPattitudine di sollecita vigilanza e magnanimita dei reggenti, connotata dai termini ?7UTp?7i;?tv, 7tpaov, etpevtxov, cptXavOpomos, corri
sponde, a contrario, Paffermazione della mancanza di analoga cura da parte loro verso i cristiani. Una anomalia ancor piu sorprendente, giacche viene rimarcato co me questi ultimi realizzino al massimo grado proprio le condizioni poste in essere
dagli imperatori e dai vofxoi, come Atenagora aveva affermato in precedenza: alPa
atftiq di Leg., 1,2 risponde euaepeaTocTa a Leg., 1,3; a toO dStxetv 7cp6c; to 0etov il St xociotoctoc Tipoc; xe to OeTov. Si noti, tra Paltro, come questi concetti, applicati alia ge nerality delPimpero, risultano caratterizzati in negativo (a-aejJe?, av-6aiov, a-Stxelv: Athen. Leg., 1,2), mentre invece, applicati ai cristiani, vengono posti addirittura al
grado superlativo. Atenagora fa qui uso di due topiche specificamente suggerite da Menandro Re
tore per il 7cp?<j(kuTtx6c; X6yo<;: Pamplificazione del contrario 72 nella prima parte, e la SiocTUTtcoaic;, che potremmo definire come ?rappresentazione enfatica?, utilizzata soprattutto a Leg., 1,4 73.
Cosi Atenagora usa ancora composti di tipo privativo per indicare la condizione che i cristiani si trovano a dover patire: \ir\hh dSixoOVcocc;... ocTep Sixrjc; (Leg., 1,3); come ovvio, si tratta di una argomentazione tipica di ogni intrapresa apologetica, e tuttavia la strutturazione che viene data alia materia e le stesse scelte lessicali sono tali da insinuare sottilmente negli interlocutori il dubbio che non solo sia in atto una
procedura distorta verso un soggetto tra i tanti, ma che la normalita stessa della
70 Athen. Leg., 1,2-3: hionzp to 7tpaov ujxcov xal Tjfxepov xat to npoc; arcavTa ?tpr)vtx6v xat 91X av0poo7cov 0au(Jtd?ovT?<; ot ptev xa0' eva laovofxouvTat, at hi 7c6Xet? %po<; a?tav Tfjs tar)? (JteTexouat Ttptfji;, xat Tj au(Jt7uaaa oixou[i?V7j ttj ujjteTepa auv?aet pa0eta$ dpr\vr\<; d7CoXauouatv. rj(jtet<; 8e ot Xey6[Ji?vot xpt_ aTtavot...
71 Athen. Leg., 2,1-2: upuov rjSrj i'pyov toov (jteytaTcov xat <ptXav0p(O7UOTaT(ov xat cpiXofxaGecrcdTtov (BaatXewv a7toax?odaat rj[jtwv v6[xq> tt)v ?7trip?iav, IV aSarcEp rj ao[A7uaaa Tat? 7tap' uuxav euepyeatat? xai xa0' eva xexotvwvTjxe xat xaTa 7r6Xet<;, xat rjfxet? e'xwfjiev 6[juv x^Plv <J?ptvuv6fjt?vot oti 7t?7tau(i.?0a auxo
cpavxoufxevot. xai yap ou npo<; xr\<; ufxexepa? Stxatoauvrj?... Lo Stephanus propone in questo passaggio due emendamenti: il primo e la correzione di cptXav0pa>7ucov tradito dai codici nel superlativo, il secondo l'inser zione di otxou[X?VTj in questo punto, modellando l'espressione su Leg., 1,4; mentre il primo dei due e uni versalmente accetto, il secondo viene invece rigettato dalla pressoche totalita degli editori.
72 Questa e la prima indicazione di Menandro (Spengel 423): ?v hi TauTTj 8uo totcou? ipydarj, i'va
pt?v tov arcd if[<; tou dvavTtou aujprjaEoai;... 73 Menandro cosi prosegue (ibid.): then, tov ?x hic/L-zvizoxjiGx;, ?v a> xai 8taax?uda?t<; tt]v rcapouaav
Tuxrjv, OTt 7:?7rTwx?v ?i? ?8a9o?...
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

:IUSTITIA? E ?VERITAS; 137
realta sia rovesciata: e concesso di esistere alia molteplicita che svela da se le proprie contraddizioni e che permette solo condizioni minimali e ridotte di giustizia (il sem
plice (xr) dStxetv), mentre invece chi, oltre che essere gia conforme a questo dato mi nimale ((xrjSev aBixouvxas), garantisce la giustizia al massimo grado (euaepeaTaxa... Stxaioxaxa) viene ad essere perseguitato, in spregio di quei principi formalmente a tutti offerti e tutelati74. Appellandosi alia euaefkioc ed alia quXocvGpoama degli impera tori, Atenagora legittima la richiesta di una modifica del vofioc, a favore dei cristiani: non si tratta di una concessione graziosa, bensi della piu compiuta e completa realiz
zazione, da parte degli imperatori, di quella cura filantropica e saggia dell'impero e
degli uomini che li caratterizza; essi possono e debbono cosi garantire il bene collet tivo attraverso la promozione e la diffusione della piu corretta e veritiera visione del divino, di cui i cristiani sono portatori, che supera di gran lunga in valore la molte
plicita cultuale che lo garantisce solo in negativo (il [jly] dStxelv). In questo senso, la richiesta di Atenagora non e riducibile, come spesso accade, a quella di un generico 'conciliante': non c'e un arretramento delle frontiere di cio che e specifico del cri stianesimo, come mostrera Panalisi del concetto di veritas che piu sotto sara abboz zata, bensi Pevidenziazione di uno spazio valoriale comune e compatibile tra cristia nesimo e altro.
Risulta cosi chiaro come nella argomentazione della Legatio sia riconosciuto e tematizzato sin dalle battute iniziali uno spazio positivo per la lex e Pautorita, stru
menti a disposizione degli imperatori per la realizzazione del bene collettivo, su cui si puo innestare la legittima esistenza del Cristianesimo nelPimpero: Papologista in fatti afferma che la persecuzione si svolge oc-cep Stxrjc, xoct rcocpa rcavToc vofxov xai X6
yov (Athen. Leg., 1,3), contro cioe i due stessi elementi costitutivi dello spazio della cultura antica, appunto v6{jlo^ e Xoyoc;.
Cosi, a differenza di Tertulliano, lo spazio della legge non e connotato imme diatamente in senso negativo, anzi di viene un terreno di confronto, non solo possibi le ma doveroso, con il Cristianesimo, laddove nelYApologeticum Yalterita era imme diatamente oppositiva, non conosceva cioe altra condizione che Pirriducibilita di un termine (il Cristianesimo) all'altro (il paganesimo).
Se nel passaggio da Tertulliano ad Atenagora abbiamo rilevato una maggiore complessita delle strutture esordiali attorno dlYinitium ab iudicibus, il procedimento di Giustino nelYincipit della sua Apologia e ancor piu articolato. Al di la delle tradi zionali osservazioni sul suo greco approssimativo e sciatto, e sempre stata ricono sciuta all5exordium una certa efficacia e una piu attenta cura stilistica 75. La chiave di volta e rappresentata dalPampia inscriptio, che pero e sempre stata indagata nella parte iniziale, in relazione alle titolature dei destinatari, per cercare di determinare la data di composizione, la correttezza degli epiteti ecc. 76. L'Holfelder per primo ha centrato invece Pattenzione sulla coppia di appellativi euaePrj^ e cptXoaocpoc, e sui loro derivati: giustamente lo studioso tedesco nota che Pinsistenza, in altri luoghi dell'ex ordium, nel ripresentare la coppia (lust. Ap., 1,1; 1,2,2; 1,3,2) e le riprese successi
74 Athen. Leg., 3,2: ...xat outco 7cots auyx^P^F011 ouBev rcXeov <rj> xot<; Btcoxouciv rjfJLa<;. 75 Cosi ad esempio K. Hubik, Die Apologien des heiligen Justinus des Philosophen und Martyrers.
Literarhistorische Untersuchung, Wien 1912, pp. 60-64; e da ultimo H.F. Stander, Is Iustin Really a Bad
Stylist?, ?The Second Century?, 5 (1986-1987), pp. 226-232. 76 Per i risultati di queste indagini si pud vedere riassuntivamente il Wartelle nell'ed. cit., pp. 30-34,
che sinteticamente ragguaglia anche sugli studi precedenti, tra i quali occorre ricordare A.A.T. Ehrhardt, Justin Martyr's Two Apologies, ?The Journal of Ecclesiastical History?, 4 (1953), pp. 10-12.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

138 M. RIZZI
ve (ibid., 1,12,5; 11,15,5) si spiegano con la precisa funzione topica di questi termini. Infatti, nella tradizione retorica e presente la concettualizzazione del locus ex nomine come spunto argomentativo; si tratta di una variante, costruita proprio a partire dal
Tinterlocutore, del locus expersonis. Quintiliano la esemplifica cosi: ?Anche il nome e relativo alia persona, di cui e una determinazione accidentale, che pero necessariamen te Paccompagna, ma che difficilmente pud avere a che fare con Pargomentazione, se non quando e assegnato a ragion veduta, come nel caso di Sapiente, Grande, Pio, o
quando anch'esso ha fornito materia per una qualche riflessione; ... Tuttavia da esso si trae abbondante materia di giochi di parole; Cicerone ne ha fatto piu di una volta uso contro Verre? 77.
L'analisi delPHolfelder mostra che ?Giustino, muovendo dai due epiteti della de dica, sviluppa nell'esposizione con la coppia di concetti euaePetoc xai cptXoaocptoc un'ar
gomentazione apologetica, con la quale, nella forma di una applicazione personale, le
ga indissolubilmente autocomprensione filosofica, responsabilita politica e destino
escatologico alia scelta pro o contro il Cristianesimo. Con cio, Giustino ha ricondotto
nell'esposizione la titolatura degli imperatori, cui dirige la propria supplica, a topos della sua argomentazione apologetica? 78. In altri termini, per Giustino, gli imperatori debbono mostrarsi coerenti, di fronte agli uomini e di fronte a Dio, con i loro epiteti di filosofi, per garantire la propria funzione politica
79 e il giudizio escatologico che li
riguardera di persona; naturalmente questo comporta il cambiamento dell'atteggia mento nei confronti del Cristianesimo 80, che rappresenta soprattutto la 'vera filoso fia\ oltreche una garanzia di stabilita per Pimpero, stante la dirittura morale dei cri stiani. Giustino volgerebbe cosi in senso cristiano il tema, molto sviluppato dalla rifles sione etico-filosofica del II secolo, della responsabilita nella gestione del potere.
Si pud certamente concordare con queste osservazioni. Tuttavia un piu minuzioso esame dAY exordium permette di aggiungere precisazioni importanti. Innanzitutto, oc corre notare che ndYinscriptio, accanto ai due epiteti euaeprjc e cpiX6ao<po$, ne compare un terzo, quello di ?pa<jT7]$ 7cou8eta$; inoltre non e senza significato, sempre nella dedi ca, il modo in cui Giustino presenta Poggetto della sua supplica, i Cristiani, e con esso anche se stesso 81: ?... A vantaggio degli uomini di tutte le razze, ingiustamente odiati e perseguitati, io Giustino, figlio di Prisco e nipote di Bacchio, originari di Flavia Nea poli di Siria Palestina, uno di loro, ho redatto questa interpellanza e supplica? 82.
77 Quint. Inst. or., V, 10,30 s.: ?Ponunt in persona et nomen, quod quidem accidere ei necesse est, sed
in argumentum raro cadit, nisi cum aut ex causa datum est, ut Sapiens, Magnus, Pius, aut et ipsum alicuius
cogitationis attulit causam... Iocorum tamen ex eo frequens materia, qua Cicero in Verrem non semel usus est?.
78 Holfelder, Eusebeia kai Philosophia, p. 59: ?...Die Analyse... hat gezeigt, dass Justin ausgehend von den beiden Epitheta im Praskript in der Exposition mit dem Begriffspaar sua^eta xai 91X0(709101 einen
apologetischen Argumentationsgang entwickelt, mit dem er in der Form einer persdnlichen Applikation philo sophisches Selbstverstandnis, politische Verantwortung und eschatologisches Geschick unabtrennbar mit der
Entscheidung fur oder gegen das Christentum verbindet. Damit hat Justin schon in der Exposition die Titula tur der Kaiser, an die er seine Eingabe richtet, zum Topos seiner apologetischen Argumentation gemacht?. Si
puo altresi notare come il primo ad indicare questo tipo di procedimento argomentativo, pur non sviluppan done le conseguenze cosi a fondo, sia stato T.M. Wehofer, Die Apologie Justins des Philosophen und
Martyrers in literarhistorischer Beziehung zum erstenmal untersucht, ?R6mische Quartalschrfit?, Supp. 6, 1897, p. 9n. 2.
79 Secondo l'indicazione di Platone, che Giustino citera esplicitamente ad Ap., 1,3,3. 80 Cf. Holfelder, Eusebeia kai Philosophia, pp. 60-66 (il titolo del paragrafo e: ?Die topische Funk
tion von uxTOcvoeTv, u.?Tcm0?a0at?). si Ibid., p. 54 n. 20. 82 Iust. Ap., 1,1: ...uTuep twv ?x 7uocvto<; yfvous dv0pw7uwv dBtxco? puaoofjivcov xai ?7tt]p?a?ofX?voov,
TouaTtvo$ Ilptaxou tou Baxx^tou, xwv owio OXaoutag N?a<; 7i6X?co<; xfjs ?upia$ riaXataTtvr]^, ?i<; auxwv, xrjv 7cpoa9a>vr)aiv xai evxeojiv 7c&7coi7](xai.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

;1USTITIA? E ?VERITAS) 139
II radicale Six-, che qui nell''inscriptio si presenta nella forma avverbiale a8ixa>$, compare con insistenza nel primo paragrafo del testo (lust. Ap.f 1,2,1, nelle forme
aSixcos e xa Sixocia), che viene a svolgere la funzione di yvcofjir) proemiale 83: esso e infatti utilizzato per enunciare i principi generali cui si deve attenere chi voglia essere
?ucj?[3y)s xoct cptXoaocpo^. Giustino circostanzia e riempie di contenuti quegli epiteti che ha riservato agli imperatori mlYinscriptio. Questa specificazione e centrata sul con cetto di giustizia: chi si fregia di tali titoli non solo e necessario non segua chi faccia e predichi Tingiustizia, bensi positivamente deve operare la giustizia: ?A coloro che sono pii e filosofi secondo verita, il logos impone di stimare ed amare solo il vero, rifiutando di seguire le opinioni degli antichi, qualora siano cattive: infatti, il logos sapiente non solo ordina di non seguire coloro che facciano o teorizzino qualcosa di
ingiusto, ma altresi che chi e amante della verita debba scegliere di dire e fare cio che e giusto in ogni modo e a costo della sua stessa vita, se anche la morte lo mi nacci? 84.
A questo punto, specificati nella yvcofxr] proemiale gli obblighi derivanti dalla ti tolatura deWinscriptio, e possibile tornare alia diretta interpellazione degli interlocu tori; notiamo che ad Ap., 1,2,2, Giustino riprende tutti i termini presenti nell'm
scriptio 85, ma aggiungendo un ulteriore epiteto, attinente proprio la salvaguardia e la pratica della giustizia: ?Voi dunque, che siete detti pii, filosofi, custodi della giu stizia (cpuXaxes Sixatoauvris)86 e amanti della cultura, ascoltate dunque: se lo siete, sara messo in chiaro? 87.
L'argomentazione che Giustino costruisce parte cosi da una situazione dell'ogget to della supplica (i cristiani perseguitati aStxcos) che si contrappone alia qualifica degli imperatori come euaejkls xai cpiXoaocpot xai epaaxai 7rai8?tas, che sono quindi chiamati a superare la situazione di a-normalita (<x-8ixoj<;), anzi a capovolgerla ristabilendo le
giuste condizioni, per poter essere pienamente coerenti con gli epiteti precedents Si ve de cosi come Yargumentum ex nomine, individuato dalPHolfelder, abbia un concreto campo di applicazione, la Sixocioauvr], delimitato dalla iustitia e dalla lex. Come in Ate nagora, anche per Giustino la funzione imperiale si definisce per la sua pertinenza al
campo della lex (cpuXoc? Bixaioauv7]<;); tuttavia, mentre per il primo la positivita dell'a zione degli imperatori era gia di per se evidente 88 e il trattamento riservato ai cristiani
83 Secondo l'indicazione retorica che nelPenunciazione di una massima di sicura condivisibilita vede va una delle forme piu efficaci per prendere la parola; si veda ad esempio la rexvr) di Rufo di Perinto
(Spengel, 402): y) hi yvcoptT) aeuwcepav xtjv rcpoxaxdaxaatv xou Xoyou 7cot?t, ox; 6 0ooxu8i'8t]s rcavxaxT)- Si
pud notare che Giustino connette le due topiche esordiali, initium ab iudicibus e yvcbfxri proemiale, Tuna utilizzata nell'ampia inscriptio, l'altra qui al primo paragrafo di testo, fondendole infine ad Ap., 1,2,2-3: uu.et<; uiv ouv oxt XeyeaGe euaeP&T? xai 91X600901 xai 9uXax?<; 8txatoauvr)<; xai epaa-cai 7rat8eta<;, dxou?x?
Travxaxou- ei hi xai uroxpxexe, 8etxGr|aexat... d*catxr|aovxe<; xaxd xov dxptPfj xai e?exaaxix6v Xoyov xtjv xptatv TcotrjaaaGat... \ir\ TCpoXrj4>?t u.r)8' dvGpco7i;ap?ax?ta xt) BeiaiBatfxovwv xax?xouivou$...
84 Iust. Ap., 1,2,1: xou<; xaxd dXrjGeiav euae(kte. xai 91X006900^ u.6vov m\r$i<; xtu.dv xai axepyetv 6
Xoyo? UTtayop&uei, 7capatxouuivou<; 86?au; rcaXatcov ??axoXouGetv, av 9auXat coatv ou yap [xovov u.7) erce aGat xot<; d8txco$ xt rcpd^aatv rj 8oyu.axtaaatv 6 aa>9pcov X6yo<; UTcayopeuei, dXX' ex izcwzbq xpOTCOu xai npo xrj<; eauxou c|)uxfj? xov cpiXaXrjGr), xdv Gdvaxo<; a7i?iXfjxai, xd 8txata X?yeiv x? xai 7tpdxx?tv atp?taGat 8?t.
85 L'Holfelder tralascia di osservare questo particolare, e limita cosi la sua analisi alia coppia ?u
<j?Pr)<;/9iX6ao90<;, non accorgendosi che anche in questo caso Giustino opera un arricchimento del suo det tato attraverso la quasi impercettibile inserzione di elementi ulteriori.
86 Si noti come questo ulteriore epiteto sia inserito in terza posizione all'interno della serie dei titoli
ripresi da\V inscriptio. E chiaro cosi il suo carattere aggiuntivo rispetto alia dedica. 87 Iust. Ap., 1,2,2: ufxeT? uiv ouv oxi X?y?aG? ?uae(3et<; xai 91X600901 xai 9uXaxe<; 8txatoauvrj<; xai
epaaxai rcaiSeias, dxouexe 7uavxaxou* et hi xai urcdpxexe, SetxOrjaexat. 88 Athen. Leg., 1,2-3: Storcep xo rcpaov uu-aiv xai r\[Ltpov xai xo npbq arcavxa ?tpyjvtxov xai 91X
dvGpcoTiov 6au[xdCovx?i; ot uiv xaG' eva taovo^ouvxat, at 8e 7x6X.ei<^ npbq d?tav xr\q Xvr\q [x?x?Xouat tijjlyj?, xai r\ (juu-Ttaaa otxouuivri xfj uu.?x?pa auviaet PaGeta? etprjvTi^ drcoXauouatv. r\\iii<; hi ot X?y6[x?vot xp^iavot...
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

140 M. RIZZI
un'anomalia sia pure paradossale, Giustino lascia impregiudicato il giudizio sugli im
peratori: ei Se u7capx?t?, BeixOrjaeTai (lust. Ap., 1,2,2). Anche i cristiani, con Patteggiamento che li distingue, si muovono su questo
piano: la richiesta avanzata da Giustino, che parla in prima persona plurale, e quella di un giudizio equanime e approfondito 89, che altrimenti il giudizio negativo si ritor cerebbe immediatamente contro gli stessi imperatori.
Ma si noti come sia solo dopo questa ampia caratterizzazione delPinterlocutore, sviluppata a partire dalle categorie di auctoritas e di iustitia, che compaiono per la
prima volta i cristiani. In Giustino la contrapposizione noi/voi viene a costituirsi
partendo dalPaffermazione di innocenza dei cristiani e dal connesso problema della corretta esplicitazione della giustizia 90: ?Noi infatti abbiamo ritenuto di non poter subire alcunche di male da parte di alcuno, se non siamo accusati di essere operatori di malvagita o se non siamo stati riconosciuti colpevoli: voi potete ben ucciderci, ma non danneggiarci? 91.
Non deve inoltre sfuggire il parallelismo che Giustino realizza tra questa e Paf fermazione di Ap., 1,2,1: chi e euae(3y|?' xai cptXoaocpos deve scegliere di predicare e fare il giusto, anche se cio potra costargli la vita (xav 0avaTo$ a7r?iXrjTat); e qui, ad
Ap., 1,2,4, Porgogliosa affermazione dell'apologista vuole indicare che, in realta, il
giudizio sui cristiani e giudizio sugli accusatori92: Pindifferenza di fronte alia morte situa immediatamente il nos dei cristiani nel numero di coloro che toc Sixocioc TipdcT xouaiv, e con cio stesso li sottrae a qualsiasi giudizio.
L'apologista colloca dunque sia il nos che il vos nel campo della iustitia e della lex, e al tempo stesso definisce le condizioni di coerenza che in esso devono vincola re gli imperatori.
Riassumendo, si pud osservare come si e sviluppata la tecnica compositiva di Giustino: a partire dalla definizione degli imperatori come euaePets xal <piX6ao<poi xai
spaaral TcatSeiac e attraverso Piterazione del radicale Six-, Pautore ha portato a
compiuta tematizzazione il ruolo centrale che anche in questo caso gioca la iustitia nel rapporto tra il nos dei cristiani e il vos degli imperatori.
A questo punto, sempre attraverso la tecnica della Themenfiihrung, viene intro dotta la terza figura, quella degli accusatori. Essa e lasciata pero sullo sfondo, con Puso delPindeterminativo tic; (lust. Ap., 1,2,4) e di ocutgov (ibid., 1,3,1). L'entrata in scena del terzo attore del discorso serve a Giustino per ribadire ulteriormente il ruo lo degli imperatori come garanti della giustizia, ancora grazie alPiterazione del radi cale Six-: aSixetv (lust. Ap., 1,3,1); xocXyjv hi xai [xovrjv Bixou'ocv ^poxXyjaiv...
93 (ibid., 1,3,2); infine ...rjv fxr) toc Si'xata 7roirja7]t?... (ibid., 1,3,5). II terzo capitolo dell'Apo logia riprende cosi elementi gia trattati da Giustino: la ritorsione del giudizio contro
gli stessi imperatori se non verranno rispettate le condizioni di un esame equilibrato delle accuse (lust. Ap., 1,3,1); una nuova variazione sull'argumentum ex nomine
89 Iust. Ap., 1,2,3: ...djtatxrjaovxei; xaxd xov dxptpfj xai ???xaaxtx6v Xoyov xrjv xptcnv TrotrjaaaGai. 90 Atenagora aveva invece introdotto il nomen dei supplicanti limitandosi ad indicare la generica
condizione di ingiustizia in cui essi risultano costretti. 91 Iust. Ap., 1,2,4: rjfjiets uiv yap npbq ouSevo? 7t?iaea0a? xi xaxov 8uvaaGai XeXoytafxeGa, ^v fxr]
xaxt'a? ipydxai eXeyx^^6^01 ^ KOvr\poi BieyvcoafxeGa* uuxts 8' a7uoxxetvai uiv SuvaaGe, (3Xac[>at 8' ou. 92 Come conferma il parallelo con Iust. Ap., 1,27,5: xai xd 9avepa><; upiiv 7ipaxx6u.?va xai xtu.cou.eva
dvaxexpa{X[X?vou xai ou 7rap6vxo<; 900x6$ Geiou rjulv 7rpoaypd9?xe- 07cep dTnqXXayuivoK; r\\iiv xou rcpdx xeiv xi xouxcov ou pXd(3r|V cpepet, dXXd xot? rcpaxxouai xai c[)?u8ou.apxupouai piaXXov.
93 Non mi sembra opportuno seguire il Wartelle che, seguendo l'Otto, nell'ed. cit., pp. 100; 240 cor
regge questo termine in rcpoaxXiqaiv: il testo tradito non da luogo a problemi.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

?IUSTITIA? E ?VERITAS) 141
(ibid., 1,3,2); a parziale correzione di quanto precedentemente detto circa le opinioni degli antichi che non devono essere seguite acriticamente 94, e citato Platone, ?uno
degli antichi? 95, per dare maggiore autorevolezza al proprio discorso; soprattutto, Giustino riprende Pantitesi noi/voi che gia caratterizzava la conclusione del secondo
capitolo o\z\YApologia. Questa volta, pero, essa viene declinata in una piu precisa prospettiva giudiziale: ?Nostro compito e dunque fornire a tutti un esame della vita e delle dottrine, in modo da non dover subire noi stessi, al posto di coloro che riten
gono di ignorare le nostre azioni, la punizione di quelle azioni che a loro volta com mettono. Vostro invece, come richiede la ragione, essere ritenuti giusti giudici, dan doci ascolto? %.
Questo passaggio svolge la funzione di propositio, anticipatrice degli sviluppi ar
gomentativi successivi. Rispetto a Tertulliano ed Atenagora la part it io viene premes sa al trattamento del problema del nomen; cio si spiega con la peculiarity dello stile
argomentativo dell'autore 97.
Vediamo cosi Papologista procedere, nel suo exordium, per sezioni di testo con catenate strettamente tra loro da rimandi concettuali ed iterazioni lessicali, creando una unita omogenea, ma riccamente articolata al suo interno, attorno alia definizio ne degli attori del confronto (i cristiani, gli imperatori, gli accusatori) e del terreno su cui esso si svolge, quello delPapplicazione corretta e razionale della iustitia.
Si sono cosi esaminati gli initia ab iudicibus delle tre opere. In tutte e stato pos sibile riscontrare, coerentemente con la caratterizzazione delPinterlocutore cui ci si
rivolge, una precisa attenzione a delimitare il piano su cui si svolge il confronto tra cristiano e altro, quello della iustitia. Per i due autori orientali siamo in presenza di un per cor so articolato e complesso, laddove, invece, in Tertulliano abbiamo visto operare una netta contrapposizione tra lo spazio della lex e quello della veritas. L'e same del trattamento del problema del nomen diviene cosi il secondo momento del Panalisi.
A questo proposito e chiara in Tertulliano la consapevolezza che Pavversione dei pagani al nomen christianum non e un semplice incidente di percorso, che si puo esaurire nel momento in cui ne vengano rimosse le casuali circostanze che Phanno generato. In realta per Pautore deWApologeticum P?iniquitas odii erga nomen chri stianorum? (Tert. Apol., 1,4) e semplicemente la manifestazione in superficie di un
atteggiamento negativo piu profondo del mondo romano nei confronti della nuova
religione. Tertulliano sviluppa una lunga trattazione dei problemi giuridici connessi alle procedure anticristiane (Apol., 1,4-3,8) e successivamente una ulteriore digressio ne sulle leges e la loro auctoritas (Apol., 4,3-6,10). Tuttavia non si deve venir tratti
94 Iust. Ap., 1,2,1: ...7tapaixou|Jievou<; 86?ais rcaXatcov e|;axoXou0etv, av 9auXai waiv. 95 Iust. Ap., 1,3,3: ... xat xt<; xcov rcaXaicov. 96 Iust. 1,3,4: Tjfxe-uepov ouv epyov xai (Sfou xai |j.a0T)(jidxcov xr)v e7uaxec|nv Tcdat rcapexeiv, 6tcco<;
fjtTj urcep xcov dyvoeiv xd 7)[xexepa vo(ju?6vxcov xrjv xtfxcopiav, cov av 7tXr)fji[xeXcoai xi^Xcbxxovxei;, auxot eau
xot? ocpXrjacofxev uuixepov 8e, <!><; aipei X6yo<;, dxouovxa? dyaGou? eupiaxeaGai xptxa?. 97 Si noti come il compito proprio dei cristiani riprenda quanto gia detto da Giustino ad Ap., 1,3,2
circa gli accusati che debbono esporre piov xai Xoyov all'esame dei giudici, secondo un procedimento di ar
gomentazione analogo a quello gia sviluppato da Giustino tra Yinscriptio e il cap. 2 dell'Apologia: enuncia zione del soggetto (dljioufxev xd xaxr)yopouu,eva: Iust. Ap., 1,3,1); principi generali che si applicano alia si tuazione (xaXrjv 8e xai (jlovtjv 8ixaiav 7ip6xXr)atv: ibid., 1,3,2); applicazione dei precetti generali al soggetto concreto (Tjuixepov ouv epyov...: ibid., 1,3,4). Ancora a margine, si puo inoltre osservare come la funzione
giudiziale degli imperatori sia sempre scandita da una ricorrente ed esplicita conessione al tema delia razio
nalita, del Xoyo?, che infatti compare, nella forma sostantiva o nei suoi derivati, ad Ap., 1,2,1 (bis); 1,2,3 (bis); 1,3,1 (bis); 1,3,4.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

142 M. RIZZI
in inganno circa le reali intenzioni delPapologista: non vi e, in lui, fiducia in una
positiva risoluzione delle contraddizioni cosi messe in luce, quanto invece suo obiet tivo e smascherare il vero atteggiamento degli interlocutori, al di la della situazione
giuridica. Quest'ultima e, infatti, semplicemente una costruzione elaborata per dare una parvenza di legittimita alia malvagita che agisce contro i cristiani, frutto di odio e di ignoranza. Si noti come ad Apol., 1,4 Tertulliano enunci il tema che sta per trattare: ?Hanc igitur primam causam apud vos collocamus iniquitatis odii erga no men christianorum?. Ebbene, al termine del ragionamento Yiniquitas erga nomen si e smascherata per quello che e in realta, iniquitas contro i cristiani tout-court: ?At
que adeo, quasi praefatus haec ad suggillandam odii erga nos publici iniquitatem...? (Tert. Apol, 4,1).
L'argomentazione giuridica e per sua stessa natura accessoria e derivata rispetto alia contrapposizione originaria tra cristianesimo e altro, come conferma Pesclama zione a proposito della contraddizione insita nel rescritto di Traiano: ?0 sententiam necessitate confusam!? (Tert. Apol., 2,8). La necessitas e quella delPopposizione as
siologicamente inevitabile tra Cristianesimo e altro da esso. Cosi, Pargomentazione condotta da Tertulliano nella sezione di testo compresa tra Apol., 1,4 e Apol., 4,1 si
sviluppa sul piano formale e vuole metterne in luce le contraddizioni interne che si trasferiscono immediatamente sul piano procedurale; la difesa sostanziale del Cristia nesimo sara svolta successivamente, ma questa premessa non solo inficia a priori il valore legale della politica avversa ai cristiani, ma rende anche impossibile una valu tazione positiva della stessa lex e della iustitia ad essa connessa, e quindi la concilia zione tra impero e cristiani98.
Anche Pargomentazione che Tertulliano sviluppa a proposito delle leges si muo ve in questa direzione, ed e chiaramente enunciata poco dopo, quando egli ristabili sce esattamente la dicotomia di partenza ddYincipit: da un lato la veritas, definita in
maniera perentoria nostra, dalPaltro Yauctoritas legum 99; successivamente ricompare ancora la contrapposizione spaziale tra lex e veritas: ?Si lex tua erravit, puto, ab ho mine concepta est; neque enim de caelo ruit? (Tert. ApoL, 4,5). Non e questo sem
plicemente un sarcastico hon mot; e Pessenza stessa della situazione: il cielo non pud essere generatore della lex, proprio perche lo spazio del cielo e sedes veritatis (ibid., 1,2), e con cio stesso di Dio, mentre il regnum legum e spazio delPuomo: tra i due e'e concorrenzialita ed opposizione, come e confermato subito: ?Per dire qualcosa delPorigine delle leggi di questo genere, esisteva un antico decreto che proibiva che una qualche divinita venisse consacrata dd\Y imperator senza P approvazione del sena to... Cio si confa al nostro caso, perche presso di voi la divinita e definita dalParbi trio umano. Se dio non sara piaciuto alPuomo, non sara dio: infatti e Puomo che dovra essere propizio a dio!? 10?.
Dunque la lex per Tertulliano non puo essere nulPaltro che il prodotto umano di un processo basato sul riconoscimento di una aequitas consensuale, non categoria le (fondata cioe su una iustitia assoluta e conforme alia veritas), e percio stesso falli bile ed inefficace: Papologista enuncia con chiarezza questa sua convinzione dappri
98 Cf. Waltzing nell'ed. cit., pp. XLIX-LI. 99 Tert. Apol., 4,3: ?Sed quoniam, cum ad omnia occurrit veritas nostra, postremo legum obstrui
tur auctoritas adversus earn, ut aut nihil dicatur retractandum esse post leges, aut ingratis necessitas obse
quii praeferatur veritati, de legibus prius consistam vobiscum, ut cum tutoribus legum?. 100 Tert. Apol., 5,1: ?Ut de origine aliquid retractemus eiusmodi legum, vetus erat decretum, ne qui
deus ab imperatore consecraretur, nisi a senatu probatus... Facit et hoc ad causam nostram, quod apud vos de humano arbitratu divinitas pensitatur. Nisi homini deus placuerit, deus non erit; homo iam deo propi tius esse debebit?.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

:IUSTITIA? E ?VERITAS) 143
ma in termini teorici 101 e successivamente storici con la vasta esemplificazione del sesto capitolo dell5Apologeticum.
Veritas e lex, cosi come tipologizzate da Tertulliano, sono quindi due realta in
compatibili, non mediate ne mediabili nel campo della iustitia; tra i cristiani portato ri della veritas nostra e gli altri interpellati in quanto tutori delle leggi, Tunico punto di contatto e il confine che separa e non unisce. Su questa opposizione, programma ticamente enunciata nelle sue prime battute, si consuma VApologeticum: ?Ut est ae
mulatio divinae rei et humanae, cum damnamur a vobis, a Deo absolvimur? (Tert. ApoL, 50,16). Sostituendo cosi alia coppia antitetica veritas/lex quella di Deus/vos, Tertulliano viene a concludere il suo scritto, stabilendo una sostanziale identita tra veritas e Dio, nella linea tracciata anche in altre sue opere: ?Qual e infatti il sapiente e conoscitore della verita che ignora che Dio e il padre e il signore della verita e del la stessa sapienza?? 102. La centralita del concetto di verita nella teologia di Tertullia no e gia stata sottolineata in molteplici studi, in specie dal Braun 103; l'importanza di
questa sottolineatura non risiede quindi nelle sue implicazioni storico-teologiche 104, quanto invece nella caratterizzazione di questa opposizione come principio di struttu razione del discorso sviluppato da Tertulliano nell'Apologeticum; il che naturalmente si riconnette alia sua impostazione teologica, ma ne rappresenta una concretizzazione
specifica in relazione a determinati interlocutori e ad una precisa forma retorico-ar
gomentativa. E proprio questa connotazione della coppia lex/veritas che caratterizza Tertullia
no nei confronti di Giustino ed Atenagora. Non e un caso che in questi due autori l'esame degli aspetti procedural! delle accuse anticristiane, pur presente, non conosca uno sviluppo altrettanto ampio, e soprattutto il discorso non venga esteso alPanalisi storica di altre situazioni di conflitto religioso, come invece per l'apologista latino.
101 Tert. Apol., 4,13: ?Nulla lex sibi soli conscientiam iustitiae suae debet, sed eis, a quibus obse
quium exspectat. Ceterum suspecta lex est, si probari se non vult, improba autem, si non probata do minatur?.
102 Tert. Ad nat., 11,2,2 ?Quis autem sapiens, expers veritatis, qui ipsius sapientiae ac veritatis pa ttern et dominum Deum ignoret??. E chiara nelPApologeticum la funzione di Cristo quale portatore della
possibilita di accedere alia verita, secondo l'indicazione di Apol., 21,30. E in questa chiave che si compren de il problema deW ignorantia vestra rinfacciata ai pagani: il rifiuto di accedere alia veritas e tutt'uno con il rifiuto di conoscere il Cristianesimo e con la scelta di perseguitarlo.
103 R. Braun, Deus Christianorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien, Etudes
Augustiniennes, Paris 19772, soprattutto alle pp. 74-76 (sotto la voce Le Dieu vrai) e 74 s. (s.v. Veritas): secondo il Braun Tertulliano ?ha concepito il cristianesimo come la verita in opposizione al secolo che e il
regno del mendacium, dell'error, della vanitas? (p. 74). Si pud vedere anche il lavoro di Lortz, Tertullian, I, p. 192; II, pp. 87-95 (Die Religion des Wahrheit). J.C. Fredouille, Tertullien et la conversion de la cul ture antique, Etudes Augustiniennes, Paris 1972, non dice nulla a questo riguardo; probabilmente l'avere trascurato questa dimensione centrale nel pensiero di Tertulliano ha portato il Fredouille a conclusioni non del tutto accettabili (la forte attenuazione cioe della contrapposizione di Tertulliano nei confronti della cul tura a lui contemporanea), per quanto di estremo interesse, come testimonia il ricco dibattito stimolato dal le sue pagine, su cui si pud vedere la precisa ed equilibrata sintesi di P. Siniscalco, Recenti studi su Ter
tulliano, ?Rivista di Storia e Letteratura Religiosa?, 14 (1978), pp. 396-405, cui si rimanda anche per l'ulte riore bibliografia e di cui merita riportare parzialmente la conclusione: ?Tertulliano e convinto che natura
(e quindi ragione), legge (e quindi norme morali che permettono la convivenza umana) e S. Scrittura abbia no la loro fonte unica in Dio. Dal che discendono due conseguenze: non e possibile vi sia contraddizione tra loro; cio che e loro contrario non perviene da Dio e va percio respinto? (p. 404). E questo il caso delle
leges dell'Apologeticum. 104 Che peraltro sono state assai indagate, cf. la nota precedente; si badi inoltre che l'analisi qui con
dotta e mirata esclusivamente alia strategia apologetica posta in atto nell'opera esaminata, senza I'intenzio ne di una generalizzazione complessiva circa 1'opera e la figura di Tertulliano. Cio che qui interessa e l'a nalisi della struttura e del contenuto precipuamente letterario delle opere che vengono esaminate.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

144 M. RIZZI
Viene altresi richiamato il preciso ruolo che gli imperatori possono svolgere nell'esa me sostanziale dei fatti imputati al cristianesimo.
In effetti, per Atenagora non e solo una forma di captatio benevolentiae Paffer mazione della giustizia degli imperatori in opposizione alia degenerazione della plu rality degli atteggiamenti cultuali, quanto invece il riconoscimento delPesistenza di un ambito possibile di confronto tra Cristianesimo e realta civile. In Atenagora, lo
sviluppo che il tema del nomen conosce nel secondo capitolo della Legatio viene co struito partendo dal richiamo alia Sixatoauvr] degli imperatori; cosi, esso e concluso dalla fiduciosa affermazione che una corretta informazione coincidera con il ristabi limento del giusto rapporto tra ius e veritas: ?E dunque necessario che io, mentre inizio a difendere la mia dottrina, vi supplichi, o grandissimi imperatori, di essere
giusti ascoltatori nei nostri confronti e di non venir fuorviati per Pessere condiziona ti da una volgare ed insensata diceria, ma di indirizzare il vostro amore per la sa
pienza e la verita anche verso la nostra dottrina. Cosi voi non sbaglierete piu per ignoranza, e noi, liberati dalla sciocca accusa delle masse, cesseremo di essere perse guitati? 105.
Sostanzialmente analogo e Patteggiamento di Giustino 106. II trattamento esplici to della questione del nomen e sviluppato nel quarto capitolo dell'Apologia; anche in questo caso, dopo Piniziale esplicitazione (6v6[aocto$ jxev...) si arriva al cuore del
Pargomentazione attraverso un processo di scivolamento tematico che procede per approssimazioni sempre piu strette alPoggetto vero e proprio. II nomen christianum
comparira esplicitamente solo verso la fine del ragionamento (lust. Ap., 1,4,5): alPi nizio Giustino si esibisce in un gioco di parole o, meglio, in una altra applicazione delle potenzialita dell''argumentum ex nomine 107, che gli offre il destro per un'arguta contestazione della persecuzione: non pretendendo di essere assolti per che portatori del nome di ?eccellenti? (xpia-uiavol ex xp^aTOTaTot) se ne venisse provata la perver sita, i cristiani a contrario non debbono essere condannati senza che ne sia dimostra
ta la malvagita (lust. Ap., 1,4,1-2) 308. Giustino, rispetto ad Atenagora, presenta a questo proposito una ulteriore e si
gnificativa inserzione: la responsabilita dei giudici, gli imperatori, e attenuata dall'in flusso negativo dei demoni di cui sarebbero vittime, come gia anche gli Ateniesi nel caso di Socrate 109: ?Contro di noi, che facciamo professione di non commettere in
105 Athen. Leg., 2,6: dvayxatov hi \ioi dpxouivco d7uoXoy?ta0at orcep xoG Xoyoo 8eTj9fjvat ufjttov, jxe ytaxot auxoxpaxope;, laou? rjfxtv dxpoaxd; yeveaOat xai ptrj xfj xotvfj xai dXoyto 9T)U.T) auvarcevex^vxas TCpoxaxaax^vat> ?fttxpec|>ai 8e Ufxtov xo 9iXou.a0e<; xai 9tXdXr)9e? xat xcp xa0' T)|xd<; Xoyto. ufxel^ xe yap ou icpoc dyvot'a; e^afxapxTjcexe xai 7)fA?t<; xd arcd xfj; dxpt'xou xcov tuoXXcov 9rju.7]<; d7uoXi>ad[xevot rcauaopteGa 7roXe(xoufjt?Vot. Si noti anche 1'allitterazione che chiude il capitolo.
106 Cf. Schoedel, Apologetic Literature, p. 27; Keresztes, Law ffrtflf Arbitrariness in the Persecution
of the Christians and Justin's First Apology, ?Vigiliae Christianae?, 18 (1964), pp. 204-214. 107 Che e banalizzante ridurre a 'falsa etimologia': espressione tipica di sensibilita retorica, Yargu
mentum ex nomine non pud essere ridotto a semplice metalogismo, come vorrebbero le categorie della logi ca formale; del resto dalle etimologie di Heidegger alle 'affabulazioni' filosofiche postmoderne la categoria ha conosciuto una sostanziale, anche se misconosciuta, nuova vita.
108 Qui, l'argomentazione e giocata sul paradosso e sull'antitesi, come tante che incontriamo in Ter
tulliano, ma non e difficile cogliere il differente 'tono' tra i due autori. Va pero notato come questa sezio ne di testo sia in qualche misura legata ai passaggi precedenti; lo sviluppo del tema avviene anche in questo caso attorno alia reiterazione di alcuni termini gia usati piu indietro: si tratta di eXeyxco ed xaxT)yopeco, non a caso tipici del linguaggio giudiziario; questi verbi erano stati utilizzati da Giustino in due passaggi assai ravvicinati ad Ap., 1,2,4 ed Ap., 1,3,1, e sono ripresi con frequenza nella sezione di Ap., 1,4,1-6, per un totale di cinque volte ciascuno.
109 Sulla figura di Socrate nella letteratura cristiana antica, oltre al classico lavoro di A. von Har
nack, Socrates und die alte Kirche, Berlin 1900 (pp. 8 s. su questo passaggio), si puo vedere ora K. Doe
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

IUSTITIA? E ?VERITAS) 145
giustizia e di non considerare queste cose empie, voi non istruite processi, ma spinti da una passione irrazionale e dalla frusta dei demoni malvagi, ci perseguitate in ma niera sconsiderata, senza rifletterci? uo.
Giustino, dopo aver introdotto il nomen christianum (ad Ap., 1,4,5) e aver chia rito definitivamente quale sia Pambito in cui si svolge il confronto in atto 1H, con clude Yexordium con il ricordo della figura eponima: tou SiSocaxdcXoo Xptato^ (lust. Ap., 1,4,7); pud iniziare cosi Pesposizione vera e propria delPapologia, secondo la propositio di Ap., 1,3,4.
In Giustino e Atenagora Pinterpellazione ddYaltro avviene nel nome e sul terre no della iustitia, e non con Popposizione della veritas, come invece in Tertulliano. Lo stesso richiamo alia verita, pur presente, e realizzato in maniera diversa: in Ate nagora Puso del termine dXrjGeia e del campo semantico ad esso connesso e sapiente mente graduato ne\Y exordium; esso compare per la prima volta a Leg., 2,6 nella se zione del testo, piu sopra riportata, dedicata alPesame del nomen, nella forma del derivato cpiXocXiqOes, unito a cpiXofxaGes; Atenagora e cosi attento, in qualche misura, a non enfatizzarne, almeno in questa fase, il valore.
L'aggettivo alrfiic, viene utilizzato poi a Leg., 3,1 non in senso pregnante, ma
semplicemente nelPaccezione di ?reale?, ?dimostrabile?. E in conclusione delYexor dium che si trova per la prima volta il vocabolo ?verita? con significato pieno, al termine del discorso sulla giustizia e sugli imperatori, per mostrare come la fiducia dei cristiani nella giustizia e nella vittoria sulle calunniose accuse derivi dalla consa
pevolezza della propria dedizione ? sino alia morte ? alia verita: ?Supereremo sen za dubbio costoro (scil. gli accusatori), noi che senza esitazione offriamo anche la nostra vita per la verita? 112.
Si tratta di una ripresa variata del motivo presente in Giustino ad Ap., 1,2,1: anche in questo caso chi aveva amore per la verita (t6v <ptXocXr]6r|) doveva testimo niarlo con il comportarsi secondo verita (-cot Sixocioc TtpaTceiv) anche a costo della vi ta. Tuttavia in Giustino Pappello era rivolto agli imperatori che erano chiamati a dar prova del loro essere cpiXaXr)0?t$, mentre in Atenagora e la positiva testimonianza usque ad mortem dei cristiani a combinarsi necessariamente con Pamore per la verita degli imperatori.
Si noti, per6, che neppure in Giustino ne in Atenagora questo atteggiamento ri sulta arrendevole sul tema della verita; pur mancando nel caso di Atenagora
113 uno studio altrettanto valido del lavoro dello Story sul concetto di verita in Giustino 114,
ring, Exemplum Socratis. Studien zur Sokratesnachwirkung in der kynischstoischen Popularphilosophie der friihen Kaiserzeit und in friihen Christentum, Steiner, Wiesbaden 1979.
1,0 Iust. Ap., 1,5,1: icp' Tju-tov, uTCiaxvouuivtov [xrjBev dStxetv -cd dOeoc xauxa Bo^dCeiv, ou xpi aet; i&ia&xz, dXXd dXoycp 7ta9ei xai u.d<rciyi Saipiovtov cpauXtov e^eXauvofxevoi dxpiTco? xoXd?exs [AT] 9povc{^ovxe<;.
111 Da questo momento in poi non sono piu presenti, se non episodicamente, richiami alia funzione giudiziale degli imperatori e agli altri temi che hanno caratterizzato Vexordium.
112 Athen. Leg., 3,2: vtxr)ao[xev yap ataou; unip dXT)0eia<; doxvco? xai xd<; c|>uxd<; ?7ut8i86vT?<;. 1,3 Su Atenagora si puo vedere il volume di L.W. Barnard, Athenagoras. A Study in Second Cen tury Christian Apologetic, Beauchesne, Paris 1972 (Theologie Historique, 18), che al tema della verita ac cenna alle pp. 135 s., ma non in maniera specifica; R. Joly, Christianisme et philosophic Etudes sur Ju stin et les Apologistes grecs du IIe siecle, Ed. de PUniversite libre, Bruxelles 1973, pp. 81 s. Indicazioni piu generali, ma che confermano Panalisi qui proposta, nella monografia del Pouderon.
114 C. Story, The Nature of Truth in the 'Gospel of Truth' and in the Writings of Justin Martyr, E.J. Brill, Leiden 1970, che presenta alle pp. 68-176 cinque tesi, di cui risultano qui interessanti le prime due: 1) la verita, per Giustino, e inerente a un Dio incomprensibile (appYvco<;) e ha dimensione cosmica. Es sendo Dio all'origine di tutto, cio che deriva da lui riflette la sua verita; questa concezione della verita ha scopo apologetico: Pesame secondo verita (cioe la realizzazione della iustitia) e richiesto fiduciosamente ai
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

146 M. RIZZI
non e difficile mostrare come anche nel testo della Legatio, muovendo da questo uso del termine apparentemente neutro e non connotato in senso cristiano, lo spazio del la veritas dei pagani si restringe sino a ridursi a poco piu di approssimative intuizio ni, mentre i cristiani divengono gli unici ad avere accesso alia verita e alia conoscen za delle cose di Dio: ?Poeti e filosofi, come anche per altre materie, hanno procedu to per approssimazioni, ciascuno essendo stato spinto dalla propria anima secondo una qualche affinita con Pispirazione di Dio a cercare se fosse possibile trovare e
comprendere la verita; ma furono solo capaci di comprensioni marginali, non trova rono Pessere, avendo pensato di apprendere cio che riguarda Dio non da Dio, ma ciascuno da se. Percio ognuno di loro formulo dottrine differenti dagli altri sia ri
guardo a Dio, che alia materia, alle forme e al cosmo. Noi, invece, delle cose che
pensiamo e abbiamo creduto abbiamo per testimoni i profeti, che hanno parlato, per ispirazione dello spirito divino, di Dio e delle cose che lo riguardano. Voi che siete
superiori agli altri per sapienza e per pieta circa la vera divinita, potreste ben dire che e insensato seguire le opinioni umane, dopo aver trascurato di credere allo spiri to di Dio che ha mosso come strumenti musicali le bocche dei profeti? 115.
Si noti come anche in questo caso non manchi un preciso richiamo agli impera tori, che sopravanzano tutti per saggezza e pieta; certamente siamo di fronte alia ri presa di un xortoc, del modello retorico cui Atenagora si rifa, ma esso certamente
corrisponde anche ad una precisa strategia apologetica, diametralmente opposta a
quella di Tertulliano, e differente anche da quella di Giustino.
E possibile trovare conferma delle diverse impostazioni nella conclusione delle tre opere.
In Tertulliano abbiamo la riproposizione delPantitesi di partenza tra lex e veri tas, declinata questa volta nei termini Dio/giudici: ?Cum damnamur a vobis, a Deo absolvimur? (Tert. Apol., 50,16). Si conferma cosi, nello sviluppo argomentativo, Popposizione tra Cristianesimo (spazio della veritas e di Dio) e altro (spazio delPu mano e della lex). Nessun ruolo positivo e riconosciuto agli interlocutori e alia loro iustitia, che collocata com'e nel campo del mondo non pud che essere espressione della sua consustanziale vanitas ed err ore.
Per Giustino, invece, Pessere giudicati non si rivela in conclusione pertinente ai cristiani, quanto invece agli stessi giudici: ?Dunque, se vi sembra che abbiano qual che ragione e qualche verita, rispettate queste cose; se invece vi sembrano una scioc
chezza, disprezzatele come affari di sciocchi e non stabilite la pena di morte, come se fossero dei nemici, contro quanti non hanno fatto nulla di male. Vi prediciamo
giudici. 2) L'idea di verita si concentra su Cristo, visto come il Logos del Padre. Per Giustino la verita e il
processo divino in cui il Logos del Padre agisce (functions) nella creazione, nella storia del popolo di Dio, nei profeti dell'Antico Testamento. L'eccellente studio dello Story consente di non approfondire qui ulte riormente il tema.
115 Athen. Leg., 7,2-3: 7rot7]xai ptiv yap xat 91X6(10901, tb? xat xot? aXXot?, ercepaXov axoxaaxtxto?, xiv7]0?vx?? uiv xaxd cju(X7rd0?iav xfjc rcapd xoG 0eoG 7Cvorj? utco xrj? auxo? auxoG c[>uX^l^ exaaxo? CT]x7)aat, ei
8uvaxo? eupetv xat vorjaat xrjv dXrj0etav, xogouxov hi 8uvr)0evxe? oaov 7U?ptvofjaat, oux eupetv xo 6'v, ou rca
pd 0eoG 7iepi 0eoG d^ttoaavxe? u.a0etv, dXXd rcap' auxoG exaaxo?- 816 xat dXXo? dXXto? s8oy(jtdxi<j?v aoxtov xat Tuepi 0eoG xat Tcepi uXr\q xat Tcepi et8tov xai Ttepi xoajjtou. T)fJteT? 8e tov vooGu.ev xai 7U?7utaxeuxa(Jiev e'xo fjtev 7rpo97)xa? ptdpxupa?, o'i Trveofxaxt ev0ea> ?X7U?9tovr|xaai xai 7uepi xoG 0eoG xai rcepi xtov xoG 0eoG. ewuot xe 8'dv xai ufjtet? auveaet xai xfj 7cepi xo 6'vxto? 0?tov euaejkta xou? aXXou? 7cpo6'xovx?? tb? eaxtv dXoyov TuapaXircovxa? 7uax?uetv xco rcapd xoG 0eou 7rveufxaxt co? 6'pyava xextvT)x6xi xd xcov 7cpo9T)xcov axojxaxa, 7rpoaex?tv 86?at? dv0pto7u'vat?.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

?IUSTITIA? E ?VERITAS> 147
infatti che non sfuggirete il giudizio di Dio che verra, qualora rimaniate nelPingiusti zia? 116.
Giustino aveva concluso il suo initium con un ultimo richiamo alia responsabili ta degli imperatori in quanto giudici, operando una trasposizione sul piano trascen dente delPorizzonte in cui si gioca il confronto: ?Per il resto, sarete senza scuse di fronte a Dio se non farete cio che e giusto, essendo ben informati? 117. Qui nel fina le, in corrispondenza alPimpostazione iniziale, la lex umana e la sua iustitia sono trascese in quelle di Dio: la comune accettazione di un criterio di giustizia (toc Sixouoc
rcpdcTueiv: lust. Ap., 1,2,1), fa si che il giudizio sui cristiani si trasformi in giudizio sugli accusatori e sui giudici stessi. A differenza che in Tertulliano, Dio non ribalta il giudizio degli uomini, quanto invece ne sposta Poggetto; anche in Giustino e pos sibile un confronto non immediatamente esclusivo, ma, partendo da un comune fon damento valoriale, viene svolta Pargomentazione
? ed e questa la funzione del X6
yoc, apologetico ? sino a rivelare che quello stesso fondamento e gia saldamente cri
stiano, tanto che i giudicanti si trovano ad essere a loro volta giudicati. La confor mity del cristianesimo alia veritas, enunciata da Giustino, stabilisce quindi gli ambiti della iustitia e della iniustitia, che pero non necessariamente ne assiologicamente coincidono con Pantitesi cristianesimo/a//ro: la possibility di un diverso atteggiamen to degli interlocutori e lasciata almeno come possibile, se non come necessaria.
In Atenagora, infine, ancora il terreno della Stxrj e decisivo per Patteggiamento reciproco tra Cristianesimo e altro; Pesplicita richiesta di assenso imperiale
118 nasce dalla dimostrazione della pertinenza del fatto cristiano alia realta della giustizia; an
zi, chi e piu nel giusto dei cristiani? ?Voi dunque... a me che ho smentito le accuse, ed ho mostrato che siamo pii, mansueti e puri d'animo, piegate il vostro capo regale (scil. in segno di assenso). Chi infatti e anche piu giusto...? 119. Anche in questo ca so un valore identificato come pertinente aWaltro cui ci si rivolge, la giustizia, si ri vela realizzato al massimo grado proprio dai cristiani. E se in Giustino il valore del la lex umana era trasceso da quella divina (gli imperatori saranno giudicati da Dio [lust. Ap., 1,68,1], mentre i cristiani possono essere uccisi ma non danneggiati [ibid., 1,2,4]), in Atenagora esso e affermato positivamente, e la disponibilita alia morte e garanzia di un giudizio favorevole (Athen. Leg., 3,2).
Iustitia e veritas marcano cosi in confini entro cui viene impostato Yexordium (ma con cio stesso Pintero Xoyos) apologetico di Giustino, Atenagora e Tertulliano; autori differenti, ma di cui Panalisi ha mostrato affinita e divergenze riconducibili a scelte diverse, compiute pero a fronte di interlocutori tipologicamente omogenei. Al Pinternb di questi confini si dispiega un ventaglio ampio ed articolato di opzioni re
116 Iust. Ap., 1,68,1-2: xai et [xev 8ox?t oulv Xoyou xocl dXr)0?t'a? ?X?<J0at, xtu.r|aax? a6xd- et 8e Xf] po? upiiv 8oxet, to? XiqptoStov TCpayu-dxtov xaxa9povr|aax?, xoct pirj to? xax' ix^ptov xotT<* 'c&v (Jt^Sev d8t xouvxtov 0dvaxov 6pt??x?. npoXiyou-ev yap ujxtv oxt oux ?X9?u?eo0? ttjv iaouivrjv xou 0eou xptatv, ?<xv irct
[x?vnx? xfj d8txta. 117 Iust. Ap., 1,3,5: dvaTCoXoyrixov yap Xotrcov (jta0oOatv, rjv fjir] xd 8txata rcotr|ar)x?, U7cdp??t 7tpd?
0?ov. 118 Secondo l'indicazione di Menandro Retore (Spengel 423 s.): xai xd xotaoxa ?X??tvoXoYT)adu.evo?
?Tcd??t<; oxt 8td xauxa ix?x?uou.ev, 8e6fX?0a, rcpo xtov yovdxtov iutcxouxv, xd? tx?xr|pia? rcpoxetvouxv vou-iCe yap xrjv xoG" 7ip?apeuxou 9covyjv etvat TCaarj? xfj? rcoXeto?, 8t' rj? xai 7iat8a? xai yuvatxa? xai av8pa? xai
;ip?aPuxa? 8dxpua rcpoxee-tv, 7i:apaxaX?tv at 7tp6? ?Xeov. etxa d^ttoaet? erctv?uaat auxov 8ex0f]vat xo
c|>ri9ta[xa. 119 Aten. Leg., 37,1-2: 6u.?t? 8?... 8taX?Xuuivto uiv xd ?yxXr|u.axa ?TCi8?8?ix6xt 8e. oxt xai 0?o<j?(kt?
xai ?7ti?ix?i? xai xd? c|>uxd? x?xoXaafX?vot, xtjv (BaatXtxTiv x?9aXfjv ?Tctv?uaaxe. xtv?? yap xai 8txat6x?pot...
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

148 M. RIZZI
torico-argomentative, che spaziano dalla scelta di genera loquendi diversi quanto ina
spettati, alia simultanea e non casuale compresenza di analoghe strutturazioni esor
diali, di topiche quantomai varie. In questi autori la pratica retorica, che pud essere messa puntualmente in evi
denza dal confronto con la manualistica allora comune, risulta tutt'altro che improv visata e dilettantesca, posta pero rigorosamente a servizio di precise scelte di natura tematica.
Per la concreta articolazione delle apologie dei tre autori esaminati, centrale ri sulta essere la figura delFinterlocutore altro, formalmente designato. Si e visto, nel corso delPanalisi dei differenti exordia, come sia lo statuto del destinatario a deter minare concretamente Yinitium argomentativo, che risulta articolato in movimenti strutturali sovrapponibili per autori i cui esiti storico-teologici risultano profonda
mente differenti. Se si considera come Pinizio del discorso determini lo sviluppo suc cessive e ne marchi i confini, emerge tutta Pimportanza che assume la caratterizza zione che del proprio interlocutore gli apologisti forniscono.
A questo punto si innestano le possibili, diverse tipologizzazioni del rapporto tra Cristianesimo e altro che costituiscono il nodo di fondo delPintrapresa apologeti ca da cui questa indagine ha mosso.
Per Tertulliano, Cristianesimo e altro sono, sin dalle battute d'inizio ddYApolo geticum, due entita definite, dai confini netti che immediatamente vengono a coinci dere con Popposizione tra cio che e positivo e vero, e cio che invece e segnato dallo
stigma della negativita e de\Yerror umano. In questo spazio rigidamente bipolare non e concesso margine a nulPaltro che non sia Popposizione e il contrasto; tanto
che, in modo neppure troppo nascosto, il desiderio di Tertulliano e quello di una ?civitas Christiana in eremo? 120, isolata cioe da ogni contatto con Palterita, identifi cata con Pelemento di corruzione della veritas di cui i cristiani sono portatori. Non stupisce quindi che in Tertulliano il vos sia immediatamente connotato negativamen te, come pure il
' valor e' di cui e tut ore, quello della iustitia.
E se Tertulliano pare rivolgersi con altro spirito ad esempio agli imperatori, ri
spetto a quello con cui si pone in relazione agli antistites, non va omesso di notare che non alia funzione imperiale egli si rivolge, bensi dXYinteresse dei regnanti, che si
pud comporre tatticamente, ma non assiologicamente, con Pinteresse del Cristianesi mo. Si tratta solo di un male minore, di una tregua guerreggiata, ben lontano da un consenso che sostanzialmente riposi su dei valori, che anzi questa possibility e pre clusa radicalmente dall'estraneita assoluta (come tra cielo e terra...) tra cristianesimo e altro.
Diversa invece la tipologizzazione possibile nei casi di Atenagora e Giustino: con loro, infatti, siamo in presenza di uno spazio tripolare, dai confini tutt'altro che netti ed invalicabili: per superarli nessuno deve rinnegare se stesso, ma proprio supe randoli potra ritrovarsi pienamente. Tra Cristianesimo ed altro si colloca lo spazio della iustitia, come valore assoluto per Giustino, come concretizzazione del bene del
Pimpero per Atenagora. Entrambi gli apologisti greci ridisegnano questo terreno di comune confronto come il piu pertinente ai propri interlocutori: il primo lo sposta su di un piano trascendente, affermando che il giudizio delValtro sul Cristianesimo diviene occasione di giudizio per Valtro, proprio in relazione ai suoi attributi di giu stizia; Atenagora resta invece sul piano intrastorico, ma afferma che solo a partire da un diverso atteggiamento nei confronti del Cristianesimo Yaltro potra compiuta mente realizzare il proprio ruolo di taovoptoTTqc; del benessere delPecumene. Ma anche
120 Cf. Tert. ApoL, 37,6.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

:IUSTITIA? E ?VERITAS> 149
i cristiani non escono immutati da questo confronto e dalla corretta realizzazione del valore della iustitia: ?Vi prediciamo infatti che non sfuggirete il giudizio di Dio che verra, qualora rimaniate nelPingiustizia. E noi grideremo: cio che e caro a Dio, que sto avvenga? esclama Giustino 121; e cosippure Atenagora: ?Ci6 e anche a nostro
vantaggio, in maniera che noi possiamo trascorrere una vita quieta e pacifica, e ub bidire anche noi ben volentieri a tutto quanto e ordinato? 122.
I confini, cosi, non sono ultimativi: anzi, ad un pacato e sereno esame, risulta inevitabile che Yaltro scopra che quanto riteneva proprio (la potestas iudicandi, la tutela del bene delPimpero) risulta modificato dall'incontro con il Cristianesimo, si no ad essere, nel suo grado pieno, in qualche misura cristiano: per Atenagora Piso nomia pud essere compiutamente e positivamente realizzata solo a partire dalla giu sta considerazione delPunicita della divinita, propria del Cristianesimo. In Giustino
Pingiustizia nei confronti dei Cristiani si ritorce in condanna sui giudici stessi. Tutto
questo, naturalmente, senza annacquare il vino della propria fede: non e infatti in
gioco il contenuto della nuova religione, ma la declinazione del suo rapporto con Yaltro da se.
Sicuramente i differenti momenti storici in cui queste opere nascono ne determi nano alcuni caratteri; ma la struttura letteraria e di contenuto che li contraddistingue e un portato della differente opzione teologica operata dagli autori; in altri termini, essa dipende dalla scelta di considerare Yaltro come espressione di un sostanziale ri fiuto del Cristianesimo, o di un potenziale accoglimento della buona novella, della
veritas, che e tale in quanto capace di assumere e redimere tutto cio che e proprio delPuomo, anche la sua imperfetta iustitia.
Marco Rizzi
121 Iust. Ap., 1,68,2: 7ipoX?yo[AEv yap upitv oxt oux ixytv%ia?t xt)v eaouivrjv xou Geou xptatv, edv
emuivrjxe xfj d8txt'a. xat yjfxeT^ empoTjaofAEv o 91X0V xw 9ea> xouxo yeveaOco. 122 Athen. Leg., 37,3: xouxo 8' eaxt xat 7cp6<; Tjfjtcov, orcax; 7}p?fAOv xat T)auxiov Ptov Stdyouxev, au
xot hi rcdvxa xd xexeXeuafxeva TCpo8uuxo<; uuTipexotfiev.
This content downloaded from 185.2.32.96 on Sat, 14 Jun 2014 01:16:02 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions







![Slide Giustino Mezzalira [modalità compatibilità] Direct/Slide Giustino... · 07/06/2012 2 La pianura veneta: un sistema agropolitano … una città con l’agricoltura dentro …](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c6cf56d09d3f2d9358b8281/slide-giustino-mezzalira-modalita-compatibilita-directslide-giustino.jpg)







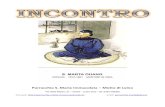



![Tertulliano - digilander.libero.it · [13] Che male è codesto, che i caratteri naturali del male non presenta, paura, vergogna, irresolutezza, pentimento, deplorazione? Che male](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c65ceff09d3f2a86e8d220c/tertulliano-13-che-male-e-codesto-che-i-caratteri-naturali-del-male-non.jpg)