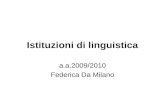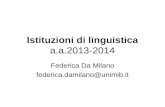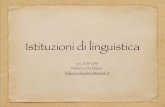Istituzioni di linguistica 2013-2014
-
Upload
tiberiu-tarabic -
Category
Documents
-
view
52 -
download
1
description
Transcript of Istituzioni di linguistica 2013-2014
-
Istituzioni di linguistica 2013-2014
(LCM)
Dispensa Parte I
(Pescarini - 28 ore)
Sommario
I. Introduzione
II. morfologia
III. Fonetica
IV. La sillaba
V. Fonologia
Avvertenze
Questa dispensa stata creata come supporto per lo studio individuale ad integrazione degli appunti
presi a lezione. Le idee qui raccolte verranno sviluppate nella prima parte del corso (circa 28 ore).
Alcune parti della dispensa potranno quindi risultare troppo compresse per gli studenti non-
frequentanti, che potranno per integrare con la lettura di un manuale di linguistica. Quelli
consigliati sono:
- Akmajan A., Demers R., Farmier A., Harnish R., Linguistica. Bologna: Il Mulino, 1996 (buon
manuale, ma non pi in commercio).
- Giorgio Graffi, Sergio Scalise. Le lingue e il linguaggio. Bologna, Il Mulino. (qualsiasi edizione,
di facile reperibilit).
Parallelamente alla dispensa sar fornita una batteria di esercizi relativi ai contenuti dei capitoli III e
IV.
Per ogni ulteriore informazione, per segnalare errori o per fornire consigli su come migliorare la
presente dispensa, non esitate a contattarmi via mail: [email protected]
Rev. 2 (16.10.13)
-
LINGUISTICA LCM 2013
2
I. Introduzione
Cos la linguistica?
La linguistica la disciplina che studia le lingue ed il linguaggio. Con il termine lingua intendiamo
un codice simbolico, dotato di caratteristiche specifiche che via via verranno illustrate, utilizzato da
una comunit di persone per comunicare fra loro. Le lingue sono soggette a forte variazione:
individui che appartengono a comunit linguistiche distinte utilizzano lingue diverse, ma anche
individui appartenenti alla medesima comunit linguistica possono presentare delle differenze
sistematiche dovute a numerosi fattori extra-linguistici fra cui la diversa provenienza geografica
(per es. gli inglesi americani e gli inglesi britannici presentano differenze piuttosto evidenti nella
pronuncia della stessa lingua). Inoltre, le lingue variano anche nel tempo, evolvendosi con ritmi che non sono direttamente percepibili allorecchio di chi parla, ma che determinano dei cambiamenti sensibili nel corso di pochi secoli. Molti di tali mutamenti avvengono in modo
naturale, senza essere causati da alcuna causa esterna, ma innegabile che in alcuni casi il cambiamento linguistico sia forzato dalle vicende storiche che influenzano la vita delle comunit
linguistiche (migrazioni, conquiste, ecc.).
Con il termine linguaggio, invece, ci si riferisce alla capacit propria dellhomo sapiens sapiens di poter acquisire e utilizzare una o pi lingue. Tutti gli esseri umani sono quindi dotati
della facolt del linguaggio, che consente loro di apprendere una o pi lingue: in questo senso, il
linguaggio una propriet universale. Tale capacit pu essere limitata da specifiche patologie
neurologiche che, in seguito a danni cerebrali, possono impedire lacquisizione di qualsiasi lingua o danneggiare la competenza di una lingua gi acquisita. Tali patologie, che vanno sotto il nome
generico di afasie, colpiscono solitamente specifiche capacit linguistiche (la capacit di ricordare
le parole, la capacit di coniugarle, la capacit di pronunciarle) e non sono necessariamente
connesse a deficit intellettivi. In seguito a lesioni di alcune aree corticali ben definite, si possono
infatti verificare dei deficit linguistici in pazienti che, per il resto, hanno capacit intellettive
inalterate.
Le due dimensioni quella sociale/variabile delle lingue e quella cognitiva/invariabile del linguaggio non sono del tutto scindibili: lo studio delle lingue non pu prescindere dalla conoscenza delle propriet universali/invariabili del linguaggio e, viceversa, queste ultime possono
essere individuate solamente attraverso lanalisi e la comparazione delle diverse lingue. Tuttavia, se non altro da un punto di vista concettuale, i due piani devono essere tenuti distinti.
Lo studio delle lingue pu avvenire da due punti di vista diversi: possiamo interessarci o
allevoluzione storica di un determinato fenomeno/aspetto linguistico, oppure possiamo concentrarci sulle propriet di tale fenomeno cos come sono visibili in uno stadio cronologico ben
preciso. Nel primo caso avremo un approccio di tipo diacronico, nel secondo caso un approccio
sincronico. Sincronia e diacronia sono due aspetti di fatto collegati: ad esempio, ci che
sincronicamente anomalo le cd. eccezioni pu essere il relitto di un costrutto grammaticale un tempo vitale, poi caduto in disuso nel corso dellevoluzione diacronica.
Le lingue si basano sullinterazione di tre sotto-sistemi, che, con un certo grado di approssimazione, possiamo chiamare il Lessico, la Grammatica e la Pronuncia. Con un po di approssimazione, il lessico linsieme delle parole di una lingua, che devono essere combinate secondo una grammatica e poi trasformate in suoni attraverso un sistema di pronuncia che
garantisca la trasmissione del messaggio linguistico.
Il lessico come insieme di segni arbitrari
Il lessico un insieme di segni, ovvero di unit simboliche dotate di un significato (il concetto
mentale che vogliamo esprimere) e un significante (un evento fisico, percepibile da chi ci sta
intorno). Ad esempio, il significato recipiente dotato di tappo utilizzato per conservare un liquido avr come significante linsieme di suoni bottiglia in Italiano o bottle in inglese.
-
LINGUISTICA LCM 2013
3
Si noti che la relazione esistente fra significato e significante soggetta a variazione (cambia
da lingua a lingua) e non esiste alcun rapporto di causa-effetto fra i due: il segno la relazione significato/significante infatti arbitrario, ovvero non dipende da alcuna relazione naturale ed intrinseca fra i due pieni, ma solamente da fattori storici e culturali che hanno fatto s che, per una
determinata comunit di parlanti, si instaurasse una relazione fra un dato concetto mentale e una
certa sequenza di suoni. Infine, il concetto di significato (limmagine mentale, astratta) non coincide con loggetto in s (che viene chiamato referente), tanto che in alcuni casi esistono segni dotati di significato, ma privi di referente: si pensi ad esempio alle parole astratte come bont o alle parole
che hanno un contenuto solamente grammaticale come che, oppure, gi, ecc.
La teoria del segno come relazione arbitraria fra un significato ed un significante si deve al
linguista ginevrino Ferdinand de Saussure, di cui torneremo a parlare pi tardi.
La grammatica come insieme di regole implicite
Con il termine grammatica intendiamo un sistema di regole che ci consentono di combinare assieme
i segni in modo da formare delle espressioni complesse: ad esempio, le parole possono combinarsi
assieme per formare delle frasi. Per, solo se combinate secondo certe regole, le parole formano
delle frasi grammaticali: mio figlio partito una sequenza grammaticale, mentre figlio partito
mio non lo . Il fatto che, senza starci troppo a pensare, riconosciamo che una frase possibile e
laltra no significa che da qualche parte nella nostra mente c un apparato di regole che ci consentono di discriminare fra frasi grammaticali e agrammaticali. interessante notare come
queste regole siano apprese da ogni parlante ben prima di andare a scuola, secondo un processo di
acquisizione che si svolge in modo naturale sin dai primi mesi di vita. In un certo senso, quando
andiamo a scuola per studiare la grammatica, di fatto la grammatica la possediamo gi: ci che la
scuola fa (o tenta di fare) di rendere esplicite le regole che noi implicitamente gi conosciamo e
utilizziamo tutti i giorni per parlare.
La grammatica non deve quindi essere vista come uno strumento di coercizione (ovvero,
come un insieme di regole che unautorit superiore impone per costringerci a parlare tutti nello stesso modo), ma piuttosto come la disciplina che ci consente di tradurre un sistema di regole
implicite in un insieme di regole esplicite, che possono essere studiate. Questo importantissimo se
il nostro obiettivo quello di apprendere una seconda lingua, ovvero una lingua di cui non abbiamo
potuto imparare le regole finch eravamo piccoli: oramai le speranze di acquisire quella lingua in
modo naturale e senza sforzo, come farebbe un bambino, sono quasi nulle. Dobbiamo quindi
rassegnarci a studiare il sistema delle regole esplicite in modo da impadronirci del sistema
grammaticale della seconda lingua anche se in modo meno naturale.
Le branche della linguistica che si occupano della grammatica sono la morfologia e la
sintassi: la prima studia la struttura delle parole, la seconda si occupa invece della struttura delle
frasi.
La Pronuncia come insieme di istruzioni senso-motorie
La pronuncia il sistema che ci consenta di tradurre i segni linguistici in eventi fisici (suoni, gesti)
tali da poter essere percepiti dai nostri interlocutori. Con il termine pronuncia ci riferiamo anche alla
capacit di alcuni parlanti di esprimersi attraverso dei gesti come quelli dellalfabeto dei segni impiegati per la comunicazione con persone sorde. Dal punto di vista linguistico, infatti, non c nessuna differenza fra un suono prodotto mediante la cavit orale e un gesto prodotto nella Lingua
Italiana dei Segni (LIS): entrambi servono per pronunciare (in senso lato) gli enunciati elaborati
dalla nostra grammatica.
Siamo soliti considerare la pronuncia come un fatto acustico: la pronuncia data dai suoni
delle nostre lingue. Dobbiamo per considerare che tali suoni sono il prodotto di una serie di
movimenti muscolari che interferiscono con la respirazione in modo da generare onde sonore a
partire dal flusso daria che transita attraverso la nostra cavit orale.
-
LINGUISTICA LCM 2013
4
Le branche della linguistica che si occupano degli aspetti legati alla pronuncia sono la
fonetica e la fonologia. Intuitivamente, la fonetica si occupa degli aspetti hardware come i movimenti dellapparato fono-articolatorio necessari per produrre un determinato suono. La fonologia, invece, si occupa degli aspetti software, ovvero di come le diverse lingue impieghino tali possibilit fono-articolatorie. Infatti, la diversit linguistica non nasce dal fatto che cambia la
configurazione degli organi fonatri (quello che abbiamo chiamato lhardware), ma dipende dai diversi modi in cui le lingue impiegano tali organi per produrre i suoni rilevanti.
Gli animali hanno un linguaggio?
Viste le principali componenti del linguaggio umano, lecito chiedersi quali siano le somiglianze e
le differenze rispetto ai sistemi di comunicazione impiegati da altre specie viventi.
un dato di fatto che gli animali comunichino fra di loro. Api, balene, primati hanno dei loro
sistemi di comunicazione, che usano per scambiarsi informazioni in merito al cibo, alla presenza di
un pericolo, ecc. Alcuni animali, inoltre, possono comunicare con luomo: i nostri animali domestici imparano il significato si alcune parole ed esistono primati che, dopo una fase di apprendimento, riescono a padroneggiare un lessico di alcune centinaia di parole (per comunicare
con i primati si usa solitamente lalfabeto dei segni poich questi mammiferi non hanno la conformazione dellapparato vocale necessaria per poter imitare i suoni del linguaggio umano).
Le domande che ci poniamo sono quindi le seguenti: i sistemi di comunicazione animale sono
un linguaggio? Gli animali almeno i primati che sono evoluzionisticamente pi vicini alluomo possono acquisire il linguaggio?
La risposta ad entrambe le domande no. Pur essendo fuori di dubbio che questi animali
sappiano comunicare, non ci sono prove conclusive per poter dire che tali animali comunichino
attraverso uno strumento simile o comparabile al linguaggio umano. Abbiamo infatti visto che le
lingue sono composte da almeno tre componenti fondamentali: un lessico, un sistema di pronuncia
ed una grammatica.
Possiamo ammettere che gli animali posseggano un lessico, ovvero un insieme di segni che,
per quanto ridotto, sia paragonabile a quello umano. Possiamo anche ammettere che parte dei segni
del lessico umano possono essere compresi da altre specie (ma gi qui opinabile se gli animali effettivamente comprendano il significato a partire da un significante o solamente reagiscano al
significante con un meccanismo di stimolo-risposta). Possiamo anche ammettere che gli animali
siano dotati di un sistema di pronuncia, pur essendo questultimo molto diverso dal nostro. Abbiamo anche visto che, utilizzando le lingue dei segni, uomini e primati possano comunicare
senza dover ricorrere alluso del canale fonico. Esiste per un punto dove gli esseri umani si discostano radicalmente dagli altri animali: la grammatica. I primati, per quanto riescano a
padroneggiare inventari lessicali di alcune centinaia di simboli e per quanto riescano a combinarli in
sequenze dotate di significato, non sono in grado di formare combinazioni ampie quanto le frasi che
ora stai leggendo.
La possibilit di combinare segni non solamente un fatto quantitativo (noi esseri umani
siamo dotati di linguaggio perch riusciamo a produrre frasi molto lunghe), ma anche qualitativo.
Infatti, il cuore della nostra grammatica non consiste tanto nel poter formulare delle frasi molto
lunghe, quanto nel fatto che i segni linguistici si combinino in modo non casuale. Le due frasi
Mario picchia Giorgio e Giorgio picchia Mario hanno significati diversi perch hanno ordini delle
parole diverse (e, come vedremo pi avanti, hanno ordini diversi perch hanno strutture gerarchiche
diverse). Questo vuol dire che la grammatica non consiste solamente nella capacit di combinare
segni a piacere (cosa che anche gli scimpanz riescono a fare fino ad un certo punto), ma nella
capacit di creare delle combinazioni ordinate, costruite secondo una struttura da cui dipendono
interpretazioni diverse. Tale propriet, tipica delle lingue umane, detta dipendenza dalla struttura.
Inoltre, nella nostra grammatica sono state inglobate una serie di informazioni, ad esempio
riguardo al tempo e allo spazio, che ci consentono di slegare il significato dei nostri enunciati dal
-
LINGUISTICA LCM 2013
5
momento e dal luogo dellenunciazione: io posso riferirmi a stati passati (dormivo, ho dormito, dormii), futuri (dormir), irreali (avrei dormito), possibili (dormirei), posso dare ordini (dormi!),
posso riferirmi a terzi (dorme, dormirebbe), ecc. A differenza di altre specie umane, in definitiva,
possediamo una serie di nozioni grammaticalizzate che rendono le nostre frasi un sistema molto
articolato e non solamente una somma di significati lessicali.
Su questi aspetti generali e sulle propriet fondamentali del linguaggio umano, consiglio le
seguenti letture: S. Pinker, Listinto del linguaggio, Milano: Mondadori oppure Andrea Moro, I confini di Babele, Milano: Longanesi.
Quante sono le lingue del mondo?
Esperti e divulgatori si sono spesso posti questa domanda. Ecco una risposta-tipo, tratta dal sito di
una rivista di divulgazione scientifica (Focus 2002):
Attualmente circa 6.700. Le pi parlate sono: cinese mandarino, inglese, hindi/urdu, spagnolo, russo,
arabo, bengali, portoghese, indonesiano e giapponese. L'italiano parlato da circa 70 milioni di persone e
si attesta al 19 posto, a pari merito con cantonese, telogo (parlato in India e in Malaysia) e turco.
La pi grande concentrazione di lingue parlate si trova nelle zone del Pianeta dove c' anche la maggiore
biodiversit (variet di animali, piante e ambienti). Nelle foreste pluviali tropicali, che occupano solo il
7% della superficie emersa della Terra, ci sono il 36% dei gruppi etnolinguistici del mondo.
Valutando la situazione degli ultimi decenni, si calcola che, entro la fine del ventunesimo secolo,
potrebbero estinguersi il 90 per cento delle lingue attualmente parlate.
Il dato coerente con quanto contenuto nella direttiva ISO 639-2 emessa dallInternational Standard Organization con lobiettivo di identificare attraverso un codice tutte le lingue conosciute, comprese quelle morte.
Di fronte a questi dati, tuttavia, lecito chiedersi come siano state effettuate tali stime.
Pensiamo ad esempio allItalia, la cui lingua ufficiale litaliano. Basta per pensare alle nostre interazioni quotidiane per vedere come la situazione linguistica sia un po pi complessa perch molti di noi, oltre allitaliano, parlano anche un dialetto e, per alcuni (specie gli anziani) il dialetto rimane la prima e talvolta lunica lingua parlata. Questi dialetti sono molto diversi fra loro, tanto che gi Dante, a proposito dellItalia duecentesca, osservava che Se volessimo calcolare tutte le varianti dei volgari italiani, le principali, le secondarie, le minori, anche solo in questo piccolissimo
angolo di mondo finiremmo per contare un migliaio di variet linguistiche, anzi, persino di pi. (De vulgari eloq. I, x, 9). La domanda se tali dialetti debbano contare o meno come lingue e, in
subordine, se tali dialetti meritino lattenzione dei linguisti. Si noti infatti che la situazione dellItaliano non un unicum, anzi si tratta di una situazione
molto comune in cui alla lingua ufficiale parlata da una minoranza di persone si debba aggiungere
una moltitudine di dialetti locali, che spesso sfuggono alle classificazioni e alle statistiche. In molti
casi, poi, quasi impossibile stabilire i confini di un dialetto o identificarne le caratteristiche
salienti.
Qualcuno potrebbe obiettare che tali dialetti non debbano essere considerati delle lingue
perch non hanno la dignit di lingua. In verit, dal punto di vista linguistico non c nessuna differenza fra una lingua come litaliano e un dialetto come il padovano: entrambe hanno un loro lessico, entrambe hanno una loro grammatica, entrambe un proprio sistema di pronuncia.
La differenza fra lingua e dialetto non pertiene infatti al piano strettamente linguistico, ma a
quello storico e politico: una lingua, a differenza di un dialetto, una variet che stata scelta da
una determinata comunit linguistica come variet per la comunicazione ufficiale. Le lingue si
usano per scrivere le leggi, celebrare i processi, insegnare nelle scuole, trasmettere nei mezzi di
comunicazione. I dialetti, viceversa, sopravvivono come lingua di comunicazione nei contesti pi
informali, anche se ci non esclude che di fatto si usi il dialetto anche in situazioni pi strutturate
(ad esempio le riunioni di lavoro) o che si sviluppi una tradizione letteraria talvolta anche molto
importante.
-
LINGUISTICA LCM 2013
6
Solo per motivi storici e sociali, quindi, litaliano si imposto sugli altri volgari italiani come lingua dello stato Italiano, non per motivi intrinsecamente linguistici. Ladozione dellitaliano come lingua ufficiale fu infatti un atto politico, sancito da provvedimenti legislativi presi nellItalia postunitaria (sebbene nella costituzione repubblicana, ad esempio, non si faccia menzione della
lingua ufficiale). Ci tuttavia, non cancell gli altri dialetti italiani che continuarono ad essere
parlati sul territorio e che, a rigore, andrebbero quindi annoverati nel conteggio delle lingue del
mondo.
A questi si aggiungano inoltre le cd. parlate alloglotte, ovvero le variet dialettali che sono
parlate in Italia ma non sono direttamente imparentate con lItaliano (sul concetto di parentela linguistica, vedi sotto): le variet cimbre del nord est (in verit si tratta di dialetti basso-tedeschi che
nulla hanno a che fare con i Cimbri che invasero il nord Italia nel II secolo a.C.), le variet occitane
parlate nelle valli piemontesi, lo slavo-molisano, le variet arbresh (italo-albanesi) parlate nel
meridione; ecc.
Ci sono infine dialetti che aspirano al rango di lingue. Si soliti dire che il friulano ed il sardo non siano dialetti come il padovano o il fiorentino, ma piuttosto lingue. Questa affermazione
lecita? In primis, si tratta di una questione molto delicata poich alla base di tali affermazioni ci
sono visioni ideologiche e politiche sulle quali qui non il caso di soffermarci. Dal punto di vista
linguistico, vero che friulano e sardo hanno caratteristiche pi conservative di altri dialetti italiani
poich conservano alcune caratteristiche del latino meglio di quanto abbiano fatto le altre variet
italiane. Lo stesso per vero anche per i dialetti parlati nella zona di confine fra Basilicata e
Calabria, che pure non aspirano al rango di lingua. Essere pi simili al latino di altri, insomma, non
di per s un buon motivo per definirsi lingua.
Cenni di genealogia linguistica
Sappiamo che litaliano, cos come ogni altra lingua, non sempre esistito nella forma che oggi conosciamo e parliamo. Litaliano, come altre lingue (francese, rumeno, portoghese, ecc.), deriva infatti da una lingua nota (il latino) attraverso un processo evolutivo durato secoli e, in parte, ancora
ignoto.
Da un punto di vista storico possiamo quindi sostenere che il latino sia un progenitore
dellitaliano, mentre italiano, francese, rumeno e portoghese sono tutti discendenti del latino e quindi, in un certo senso, sono lingue sorelle. Sulla base di queste osservazioni quindi possibile
tracciare una sorta di albero genealogico come il seguente, che esemplifica levoluzione delle lingue derivate dal latino, dette per questo lingue neolatine o romanze:
latino
italiano francese spagnolo portoghese catalano rumeno
Questo grafico piatto: tutte le lingue romanze sono messe sullo stesso piano come discendenti
diretti del latino. In verit lo schema dovrebbe essere pi articolato, perch alcune lingue si sono
probabilmente staccate prima di altre dal ceppo originario, rimanendo isolate e mantenendo quindi
dei tratti pi arcaici, come nel caso di sardo e rumeno. Altre invece hanno condiviso un tratto di
evoluzione linguistica, risultando quindi pi imparentate fra loro rispetto alle altre, come le lingue
Ibero-Romanze: castigliano, portoghese, galego e relativi dialetti.
Nel corso degli ultimi due secoli in particolare nel XIX secolo i linguisti hanno cercato di raffinare la struttura di questi alberi genealogici, cercando di capire il grado di relazione fra le
lingue comparando le loro caratteristiche e mettendole in relazione rispetto allevoluzione ideale rispetto ad un possibile progenitore.
-
LINGUISTICA LCM 2013
7
In alcuni casi, come nel caso delle lingue romanze siamo fortunati perch possiamo
riconoscere in una lingua attestata il latino lantecedente storico delle lingue parlate oggi. In altri casi, per, tale antecedente storico non pi attestato perch ad esempio la comunit linguistica che parlava tale lingua storica non conosceva la scrittura, oppure non ci sono pervenuti documenti
scritti, oppure non siamo in grado di decifrarli. In questi casi per possibile ipotizzare lesistenza di una lingua-madre (detta protolingua), di cui siamo in grado di ricostruire alcuni tratti linguistici.
Ad esempio, mediante la comparazione scientifica possibile sostenere che latino e greco
antico sono imparentati fra loro e sono a loro volta genealogicamente legati alle lingue storiche
parlate nellIndia del nord (il sanscrito ed il vedico). Sulla base della comparazione fra queste lingue storiche, i linguisti dellOttocento furono in grado di postulare lesistenza di un progenitore comune detto proto-indoeuropeo da cui derivano gran parte delle lingue parlate oggi in Eurasia. Possiamo quindi andare allindietro di una generazione nel nostro schema:
proto-indoeuropeo
sanscrito greco antico latino
lingue romanze
(vedi sopra)
Questo per non esaurisce il novero delle lingue che derivano dal proto-indoeuropeo. Vanno
infatti incluse lingue che a loro volta formano ulteriori gruppi e sotto-gruppi:
- Le lingue germaniche si suddividono in tre sotto-gruppi: g. orientale (oggi estinto, ci sono pervenute attestazioni di gotico), g. settentrionale (o nordico: svedese, danese, norvegese,
islandese, dialetti delle isole Fr er), g. occidentale a sua volta suddiviso nel sotto-gruppo
anglo-frisone e nel gruppo neerlando-tedesco.
- Le lingue italiche si suddividono in due sotto-gruppi: i. orientale (oggi estinto, ci sono pervenute attestazioni di osco, umbro e sannita) e i. occidentale, comprendente il latino e
tutte le lingue romanze (vedi sopra).
- Le lingue celtiche si suddividono in lingue gaeliche (irlandese e scozzese) e brittoniche (gallese e bretone).
- Le lingue slave si suddividono in tre sotto-gruppi: lo s. orientale (russo, bielorusso, ucraino), s. occidentale (polacco, ceco, slovacco) e s. meridionale (bulgaro, macedone, serbo-croato,
sloveno).
- Le lingue baltiche come lituano e lettone (lestone, invece, non una lingua indoeuropea, vedi sotto).
- Le lingue anatoliche, oggi estinte sebbene ci sia pervenuta una documentazione piuttosto ampia dellIttita. Oggi in Anatolia si parla prevalentemente turco, che non una lingua indo-europea.
- Le lingue indo-iraniche: il sottogruppo indiano include le gi citate lingue storiche dellIndia (sanscrito e vedico) e le lingue moderne hindi e urdu. Fanno invece parte delle lingue
iraniche il persiano, il curdo ed il pashtun.
- Le lingue tocarie (A e B, entrambe estinte) parlate originariamente da una popolazione attestatasi nei territori pi occidentali dellattuale Cina.
- Larmeno. - Lalbanese. - Il greco.
Ricapitolando, tutte le lingue precedentemente menzionate derivano dallo stesso antecedente
storico, che non attestato ma ricostruito: il proto-indoeuropeo. Per questo motivo, esse fanno parte
della famiglia indoeuropea. Per chi volesse approfondire i dettagli della storia linguistica delle
-
LINGUISTICA LCM 2013
8
lingue indoeuropee, unottima introduzione F. Villar 2008. Gli indoeuropei e le origini dellEuropa. Bologna: Il Mulino.
Oltre alla famiglia indoeuropea, si ipotizzata lesistenza di altre famiglie linguistiche: - La famiglia afro-asiatica, comprendente molte lingue dellAfrica del nord, fra cui larabo e
lebraico. - La famiglia niger-kordofaniana, composta dalle lingue dellAfrica nera come lo swahili. - La famiglia uralica, che comprende il finnico (o finlandese), lungherese e lestone. - La famiglia sino-tibetana, che comprende il cinese. - La famiglia altaica, comprendente il mongolo, il turco e, secondo alcuni, il coreano ed il
giapponese (ipotesi molto controversa)
- La famiglia dravidica, che raggruppa le lingue dellIndia meridionale fra cui il tamil. - La famiglia austro-asiatica, che comprende il vietnamita. - La famiglia austronesiana.
possibile ipotizzare anche dei raggruppamenti genealogici anche per le lingue amerindiane e
australiane, ma la ricostruzione genealogica di queste aree ancora aperta e controversa.
Oltre alle famiglie linguistiche si sono poi notate delle lingue isolate che non possono essere
(ancora) iscritte ad una famiglia o ad unaltra. Un caso tipico il basco.
Appendice: Perch la linguistica una scienza? (e che cos una scienza?)
Tutti noi abbiamo delle idee in merito alle lingue ed al linguaggio. Voltaire, ad esempio, sosteneva
che litaliano non possiede le melodiose e nobili terminazioni delle parole spagnole, che un felice concorso di vocali e consonanti rende cos sonore []. Vi mancano anche quei dittonghi che, nella nostra lingua [il francese], fanno un effetto cos armonioso. (cit. in Stammerjohann, H. Immagine dell'italiano, in Enciclopedia dellItaliano. Roma: Treccani, 2010).
Ci piaccia o no, questo era il giudizio estetico di Voltaire , come tale, insindacabile. Il
punto per un altro: questa conclusione scientifica?
Nella concezione moderna scientifico tutto ci che provabile attraverso il metodo
sperimentale (quindi, scientifico tutto ci che provabile, mentre non detto che sia scientifico
ci che probabile). Questo metodo, accettato nelle scienze dure come la fisica sin dal secolo XVI, deve essere alla base dei nostri ragionamenti sulle lingue. La linguistica, pur avendo come
oggetto di studio il prodotto dellintelletto umano (il linguaggio/le lingue) intende infatti operare secondo il metodo delle scienze fisiche.
Per prima cosa, il ragionamento scientifico si basa su concetti chiari e non ambigui: cosa
significano aggettivi come nobile o melodioso in relazione ai suoni delle parole? Ad esempio, quali
sono le caratteristiche acustiche che renderebbero tali suoni melodiosi e nobili? Il primo passo di
qualsiasi ragionamento scientifico quindi quello di descrivere nel miglior modo possibile ci che
si osserva, tralasciando il pi possibile i nostri giudizi soggettivi, i nostri pregiudizi e, in alcuni casi,
ci che altri prima di noi hanno detto o scritto su un determinato fenomeno.
Il secondo passaggio fondamentali del metodo scientifico quello della generalizzazione,
ovvero il passaggio dalla descrizione di un caso specifico alla descrizione di un fenomeno in
astratto. Cosa vuol dire in astratto? Ci sono persone che pensano che ragionare in astratto significhi allontanarsi dalla realt: ogni forma di generalizzazione diventa quindi un allontanamento
e, a volte, un tradimento della realt delle cose. In verit, fare astrazione significa descrivere un
fenomeno ignorando tutte le variabili che con quel fenomeno non hanno alcun legame diretto. Si
prendano ad esempio le tre frasi seguenti:
(1) a. Giulia stata vista partire. b. A Linda stata regalata una bicicletta.
c. Il pane stato tagliato da Carlo
-
LINGUISTICA LCM 2013
9
Queste tre frasi sono apparentemente diverse le une dalle altre, eppure hanno una caratteristica
comune: in tutte e tre un verbo transitivo viene volto al passivo. In tutte e tre, infatti, il
complemento oggetto del verbo principale diventa soggetto della frase. Per osservare questo che il primo passo per capire come funziona il passivo in italiano abbiamo dovuto fare astrazione da una serie di particolari: gli elementi lessicali utilizzati, il fatto che loggetto sia animato o inanimato, il fatto che lagente (chi compie lazione) sia espresso solamente nella terza frase, il fatto che il soggetto della frase preceda il verbo o lo segua (come nel secondo caso).
La medesima capacit di astrazione alla base anche della nostra percezione dei fenomeni
linguistici. Pensiamo infatti alla pronuncia di ogni singolo suono del linguaggio: tutti noi siamo
concordi nel dire che litaliano presenta un suono [a] corrispondente alla lettera a. Eppure, se si conducono delle misurazioni acustiche sulla [a] pronunciata da un campione di parlanti italiani,
possiamo osservare che le caratteristiche acustiche di tali [a] sono soggette a fortissime fluttuazioni
che dipendono in larga parte dallet e dal sesso dei parlanti. Quindi, se badassimo al dato acustico, la [a] di Giulia (femmina, 5 anni) completamente diversa dalla [a] di Paolo (maschio, 50 anni).
Queste differenze sono linguisticamente interessanti? Direi di no: per questo motivo, quando
studiamo una lingua, per apprenderla o per studiarne le strutture, dobbiamo tralasciare queste
distinzioni cos sottili e dobbiamo concentrarci sullo studio di una [a] prototipica. Secondo il
linguista svizzero Ferdinand de Saussure, la linguistica deve quindi concentrarsi su un sistema
astratto detto langue e non su specifiche realizzazioni di singoli parlanti dette parole che sono quindi soggette a forte variazione contestuale e inter-soggettiva. Ci non significa che tale
variazione non sia a sua volta rilevante, come notato nei lavori del sociolinguista William Labov,
ma significa che la linguistica, se vuole essere una scienza, deve saper raggiungere un grado
adeguato di astrazione.
Dobbiamo poi considerare che la parole (ovvero, linsieme della produzione linguistica dei parlanti) condizionata da fattori extra-linguistici. La stanchezza, la distrazione e tutta una serie di
fattori collaterali ci possono infatti portare a compiere degli errori o delle disattenzioni che, se
asistematche, non hanno valore linguistico.
Il concetto di langue merita qualche ulteriore precisazione. In primo luogo, bene notare che
la langue non ha nulla a che vedere con la norma linguistica. Questultimo frutto della riflessione di grammatici prescrittivi che cercano di stabilire attraverso una serie di regole quali costrutti linguistici siano ammissibili e quali siano invece da censurare. Quindi, a me mi, piuttosto che,
attimino, ecc. sarebbero costrutti e parole che, secondo la norma, non andrebbero usati in un italiano
corretto. Tali norme vengono solitamente elaborate da istituzioni preposte in Italia, questo uno dei compiti che si data lAccademia della Crusca e tradotte in grammatiche prescrittive ad uso, ad esempio, degli studenti delle scuole. Il concetto di langue non coincide con quello di norma: la
langue non un insieme di regole e prescrizioni, quanto un sistema astratto che viene idealmente
condiviso da una comunit di parlanti senza che tale sistema venga necessariamente codificato
attraverso grammatiche normative. Scopo della linguistica quello di studiare il funzionamento di
tale sistema astratto, descrivendolo in modo oggettivo e privo di ambiguit, senza mirare a
censurare i comportamenti linguistici non conformi ad una supposta norma. Per questo motivo, le
grammatiche dei linguisti sono dette grammatiche descrittive (o scientifiche) e si discostano per
obiettivi e metodologie dalle grammatiche normative di chi ha intenti prescrittivisti.
Abbiamo per anche sostenuto che le lingue non sono solamente degli oggetti sociali, ma
sono anche il prodotto di strutture cognitive dotate di una base neuro-fisiologica. Quindi, una lingua
deve essere interiorizzata nella mente dei parlanti che lhanno acquisita. Partendo da tale prospettiva, Noam Chomsky ha proposto una dicotomia che, sul piano cognitivo, rispecchia quella
posta da Saussure in termini di langue e parole. Chomsky infatti sostiene che ci che noi
effettivamente diciamo costituisce una performance, ovvero una produzione spontanea e, come tale,
viziata da condizionamenti dovuti al contesto. Ci non toglie per che nella nostra mente esistano
delle strutture linguistiche stabili, insensibili al contesto, che formano ci che lui chiama
competenza linguistica (competence), ovvero un insieme di regole implicite (cio, di cui non siamo
-
LINGUISTICA LCM 2013
10
consci) che ci consentono di produrre enunciati linguistici potenzialmente nuovi e di discriminare se
un enunciato pi o meno conforme alle regole grammaticali che abbiamo interiorizzato. Facciamo
un esempio: tutti noi sappiamo che il passato prossimo di mangiare ho mangiato, non *sono
mangiato. Allo stesso modo, sappiamo che il passato prossimo di dormire ho dormito ed il
passato prossimo di partire sono partito (dora in poi, useremo un asterisco per contrassegnare frasi e parole agrammaticali
1).
(2) a. ho/*sono mangiato b. ho/*sono dormito
c. *ho/sono partito
Chi ci ha insegnato che alcuni verbi richiedono lausiliare avere e altri lausiliare essere? Nessuno: si tratta di una regola implicita che abbiamo acquisito quando eravamo piccoli e di cui non siamo
consci.
Qualcuno potrebbe per obiettare che quella che regola la selezione dellausiliare in italiano non una regola, ma una distinzione lessicale: alcuni verbi prendono essere mentre altri prendono
avere, senza un motivo apparente. In verit, le cose non sono cos semplici. Infatti, la selezione
dellausiliare correla con una serie di fatti linguistici. Per prima cosa, bisogna notare che tutti i verbi transitivi prendono sempre avere, mentre gli intransitivi prendono o avere (come dormire) o essere
(come partire). Questi due tipi di verbi intransitivi, per, non differiscono solamente nella selezione
dellausiliare, ma anche per altri fattori: a) i verbi che selezionano essere possono formare participi assoluti:
(3) a. * Dormita Anna, possiamo andare via. Partita Anna, possiamo andare via
b) Con i verbi che selezionano essere possibile pronominalizzare il soggetto con pronome clitico ne:
(4) a. * Ne hanno dormiti tre b. Ne sono partiti tre
Queste cose noi le sappiamo senza che nessuno ce le abbia mai insegnate. Pochi di noi prima di
oggi si erano imbattuti in frasi come quelle contrassegnate con *, eppure non abbiamo esitato un
secondo prima di concludere che tali frasi in italiano non sono possibili. Abbiamo dato questo
giudizio senza basarci sul parere di altri, senza consultare le grammatiche normative, senza chiedere
un parere alla Crusca. Lo abbiamo fatto, direbbe Chomsky, sulla base della nostra competenza
linguistica che, come si vede, ci porta a distinguere almeno due classi di verbi intransitivi: quella
degli inergativi (con lausiliare avere) da quella degli inaccusativi (con ausiliare essere). Una volta individuata una generalizzazione nel caso sopra, la correlazione fra selezione
dellausiliare, costruzioni participiali, pronominalizzazione con ne possiamo provare a formulare una (o pi) ipotesi, ovvero una congettura che spieghi la generalizzazione. Lipotesi rappresenta una previsione su fatti che io non ho ancora osservato e che deve essere quindi verificata o falsificata
sulla base di nuovi dati. Ad esempio, io potrei formulare lipotesi che tutte le lingue che presentano i dittonghi del francese siano pi armoniose dellitaliano (ovviamente, dopo aver definito cosa si deve intendere per armonioso). Se le ricerche su altre lingue confermeranno l'ipotesi, si potr allora iniziare a fondare su di essa una teoria, ovvero un insieme di asserzioni in merito a fatti
1 In linguistica storica, lasterisco ha unaltra funzione: serve a segnalare quali forme sono state ricostruite: si tratta cio di parole di cui non si ha attestazione diretta, ma di cui si ipotizzata lesistenza a partire dagli esiti nelle lingue note.
-
LINGUISTICA LCM 2013
11
concreti che riguardano, nel caso specifico, la correlazione fra armoniosit e presenza di dittonghi
(non occorre dire che lesempio dei dittonghi volutamente provocatorio). In definitiva, il metodo scientifico si basa sulla sequenza di osservazione > descrizione >
generalizzazione > formulazione dellipotesi > verifica (o falsificazione) dellipotesi. Inoltre, se descrizione, ipotesi e verifica sono corrette, queste dovrebbero rimanere tali ogniqualvolta altri
studiosi interessati allo stesso problema si applichino nello studio dei fenomeni da me indagati.
Unipotesi deve infatti rimanere valida a prescindere dal contesto e dai parlanti e, se riteniamo che lipotesi abbia a che fare con il linguaggio inteso come capacit mentale, anche a prescindere dalla specifica lingua.
Lo stesso metodo deve essere applicato alla linguistica: dora in poi descrizioni incomplete o ambigue, opinioni non verificate, ipotesi non falsificabili, dimostrazioni fallaci non saranno pi
ammesse. Conta solo ci che voi vedete e ci che pu essere dimostrato senza ragionevole dubbio.
-
LINGUISTICA LCM 2013
12
II. Morfologia
Cos una parola?
Abbiamo visto in precedenza che le lingue presuppongono un lessico, ovvero un inventario di segni
linguistici, ovvero di relazioni arbitrarie fra un significato ed un significante.
Ad una prima approssimazione, possiamo sostenere che i segni equivalgano alle parole. Cane,
bellezza, , ecc. sono tutte parole dellitaliano e come tali debbono essere considerati dei segni linguistici. Questa conclusione corretta? Se s, potremmo pure fare a meno del concetto di parola
(o di quello di segno, in alternativa) visto che entrambi si riferiscono al medesimo oggetto e lobiettivo della linguistica prima di tutto quello di creare un metalinguaggio, ovvero un linguaggio scientifico non ambiguo e non ridondante per poter descrivere e analizzare le lingue.
Cerchiamo per prima cosa di definire cosa intendiamo per parola, che, come tutti i termini di
uso comune, sono i pi ovvi e, quindi, pi difficili da definire.
Alcuni hanno una concezione eminentemente grafica del concetto di parola: una parola un
elemento grammaticale che, quando scritto, occorre fra due spazi. Eppure, abbiamo visto in
precedenza, questo criterio non affatto cos chiaro come si potrebbe pensare: la grafia, infatti, un
sistema che poche culture hanno elaborato e, fra queste, pochissime hanno criteri grafici per
distinguere i confini di parola.
Ci vogliono quindi criteri di altre natura: chiari e, soprattutto, validi per tutte le lingue. Eccone
alcuni:
- non interrompibilit: non possibile inserire una parola nel mezzo di unaltra parola: - pronunciabilit in isolamento: una parola pu costituire un enunciato di senso compiuto, ad
esempio come risposta ad una domanda
- non commutabilit: se si modifica lordine degli elementi che compongono una parola, la parola diventa una non-parola, ovvero un insieme indistinto di segni privi di significato.
Le parole sono segni?
Molto spesso le parole non sono dei segni (intesi come relazioni arbitrarie fra
significato/significante), ma combinazioni di pi segni. Prendiamo ad esempio una parola come
libro: si tratta inequivocabilmente di una parola, eppure possibile scomporla in almeno due segni
distinti, ognuno dotato di significato diverso: libr- oggetto di carta dotato di pagine ecc. e -o maschile, singolare. In effetti, il significato della parola libro e diverso da quello della parola libri, sebbene entrambe le parole condividano lelemento libr-.
Dora in poi chiameremo morfemi gli elementi minimi dotati di significato e morfologia la branca della linguistica che studia le combinazioni dei morfemi che formano delle parole. Ad
esempio, la morfologia della parola libro data da un morfema lessicale libr-, detto radice della
parola, e da un morfema grammaticale (o funzionale) -o che ne specifica alcune caratteristiche
grammaticali come il genere (maschile) ed il numero (singolare).
La distinzione fra morfemi lessicali e grammaticali fondamentale. I primi formano una
classe aperta, il cui numero, in ogni lingua, ammonta a diverse migliaia e i cui significati possono
riferirsi a qualsiasi stato e evento pensabile (azioni, oggetti, pensieri, colori, ecc.). I morfemi
grammaticali, al contrario, sono relativamente pochi e si riferiscono ad un numero limitato di
caratteristiche grammaticali (il genere, il numero, il tempo, laspetto, la definitezza, ecc.). I morfemi possono essere liberi o legati: i primi bastano per formare una parola, mentre i
secondi devono accompagnarsi ad un altro morfema per poter formare una parola grammaticale. Ad
esempio, la semplice radice libr- in italiano un morfema legato perch per poter occorrere nella
frase deve necessariamente combinarsi con una morfema funzionale: libr-o/i.
Un altro parametro per la classificazione dei morfemi quello posizionale: si chiamano affissi
in generale tutti i morfemi funzionali che devono essere legati ad una radice. Gli affissi si
distinguono per in prefissi o suffissi a seconda che essi seguano o precedano la radice lessicale.
-
LINGUISTICA LCM 2013
13
Esistono anche circonfissi, che sono dei morfemi complessi formati da due affissi, uno che precede
e uno che segue la radice, e gli infissi, che si pongono allinterno della parola. Si parla poi di transfissi nel caso in cui un morfema grammaticale e un morfema lessicale siano separati in pi
pezzi alternati fra loro. Ad esempio, in arabo le parole si formano a partire da una radice composta
da una serie di consonanti di solito tre che vengono combinate con una sequenza vocalica che funge da transfisso grammaticale. La parola quindi data da una sequenza di consonanti e vocali
alternate come esemplificato negli esempi seguenti:
(5) radice: k-t-b scrivere, scrittura
parole derivate: kitab libro kutub libri
ka:tib scrittore kataba egli scrisse
Gli affissi possono cumularsi, come nel caso della parola de-industri-al-izz-azion-e. Quando
un suffisso non si combina direttamente con la radice, ma con una forma che a sua volta contiene un
altro affisso, si dice che questultima la base dellaffisso pi esterno. Ad esempio, nel caso seguente, una parola suffissata costituisce la base per un'altra parola suffissata:
(6) [[libr-]radice -ett-]base -o
Non sempre i significati grammaticali sono espressi mediante affissi. Talvolta, essi sono
espressi mediante alternanze morfologiche visibili sulla radice stessa. Si consideri ad esempio
lalternanza fra le forme seguenti, dovuta ad un processo morfo-fonologico detto apofonia:
(7) sink sank sunk sing sang sung
ring rang rung
begin began begun
Un altro modo per esprimere i tratti flessivi (solitamente valori intensivi o il tratto di pluralit)
mediante la reduplicazione di tutta o parte della radice:
(8) piga 'picchiare'; (Swahili) pigapiga 'picchiare ripetutamente'
In questi casi, possibile postulare lesistenza di un morfema funzionale che modifica la struttura della radice, per, a differenza dei casi precedenti, qui non pi possibile identificare in modo
chiaro il significante associato al morfema funzionale. Tale significante avr quindi una forma pi
astratta e interagir in modo un po pi complesso con il materiale della radice. Per il momento, non abbiamo ancora introdotto gli strumenti necessari per analizzare questi fenomeni.
I tratti grammaticali
Abbiamo detto in precedenza che i morfemi funzionali esprimono un numero limitato di
caratteristiche funzionali, che dora in poi chiameremo tratti. Ecco un elenco provvisorio (e incompleto) con qualche spiegazione:
Numero (singolare, plurale, duale, paucale): i sistemi grammaticali solitamente codificano se
una parola si riferisce ad un individuo singolo o a pi individui. Pi raramente, i sistemi
grammaticali esprimono il fatto che la parola si riferisca a due individui (duale) o a pochi (paucale);
-
LINGUISTICA LCM 2013
14
Genere (maschile, femminile): non coincide sempre con il sesso. Il genere infatti una
categoria grammaticale che viene spesso attribuita anche ad entit inanimate, si pensi a parole come
sole maschile vs luna femminile. La distinzione dei nomi in elementi maschili e femminili non universale: in molte lingue ci che conta (anche) la distinzione fra umano e non umano (si pensi
alla distinzione dei pronomi inglesi he/she/it) o distinzioni ancora pi elaborate. Lappartenenza di un nome ad una determinata classe spesso dovuta a cause linguo-specifiche e pu dipendere da
credenze extralinguistiche poi opacizzatesi nel corso della storia. Non c quindi un perch in italiano la luna sia femminile e il sole sia maschile; anche questo dipende dalla propriet
dellarbitrariet del segno. Persona (prima: il parlante, seconda: lascoltatore, terza, ecc.): codifica se il riferimento
diretto verso uno degli attori della comunicazione (il parlante, lascoltatore o nessuno dei due). La prima persona plurale (noi) non identifica un insieme di parlanti, ma piuttosto un insieme che
contiene il parlante. Tale insieme pu contenere oppure no anche lascoltatore: nel primo caso si parler di prima persona inclusiva, nel secondo caso di prima persona esclusiva. Esistono lingue in
cui la distinzione inclusivo/esclusivo espressa dalla morfologia. Allo stesso modo, la seconda
persona plurale non si riferisce necessariamente ad una pluralit di ascoltatori, ma ad un insieme di
persone che include almeno un ascoltatore.
Caso: in molte lingue, ad esempio in Latino, gli elementi nominali (nomi, pronomi e
modificatori del nome come determinanti e aggettivi) presentano morfologia di caso. Il caso
esprime la funzione sintattica di un complemento. Possiamo distinguere due tipi di caso, sebbene la
distinzione non sia cos netta e precisa: i casi relazionali sono quelli che esprimono la funzione
grammaticale dellelemento nominale (soggetto, oggetto, oggetto indiretto o compl. di termine) mentre i casi semantici sono quello che non esprimono soltanto una relazione grammaticale ma
anche un valore semantico: strumentale (lo strumento attraverso il quale si compie lazione), comitativo (il caso del cd. compl. di compagnia), locativo, ecc. Spesso, distinzioni di caso sono
visibili nella morfologia dei pronomi piuttosto che in quella dei nomi.
Tempo (passato, presente, futuro): indica se il parlante sta facendo riferimento ad uno stato o
azione precedente, contemporaneo o successivo al momento dellenunciazione Inoltre, possibile esprimere se uno stato/azione abbia avuto luogo prima, durante o dopo un
momento del riferimento (MR) che diverso dal momento dellenunciazione (ME). Nella frase seguente, ad esempio, il MR il momento in cui Carlo arrivato, quindi il MR precede il ME.
Inoltre, il tempo trapassato utilizzato nella frase temporale indica anteriorit non solo rispetto al
ME, ma anche rispetto al MR:
(9) Quando Carlo arrivato, Giulia era partita
Le relazioni temporali codificate nella frase precedente possono essere rappresentate in questo
schema, in cui la retta rappresenta lasse del tempo, ME il Momento dellEnunciazione, MR il momento di Riferimento e la x rappresenta lazione denotata dal verbo trapassato:
x MR ME
Modo: indica latteggiamento del parlante rispetto allevento denotato. Dato lo stesso verbo, un parlante pu descrivere un evento reale (modo indicativo: Mario parte), riferirsi ad un evento
potenziale (modo congiuntivo: penso che Mario parta), comandarlo (modo imperativo: parti!),
desiderarlo (modo ottativo/desiderativo, che in italiano viene espresso con il congiuntivo
imperfetto: partisse almeno Mario), ipotizzarlo (modo condizionale: Mario partirebbe).
Dal punto di vista morfologico, dobbiamo inoltre distinguere i modi finiti (quelli che
presentano flessione di persona a seconda dei tratti del soggetto) da quelli non finiti come linfinito, il gerundio ed il participio. Tali forme verbali non possono essere flesse sulla base della persona,
-
LINGUISTICA LCM 2013
15
ma, in determinate lingue, presentano le stesse propriet flessive degli elementi nominali,
accordandosi in genere e numero.
Il concetto di modo non va confuso con quello di modalit, che ha a che fare con il giudizio
del parlante sulla necessit o possibilit che levento denotato dal verbo abbia luogo. In Italiano, la modalit espressa attraverso dei morfemi liberi, detti appunto verbi modali: si distinguono quindi
modali di necessit (dovere, bisognare) e modali di possibilit (potere). La modalit pu essere
espressa da perifrasi pi ampie, dette appunto perifrasi modali, come ad esempio le forme dialettali
avere da (es. Ven. go da dirte na roba). La possibilit o necessit di un evento pu dipendere da
due tipi di fattori: a) dalla conseguenza logica di un altro evento (la strada bagnata, deve aver
piovuto; hanno suonato, potrebbe essere Carlo): b) da condizionamenti imposti da entit umane (il
parlante o entit terze, a volte non specificate): bisogna alzarsi presto, devo portare questo libro a
Matteo, non posso alzarmi perch mi sono fatto male al ginocchio. Nel primo caso si parla di
modalit epistemica, nel secondo di modalit deontica.
Aspetto: indica punti di vista diversi rispetto allo svolgimento del processo/azione denotato
dal verbo. La principale distinzione aspettuale quella fra aspetto perfettivo vs imperfettivo: nel
primo caso, il parlante pone laccento sul fatto che esiste un momento temporale in cui il processo denotato dal verbo chiuso e terminato. Viceversa, laspetto imperfettivo non denota lesistenza di un punto temporale in cui soggettivamente possibile vedere la fine del processo (questo non significa che il processo non sia oggettivamente terminato, ma semplicemente che tale termine non
rilevante). Si confrontino le due frasi seguenti:
(10) a. Mario ha mangiato la mela b. Mario mangiava la mela
Entrambe le frasi si riferiscono ad un tempo passato rispetto al momento dellenunciazione. Nel primo caso, per, possiamo dedurre che la mela sia stata mangiata, mentre nel secondo caso ci non
detto. Infatti possiamo costruire un enunciato come Mario mangiava la mela, ma non lha finita, mentre nel primo caso la stessa continuazione d un risultato leggermente contraddittorio (Mario ha
mangiato la mela, ma non lha finita). Gli avverbiali di tempo danno comportamenti contrastanti se combinati con forme perfettive o imperfettive, si consideri:
(11) a. Mario ha mangiato la mela per due ore. b. * Mario mangiava la mela per due ore.
Unaltra distinzione aspettuale rilevante, ma probabilmente subordinata a quella perfetto/imperfetto, quella fra aspetto iterativo (o abituale) e progressivo. Si confrontino a questo
proposito le due forme di presente dellinglese, la prima con valore abituale (I eat bananas), la seconda con valore progressivo (I am eating a banana).
Linterazione di aspetto e tempo spesso molto complessa, tanto che nei paradigmi verbali romanzi le due componenti sono difficilmente scindibili (diverso il discorso per il sistema tempo-
aspettuale delle lingue slave). In particolare, non c una visione condivisa per quanto concerne le caratterizzazioni tempo-aspettuali dei tempi composti. In inglese, ad esempio, la terminologia
utilizzata (present perfect) lascia intendere come le forme del tipo have eaten non debbano essere
considerate dei passati, ma piuttosto dei presenti perfettivi, in cui cio viene messo in luce il fatto
che nel momento dellenunciazione lazione/processo denotato dal verbo compiuta. Invece, per il passato prossimo italiano tale descrizione non sembra abbastanza efficace (fermo restando che solo
una minoranza della popolazione italiana padroneggia la distinzione fra passato prossimo e remoto:
ad esempio, per i parlanti settentrionali il passato prossimo lunica forma di passato indicativo possibile, necessariamente perfettiva). Viceversa, i parlanti che distinguono passato prossimo e
remoto possibile che siano sensibili a qualche sotto-distinzione di tipo aspettuale, ma le categorie
sin qui introdotte sono troppo grossolane per poterla cogliere.
-
LINGUISTICA LCM 2013
16
Aspetto vs azione: tutti i tipi di verbo possono flettersi secondo i tratti aspettuali sopra
elencati. Questo perch laspetto (come il tempo, il numero, la persona) sono categorie funzionali esterne alla radice lessicale. Viceversa possibile individuare delle costanti semantiche secondo cui possibile organizzare le radici verbali in gruppi secondo un numero limitato di opposizioni, ad
esempio quella fra verbi durativi vs non-durativi: nei primi levento denotato scomponibile in una sequenza temporale, cfr. mangiare vs arrivare (ho mangiato per due giorni vs *sono arrivato per
due giorni). Una sotto-classe dei verbi non-durativi sono i verbi stativi come essere, pesare, ecc.
(che non ammettono limperativo). Unulteriore classe azionale quella dei verbi trasformativi, che denotato un cambiamento fra il momento in cui lazione ha inizio e quello di fine (ad esempio, addormentarsi, che anche un verbo non-durativo).
Fra le categorie flessive del verbo possiamo annoverare anche la diatesi, ovvero
linformazione se il verbo abbia struttura attiva o passiva. Approfondiremo questi aspetti nella sezione dedicata alla sintassi.
Per chi fosse interessato ad approfondire le propriet dei tratti grammaticali del verbo,
consiglio la lettura di G. Borgato, Un profilo del verbo, Padova, Unipress oppure P.M. Bertinetto, Il
dominio tempo-aspettuale, Torino, Rosenberg & Sellier, 1997.
I morfemi grammaticali che esprimono questi tratti sono detti morfemi flessivi ed il processo
di combinazione di una radice lessicale con uno o pi morfemi flessivi detto flessione.
Se la flessione veicolata da suffissi, tali suffissi si troveranno nella posizione pi periferica
nella struttura della parola e prendono il nome di desinenza.
Tutte le forme flesse aventi la stessa radice formano un paradigma.
Alcuni dei tratti flessivi precedentemente illustrati (tempo e persona) devono essere
interpretati sulla base di dati contestuali: linterpretazione di un tempo presente o di una forma alla prima persona cambia in fatti al variare del momento dellenunciazione e di chi compie lenunciazione. Questi tratti funzionali sono detti deittici. Altri tratti deittici sono salienti nella morfologia dei dimostrativi (questo, quello, ecc.), che identificano referenti vicini a chi ascolta o a
chi parla. Anche in questo caso, quindi, il significato di tali espressioni varia al variare del contesto
spaziale in cui avviene lenunciazione. Si noti che i morfemi flessivi si combinano con le radici secondo un ordine che non pu
essere modificato: ad esempio, i morfemi tempo-aspettuali devono precedere quelli di persona e
numero, che risultano quindi pi esterni nella struttura della parola rispetto alla radice. Se infatti
scomponiamo una forma verbale come amavo, possiamo notare come il morfema che indica la
persona ed il numero del soggetto segue il morfema di imperfetto -v-. Ovviamente, se si provasse ad
invertire lordine dei morfemi, la parola risultante sarebbe inaccettabile (*amaov). Questa non una propriet specifica dellitaliano, ma una caratteristica condivisa da tutte le lingue del mondo.
Strutture analitiche e sintetiche; tipologia morfologica
Confrontiamo le forme del futuro semplice in due lingue genealogicamente imparentate: il latino
tardo e litaliano: cantare habeo vs canter. Le due forme esprimono lo stesso nucleo di tratti grammaticali, che indicano posteriorit rispetto al momento dellenunciazione. Ci che cambia fra le due lingue la morfologia delle due forme. In un caso abbiamo infatti una forma complessa
creata grazie alla combinazione di due parole (come nellinglese will+V): una parola funzionale (lausiliare habeo) e una lessicale (linfinito di cantare). In italiano, invece, gli stessi tratti sono espressi da una singola parola (canter) in cui i tratti di futuro sono espressi da un morfema legato:
cant-er-.
Il primo tipo di struttura morfologica detta forma analitica, mentre il secondo detta forma
sintetica. Possiamo quindi dire che levoluzione della morfologia del futuro dal latino allitaliano consiste nel passaggio da una forma analitica ad una sintetica.
-
LINGUISTICA LCM 2013
17
Un altro caso di evoluzione da una struttura sintetica ad una analitica rappresentata dal passivo,
che nei tempi semplici del latino era espresso sinteticamente, mentre in italiano richiede strutture
analitiche con tutti i tempi/modi verbali.
Il punto importante che il medesimo significato grammaticale (esprimibile in tratti) pu
essere espresso, in lingue diverse, o in modo analitico o in modo sintetico. Nel primo caso, i tratti
flessivi di cui sopra saranno espressi attraverso morfemi liberi, la cui distribuzione e le cui propriet
saranno regolate dai principi della sintassi. Nelle strutture sintetiche, invece, la codifica di tali tratti
affidata a morfemi legati, le cui propriet saranno oggetto di studio della morfologia. In questo
senso, quindi, la flessione un aspetto delle lingue che sta a cavallo fra livelli di analisi diversi.
Alcune lingue, come il cinese, ammettono solamente strutture analitiche: tutti i morfemi
grammaticali sono quindi espressi da morfemi liberi. Tali lingue si chiamano lingue isolanti.
Viceversa, nelle lingue come litaliano, molte ma non tutti i tratti grammaticali sono realizzati mediante morfemi legati. Fra le lingue dellultimo tipo, possibile tracciare una sotto-tipologia: in Italiano, infatti, non c una relazione 1:1 fra tratti grammaticali e morfemi grammaticali. Solitamente, infatti, un solo morfema esprime tratti diversi. Si pensi alla desinenza -o
di amo che veicola tratti di tempo, aspetto, modo, numero e persona. Questo sistema di veicolare
pi tratti attraverso un solo morfema tipico delle lingue dette flessive o fusive (in cui pi tratti
sono fusi in un unico morfema). Tali lingue si differenziano da un terzo tipo, quello delle lingue agglutinanti, in cui i tratti
grammaticali sono espressi da una serie di morfemi legati tale per cui vi sia una relazione 1:1 fra
tratti e morfemi, come esemplificato dalla glossa della seguente forma verbale del turco:
(12) sn- dr- l- eme- mek spegnere CAUS PASS MOD INF
non poter essere spento
Le categorie grammaticali
Non tutte le radici possono combinarsi con tutti i tratti grammaticali. La radice libr- pu infatti
combinarsi con morfemi che esprimono il genere ed il numero, ma non con morfemi aspettuali,
temporali o modali. Viceversa, la radice legg- non pu combinarsi con un morfema di genere. Da
cosa dipendono queste restrizioni (fra molte altre)?
Potremmo pensare che ci dipenda dalle propriet ontologiche dei referenti designati dai
segni libr- e legg-: il primo ha come significato un oggetto, che quindi non modificabile da
informazioni relative a tempo-aspetto-modo (TAM), mentre il segno legg-, che denota unazione, non direttamente combinabile con informazioni relative al genere (sebbene non si possa escludere
che un verbo possa esprimere i tratti di genere del suo soggetto, come infatti accade in alcuni
dialetti italiani come quello parlato a Ripatransone, Marche).
In verit, le cose non sono cos semplici e, come vedremo fra breve, non possiamo sostenere
che la grammatica abbia accesso diretto ad informazioni ontologiche (= che riguardano lessenza dei referenti): una distinzione come oggetto vs azione non di nessun aiuto per comprendere il
comportamento grammaticale dei segni linguistici. Dobbiamo quindi postulare un tipo di
informazione aggiuntivo che, dato un morfema lessicale, ci consenta di capire il suo comportamento
grammaticale (ad esempio se in italiano esso possa o meno combinarsi con un morfema TAM). Tale
informazione data dalla categoria grammaticale. Possiamo immaginare che ogni morfema
lessicale immagazzinato nel Lessico sia associato ad almeno una categoria grammaticale come
Verbo, Nome, Aggettivo, ecc. che determina le sue propriet morfologiche e sintattiche: solamente
le radici categorizzate come Verbi possono combinarsi con morfemi TAM, solamente radici
nominali possono presentare, in italiano, morfemi di genere.
-
LINGUISTICA LCM 2013
18
Immaginiamo quindi che il lessico sia costituito da una lista di morfemi lessicali, ognuno dei
quali associato ad una categoria grammaticale, ad esempio: libr-N, legg-V, alber-N, dolc-AGG,
prestoAVV, ecc. In alcuni casi, dobbiamo supporre che una radice sia associata a pi categorie. Si
prenda ad esempio la radice sogn-, che pu dare origine sia ad un nome (sogn-o,-i) che ad un verbo
(sognare): in questo caso bisogna supporre che la radice abbia una doppia categoria, sogn-N/V.
In alternativa, si potrebbe supporre che alcune (o, secondo alcuni studiosi, tutte) le radici
siano originariamente prive di categoria e che essa non sia memorizzata nel lessico, ma venga
assegnata di volta in volta dalla grammatica. Non potremo esplorare ulteriormente le conseguenze
di questa ipotesi.
Quali (e quante) sono le categorie?
Le categorie lessicali sono quattro: Nome, Verbo, Aggettivo, Avverbio.
Tradizionalmente, la distinzione fra verbi e nomi e data su base ontologica: i primi esprimono
azioni, i secondi oggetti. Abbiamo per gi visto che questa impostazione non pienamente
sostenibile. In primis, non ben chiaro quali siano i parametri per distinguere un oggetto da
unazione: cos sogno, cos passione, cos paura? Difficile stabilire se si tratta di azioni o oggetti. Inoltre, in certi casi la distinzione proposta controintuitiva come nei casi di nomi come
corsa, salto, capriola che si riferiscano ad azioni e non ad oggetti.
La distinzione fra verbi e nomi come quella fra altre categorie non dipende infatti direttamente da propriet ontologiche, ma collegabile a propriet grammaticali, principalmente
quella di potersi combinare con certe classi di morfemi funzionali e non con altre.
Questo vale sia per combinazioni morfologiche con morfemi legati (come nei casi gi citati),
ma anche per combinazioni sintattiche con morfemi liberi. Ad esempio, impossibile combinare un
articolo con un avverbio (*il certamente), oppure impossibile combinare un determinante con una
forma verbale che non sia un infinito con funzione di sostantivo (il partire vs *il partendo).
Nella suddivisione delle categorie contano anche distinzioni di natura semantica. La
caratteristica primaria degli aggettivi e degli avverbi, ad esempio, quella di non denotare entit,
ma propriet di individui: un nome (es. cane) si riferisce a tutti gli individui accomunati da un
insieme di propriet (mammifero, quadrupede, miglior amico delluomo ecc.), mentre un aggettivo identifica una di queste propriet (es. peloso, agile, affettuoso, ecc).
Anche gli avverbi, come gli aggettivi, denotano una qualit, ma, mentre gli aggettivi
modificano un nome, gli avverbi qualificano la propriet di una frase o di una sua porzione. Il
termine avverbio lascerebbe intendere che lavverbio modifichi il verbo, ma non si pu sostenere questo in tutti i casi. Si prenda ad esempio la frase sinceramente Paolo mi ha stancato: in questo
caso, lavverbo sinceramente non d informazioni aggiuntive relative allazione descritta dal verbo (come invece accade nella frase Paolo mi ha stancato molto). Avverbi come sinceramente,
francamente descrivono infatti una valutazione del parlante in relazione allintera enunciazione, piuttosto che specificare una propriet del verbo. Ecco perch il termine avverbio non va preso alla
lettera.
Come per il caso della distinzione Verbo/Nome, anche nel caso Aggettivo/Avverbio ci sono
dei casi ambigui: possiamo infatti dire che ho corso velocemente, ma anche possibile dire che ho
corso veloce, in cui laggettivo, almeno ad una prima analisi, non modifica un nome ma si riferisce allintera azione e si comporta quindi come un avverbio. In molte variet del meridione, e di riflesso anche nellitaliano regionale parlato nella medesima area, luso di aggettivi con funzione avverbiale molto comune (ho mangiato buono) e, nei dialetti, lunica forma di modificazione avverbiale possibile.
Accanto a categorie lessicali come N, V, Agg e Avv, a cui appartiene un numero elevato e
potenzialmente espandibile di radici, possiamo postulare anche alcune categorie funzionali, che
raggruppano insiemi chiusi di elementi grammaticali che hanno le medesime propriet sintattiche.
Le tre categorie funzionali principali sono:
-
LINGUISTICA LCM 2013
19
Le preposizioni, che semanticamente presentano caratteristiche ibride di morfemi lessicali e grammaticali. Infatti, alcune preposizioni sono dotate di significato, specialmente locativo, e
possono essere utilizzate con funzione avverbiale: per es. sotto, sopra, accanto, ecc. Altre
preposizioni, invece, sono completamente prive di significato e assolvono unicamente funzioni
grammaticali esprimendo relazioni grammaticali fra costituenti: per es. a, da.
I complementatori (o, pi tradizionalmente, le congiunzioni frasali) come che, perch,
sebbene, ecc. Il ruolo di questi elementi quello di connettere fra di loro le frasi che appartengono
al medesimo periodo.
I determinanti: sono modificatori del nome come gli articoli, i dimostrativi, i possessivi che
specificano alcune propriet del nome. A differenza degli aggettivi, i determinanti sono una classe
chiusa che esprime una serie di concetti grammaticalizzati. Fra i determinanti, larticolo deputato alla codifica della definitezza, ovvero la propriet di riferirsi ad un individuo definito (il libro, quel
libro) o ad un individuo indefinito (un libro), ovvero uno qualsiasi di tutti i libri possibili. Gli
elementi possono essere definiti perch gi menzionati o salienti nel discorso oppure perch
specificati da un modificatore come un aggettivo (il libro nero) o da una frase relativa (il libro che ti
ho regalato). In italiano, larticolo definito si usa anche per riferirsi ad unintera classe di individui (la tigre vive in Africa e Asia).
Anche il dimostrativo indica definitezza (ed infatti articoli e dimostrativi non possono co-
occorrere), ma oltre alla definitezza esprime informazioni deittiche come la vicinanza/lontananza da
chi parla/ascolta. Litaliano centro-meridionale si basa su un sistema a tre distinzioni: vicino a chi parla (questo), vicino a chi ascolta (codesto), lontano (quello), mentre nellitaliano settentrionale attivo un sistema a due opposizioni: vicino a chi parla (questo) e lontano da chi parla (quello). I
dimostrativi possono modificare un nome, ma possono anche occorrere senza nome, assumendo
quindi una funzione pronominale.
Lo stesso comportamento riscontrabili nei possessivi. Si noti che in alcune lingue il
possessivo pu co-occorrere con gli altri determinanti (il mio libro, quelle tue matite), mentre in
altre lingue possessivi e altri determinanti si escludono a vicenda (*the my book, *these your
pencils).
Infine, i quantificatori: sono determinanti che specificano la quantit di individui denotati. Si
distinguono in q. definiti (i numerali) ed indefiniti (molti, pochi, ecc.). Gli ultimi non forniscono
linformazione sul numero esatto di referenti. I q. indefiniti possono essere positivi o negativi, come nessuno e niente. Gli indefiniti possono avere forme diverse a seconda che si riferiscano ad entit
umane o non-umane. Inoltre, si distinguono i q. assoluti, che denotano, in positivo od in negativo,
unintera classe di individui (es. tutti i libri, ogni ragazzo, ecc.) dai q. esistenziali, che invece denotano lesistenza di un sottoinsieme degli individui di una determinata classe (qualche foglio, alcuni amici).
Cambiare categoria
Esistono dei processi morfologici che consentono di cambiare la categoria grammaticale di una
radice. Tali processi vanno sotto il nome di derivazione.
Per alcuni studiosi, anche le alternanze V/N (ad esempio, ingl. cut tagliare vs cut taglio) non sono dovute alla presenza nel lessico di una radice con una doppia categoria, ma ad un processo
di mutamento di categoria detto conversione.
Solitamente, per, tali cambiamenti si ottengono combinando una radice con categoria X ad
un morfema grammaticale il cui scopo quello di trasformare la categoria di X in Y. Ad esempio, la
funzione del suffisso italiano -tore quello di trasformare un verbo in un nome: creare creatore; saldare saldatore; imbalsamare imbalsamatore, ecc. Nel caso specifico, il suffisso -tore si aggiunge ad una radice verbale per creare un nome. I suffissi come -tore sono quindi detti suffissi
deverbali (in quanto il punto di partenza un verbo).
-
LINGUISTICA LCM 2013
20
Un altro processo di mutamento di categoria attestato in italiano la cd. parasintesi: ovvero, la
creazione di un verbo a partire da un aggettivo, ad es. giallo -> ingiallire; bianco ->
imbiancare/sbiancare, rosso -> arrossire ecc. I verbi parasintetici sono formati a partire da una
radice aggettivale, che viene combinata con un prefisso (di origine preposizionale) e con desinenze
verbali.
Altri affissi
Non tutti gli affissi sono coinvolti in processi derivativi o flessivi. I suffissi valutativi non
esprimono tratti grammaticali, ma valutazioni da parte del parlante su propriet soggettive come la
dimensione o il valore positivo/negativo. Nel primo caso, si parla di suffissi accrescitivi e
diminutivi come -ino (tavolo, tavolino) o -one (tavolo, tavolone). Nel secondo caso di parla di
affissi vezzeggiativi o peggiorativi come -uccio (quadro, quadruccio) e -accio (quadro,
quadraccio). Spesso non possibile distinguere fra valore diminutivo/vezzeggiativo (quadro,
quadretto: un piccolo quadro o un quadro grazioso?). Alcuni suffissi valutativi possono essere
combinati fra loro (tavol-in-etto), ma sempre con un ordine fisso (*tavol-ett-ino). Inoltre, i suffissi
valutativi si trovano sempre fra i suffissi derivativi (quelli che cambiano la categoria sintattica della
base) e i suffissi flessivi.
I prefissi dellitaliano, a differenza dei suffissi, non possono mai modificare la categoria della radice cui si aggiungono: possibile un aggettivo, la corrispondente parola prefissata (impossibile)
pure. I prefissi, in italiano, non possono nemmeno esprimere tratti di accordo, ma possono
esprimere ulteriori tratti semantico-grammaticali quali
- Negazione: in-disponibile, ir-responsabile, ecc. - Privazione: s-conforto, dis-inibito, dis-attento, ecc. - Iterazione: ri-allacciare, ri-conquistare, ecc. - Localizzazione (nel tempo e nello spazio): anteprima, postbellico, previsione, ecc.
Esistono infine affissi apparentemente privi di significato. Si prendano ad esempio le vocali
tematiche dellitaliano: am-a-re, cad-e-re, dorm-i-re. La vocale tematica si aggiunge alla radice del verbo formando il tema verbale, che si combina poi con gli altri affissi:
(13) [[am-]radice -a-]tema -re
Come si diceva, la vocale tematica non esprime alcun tratto grammaticale, ma segnala lappartenenza di una determinata radice verbale ad una delle tre classi verbali dellitaliano. Una classe un sotto-insieme del lessico che non identificabile sulla base di propriet semantiche, ma
morfologiche. Infatti, non possibile trovare alcuna correlazione solida fra le vocali tematiche
dellitaliano e altre propriet grammaticali (lazione verbale, ad esempio) o semantiche. La forma della parola italiana quindi la seguente: radice + vocale tematica + suffissi
derivativi + suffissi valutativi + suffissi flessivi. Ecco alcuni esempi:
(14) radice V.T. der. val. fless. a. sudaticce sud- -a- -t- -icc- -e
b. frullatoroni frull- -a- -tor- -on- -i
Il fatto che lordine degli affissi fisso indica che le parole sono dotate di una struttura ben definita e non sono date dalla semplice concatenazione di morfemi. Inoltre, lo studio delle possibili
combinazioni di affissi ci consente di esplorare la struttura gerarchica della parola. Scomponendo la
parola in morfemi siamo infatti in grado di stabilire quali affissi siano strutturalmente pi prossimi
alla radice di altri. Prendiamo ad esempio una parola complessa come deindustrializzare, che pu
essere scomposta come segue: de- industri- -al- -izz- -a- -re.
-
LINGUISTICA LCM 2013
21
Osserviamo ora il comportamento del prefisso de-: non possiamo sostenere che tale prefisso si
combini direttamente con la radice nominale industri-, altrimenti si formerebbe la forma
*deindustri(a) che in italiano non esiste. Dobbiamo quindi ipotizzare che il prefisso si combini con
la base aggettivale industri-al- e che quindi la suffissazione di -al- avvenga prima della
prefissazione con de-. Tuttavia, anche questo non basta perch, combinando il prefisso con la base
aggettivale, ottengo nuovamente una forma non accettabile: *deindustrial(e). Per poter combinare il
prefisso devo quindi aspettare di avere una base verbale (industrializz-) che, assieme al prefisso,
forma una base attestata (deindustrializz-) che pu poi flettersi come qualsiasi verbo della prima
coniugazione. Volendo esprimere quanto appena visto con uno schema, possiamo farlo attraverso
delle parentesi che rendano conto di come il processo di prefissazione, in questo caso, si applichi
solamente dopo due processi di suffissazione che hanno trasformato la radice nominale prima in un
aggettivo, poi in un verbo:
(15) [[[de- [[[industri-]N -al-]AGG -izz-]V ] -a-] -re]
Le stese relazioni gerarchiche possono essere rappresentate mediante un diagramma ad albero
rovesciato:
(16)
de- industri- -al- -izz- -a- -re
Allomorfia e suppletivismo
I morfemi sono delle unit astratte, la cui realizzazione morfo-fonologica pu subire variazioni contestuali pi o meno sistematiche. Prendiamo ad esempio il prefisso in- dellitaliano presente nelle parole inabile, intollerante, indifferente, ecc. Tale prefisso, che ha un valore negativo, lo
ritroviamo in forma diversa anche in altre parole come irrilevante, importuno, illiberale, ecc. Fa
parte della nostra intuizione di parlanti che in-, ir-, im-, il- siano tutte varianti dello stesso morfema
la cui variazione dipende in ultima analisi dal suono che compare allinizio della radice (approfondiremo questo genere di problemi nei prossimi di capitoli). Tali varianti di un unico
morfema sono dette allomorfi.
Spesso, come nel caso precedente, gli allomorfi sono facilmente riconoscibili poich, oltre a
condividere il medesimo nucleo di significato, la forma morfologica di un allomorfo facilmente
confrontabile con quella di un altro allomorfo ed possibile trovare delle spiegazioni regolari dal
punto sincronico o diacronico che rendano conto della loro distribuzione.
Fenomeni di allomorfia non riguardano solamente i morfemi grammaticali, ma anche quelli
lessicali. Si consideri ad esempio la radice del verbo vincere nelle due forme del presente indicativo
vinc-o ~ vinc-i. I due suoni rappresentati dalla lettera c dellalfabeto sono sensibilmente diversi: possibile quindi individuare due allomorfi della radice del verbo vincere, la cui distribuzione
apparir chiara una volta introdotto qualche concetto di fonologia.
In altri casi, tuttavia, non sembra possibile ricostruire una relazione sistematica fra due forme
alternanti. Si prenda ad esempio il caso della radice del verbo andare nelle forme del presente
indicativo: vado, vai, va, andiamo, andate, vanno. Le forme di prima e seconda persona plurale,
cos come linfinito, selezionano la radice and-, mentre le altre forme del paradigma hanno la radice va(d)-. In questo caso abbiamo a che fare con unalternanza allomorfica un po particolare, visto
-
LINGUISTICA LCM 2013
22
che non possibile rendere conto della distribuzione dei due alternanti sulla base di principi
regolari, n dal punto di vista sincronico, n da quello diacronico. Tali casi vengono solitamente
rubricati come fenomeni di suppletivismo, intendendo con questo termine un caso limite di
allomorfia in cui non siamo in grado di definire una relazione formale fra le due forme in variazione
contestuale.
Composti
I composti sono parole contenenti due morfemi lessicali come girarrosto, portacenere, piedipiatti,
girocollo, grigioverde.
Spesso, fra i due membri del composto vige una relazione asimmetrica. Prendiamo ad
esempio il caso della parola uomo-rana (palombaro). Se applichiamo i test di interrompibilit, commutabilit, ecc. vediamo chiaramente come la forma uomo-rana conti come una sola parola.
Tuttavia, uno dei due membri del composto ha la prevalenza sullaltro: uomo-rana un tipo particolare di uomo, non di rana. Pi tecnicamente uomo iperonimo di uomo-rana, mentre, al
contrario, uomo-rana iponimo di uomo. Non c invece alcuna relazione di iper-/iponimia fra rana e uomo-rana. Dal punto di vista morfologico, poi, notiamo che il composto ha gli stessi tratti
flessivi (genere e numero) del membro uomo e che il plurale del composto uomini-rana e non
*uomo-rane.
Tutti questi dati indicano come allinterno del composto uomo-rana vi sia un membro pi importante dellaltro, detto testa del composto, da cui dipendono molte delle propriet semantiche e morfologiche dellintero composto. I composti in cui chiaramente individuabile una testa sono detti composti endocentrici. Gli altri composti, in cui una testa non individuabile, vengono
solitamente definiti composti esocentrici: fanno parte di questa seconda categoria molti composti
dellitaliano, ad esempio quelli formati da un verbo e da un nome (portalettere, posacenere, reggimensola, paracolpi, ecc.).
In altri casi, come nei cd. composti di coordinazione (chiaroscuro, grigioverde) non
possibile stabilire qual la testa perch entrambi i membri del composto sembrano svolgere una
funzione identica.
Clitici
La distinzione fra morfemi liberi e legati non sempre cos evidente. Prendiamo ad esempio i
pronome italiano lo. Tale elemento non ha un accento primario e deve sempre occorrere in
adiacenza al verbo (fa eccezione la forma eccolo). In italiano moderno, se il verbo di modo finito,
il pronome clitico precede il verbo ( proclitico), se il verbo di modo infinito il clitico segue il
verbo (enclitico). In italiano antico, le condizioni che regolavano la posizione dei pronomi clitici
erano diverse (si potevano trovare enclitici con i tempi finiti), ma il requisito di adiacenza era
grosso modo il medesimo.
(17) a. lo manger b. voglio mangiarlo
Unaltra propriet dei pronomi clitici romanzi che, solitamente, il loro ordine rigido. Infatti, data la sequenza me lo, il contrario non grammaticale: *lo me (ma se osserviamo lordine di tali elementi nellitaliano antico, ancora una volta ci imbattiamo in una distinzione sistematica, in quanto lordine di alcune combinazione era in origine il contrario).
Inoltre, i pronomi clitici, a differenza di quelli tonici come lui, non possono comparire in
isolamento:
(18) D: Chi hai invitato? R: lui/*lo
-
LINGUISTICA LCM 2013
23
Oltre a non poter comparire in isolamento, i pronomi clitici si differenziano dai tonici per non
poter essere contrastati e coordinati:
(19) a. lui/*lo che ho visto.
b. Ho visto lui/*lo e Maria
Quindi, gli elementi clitici hanno alcune propriet dei morfemi legati: devono comparire in
adiacenza ad un determinato elemento della frase, il loro ordine rigido, non possono comparire in
isolamento. Tuttavia, il fatto che la loro posizione cambi a seconda del modo verbale e il fatto che
essi non siano una componente obbligatoria della struttura della parola ci porta a pensare che tali
elementi non siano di natura affissale, ma che piuttosto elementi liberi che, per vincoli sintattici
indipendenti, sono obbligati ad occupare una posizione fissa nella struttura della frase, che in
italiano adiacente a quella del verbo.
Abbiamo sin qui illustrato le propriet dei pronomi clitici romanzi, ma la casistica di elementi
clitici nelle lingue del mondo molto varia. In pratica, qualsiasi elemento grammaticale come le
congiunzioni, i determinanti, gli ausiliari, ecc. possono essere clitici e presentare alcune o tutte le
propriet illustrate sopra.
Diacronicamente, plausibile che un elemento clitico rappresenti uno stadio intermedio
dovuto allevoluzione di un elemento libero in un affisso, ma tale ipotesi dovr essere provata e verificata caso per caso.
-
LINGUISTICA LCM 2013
24
III. Fonetica
Cos un suono
I suoni sono dei fenomeni fisici, descrivibili in modo oggettivo attraverso dei parametri matematici.
I suoni sono infatti delle onde, ovvero delle continue compressioni e rarefazioni delle molecole di
un gas (o di un fluido) che funge da mezzo di propagazione del suono.
Tali compressioni/rarefazioni possono essere rappresentate attraverso dei diagrammi che
rappresentano in ascissa i valori dellescursione fra fasi di pressione e rarefazione e in ordinata levoluzione nel tempo.
Alcune onde sonore sono cicliche: possono cio ripetersi ad intervalli regolari. I suoni
caratterizzati da oscillazioni cicliche sono detti suoni periodici (gli altri sono detti aperiodici). Il
numero di cicli nellunit di tempo ci d la frequenza del suono, che si misura in Hertz (1Hz = 1 ciclo al secondo).
Oltre alla frequenza (che un parametro relativo solo ai suoni periodici) i suoni si distinguono
in base alla loro intensit (misurata in decibel, dB), che la misura dellescursione fra i picchi di massima compressione e massima rarefazione causato dallonda.
Semplificando, la frequenza dei suoni determina la loro altezza, mentre lintensit determina il loro volume.
I suoni delle lingue
Gli esseri umani sono in grado di produrre molti tipi di suoni, in particolare, perturbando il flusso
daria che passa attraverso la bocca. Fischi, colpi di tosse, sospiri, gorgoglii, ecc. sono alcuni dei suoni che siamo in grado di emettere. Ci non chiaramente una caratteristica esclusiva dellhomo sapiens, in quanto la possibilit di emettere suoni una propriet condivisa con moltissime altre
specie.
Solo un piccolo sottoinsieme dei suoni che siamo in grado di emettere sono utilizzati per la
comunicazione verbale: colpi di tosse e fischi, ad esempio, non rientrano nellinventario dei suoni di nessuna lingua. Non esistono culture, in pratica, in cui il fischio viene utilizzato per formare, ad
esempio, una parola (ci non vuol dire che il fischio non venga utilizzato per comunicare in senso
lato).
I suoni che usiamo per comunicare attraverso le lingue sono detti foni e la branca della
linguistica che li studia si chiama fonetica.
I foni possono essere studiati sia sotto laspetto acustico (studiandone quindi le propriet fisiche quali altezza e intensit) o percettivo (come tali propriet fisiche vengono elaborate dal
-
LINGUISTICA LCM 2013
25
nostro cervello). In particolare, lapproccio che ha avuto pi fortuna quello articolatorio, ovvero lo studio dei processi anatomo-fisiologici che ci consentono di produrre i foni.
I vantaggi di un approccio articolatorio sono due: moltissimi processi che riguardano la
pronuncia s