Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa...
-
Upload
truongngoc -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa...
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
PARTE I
Alla ricerca delle grandi costanti
del diritto pubblico europeo:
le forme di stato e di governo
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
PREMESSA - Le forme di stato e di governo come repertorio di possibilità attuali per la convivenza civile
Forme di stato e forme di governo
Quando si definisce il diritto pubblico come scienza dello stato, si mette al centro la nozione di stato nazionale sovrano, che si chiama così perché una delle sue principali caratteristiche è appunto la sovranità su un territorio.
Nella descrizione più semplice, la sovranità è la condizione per cui, all’interno dello stato, solo lo stato è titolare di poteri pubblici, di tipo normativo, giurisdizionale ed esecutivo, che esercita tramite propri apparati (organi dello Stato). La sovranità verso l’interno non osta peraltro a che lo Stato possa creare nel suo territorio altri enti dotati di poteri a sé analoghi, come è avvenuto in Italia con le Regioni e gli altri enti locali, ma che derivano i loro poteri da quelli statali.
Preminente su ogni altro potere pubblico al suo interno, lo Stato è anche indipendente da ogni altro potere pubblico al suo esterno. La sovranità verso l’esterno impedisce che norme, decisioni o atti vigenti come diritto in un altro Stato abbiano vigore nel territorio di un altro, ma non impedisce che uno Stato possa volontariamente stipulare, con altri Stati, accordi dai quali rimane vincolato (trattati internazionali). I trattati internazionali possono dar vita a forme di collaborazione temporanee o circoscritte ad alcuni ambiti (trattati commerciali, militari); o creare, tra gli Stati stipulanti, forme di collaborazione permanenti, dando con ciò vita ad associazioni, organizzazioni ‘sovranazionali’ o ‘sovrastatuali’, ossia composte da più Stati, le quali stabiliscono una compenetrazione organizzativa e funzionale tra gli Stati membri, come è accaduto coi trattati che hanno dato origine all’odierna Unione europea.
Una parte tradizionale dello studio del diritto pubblico concerne la descrizione delle tappe che hanno condotto alla formazione dello Stato sovrano in Europa continentale.
A questo scopo si usano due categorie, quella di forma di stato e di quella di forma di governo.
Per forma di stato si intende il modo in cui la sovranità statale è giustificata, ossia le basi su cui è fondata, che la legittimano (ad esempio si distingue tra forme di stato monarchiche, repubblicane, autoritarie, di diritto); il rapporto, di derivazione o meno, che esiste tra sovranità e popolo (forme di stato autocratiche, forme di stato rappresentative, forme di stato democratiche); il rapporto in cui lo stato si pone con quella particolare sfera della vita sociale che è l’economia (stato mercantilista/interventista; liberista; liberale; sociale). La forma di stato descrive inoltre il modo in cui la sovranità è distribuita ed esercitata sul territorio e sul popolo (stati accentrati, decentrati, federali, regionali).
Per forma di governo si intendono i rapporti che intercorrono tra gli organi che esercitano la sovranità (monarchia assoluta, limitata o costituzionale o rappresentativa, forma di governo parlamentare, ecc.).
Queste definizioni sono adoperate anche per classificare i vari stati contemporanei (la Francia è stato decentrato, noi regionale, la Germania federale); e le loro forme di governo, ma una loro importante funzione, come vengo dicendo, è quella di descrivere il modo in cui lo stato si è formato, evidenziando le differenze tra lo stato e ciò che lo precedeva, e individuando i fattori che, dello stato, hanno annunciato e accompagnato la formazione.
Perciò parliamo di forme di stato anche per epoche, il Medio Evo, in cui lo stato non c’era e tanto meno la sovranità come la si è poi intesa.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
La periodizzazione è la seguente:
Medio Evo: come forma di stato lo stato feudale/ per ceti/stato di giustizia, come forma di governo il governo misto.
Età moderna: come forma di stato lo stato assoluto, che evolve in stato di polizia e come forma di governo la monarchia assoluta e la monarchia assoluta ‘illuminata’.
Età contemporanea: come forma di stato lo stato a pubblica amministrazione, o stato di diritto rappresentativo, o stato liberale, che evolve in stato democratico di diritto costituzionale (passando per esperienze autoritarie) e a cui corrispondono la forma di governo parlamentare o presidenziale, o altre.
Ordine antico e moderno
Il periodo medievale e le istituzioni che lo contraddistinguono possono anche essere chiamati ‘l’ordine antico’, cui si contrappongono le istituzioni dell’età moderna e contemporanea. Pur diverse le une dalle altre, le istituzioni successive all’ordine antico hanno anche talmente tante cose in comune tra loro e diverse rispetto all’ordine antico, che si possono considerare nel loro complesso un gruppo unitario (moderno), contrapposto all’ordine antico.
Una periodizzazione e i suoi limiti
La periodizzazione delle forme di stato e di governo or ora enunciata descrive dunque il passaggio dall’assetto feudale alle prime monarchie nazionali (stati assoluti) alla formazione dello stato in senso contemporaneo dopo la Rivoluzione francese.
Questa periodizzazione ha due limiti, o comunque presenta due aspetti di cui ci dobbiamo rendere conto.
1. La periodizzazione delle forme di stato e di governo è astratta, non tiene conto di tanti percorsi particolari e diversi.
La periodizzazione poco sopra descritta riflette la storia di Francia perché la Francia è stata un Regno indipendente sin dal Cinquecento, mentre in altri paesi queste vicende sono rintracciabili in tempi e ambiti diversi (per quanto riguarda l’Italia: la feudalità fu mantenuta in Sicilia fino all’unificazione, mentre l’esperienza assolutistica fu avviata e teorizzata, ben prima che in Francia, nelle città-stato toscane o lombarde; vi sono poi, molto incisive, le peculiarità tutte proprie dello Stato della Chiesa).
Sino all’unificazione, sul territorio che oggi è l’Italia hanno convissuto, infatti, storie istituzionali che hanno avuto tempi, contenuti e modalità di evoluzione differenti.
E’ una tradizione dei nostri studi di diritto pubblico dalla seconda metà del Novecento che noi raccontiamo l’evoluzione delle forme di stato e di governo come se l’Italia fosse la Francia, cioè fosse stata, come la Francia, prima tutta quanta un grosso regno feudale, ossia uno stato territoriale per ceti, che poi si trasforma in un regno assolutistico, che poi diventa uno stato a pubblica amministrazione di tipo contemporaneo.
Questa abitudine si spiega così: intanto, la nostra storia istituzionale è talmente articolata che non si presta a categorizzazioni generali (almeno fino al 1860/61, invece di parlare delle istituzioni del diritto pubblico italiano dovremmo parlare, per l’Ottocento, di quelle del Regno di Sardegna, del Regno delle Due Sicilie, o dello Stato della Chiesa, o del Lombardo-Veneto, o del
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
Granducato di Toscana, ecc., e per i periodi precedenti delle formazioni politiche che preesistevano a queste), mentre la storia di Francia è più “semplice” e offre categorie che sono utili a capire anche quello che è successo in Italia, sebbene da noi sia successo con tempi e modalità diverse , perché anche noi abbiamo avuto feudi, ceti e sovrani (“principi”) assoluti e poi ‘illuminati’, però in contemporanea tra loro e non senza l’importante aggiunta di qualche Repubblica, come quella di Venezia, sopravvissuta nella pienezza della sua autonomia politica fino alle guerre napoleoniche, secondo un itinerario storico-politico del tutto eccezionale. Poi va considerato la storia politica, costituzionale e istituzionale della Francia ha avuto, per effetto della Rivoluzione francese, e successivamente della conquista napoleonica dell’Italia, su di noi una influenza enorme, perché ha fornito un intero serbatoio di idee e di modelli, di concetti e di istituti che sono stati utilizzati anche da noi e qualche volta hanno prevalso su una interpretazione e lettura originale dei percorsi del nostro diritto pubblico.
2.E’ una periodizzazione ispirata all’idea della storia come progresso (cattivo storicismo)
Siccome serve ad illustrare un processo che porta da una situazione in cui una certa cosa (lo stato sovrano) non c’era, a una situazione in cui quella certa cosa c’è, la periodizzazione che abbiamo descritto adotta un’idea di storia come progresso: dal guazzabuglio medievale alla perfetta macchina statale, da un mondo peggiore a un mondo migliore.
L’idea della storia come progresso è un cattivo storicismo (un cattivo uso della storia), cattivo perché fortemente ideologico: esso serve a trasmettere l’idea che il mondo in cui viviamo non può essere che come è ed è il migliore dei mondi possibili.
Un altro grave difetto dell’idea di storia come progresso è che generalmente non sa confrontarsi col futuro e col cambiamento, e per lo stesso motivo non sa fare uso del passato, dell’esperienza. Nell’Ottocento, quando lo Stato era una esperienza formata e compiuta, si formò la visione progressiva che abbiamo delineato: questo prodotto, questo oggetto, questa organizzazione è la migliore che possa esistere, allora è anche un punto di arrivo, un culmine. Ma nel giro di pochissimo si è visto che lo stato, e la sovranità, erano soggetti a cambiamenti, oggi c’è la globalizzazione, l’integrazione sovranazionale europea, parlare di ‘stato sovrano’ è una cosa che si può fare solo usando molte virgolette, perché tante cose sono cambiate rispetto all’Ottocento.
Di fronte al cambiamento, l’idea della storia come progresso sa soltanto dire che il cambiamento è caos, confusione, peggioramento; o che il cambiamento è ritorno del passato, che è negativo in quanto superato; oppure può intonare di nuovo la sua canzone e dire no il futuro sarà per definizione migliore, la globalizzazione è meglio dello stato sovrano, la nuova costituzione è meglio di quella vecchia.
Alla storia si può guardare in un altro modo, cioè come un repertorio di possibilità, che si sono date, che possono ripetersi, che possono presentare somiglianze con quel che accade oggi e aiutarci a capirlo. Questo è vero soprattutto nel diritto, il quale è una esperienza in cui ancora oggi i giuristi usano modi di ragionare e principi nati secoli fa mescolandoli con modi nuovi, e nel diritto pubblico in particolare, che si misura coi temi ritornanti dell’autorità, della libertà, di come limitare l’arbitrio, ottenere la giustizia.
Per questo questa parte del nostro studio si intitola ‘le grandi costanti del diritto pubblico’. Noi studieremo le forme di stato e di governo come un repertorio in cui prendiamo conoscenza del modo in cui questi grandi temi si presentano, sono stati affrontati, possono essere affrontati oggi.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
Capitolo I – L’ordine antico
A. Il governo misto e lo stato di giustizia
Affonda le sue radici nel periodo medievale uno dei più grandi ideali del diritto pubblico, il governo misto, che esprime l’aspirazione a un potere limitato e giusto.
Qualche sparsa nozione storica ricorda che nel periodo medievale, all’interno del territorio su cui regnavano re o imperatori non erano sovrani, perché dovevano rispettare, in primo luogo, le autonomie che essi o i loro predecessori avevano ceduto ai feudatari o costituito in capo ad essi (il principio che esprimeva questo vincolo era il pacta sunt servanda = i patti devono essere rispettati, che è una espressione dell’ideale della reciprocità).
Un feudo era un premio, una concessione che l’Imperatore o il Re faceva ai suoi alleati, per ricompensarli dell’aiuto ricevuto e mantenerseli amici. Il contratto feudale, che istituiva il feudo, stabiliva diritti e obblighi reciproci tra il Re/Imperatore concedente, e che chiameremo da ora in poi per comodità, anche se imprecisamente, ‘sovrano’, e il feudatario. Tra questi obblighi svettava quello di essere fedele al sovrano, e di prestare servizio militare gratuito, tra i diritti quello di non pagare le tasse, se non col proprio consenso, ed eccettuate alcune prestazioni finanziarie definite nel contratto feudale; e di poter essere giudicato solo dal Sovrano e davanti ai pari, cioè ad altri feudali della stessa qualità e posizione gerarchica1; intorno a questo nucleo, vi era il corredo di una serie di poteri/doveri del feudatario che includevano in particolare quello di dire la giustizia sui rapporti interni al feudo, e per esempio quelli nascenti da conflitti tra i vassalli del feudatario (quest’ultimo potendo infeudare parti del feudo a suoi sodali); il potere di imporre tasse ai villaggi e contadi rientranti nel feudo, sulle attività produttive o di consumo che in esso si svolgevano o sull’uso di beni strumentali come il frantoio o il forno o le strade; il potere/dovere di fare in modo che si provvedesse a bisogni come manutenzione del selciato stradale, o ai disboscamenti periodici; di potere/dovere di mantenere una propria milizia e, ancora, quello di riscuotere (oltre alle tasse – cui ci siamo riferiti poco sopra - che lo stesso feudatario, imponeva sul feudo) le tasse reali o imperiali, per conto del re o dell’imperatore. Infatti il feudatario non pagava tasse, se non dando il consenso, ma il sovrano o l’imperatore potevano metterne sui contadini, i villaggi e le città, e il feudatario doveva provvedere a che fossero esatte, il che avveniva incaricando gli stessi villaggi e città di farlo con mezzi loro.
Il feudatario esercitava poteri di tipo pubblicistico (normazione, giurisdizione, amministrazione) in base al suo titolo privato contrattuale; e li trasmetteva agli eredi, coi quali si rinnovava ogni volta la concessione feudale. Aveva molta autonomia, all’interno dei patti stabiliti.
Alle autonomie feudali si aggiungevano quelle del clero, il quale possedeva territori a titolo di feudo con poteri analoghi a, o anche maggiori di, quelli dei nobili laici; e alle quali potevano aggiungersene e se ne aggiunsero altre per via l’uso di concedere a gruppi o territori prerogative particolari in cambio di denaro, che permise anche a determinate città di acquistare privilegi che altre non avevano (esenzione da certe tasse, facoltà di istituire dazi, di regolamentare le professioni).
La società era corrispondentemente articolata in ceti, cioè in gruppi sociali distinti e separati, ciascuno portatore di un proprio status (che poteva anche essere segnalato esteriormente 1 Cfr. A. Marongiu, Storia del diritto pubblico. Principi e istituti di governo in Italia dalla metà del IX alla metà del XIX secolo , Istituto editoriale cisalpino, Milano-Varese, 1956, p. 74. La forma feudale trova d’altronde la sua origine nella lunga fase di sfaldamento e crisi dell’impero romano, in cui l’uso di concedere benefici immobiliari ai fidi, ai seguaci, ai protetti e ai protettori corrispondeva al tentativo delle superstiti autorità imperiali, come dei nuovi poteri sorti de facto per effetto delle invasioni ‘barbariche’, di costruirsi una rete di sostegno.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
dall’abito). La ‘divisione della società in ceti’ significa che le persone godevano di diversi diritti e doveri, compresa la capacità di esercitare determinate professioni o rivestire cariche – ad esempio quella di giudice, a seconda del ‘ceto’ nel quale erano nate (nobiltà, clero, ‘terzo stato’, servi) e spesso anche a seconda della loro religione o della loro origine (potendo esistere attività, come ad es. il dare il denaro in prestito, vietate ai cattolici ma permesse agli ebrei e ai musulmani o agli ortodossi). I ‘ceti’ si chiamarono in Francia “Stati”; nel regno di Sicilia si chiamavano Bracci, così in Sardegna con gli aragonesi e poi, a partire dalla dominazione catalana, si chiamarono ‘stamenti’.
Si trattava di un contesto altamente pluralista (dove cioè convivevano gruppi, organi, soggetti dotati di poteri diritti e doveri tra loro differenziati).
Lo “stato di giustizia”
In questo contesto, come raggiungere decisioni, come portarle ad esecuzione?
Vi erano al riguardo alcune regole fondamentali, la più basilare delle quali era che il sovrano poteva stabilire tasse solo col consenso di coloro che le avrebbero pagate, e cioè dei ceti, che erano la nobiltà, il clero e quello che in Francia si chiamò “terzo stato”, cioè i commercianti, gli artigiani, coloro che svolgevano attività produttive e non erano servi2. All’accordo sulla concessione delle tasse al Re erano destinate le riunioni periodiche tra questo e i ceti, queste riunioni si chiamarono Assemblee degli Stati Generali, in Francia, e presero invece in Italia più spesso il nome di ‘Parlamenti’ (ai tempi dei giudicati sardi si chiamavano ‘corone’). I ceti inviavano alle Assemblee i propri rappresentanti, che avevano il cd. ‘mandato imperativo’ cioè dovevano esprimere la posizione che il loro ceto li aveva incaricati di esprimere, senza recederne o modificarla.
L’idea del tempo era che queste assemblee servivano non a deliberare una volontà (per es. del re di imporre tasse) ma ad accertare e dichiarare che una certa richiesta del sovrano (ad es., di imporre una tassa) corrispondeva a un suo diritto, non esorbitava dalle sue prerogative, non ledeva i diritti dei ceti, delle altre parti della società. Se la richiesta del sovrano veniva accolta, ciò non avveniva in nome del principio che a lui spettasse il potere di imporla (né altrimenti avrebbe avuto il bisogno di convocare l’assemblea degli stati), ma perché era stato accertato, giudicato (appunto dalle componenti del Regno riunite col Re), che essa corrispondeva al diritto, non ledeva prerogative di questo o di quello. Generalmente queste riunioni erano una occasione di scambi reciproci: riconoscendo al re il suo diritto di imporre una tassa, i ceti chiedevano in cambio un nuovo privilegio, esenzione o facoltà (aprire un porto, costruire una strada, riparare un edificio: si parlava al riguardo di leges contractae = leggi ‘contrattate’, espressione che sottolinea il principio consensuale che è alla base delle espressioni del potere pubblico d’ordine antico). L’esito di ognuna di queste Assemblee, era ribadire ogni volta la validità e la vigenza del diritto del paese, che era costituito dal reticolato di privilegi e diritti e doveri reciproci stabilitisi tra i ceti e tra questi e il re.
“I parlamenti medievali erano assemblee composte dai rappresentanti delle classi, degli ordini privilegiati riuniti, nel nome e nell’interesse di tali ordini e del paese, per vegliare da un lato al mantenimento dei privilegi degli ordini, delle comunità e dei singoli, così pure alla
2 E’ lo stesso principio (‘No Taxation Without Representation”) che sigla la rivolta delle colonie americane (1775) contro la madre patria inglese, che non accordava alle colonie gli stessi diritti di partecipare alla decisione sulla imposizione fiscale, che avevano le altre articolazioni territoriali del Regno d’Inghilterra. Rimasto emblema di una Rivoluzione che apre il tempo contemporaneo, quel principio, come stiamo vedendo, affondava le radici nelle istituzioni e nei principi della tradizione antica, alla quale il mondo anglosassone, che non ha conosciuto, come l’Europa continentale, la frattura assolutistica, è rimasto sempre più vicino di quanto non sia accaduto per noi.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
conservazione dei diritti fondamentali del paese e, dall’altro, per rendere al principe la contropartita dei diritti e dei privilegi a loro riconosciuti”3.
L’idea da cui le istituzioni del tempo erano permeate era che ogni comando è un giudizio, e che, perciò, potesse avere pretesa di efficacia solo il comando corrispondente al diritto. Il quale diritto risiedeva negli accordi e negli usi e consuetudini sempre osservati che garantivano a ogni componente sociale un certo status e rispetto ai quali era giudicata la validità del comando. Soprattutto, e in essenza, per diritto si intendeva quella condizione in cui a ciascuno è dato il suo, condizione che può non essere pre-stabilita da norme certe e preesistenti, ma va sempre cercata ponderando le ragioni dell’uno e dell’altro, e l’opportunità. Per questo si parla di stato di giustizia.
Quanto al potere è immanente una istanza di garanzia: l’immagine del Re-Giudice
I tempi che stiamo prendendo in considerazione ci dunque riflettere sulla importante connessione tra la giustizia e la pace, alla quale oggi non pensiamo mai perché si dà per scontato che a garantire l’ordine pubblico ci pensa lo stato coi suoi agenti armati, e se il popolo che protesta si porta in piazza armi o mezzi contundenti arrivano i manganelli i gas lacrimogeni e poi la galera (certo, tramite un processo), e tutto sommato l’idea che una parte dell’Italia venga in armi contro un’altra, o seceda, appare remota.
Le cose si presentavano diversamente per un Re medievale che volesse garantire la pace nel suo regno, e, di conseguenza, mantenere il proprio potere, posto che i feudatari avevano castelli, milizie e risorse economiche e posto che essi si ritenevano tenuti a essere fedeli ai patti giurati al Re, nella misura in cui non sembrasse loro che egli li aveva violati. In questo contesto, agire secondo giustizia era il modo di evitare la guerra, rispettare il diritto era la condizione della pace.
Il primo garante del rispetto del diritto era il Re medesimo. Il Medio Evo elabora la concezione del Re-Giudice, che non descrive solo il fatto che il Re era giudice delle liti tra i pari, cioè tra i feudatari, e in genere era riguardato come la fonte di ogni giustizia esercitata nel Regno, o aveva poteri di graziare e comminare le pene, o che alla sua giustizia si poteva sempre fare ricorso. La concezione del Re giudice dice che la funzione del Re era quella di assicurare la pace, il che avveniva garantendo a tutti il rispetto delle loro prerogative, cominciando col rispettarle esso stesso (il re viene perciò definito: fons justitiae, fonte della giustizia; la concezione del re-iudex è quella che ha dato il nome all’esperienza delle giudicature sarde). Il Re è iudex perché i conflitti politici si presentano come conflitti giuridici, come pretese di diritto, e perché o è iudex e riesce a comporre i conflitti, o non è, e deve fare la guerra, il che significa che la sua autorità è stata messa in discussione. Vedere nel re la suprema istanza di giustizia era il modo in cui l’ordine antico rispondeva a un problema che ogni esperienza politica si pone, quello della unità e della stabilità.
Tutto questo non significa che i tempi dello stato di giustizia siano da guardare come un Eden. E’ chiaro che nelle leges contractae potevano annidarsi scambi fondati su mere valutazioni di convenienza, o che in quel meccanismo potessero allignare ricatti reciproci e abusi di varia natura.
Tuttavia è importante soffermarsi su questa esperienza perché ci consegna un modo di pensare e concepire il potere pubblico, più produttore di arbitrati che produttore di decisioni, e dove la funzione di decidere, indirizzare, fare politica è commista a una esigenza di rispetto delle regole.
L’ideale del Governo misto3 A. Marongiu, op. cit., p. 400, con riferimento al parlamento sardo del XVI sec.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
Quando il potere non spetta a uno solo, ma a molti, e il potere di ciascuno è qualcosa che ha peso, ma incontra il contrappeso del potere degli altri si parla di ‘governo misto’ (gli inglesi parlano di check and balances).
La sua formula e la sua rappresentazione è quella del Re in Parlamento, cioè dal Re insieme ai ceti, che chiedendone il consenso sulla imposizione dei tributi ne riafferma i diritti e le prerogative, e riconosce i propri doveri davanti ad essi. (King in Parliament).
Il Governo misto e la compenetrazione tra legislazione e giurisdizione: il potere di interinazione
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
L’espressione ‘governo misto’ descrive precisamente la ‘commistione’ delle funzioni pubbliche, una soluzione ‘organizzativa’ opposta a quella della ‘separazione dei poteri’ che, con l’Illuminismo e la Rivoluzione francese, sarebbe diventata l’ideale dell’epoca contemporanea.
Nello stato di giustizia a governo misto il principio secondo cui è valido il comando che corrisponde al diritto comportava che legislazione amministrazione e giurisdizione erano attività tra loro ‘mescolate’, e concepite prevalentemente in termini giurisdizionalistici.
La commistione tra legislazione e giurisdizione era molto evidente nella sfera fiscale: come ricordato, per imporre una tassa il Re aveva bisogno del consenso dei ceti, e cioè dell’asseveramento che la sua pretesa corrispondeva al diritto. Il re peraltro poteva emanare norme senza bisogno del consenso dei ceti, tutte le volte in cui queste non avessero natura fiscale. Però quest’ultimo tipo di norme, per entrare in vigore, richiedevano l’interinazione, o registrazione, cioè dovevano essere preventivamente controllate da un organo di tipo giudiziario che accertava che esse corrispondessero al diritto.
In Francia, questo organo si chiamava Parlamento. Si trattava di una grande corte giudiziaria che aveva il potere di validare i decreti del re, riconoscendone la conformità al diritto (e in caso contrario poteva cassarli). “Il potere, in altre parole, di esaminare e confermare e rendere esecutivi gli ordini editti privilegi e lettere del sovrano, dopo averne riconosciuto la corrispondenza al diritto” (Marongiu, p. 243).
I componenti dei Parlamenti erano un ceto privilegiato, potente, ereditario, e fortemente legittimato dal fatto di istituirsi, davanti al Sovrano, come garante dei diritti antichi, delle regole della comunità. La giurisdizione che essi esercitavano era considerata, e considerava se stessa, garante dei ‘diritti della terra’ delle cose come erano sempre state, del rispetto dei diritti acquisiti, dei privilegi feudali così come delle consuetudini locali.
Il potere di interinazione ci fa capire come la giurisdizione costituisse un potere sociale grandissimo e un limite effettivo alle possibilità dei sovrani di espandere i propri poteri. Nel XVI secolo nello Stato sabaudo il potere di interinazione era esercitato da un organo chiamato Senato, nel Regno di Sicilia dalla Reale Udienza.
Il Governo misto e la compenetrazione tra amministrazione e giurisdizione: l’amministrazione in forma giustiziale.
In forma giurisdizionale venivano prese anche quelle che oggi chiameremmo provvedimenti e regolamenti amministrativi. Nello stato territoriale per ceti non esiste una struttura amministrativa deputata a portare a esecuzione le deliberazioni delle assemblee, o a curare i pubblici interessi, né le attività di questo genere sono rette da un diritto particolare (quale è oggi il diritto amministrativo, che costituisce un diritto particolare nel senso di diverso da quello che si applica nei rapporti tra privati). Una volta concordata una tassa che i villaggi dovevano pagare, erano anche essi stessi che provvedevano alla esazione, alla ripartizione della tassa tra coloro che dovevano pagarla e alla riscossione del tributo. In Francia, per esempio, vi era l’uso di estrarre a sorte un membro della comunità, dandogli l’ingrato compito di ‘collettore’ delle tasse che il villaggio doveva versare. Molti dei bisogni cui oggi provvede un apparato pubblico erano soddisfatti da singoli o da collettività a titolo di doveri che derivavano dal loro status. Così, per esempio, mantenere la strada sgombra era considerato un dovere dei proprietari frontalieri mentre costruire le strade era la terribile corvée (prestazione), imposta ai contadini dalla loro condizione servile. Gli studiosi parlano a questo riguardo di ‘autoamministrazione’, nel senso che la società, ovvero ogni gruppo sociale o comunità, provvedeva direttamente allo svolgimento delle attività di
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
cura degli interessi e bisogni generali (mentre oggi siamo abituati a che esistano strutture pubbliche che a quegli interessi provvedono e si parla di eteroamministrazione).
Se ogni prestazione, cui qualcuno, singolo o gruppo, dovesse adempiere (e che non fosse un servo della gleba), doveva nascere da un obbligo di diritto che incombeva su di lui, per il suo status, si capisce che potevano sorgere molte controversie sulla esistenza o meno, e sulla precisa estensione, di quell’obbligo. Nasceva da qui la compenetrazione tra giurisdizione e amministrazione.
“In una società pluralista, che vedeva nel potere pubblico non un produttore di utilità ma un produttore di arbitrati, era ovvio che anche l’attività diretta a soddisfare interessi collettivi assumesse natura contenziosa. L’arginatura di un fiume, risolvendosi essenzialmente, dal punto di vista statale, nel determinare la giusta quota di spese da accollare a ogni famiglia, o corpo civico, che ne avesse tratto vantaggio, era strutturalmente una operazione di tipo giustiziale, la quale non poteva avvenire senza dare a ogni gravato la possibilità di difendersi nei confronti dei propri vicini troppo favoriti. L’ampliamento di una strada, essendo a carico delle comunità circonvicine, non poteva prescindere da un fondamentale momento processuale qualora qualcuna di esse non fosse consenziente. E così pure la confezione di un catasto fondiario, consistente nel ripartire equamente certi oneri di utilità comune tra i vari gruppi cetuali insediati su un determinato territorio, si calava per forza in una cornice di carattere giudiziario, che sola poteva consentire a ognuno di essi una adeguata tutela della sua posizione rispetto a quella degli altri contribuenti. Dato insomma che ogni attività di amministrazione consisteva nella distribuzione di certi sacrifici e vantaggi tra i contribuenti, essa andava sempre a sfociare nella risoluzione di un qualche conflitto orizzontale di interessi. […] La conclusione che ne possiamo trarre, è che nel mondo concettuale dello stato premoderno non esisteva alcunché di simile al diritto amministrativo contemporaneo. In quel mondo si amministrava, certo, ma lo si faceva secondo logiche che prescindevano del tutto dalla costruzione di un diritto specifico e unitario destinato a regolare l’azione amministrativa.”4
In molti casi, i giudici erano chiamati a dirimere una controversia che aveva per contenuto un obbligo di fare, di provvedere a qualcosa (per esempio al disboscamento di una certa area), e che verteva su chi fosse obbligato a provvedervi, con quali tempi, per quali quantitativi. Nel momento in cui risolvevano controversie di questa natura i giudici riformulavano il contenuto dell’obbligo intorno al quale si disputava e facevano valutazioni (di opportunità, relative al modo migliore di soddisfare un certo interesse o di raggiungere un certo obiettivo) che oggi sono tipiche degli amministratori. Le loro sentenze in questi casi equivalevano a ordinanze o regolamenti, cioè contenevano norme che valevano per tutto un territorio, per molti soggetti.
“Tutto ciò non significa assolutamente che ogni qual volta vi fosse da realizzare un interesse collettivo o fiscale a scapito di qualche suddito il magistrato premoderno cominciasse davvero a istituire un processo in piena regola, citando formalmente i potenziali danneggiati, ammettendoli a dedurre e controdedurre a loro piacere e magari rinviasse l’esecuzione del provvedimento al momento in cui fossero stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione. Non solo nessuna amministrazione potrebbe o avrebbe potuto essere ragionevolmente condotta secondo forme del genere, ma la stessa ideologia legalistica ora evocata non aveva la benché minima coloritura ‘garantistica’ in senso moderno. Essa non mirava affatto ad attuare una qualche difesa dei diritti ‘individuali’ (cioè di tutti e di ciascuno). Gli unici diritti percepiti come tali erano allora soltanto quelli storicamente acquisiti, ‘quesiti’, cioè le varie libertà status e privilegi di cui specifici soggetti godevano per nascita o a seguito di specifici atti di acquisto. Per tutelare questa sfera di posizioni soggettive, estremamente circoscritte e riconoscibili, non era per nulla necessario adottare un modus operandi particolarmente riguardoso nei confronti della generalità dei governati. Bastava che la porta della giustizia rimanesse sempre aperta per chi apparteneva a gruppi o a istituzioni qualificate. Ben coscienti di ciò, gli apparati di antico regime adottavano nel quotidiano mezzi estremamente spicci per conseguire le finalità che loro stavano a cuore, ricorrendo comunemente a quelli che allora si chiamavano precetti ‘ex abrupto’, e che nient’altro erano se non semplici ordini di fare, dare o pagare, emanati d’ufficio e che erano considerati legittimi purché fosse sempre possibile, per il controinteressato, attivare un giudizio contro di essi”. 5
Da un lato, dunque, la tassa, che il re aveva visto riconosciuto il suo diritto di esigere dall’Assemblea dei ceti, se poi veniva contestata da un singolo feudatario, da una abbazia o da una
4 L. Mannori e B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, cit., p. 70-71.
5 Cfr. L. Mannori e B. Sordi, op. cit., spec. 65 ss.:.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
città, poteva essere esatta solo, e nei termini in cui, in un giudizio, fosse stato ritenuto ‘giusto’ che ciò fosse.
Dall’altro lato, il giudice adottava provvedimenti e regolamenti di tipo amministrativo, coi poteva porre nel nulla o riformulare le decisioni e i provvedimenti adottati dagli agenti del sovrano incaricati di esigere un credito, o di imporre l’esecuzione di un’opera. E’ questo fenomeno ciò che viene descritto come ‘amministrazione in forma giustiziale’ e che esprime la compenetrazione tra giurisdizione e amministrazione nell’ordine antico, e ci riconduce all’idea del comando come giudizio (il potere può imporre a qualcuno di fare/dare qualcosa se ne ha diritto).
Governo misto, pluralismo giuridico, dismorfismo territoriale
La forma di stato (territoriale per ceti) e la forma di governo (il governo misto) erano manifestazioni del pluralismo giuridico da cui l’ordine antico era costituito: l’istanza giustiziale che lo pervade e che è tradotta dalla formula ‘stato di giustizia’ nasce dalla struttura composita, plurale e variegata dei poteri che vi coesistevano e che garantivano l’un l’altro le proprie autonomie.
Nell’ordine antico, per effetto della struttura cetuale della società, che assegnava diversi ‘corpi’ sociali regole, privilegi, doveri e diritti diversi, conviveva infatti una pluralità di ordinamenti, vale a dire di sistemi di regole inerenti a collettività insediate su territori, ciascuna appartenente a un genere ma dotata anche di proprie specificità (il feudo e i singoli feudi, i vari domini ecclesiastici, i diversi ordinamenti cittadini, le comunità di villaggio, il ceto dei mercanti, o degli artigiani, secondo lo statuto delle singole attività). Questo si traduceva in un caratteristico dismorfismo territoriale: ancorché suddiviso in articolazioni (marche, comitati, province) lo stato territoriale per ceti ne conosceva una estrema varietà; ai vari livelli territoriali si riproduceva però la forma mista di decisione, con rappresentanti, vicari, delegati del re che ricercavano, al bisogno il consenso dei ceti nei territori, secondo le loro prerogative, e autonomie, e in base ai riti e alle forme tradizionalmente prescritti.
Diritto pubblico e diritto privato nell’ordine antico
Manifestazione del pluralismo giuridico era anche la pluralità di giurisdizioni, cui accenneremo tra breve, e la pluralità di fonti del diritto, cioè degli atti o fatti contenenti prescrizioni e regole (contratti feudali, privilegi e capitolati e statuti cittadini, consuetudini, ordini e rescritti reali o signorili, ecc.), nessuna delle quali era riconducibile a una autorità sovrana, nessuna delle quali, in altri termini, poteva vedersi automaticamente riconosciuta la preminenza su altre perché proveniva da una autorità centrale o sovrana superiore a tutte le altre.
Gli atti e fatti che manifestavano prerogative nascenti da autonomie di ceto o territoriali (norme che fissano tasse, che obbligano a comportamenti di dare o di fare, compresi, in particolare, i delitti e le pene) costituivano quello che oggi chiameremmo il diritto pubblico; mentre il diritto privato (che riguarda i contratti e negozi giuridici di natura economica, le responsabilità e le obbligazioni che ne nascono, i modi in cui dovevano essere adempiuti) non era quasi mai oggetto di norme pubbliche. Su contratti e altri negozi giuridici di natura patrimoniale, che intercorrevano non dettavano norme i sovrani, o i parlamenti, le autorità pubbliche (cosa che invece è oggi normale e ricorrente, tant’è che i ‘contratti’ sono regolati nel codice, e in altre leggi): esso si formava, invece, nella giurisprudenza, cioè spontaneamente tramite le risposte che alle concrete controversie davano i giuristi, avvalendosi anche, se non specialmente, dei principi e delle regole che traevano dall’antico
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
diritto romano, o dai precedenti annotati nei libri, con una serie di implicazioni che ora approfondiremo.
I.B. Giustizia, eguaglianza, liberta’ nell’ordine antico: le radici della cultura giuridica europea.
L a giurisdizione nell’ordine antico
I soggetti davanti ai quali si andava per dirimere le controversie sui diritti e sui doveri, dalle quali dipendeva la pace interna, così come la stabilità dei rapporti economici, l’esigibilità dei crediti e quella dei tributi: i giudici, erano dunque un potere di importanza cardinale nell’assetto medievale e premoderno, nel quale tutte le manifestazioni del potere prendevano forma giustiziale.
Vediamo dunque un poco più da vicino come era fatta e come funzionava la giurisdizione nell’ordine antico.
Vi era intanto una pluralità di giudici e di giurisdizioni (cioè di ambiti in cui un giudice può dire giustizia). Alcune giurisdizioni inerivano ai poteri politici sui territori: giurisdizione imperiale o reale, feudale, ecclesiastica, cittadina o municipale, e corrispondevano al diverso spettro di poteri e di competenze assegnate ai diversi corpi politici. Alcune cariche di giudice, quelle inerenti alle prerogative feudali, erano ereditarie (e, in un secondo tempo, poterono essere acquistate e vendute, benché solo agli appartenenti al ceto nobiliare) e i giudici che le detenevano costituivano un ceto distinto. I giudici che erano tali per diritto ereditario o per ceto avevano un ruolo eminente nei rapporti di diritto pubblico (controversie cui inerissero prerogative di ceto). Per risolvere controversie nascenti da scambi contrattuali, di tipo cioè privatistico, tra mercanti, come pure per decidere sulle impugnative contro propri ordini e rescritti, le città assumevano giudici professionali, temporanei, retribuiti e responsabili per l’eventualità di cattivo adempimento dei propri compiti. Il potere di iuris-dictio era dunque attribuito a una pluralità di soggetti e con riferimento a una pluralità di ambiti (giurisdizione feudale, signorile, imperiale, papale, ecclesiastica, cittadina) che potevano sovrapporsi e incrociarsi e non si escludevano l’un l’altro. Infatti, a causa della coesistenza su un medesimo territorio di una pluralità di soggetti politici (feudo, città, abbazia, impero, chiesa) nessuna giurisdizione era esclusiva; invece, coesisteva con altre (per esempio, nel sistema feudale, ogni signore feudale era giudice dei rapporti giuridici interni al proprio feudo, ma era il re feudale giudice delle controversie tra i feudatari; mentre se una controversia coinvolgeva possedimenti o prerogative della chiesa entrava in gioco una diversa giurisdizione, quella ecclesiastica).
Il giudice come portatore di un sapere professionale
Come poco sopra ricordato, nell’ordine antico si poteva essere giudice: (a) a titolo di esperto indipendente, chiamato dalle parti a decidere una controversia, o come titolare di un incarico a termine conferito dal governo di una città; o (b) per prerogativa di ceto, in quanto si era ricevuta dall’imperatore o dal re, acquistata o eredita la giurisdizione su un certo territorio o ambito . Nel primo caso il giudice era un professionista, pagato per le sue prestazioni, e sottoposto a responsabilità se operava male, nel secondo la carica di iudex era ereditaria, ma poteva essere venduta, il che fu alla radice dello sviluppo di un ceto di giudici dotato di grandi privilegi, influenza e ricchezze nonché di un fortissimo spirito di corpo (nobiltà di toga).
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
In entrambi i casi, il giudice era considerato il portatore di un sapere professionale.
Nella mentalità dell’ordine antico, il giureconsulto assomigliava molto a quello che per noi oggi è un medico. Un medico conosce la sua scienza, ti dice che malattia hai, come la si cura; egli sa queste cose per effetto di un sapere che nel tempo si è accumulato, è stato convalidato da esperimenti, da prove, dal confronto di ipotesi, e di tante esperienze diverse; si tratta, anche, di un sapere che non è condizionato dai confini nazionali dello stato in cui opera, è invece cosmopolita cioè tendenzialmente uguale in tutto il mondo, per lo meno in tutto il mondo che condivide una certa storia, certe pratiche e certe mentalità. Noi troveremmo strano che un medico dovesse stabilire se io ho l’influenza o il morbillo sulla base di una regola che non sia nata dal sapere stesso della medicina; e troveremmo anche strano che un medico italiano considerasse “influenza” una cosa che per un medico francese è “morbillo”. Analogamente, nell’ordine antico, si considerava l’attività dei giudici e degli esperti di diritto. Ancora nel maturo Cinquecento Nicolò Machiavelli poteva dir che
“Le leggi civili non sono altro che sentenze date dagli antichi giureconsulti, le quali ridotte in ordine, ai presenti nostri giureconsulti giudicare insegnano: né ancora la medicina è altro che la esperienza fatta da li antichi medici, sopra la quale formano, i medici presenti , il giudizio” (dai “Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio”).
Per noi il giudice è un funzionario dello stato al quale ci si rivolge quando ci serve il servizio “giustizia”. Questo presuppone l’esistenza di un apparato sovrano, lo stato, che ha avocato a sé la sovranità e ha stabilito che la giurisdizione è una funzione del sovrano; i giudici sono, in questo contesto, funzionari pubblici, burocrati che applicano leggi stabilite da altri. Nei termini in cui lo pensava il Medioevo, invece, e in cui continuò a pensarlo anche l’età moderna, il giudice è un esperto portatore di un sapere accumulatosi autonomamente e che lo pone in grado di interpretare e applicare consuetudini locali, statuti e decreti emanati dalle varie autorità pubbliche, contratti e donazioni; di integrarne le lacune; di mitigarne gli eventuali abusi.
Questo sapere era dato, principalmente, dalla conoscenza del diritto romano antico e delle sue successive applicazioni a casi nuovi (diritto comune), e dalla conoscenza di un certo modo di ragionare e di argomentare i problemi, cioè dall’uso di una certa logica (logica dialettica).
L’ordine antico come età del diritto comune: le origini romanistiche del diritto europeo continentale
In età medievale era ancora considerato fondamentale fonte di diritto il diritto romano, raccolto e consolidato da Giustiniano nel Corpus Iuris.
In epoca imperiale, tra il 528 e il 565 dopo Cristo, l’imperatore Giustiniano, impegnato in una radicale riforma, emanò infatti alcuni “decreti”, atti che noi chiameremmo “leggi” (emanazioni della volontà di una autorità centrale) che, di fronte al disfacimento di fatto dell’Impero, tentarono di riaffermare l’autorità dell’imperatore e di ridefinire la struttura e il funzionamento della “macchina” imperiale. Questi decreti, appunto per il loro carattere fondamentale e innovativo, furono detti Constitutiones. Una di queste Constitutiones conteneva i Digesta o Pandette, 50 libri estratti dalle opere di circa 40 giuristi dal I secolo avanti cristo agli inizi del IV secolo dopo Cristo. Le Pandette furono composte per incarico di Giustiniano stesso. Un’altra della Costituzioni giustinianee conteneva invece l’antico manuale di Gaio, le Institutiones. Insieme, queste due costituzioni giustinianee costituirono quello che attraverso i secoli successivi venne conosciuto come il “Corpus Iuris” (il “corpo del diritto”, letteralmente, nel senso de “la materia giuridica” o “il diritto” in generale).
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
Emanandoli come proprie “costituzioni”, Giustiniano intendeva dare forza e valore di legge a un manuale, il manuale di Gaio, e una raccolta di decisioni, sentenze e opinioni di giureconsulti. Fino ad allora, il manuale di Gaio, come le decisioni sentenze e opinioni dei giureconsulti del passato, erano stati tenuti presenti dai giureconsulti spontaneamente, perché essi raccoglievano ed esponevano il sapere tradizionale a cui i giuristi facevano riferimento. I giuristi non erano tenuti a prendere la stessa decisione che Gaio o un altro giurista portava ad esempio, essi potevano sempre adottare una soluzione diversa se le circostanze del caso ben ponderate lo richiedevano. Ora, una volta diventati “legge” perché fatti diventare contenuto di un decreto imperiale, il manuale e le decisioni, sentenze e opinioni dei giureconsulti del passato dovevano essere “applicati” dai giudici “per ordine dell’imperatore”. Giustiniano corredò il Corpus Iuris con una norma che addirittura vietava che le regole raccolte nelle Pandette e nelle Institutiones fossero “interpretate”, stabilendo che esse erano la volontà dell’imperatore e dovevano essere applicate così come erano. Prendeva forma una tendenza che ritroveremo in epoca statale: quella di considerare il diritto un insieme di regole dettate dall’alto che i giudici devono solo applicare e non interpretare (perché l’interpretazione rischia di modificare la volontà autentica del potere che le ha dettate).
Giustiniano emanò il Corpus Iuris come una legge dell’Impero romano; ma poi l’Impero romano si sfaldò, e il Corpus Iuris invece rimase, e continuò ad avere vigore, non come legge stabilita da una autorità effettivamente vigente, ma come fondamento autorevole della sapienza dei giuristi.
Il diritto comune
Dopo il crollo dell’impero romano, dunque, il Corpus Iuris rimase, ma non rimase più in piedi, se non formalmente, l’apparato politico e di governo, l’insieme di funzionari e di apparati, tramite il quale esso si proponeva di operare, di venire applicato. Ma nonostante il Corpus Iuris abbia cessato nel tempo di essere l’espressione di un potere politico vigente ed effettivo, esso continuò ad essere guardato dai giuristi come il punto di riferimento essenziale del loro lavoro. Del resto era vero che il Corpus Iuris non era più l’atto di un potere vigente – per lo meno non più su tutti i territori per i quali originariamente era stato adottato -, era anche vero che non esisteva nemmeno alcun potere grado di “abrogarlo” formalmente. I giuristi continuarono così a cercare nel Corpus Iuris ispirazione per le proprie decisioni, a indicarlo come “fonte” delle proprie valutazioni. Può essere curioso ricordare che la possibilità dei giuristi di appellarsi al Corpus Iuris per fondare la validità delle proprie decisioni è rimasta operante in Europa fino alle soglie dell’800 e oltre: in Italia, l’ultima parte del nostro paese a stabilire che il Corpus Iuris non poteva più essere utilizzato fu, al momento dell’unificazione, il Granducato di Toscana e altrettanto lunga validità ebbe il Corpus Iuris in Germania. E può essere interessante ricordare che la più essenziale differenza che intercorre tra il diritto continentale europeo (civil law) e il diritto anglosassone (common law) non è tanto quella, comunemente ricordata, per cui solo nel secondo il precedente giudiziario è fonte del diritto (cosa che si può dire in una certa misura anche per la nostra giurisprudenza) ma è quella dovuta al fatto che la giurisprudenza inglese si è sviluppata, a partire dal Medio Evo, senza fare più riferimento all’antico romano, e tanto meno ai concetti e agli istituti con cui i giuristi continentali lo aggiornavano e modificavano, ma in modo autonomo rispetto ad esso, che peraltro conservò sempre invece moltissima importanza in Scozia.
I giuristi medievali continuavano dunque ad applicare le antiche figure del diritto romano, come il mutuo o la locazione (che, del resto, sono contratti che ancora oggi esistono), studiavano i libri degli antichi romani, e poi si mettevano nello stesso atteggiamento del giureconsulto romano quando si trattava di risolvere un caso che ancora non si era mai presentato: si chiedevano quale poteva essere la soluzione più equa del conflitto di interessi a loro sottoposto.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
Spesso, erano costretti a discostarsi dalla soluzione modello che trovavano nel Corpus Iuris, perché dovevano confrontarsi con realtà molto cambiate, con le nuove esigenze della vita e dei commerci, l’assetto politico tutto modificato rispetto a quello d’epoca romana. Ma proprio questo era il modo in cui essi sapevano che, a loro volta, i grandi giuristi romani avevano lavorato: alla ricerca della continuità nel cambiamento. Così si sviluppò una modalità di lavoro estremamente importante, che consisteva nella redazione delle Glosse al Corpus Iuris. Cioè le modifiche, aggiustamenti, deroghe e aggiunte che i giuristi importanti dell’epoca sentivano nella loro pratica di dover portare alle singole parti del Corpus Iuris, venivano scritte in calce a quest’ultimo, in forma di commenti (Glosse). “La scuola di Bologna”, intorno alla quale nacque l’Università di Bologna, la più antica università europea, era appunto un gruppo di giuristi “glossatori”, esperti nell’aggiornare (nel segno della continuità) il Corpus Iuris alle esigenze del presente.
Nella tradizione europea, con limitazioni solo per l’Inghilterra, la ‘scientia iuris’ si è fatta consistere per lunghissimo tempo essenzialmente nella conoscenza del Corpus Iuris. I giuristi prima bolognesi, poi di ogni altra parte d’Italia, vi hanno avuto un ruolo di primo piano, a cominciare dalla materiale diffusione del testo e con una intensa esportazione di cultura e di uomini: un ruolo che si è svolto per secoli.
Cominciarono i glossatori del XII-XIII secolo, e i Commentatori del XIII-XV, in gran parte italiani, seguiti da quei grandi giuristi nostrani che nel XVI secolo dettarono le basi del diritto commerciale, del diritto penale, del diritto internazionale e di altre branche del sapere giuridico: analisti assidui, attenti, acuti della realtà e del mondo nuovo che si veniva determinando, componendo, svolgendo sotto i loro occhi, e di cui seppero essere interpreti sensibili e sagaci.
La circolazione del loro pensiero andava da un capo all’altro dell’Europa, agevolata dall’uso del latino e nonostante il turbinio delle vicende politiche, militari, religiose.
Il diritto di cui si avvalevano i giuristi medievali era un complesso di principi e regole dedotto dalla tradizione e dalla esperienza. La formazione e le mentalità del giurista erano perciò cosmopolite: un giureconsulto di Bologna e uno di Digione avrebbe risposto allo stesso modo, o in un modo molto simile, ad una data controversia che gli si fosse presentata, nonostante che Bologna e Digione facessero parte due ordinamenti distinti e magari occasionalmente anche nemici.
Il diritto privato nasceva e si sviluppava in un modo che con termini contemporanei potremmo definire come sopranazionale, era in ampia parte indipendente dall’assetto politico del territorio (carattere che viene descritto come extrastatualità), ed ecco anche perché un giovane poteva prendere e partire da Brema o da Anversa per venire a studiare il diritto da un giureconsulto senese o fiorentino, con l’idea di tornare a fare il giureconsulto a Brema o ad Anversa: perché il sapere e le pratiche che apprendeva erano il diritto, non le leggi di Brema o di Anversa. Non casualmente, ogni esperienza assolutistica, e con essa la nascita dello Stato, interessato a mantenere al proprio interno il suo solo diritto, e a pretendersene autore, ha coinciso, invece, con la chiusura delle Università agli stranieri, e col divieto per i cittadini di studiare in università straniere, non si trattasse altro che di andare da Napoli a Firenze.
Nel mondo politicamente frammentato del Medioevo, il diritto costituiva invece una “unità ideale”, un “sapere comune”, dotato di coerenza interna ma anche di una grande flessibilità e adattabilità, intimamente e naturalmente cosmopolita, centro di una unità culturale europea dinamica e creativa. Nello sviluppo di questo sapere, accanto ai Glossatori e commentatori italiani, cominciarono col tempo ad assumere un ruolo di spicco grandi scuole giuridiche radicate
Riccardo Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 41.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
altrove, in Francia, Spagna, Portogallo, nei Paesi Bassi, nei paesi di lingua tedesca , in Danimarca, Boemia, nei paesi scandinavi, in Polonia.
E’ quello che si chiama “diritto comune europeo”: il diritto applicato in quasi tutta l’Europa continentale nel medio evo e nell’età moderna e creato dai giuristi sulla base del diritto romano.
Da un certo momento e per lungo tempo una gran parte del diritto praticato in Europa ha avuto come base o punto di riferimento il Corpus Iuris e in tale diritto molte genti europee si sono riconosciute in larga misure come partecipi di una tradizione più o meno ad esse non estranea, ma – appunto - comune
Problemi di riconoscimento del diritto o di individuazione della fonte applicabile
Un nobile scrive un testamento in cui lascia tutti i suoi beni al cane, gli eredi impugnano il testamento e vanno davanti al giudice che ispirandosi al diritto romano per cui l’erede deve essere un essere umano nega validità al testamento. Il nobile si appella al re, che per favorirlo cerca di introdurre una regola per cui un nobile può adottare il suo cane da caccia e renderlo erede. Il parlamento chiamato a dare l’interinazione conosce a memoria il Corpus Iuris e ne trae la massima per cui l’adozione può intercorrere solo nei confronti di chi potrebbe avere generato l’adottato e dice compattamente di non vedere ragione per deviare dalla regola antica. Infatti, per esempio, la nuova regola potrebbe nuocere alle aspettative legittime di tanti eredi, che rischierebbero di vedersi diseredati a favore dei cani; i cani, poi, non sanno amministrare, e le proprietà ad essi affidate andrebbero in rovina, con nocumento generale. D’altra parte, se un nobile morente volesse assicurarsi che il suo cane venga trattato bene dopo la sua morte, può istituire in capo agli eredi un ‘legato’ che li obbliga a mantenerlo e curarlo vita natural durante, e in tal senso può essere interpretata la clausola redatta dal testatore ormai defunto.
La regola generale nuova che il re vorrebbe introdurre non passa, il testamento a favore del cane viene interpretato come recante un legato che obbliga gli eredi a mantenere il cane.
Questo esempio di fantasia ci mostra una controversia privatistica che diventa controversia pubblicistica, e si traduce in conflitto tra fonti del diritto diverse (la regula iuris risalente al diritto romano, la volontà del re) e tra diversi poteri (i giudici, il sovrano).
Il diritto antico, tramandato come sapere comune dei giudici, è fonte del diritto ma anche la regola posta dal sovrano, dal governante aspira ad esserlo. La regola antica è considerata valida perché vi si riconosce ancora un fondamento di ragione che la rende migliore dell’altra e perché alla regola dettata dal re non è assegnata, in quanto tale e qualunque cosa stabilisca, una ‘forza’ prevalente su altre fonti del diritto.
Ancora oggi quando si discute a proposito dell’adozione da parte di coppie omosessuali viene chiamato in causa il criterio della imitatio naturae; tuttavia non più come regola di diritto vigente, ma, al più, come massima orientativa, consiglio della tradizione.
Il diritto come scienza dell’argomentazione: la logica del probabile e del ragionevole
L’altro tratto che caratterizzava il giurista medievale e moderno era il suo modo di ragionare, il tipo di “logica” di cui era portatore.
Riccardo Orestano, citato sopra.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
Era rarissimo il caso che il ragionamento giuridico potesse condurre a una conclusione vincolante come nelle dimostrazioni matematiche. Le ragioni avanzate miravano piuttosto a mettere l’avversario, come nei dialoghi platonici, in una situazione difficile, a mostrare l’irrilevanza o l’arbitrarietà o l’inopportunità degli argomenti impiegati, l’ingiustizia o l’irragionevolezza della soluzione proposta.
La convinzione circa l’esistenza di una “logica giuridica”, cioè di un modo di ragionare proprio del giurista, e legato alla particolare natura dei problemi che affronta, e l’abitudine a praticarla, affondavano a sua volta le radici nell’antichità classica e precisamente nel pensiero di Aristotele. Il filosofo greco ha descritto la logica giuridica come una logica dialettica, fondata sul “tener conto” delle varie ragioni in relazione a un problema concreto, una logica che non serve a trovare ciò che è vero in assoluto ma ciò che è verosimile e probabile, dunque anche equo e ragionevole, tenuto conto delle circostanze note, della credibilità di chi riferisce i fatti, dell’autorevolezza delle opinioni espresse da giuristi del passato su casi simili.
La logica dialettica, logica del verosimile e del probabile, coesiste nel diritto con la “logica dimostrativa”, che si basa sulla esistenza di premesse che possono essere considerate vere sempre in tutti i casi luoghi e circostanze e che procede così: data la premessa “x” universalmente valida, in questo singolo caso è necessariamente vera, valida, doverosa la conseguenza “y” e solo quella. Ad es.: se tutti i nati da donna sono esseri umani (premessa universale), l’affermazione che ogni nato da donna è un essere umano è una affermazione “vera”6. La logica dimostrativa è una logica che serve a controllare la coerenza interna di un ragionamento, e cioè a costruire ragionamenti dove ogni conseguenza è “logicamente” appunto, fondata sulla premessa precedente e convalidata da essa, il che garantisce che si arrivi ad affermazioni “vere”7. E’ la logica “per non sbagliare”, propria del ragionamento matematico e delle scienze naturaliste; il nostro tempo (dopo Cartesio) tende a pensare che essa sia anche l’unica logica possibile, Aristotele, invece, insegnava che la logica dimostrativa si può usare solo in certi campi (dove premesse universali possono essere trovate), ma che esistono campi della vita e dell’esperienza dove premesse “universali” non ci sono. I campi in cui premesse universali non esistono sono tutti quelli che attengono alla società e ai suoi problemi, e, in fondo, alla natura umana. Per i campi dell’esperienza e del sapere in cui premesse universali non si danno, è normale, giusto e necessario, adottare una logica diversa da quella dimostrativa e più adatta alla mutevolezza, alla concretezza, delle cose umane.
Al diritto, così, ineriva una idea di ragione, un tipo di logica, un modo di rapportarsi ai problemi, per cui diritto tendeva a corrispondere a “ciò che non è arbitrio”, che non è, cioè, irrazionale, immotivato, implausibile, ed a questo ordine di idee rimane prossimo il senso comune che distingue il diritto dalla forza.
6 Anche se, laddove l’espressione ‘essere umano’ sia resa, come avviene in molte lingue e spesso nel linguaggio corrente, con il termine ‘uomo’, questo ragionamento, a tutta prima apparentemente molto razionale, può condurre a conseguenze ben bizzarre, e cioè che tutte le donne sono uomini, o che tutti i nati da donna sono uomini. Inoltre, il fatto di sapere che tutti i nati da donna sono esseri umani ci dice ben poco circa di essi (sono bambini? Vecchi? Sono in salute, sono malati?). La logica astratta conduce di solito anche a conseguenze astratte, che, come tali, presentano una adeguatezza molto scarsa alle situazioni concrete e possono risultare perciò sbagliate, ossia ingiuste, rispetto a queste ultime. Questo spiega come mai,molto spesso e molto a lungo i giuristi, che pensano in concreto, hanno preso le distanze da quel tipo di logica.
7 Affermazioni ‘vere’ ma, spesso, fortemente autoreferenziali, cioè vere solo rispetto alle premesse adottate, e che non tengono conto di come, nella concretezza delle cose, certe premesse coesistono inevitabilmente con altre. Per esempio, in linea astratta è vero che ridurre i bilanci degli enti locali comporta una riduzione della spesa pubblica, ma siccome può comportare un aumento di bisogni sociali insoddisfatti, è anche ben possibile che l’effetto di risparmio che si attende dalla misura non si produca affatto. Non a caso la logica astratta è spesso detta ‘pura’ per intendere che non è impregnata da tutta una serie di questioni che le impedirebbero di arrivare alle sue conclusioni, e che perciò essa di fatto esclude, non considerandole rilevanti e cioè non considerandole affatto. Invece un uso giuridico della ragione, cioè quello tipicamente esemplato nella logica dialettica, impone la considerazione di tutte le circostanze rilevanti.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
Era un modo di ragionare che rifletteva le concezioni del potere dell'epoca: potere limitato e a cui inerisce la compresenza con altri poteri, interessi, valori. Era, anche, un modo di ragionare che imprimeva alla vita pubblica una particolare intonazione ‘giurisdizionalistica’. Nella Francia pre-moderna, secondo Alexis de Tocqueville:
Le consuetudini giudiziarie erano diventate su molti punti consuetudini nazionali. In genere si era presa dai tribunali l’idea che ogni questione può essere discussa, e che per ogni decisione ci si può appellare. Si era preso l’uso della pubblicità e l’amore per le forme, cose nemiche della servitù”.
Ancora oggi il pensiero giuridico viene considerato da molti come un tipo particolare di pensiero, un pensiero possibilista, cioè aperto alla costruzione di soluzioni diverse, purché plausibili e eque, dei problemi della convivenza (Peter Haeberle).
L’abuso, cioè l’uso distorto della logica dialettica è il sofisma, l’arzigogolo, il discorso capzioso. Un celebre esempio ci viene offerto dalla storia raccontata nel Mercante di Venezia di Shakespeare. Antonio ottiene un prestito dal mercante ebreo Shylock, impegnandosi a restituire, se non sarà in grado a una certa data di restituire i soldi, una libbra della sua carne. Antonio non può pagare, Shylok pretende l’adempimento del contratto. Portia, innamorata di Antonio, travestita da avvocato dimostra che Shilok può pretendere una libbra di carne, ma deve ottenerla senza versare una goccia del sangue di Antonio, perché il contratto dice ‘carne’ e non menziona il sangue.
PORTIA
Una libbra della carne di quel mercante è tua,
la corte l’aggiudica, e la legge rassegna.
SHYLOCK
Giustissimo giudice!
PORTIA
E tu devi tagliare questa carne dal suo petto,
la legge lo concede, e la corte l’aggiudica.
SHYLOCK
Dottissimo giudice! Che sentenza! Vieni, preparati!
PORTIA
Aspetta un momento, c’è qualcos’altro:
questa obbligazione non ti concede neanche una goccia di sangue;
le parole dicono espressamente «una libbra di carne».
Prendi dunque la tua penale, prendi la tua libbra di carne,
ma se, nel tagliarla, versi una goccia
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
di sangue cristiano, le tue terre e i tuoi averi
sono, per le leggi di Venezia, confiscati
dallo stato di Venezia.
Sconfitto, deriso, umiliato, Shylock pronuncia un discorso che resta come il monito circa le conseguenze di ogni abuso, specialmente quelli compiuti in nome del diritto: “La cattiveria che tu mi insegni io la metterò in pratica; e sarà duro ma eseguirò meglio le vostre istruzioni”.
L’eguaglianza nell’ordine antico. L’eguaglianza come criterio della valutazione giuridica. La connessione tra eguaglianza e giustizia. L’eguale in senso qualitativo
Il problema dell’eguaglianza accompagna l’esistenza stessa del diritto, perché è connesso al problema della giustizia e di come ricostruire un equilibrio violato dal torto.
Vi è infatti una connessione molto profonda tra eguaglianza e giustizia, che si apprezza se si si riflette sul fatto che il problema tipico che si pone nella controversia giuridica è quello del ristabilimento dell’equilibrio violato da un atto illecito, da un torto: infatti, quando si cerca la giusta compensazione del danno che qualcuno ha subito, si cerca una misura che sia eguale , nel senso di corrispondente, adeguata, proporzionata al danno subito e che perciò possa compensarlo. Il problema dell’eguaglianza è dunque pervasivo dell’esperienza giuridica: esso riguarda, come stiamo dicendo, la definizione della giusta compensazione del torto e la struttura del procedimento attraverso cui si giunge a quella decisione, e sotto questo profilo l’eguaglianza diventa parità delle parti e imparzialità del giudice.
Nella storia del pensiero umano, vi sono due modi fondamentali per ricercare la giusta compensazione del danno, due modi che si ripresentano nel corso del tempo e nel ricorrere delle mentalità: ad essi corrispondono l’idea di eguale in senso quantitativo e l’idea di eguale in senso qualitativo.
L’eguale in senso quantitativo esprime una concezione del problema della giusta riparazione, e cioè della giustizia, come problema misurabile, quantificabile, e pertanto semplice e oggettivabile; quando l’eguale è pensato in termini quantitativi, la giustizia è concepita sotto la categoria delle quantità uguali: mi hai rubato 100 mi devi restituire 100; mi hai tagliato una mano ti taglio una mano. E’ la logica del contraccambio, che regge l’antichissima legge del taglione e che è molto interessante perché richiama il legame, ineliminabile, tra desiderio di giustizia e desiderio di vendetta, tanto quanto la costante preoccupazione degli uomini per una misurazione ‘oggettiva’ di una cosa così sfuggente come il ‘giusto’. Una preoccupazione legata alla coscienza dell’importanza della giustizia per la pace, la coesione sociale e il buon governo, posto che il senso di aver subito una ingiustizia, o una ingiusta riparazione, generano rabbia e scontento. Anticamente, erano i Pitagorici che, in armonia con le loro concezioni razionalistiche e geometriche spiegavano l’eguale e il giusto in termini di un contraccambio meccanico fondato sulla logica de ‘lo stesso’. Aristotele, riconsiderando la tradizione sofistica, introdusse invece la problematica dell’eguale in senso qualitativo. Un passo della sua opera Etica a Nicomaco richiama l’attenzione sul fatto che il
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
problema di come stabilire se due cose sono eguali è condizionato dalla natura delle cose che consideriamo, e che se è vero che tutte le cose sono misurabili, onde è possibile stabilirne la stessa quantità, non sempre distribuire a due persone la stessa quantità di una certa cosa significa trattarle in modo eguale.
“In ogni cosa, dunque, che sia continua, cioè divisibile, è possibile prendere il più, il meno e l’uguale, e questo sia secondo la cosa stessa sia in rapporto a noi: l’uguale è qualcosa di mezzo tra eccesso e difetto. Chiamo, poi, mezzo della cosa ciò che è equidistante da ciascuno degli estremi, e ciò è uno e identico per tutti; e mezzo rispetto a noi ciò che non è né in eccesso né in difetto: ma questo non è uno né identico per tutti. Per esempio, se dieci è tanto e due è poco, come mezzo secondo la cosa si prende sei, giacché esso supera ed è superato in uguale misura. E questo è un mezzo secondo la proporzione aritmetica. Invece, il mezzo in rapporto a noi non deve essere preso in questo modo: infatti, se per un individuo dieci mine di cibo sono molto e due sono poco, non per questo il maestro di ginnastica prescriverà sei mine: infatti, può darsi che anche questa quantità, per chi deve ingerirla, sia troppo grande oppure troppo piccola: infatti per Milone [un atleta]1
sarebbe poco, per un principiante di ginnastica sarebbe molto. Similmente nel caso della corsa e della lotta. Così, dunque, ogni esperto evita l’eccesso e il difetto, ma cerca il mezzo e lo preferisce, e non il mezzo in rapporto alla cosa ma il mezzo in rapporto a noi”.
L’eguaglianza, dice Aristotele, si può intendere in due modi: come eguale rispetto ad altro, o come uguale rispetto a se stesso. L’uguale rispetto ad altro (mezzo della cosa) è quello che è misurabile: stabilito un termine di misura, per esempio il metro lineare, di una linea lunga 10 cm, il mezzo è 5 e questo è sempre uguale per qualunque linea lunga 10 cm. Questo tipo di eguaglianza richiede un termine di misura, o di paragone, e si realizza eguagliando i termini nuovi all’unità di misura, o di paragone, che è stata adottata. Se io voglio sapere dove è il punto medio di una trave di legno lunga 10 m questo punto sarà a 5 m e posso misurarlo con un sottilissimo filo di seta: la differenza tra i materiali, legno e seta, che sto considerando, non ha alcun rilievo. E’ questo l’eguale in senso quantitativo. Come tutti i ragionamenti quantitativi, può fregiarsi di una certa (pretesa?) oggettività.
Dall’altra parte, nel discorso di Aristotele, c’è l’uguale rispetto a noi, l’eguale rispetto a sé (o il mezzo in rapporto a noi), che non può essere conosciuto se non tenendo conto le peculiarità di quel certo soggetto, del quale ci occupiamo. Si può ben dire in generale che bere un litro d’acqua al giorno è una cosa buona, ma per uno che corre la maratona tutti in giorni sarebbe troppo poco. Si può ben dire che è una cosa giusta e opportuna che i bambini facciano catechismo, ma questo magari non è giusto dal punto di vista dei non cattolici. E’ questo l’eguale in senso qualitativo: questo modo di intendere l’eguaglianza richiede di domandarsi che cosa è proporzionato, congruo, appropriato rispetto alla situazione di volta in volta considerata, e, dovendo verificare l’opportunità, l’adeguatezza, la congruità di certe scelte, non può valutarle solo come tali, ma tenendo conto del contesto in cui sono immerse, così come del tempo storico in cui se ne giudica. Come tutti i concetti qualitativi, questa nozione di eguaglianza richiede, per essere apprezzata, ragionamenti di carattere valutativo.
Dunque, ci dice Aristotele, posso misurare il peso della carne, e darne la stessa quantità a due persone, ma se queste due persone sono molto diverse tra loro, come un bambino e un atleta, in realtà le ho trattate in modo diseguale. Posso, allora, considerare ugualmente responsabili chi ferisce una persona intenzionalmente, e chi lo fa per errore? Sarei giusto se lo facessi? Il dato oggettivo del danno, ancorché ricostruibile con certezza (ciò che non sempre è possibile) non mi dice abbastanza, ai fini di trovare il giusto contraccambio, se non vedo quel danno, quel fatto, per il suo valore, per la sua qualità (devo dunque conoscere anche: se quel danno è stato intenzionale o meno; se ha provocato una certa perdita o un’altra). Mettendo in primo piano la differenza tra eguale in senso qualitativo e eguale in senso quantitativo, Aristotele si poneva il problema di come evitare un tipico,
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
gravissimo problema legato alla legge del taglione, che è quello di aprire interminabili catene di vendette. Infatti, anche se io ripago il furto della pecora con la sottrazione di un’altra pecora, che è apparentemente pari, in realtà è molto probabile che le due offese saranno incomparabili (se tolgo una pecora a chi ne ha 10 è diverso da se la tolgo a chi ne ha una sola, per esempio, quanto a gravità delle conseguenze). L’abuso della riparazione minaccia sempre la ricerca della giusta compensazione, e può presentarsi proprio quando ad essere applicata è, meccanicamente, la logica de ‘lo stesso’. Per conoscere la giusta riparazione è necessario dunque conoscere bene il fatto, le ragioni che lo hanno determinato, il contesto in cui si è svolto: la ricerca dell’eguale diventa problematica e tale per cui non può essere affidata a una logica di tipo matematico, calcolante, quantitativo, ma a una diversa logica capace di muoversi nel campo dell’opinabile, che è il campo delle relazioni umane, dominate appunto dall’opinione, in cui non sono disponibili verità assolute: la logica del probabile e del ragionevole.
L’insegnamento di Aristotele si risolve nell’ammonimento che certe volte, anzi molto spesso, l’eguale in senso quantitativo contraddice l’eguale in senso qualitativo e ferisce il senso di giustizia, e fornisce una definizione di eguaglianza che consiste non nel trattare tutti allo stesso modo, ma nel trattare in modo eguale situazioni eguali, e in modo diverso situazioni diverse. I giuristi romani espressero questo stesso ordine di idee nel principio suum cuique tribuere, che significa “dare a ciascuno il suo”.
Nel periodo antico il principio di eguaglianza consisteva nel criterio di “dare a ciascuno il suo”, principio fondamentale del giudizio equitativo.
La concezione per cui l’eguaglianza è ‘trattare in modo eguale l’eguale e diverso il diverso’ è ancora attuale, affianca e mitiga il principio ‘tutti sono uguali davanti alla legge’.
Quella concezione è associata al criterio interpretativo dell’analogia, caratteristico del ragionamento giuridico, e si fonda sul richiamo alla natura della cosa, e ci aiuta a familiarizzare con concetti come ‘ratio’ della legge, equità e ragionevolezza, ancora oggi fondamentali nell’impostazione dei problemi giuridici.
La ‘natura della cosa’ e le dottrine del Primo diritto naturale
Bisogna sottolineare come sia centrale, nella ricerca del ‘giusto’ contemperamento di interessi, della ‘giusta’ pena, del ‘giusto’ contraccambio, l’interrogazione intorno alla natura della cosa, cioè al fatto nella sua configurazione qualitativa. Intorno alle riflessioni di Aristotele si sviluppò la dottrina che conosciamo come del Primo diritto naturale, nella quale, ben lungi dal ritenere che la giustizia derivasse da leggi di natura generali e astratte, eguali e opposte a quelle dettate dal legislatore (dalle leggi di Natura o di Dio, come ha pensato il Secondo diritto naturale), si presupponeva che essa derivasse da una circostanziata analisi della natura della cosa appunto, cioè del problema sottoposto a decisione, una analisi da svolgersi nel contraddittorio con le parti, sotto la guida di un giudice imparziale e nel rispetto di forme ordinate di argomentazione, presentando cioè argomentazioni rilevanti, attinenti al problema in causa, rispondendo puntualmente alle obiezioni, evitando gli abusi del discorso. Il ‘primo diritto naturale’ ispirò tutta la stagione classica del diritto, e in particolare il diritto romano antico. Il diritto caratterizzato dalla ricerca della natura della cosa vede come propria finalità l’equità, cioè la giustizia che tiene conto delle caratteristiche del problema concreto intorno al quale ci si interroga.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
In particolare: l’eguaglianza come criterio di interpretazione della legge. Analogia ed equità. La ratio legis.
L’uguaglianza, dunque, stiamo dicendo, nel periodo antico veniva intesa ed operava essenzialmente come un principio, o criterio, della valutazione giuridica. Serviva da un lato a conoscere le controversie tra i privati, dall’altro lato a interpretare ed applicare le leggi, gli statuti, le consuetudini.
Come criterio di interpretazione della legge, l’eguaglianza genera il criterio dell’analogia, molto utilizzato dai giuristi antichi che si muovevano, come sappiamo, utilizzando da un lato il materiale costituito dai precedenti giurisprudenziali e dall’altro le varie normative parziali caratteristiche dell’assetto pluralistico dell’epoca. Era frequente, normale l’ipotesi che un caso da risolvere non fosse contemplato in alcuna legge né in alcun precedente. L’uguaglianza imponeva di ricorrere all’analogia, cioè di applicare a questo caso una norma o un precedente simile, che avesse con quel caso in comune caratteristiche rilevanti, e soprattutto rispondesse alla stessa ratio. La ratio, o mens, della legge è un criterio da sempre importantissimo per il giurista, e consiste nella finalità o ragion d’essere di una certa disposizione (di una legge, o di un precedente giurisprudenziale, o di una clausola contrattuale). Conoscere la ragion d’essere di una certa disposizione è fondamentale per sapere se essa può essere, o meno, applicata a casi che quella disposizione non contempla espressamente, e introduce ai più squisiti e tipici problemi giuridici. Facciamo un piccolissimo esempio: supponiamo che la legge stabilisca che le persone che hanno un certo handicap, come la cecità, che vengano assunte tramite il collocamento speciale, godano di una certa indennità. Quella indennità va data anche alle persone cieche, che fanno lo stesso lavoro, ma che sono state assunte tramite i normali canali di collocamento, o che per esempio sono diventate cieche mentre già lavoravano? Se noi identifichiamo la ratio della legge nella volontà di compensare, con l’indennità aggiuntiva, il particolare sforzo che lavorare implica per coloro che sono portatori di un handicap, estenderemo l’indennità anche ai lavoratori ciechi che non sono stati assunti col collocamento speciale, anche se la legge si riferisce espressamente solo a quelli: ubi eadem ratio, ibi idem jus (=dove ricorre la stessa ragion d’essere, ci deve essere lo stesso trattamento giuridico).
Ragionare secondo analogia significa applicare l’uguale in senso qualitativo, trattare in modo eguale l’eguale e in modo diverso ciò che è diverso, dare a ciascuno il suo, ricercare una soluzione ispirata alla ragionevolezza, decidere in modo equo.
Si può disputare molto su quale sia effettivamente la ratio di una legge o di un certo istituto, e le opinioni sulla ratio di una legge o un istituto possono cambiare nel tempo. In questo periodo in tutto il mondo è diventato molto attuale il problema del riconoscimento agli omosessuali della facoltà di contrarre matrimonio. Le coppie omosessuali e quelle eterosessuali sono così simili da render giusto lo stesso trattamento? Molto dipende da quale ‘ratio’ viene assegnata al matrimonio. Serve alla procreazione? Allora non sarebbe irragionevole negarlo agli omosessuali, questo non violerebbe l’eguaglianza. Ma se nel matrimonio vediamo altro, per esempio il riconoscimento solenne dell’affetto e della mutua solidarietà tra due persone, allora si imporrebbe l’estensione del matrimonio anche a coppie naturalmente sterili come quelle omosessuali. Vediamo bene in questo esempio come eguaglianza, analogia, ragionevolezza siano espressioni contermini e tutte orientate al problema del ‘giusto’, e vediamo anche come la ricerca della ratio legis sia connessa inestricabilmente anche alla domanda sulla ‘natura della cosa’: quando mi chiedo quali finalità persegue l’istituzione ‘matrimonio’, e quali bene protegge, mi pongo un interrogativo che investe sia le finalità e la ragion d’essere dell’istituto sia la sua essenza, la sua natura, ciò in cui consiste, e questa domanda non può avere risposte astratte ma mi riconduce verso il mondo, la società, i suoi usi, costumi, credenze.
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
Da tutto queste consegue anche, come dicevo, che si possono avere opinioni diverse circa la ratio di una certa legge o di un certo istituto: questo è naturale, perché il diritto è l’ambito dell’opinabile. Che queste opinioni possono cambiare: e anche questo è naturale, perché il diritto è immerso nella vita umana e sociale dunque nel cambiamento. Fino a pochi anni fa, che potesse esistere il matrimonio omosessuale nessuno nemmeno lo pensava. Detto tutto questo, va sottolineato che basare l’analogia sulla ratio legis è un modo di dare rigore al ragionamento e di evitare soggettivismi, preferenze individuali. Nessun giudice potrebbe negare l’estensione di una norma a un certo caso con l’argomento ‘io non sono d’accordo, io preferisco un’altra soluzione’; ma si deve sempre sforzare di trovare un fondamento del suo argomento nella legge, o nei precedenti, che utilizza, e un fondamento che abbia corrispondenza nel senso comune cioè nel modo in cui quella di certa ‘cosa’, di quell’istituto, è percepito nella società, dalle persone, consistere la ‘natura’.
L’ancoraggio alla ragio legis, da un lato, e alla natura della cosa, dall’altro, sono due tra le molteplici forme con cui da un lato il ragionamento giuridico, legato al campo dell’opinabile e immerso nel mutamento, cerca, da un lato, di evitare il soggettivismo e l’arbitrio, e grazie alle quali, dall’altro lato, il diritto non si riduce al prodotto di una cerchia ristretta di esperti e di tecnici ma permane una manifestazione del mondo storico e sociale in cui è immerso.
Come ha scritto Augusto Cerri: “il criterio ermeneutico (=interpretativo) dell’analogia, in base al quale, estendendosi la norma a tutti i casi in cui ricorre la ratio che la giustifica, si realizza al tempo stesso il rigore del diritto (rigor) e l’eguaglianza di trattamento (aequitas). Mens legis, aequitas, rigor diventano anzi sinonimi nel pensiero giuridico medievale e sia tale mens sia le norme che la esprimono devono avere il requisito della generalitas. L’aequitas che si realizza attraverso una interpretazione della legge che risalga alla sua mens si congiunge dunque sempre con il rigor, è eguaglianza cioè nell’ambito del diritto e si distingue dalla aequitas rudis, dalla giustizia secondo l’apprezzamento di chi giudica” (A. Cerri, Eguaglianza giuridica ed egualitarismo, 1984, p. 95).
L’eguaglianza, animando il ragionamento analogico ed equitativo, era dunque il perno fondamentale della conoscenza e della pratica giuridica d’ordine antico. Sin dall’epoca del diritto romano l’analogia era definita “aequitas quae in paribus causis paria jure desiderat” (equità che richiede un trattamento eguale in casi eguali). Queste concezioni spinsero i giuristi romani classici e i giuristi medievali a contrastare le norme ‘personali’ cioè le leggi dettate per casi singoli; e a stabilire che le norme eccezionali o speciali non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti o comunque non sono suscettibili di analogia. L’ordinanza cittadina che, nell’Italia comunale, decretasse la messa al bando degli appartenenti a una certa fazione e la confisca dei loro beni, non poteva essere interpretata come la premessa che consentiva al Comune di confiscare i beni anche dei loro congiunti o amici.
Possiamo dunque dire che se è vero che il tempo dell’ordine antico non conosceva ‘l’eguaglianza di tutti davanti alla legge’, esso conosceva un altro e forse ancor più importante criterio: il principio secondo cui la legge (vale a dire: disposizioni normative, consuetudini, precedenti giudiziari, norme contrattuali) deve essere applicata, interpretata e portata ad esecuzione in modo eguale cioè ragionevole ed equo. Si tratta di un criterio che, dopo essere stato messo da parte in successive fasi storiche, è ritornato di profonda centralità nell’esperienza giuridica contemporanea, e comunque non ha mai abbandonato la conoscenza e la pratica giuridica.
Il legislatore ragionevole
Secondo alcuni studiosi, le concezioni proprie del tempo del diritto comune, che puntavano su una attività di interpretazione e applicazione del diritto che garantisse il minimo possibile di arbitrio, contribuirono, specialmente nell’area italiana, all’edificazione di un ideale giuridico-politico che è
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
stato chiamato il legislatore ragionevole (A. Giuliani). Questo ideale è del resto una espressione della tipica compenetrazione tra legislazione e giurisdizione che ricorre nell’ordine antico e significa che quando pone la legge l’autorità che la pone non deve tener conto solo dei suoi fini e calcoli di utilità e di efficienza ma anche di tutta una serie di principi del diritto: se il giurista potrà applicare quella legge in maniera analogica a casi simili, tanto vale che già nel momento di porre la regola la si formuli nel modo più generale possibile. L’ideale del legislatore ragionevole è quello che aspira a che i principi che ispirano la legislazione siano simili e contigui a quelli che ispirano la giurisdizione, cioè la ricerca dell’equità e l’evitamento degli abusi. Se il diritto serve a correggere i torti e evitare gli abusi, la legge in primo luogo deve evitare di farne con prescrizioni arbitrarie, ingiuste o irragionevoli. L’ideale del legislatore ragionevole sottolineava dunque che la legge non deve essere espressione solo della forza, dell’autorità di chi detiene il potere, ma della ragione, cioè di un atteggiamento preoccupato non solo della effettività del comando ma anche della sua giustezza.
Lo spessore dei problemi del diritto
“Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.”
Questo è uno dei principi espressi dall’art. 12 disp.prel.c.c. (1942) è un principio vigente e applicato, e quando è stato trasfuso nel nostro codice civile aveva già sulle spalle un paio di migliaia di anni.
Le libertà nell’ordine antico. La primazia della liberta’ politica
L’ordine antico è stato un tempo che ha ospitato una sua tutta propria, e assai potente, idea di libertà e di diritti, rimasta come archetipo delle concezioni contemporanee, benché questo sia meglio percepibile nelle aree geopolitiche che non hanno conosciuto la frattura rivoluzionaria con l’ordine antico che nell’Europa continentale l’assolutismo, la rivoluzione francese e la codificazione napoleonica rappresenteranno, e cioè in area anglosassone. Risale infatti, per esempio, alla Magna Charta Libertatum, stipulata ai primi del XIII sec. in Inghilterra da Re Giovanni insieme ai suoi ‘pari’ ribelli, onde ritrovare con essi la pace, il principio che sanciva il diritto di questi ultimi di non poter essere condannati senza un previo giudizio dei loro Pari, cioè di uomini liberi, ossia di nobili quali essi erano.
No free man shall be taken, imprisoned [...] or in any way destroyed, except by the lawful judgement of his Equals, and by the Law of the Land" (Magna Charta, N. 39, linea 40 - 1215).
Allora intimamente intriso delle concezioni medieviste di privilegio cetuale, quel documento resta ancora incorporato nella Costituzione inglese non scritta o tradizionale, ma risuona in tutti i testi costituzionali post-rivoluzionari contemporanei in cui è scritto che nessuno può essere condannato se non in base a una legge e dietro un giusto processo, come avviene anche nella nostra attuale Costituzione (habeas corpus).
L’ordine antico, infatti, fu il tempo di una particolare concezione della libertà e dei diritti, non legati a ogni essere umano come tale, ma in quanto appartenente a un ceto, un gruppo, un corpo sociale, e non consistenti nella libertà di dedicarsi indisturbati ai propri affari, ma nel diritto/dovere di
Istituzioni di diritto pubblico 2016-2017 Prof.ssa Silvia Niccolai - F -
partecipare agli affari comuni (anche nel caso del diritto a un giudizio dei pari, vi sono, insieme, il diritto, passivo, del singolo a essere giudicato dai pari, e il diritto attivo, come pari, a giudicare, col dovere di farlo lawfully, cioè conformemente al diritto).
A causa della struttura pluralistica dell’ordine antico, in cui ogni ordine aveva, rispetto a se stesso e in rapporto agli altri, competenze pubblicistiche, giurisdizionali, di cura di interessi comuni, di compartecipazione alla legislazione, e cioè in una parola di governo, l’ordine antico ha sviluppato dunque una accezione politica della libertà.
“Per quanto gli uomini dell’antico regime fossero sottomessi alla volontà del re” scrive Toqueville “un genere di obbedienza era loro sconosciuta: non sapevano cosa fosse piegarsi a un potere illegittimo e contestato, poco rispettato, disprezzato spesso ma subito volentieri perché serve e può nuocere. I privilegi erano anche forme di libertà, in quanto davano a chi li aveva orgoglio e senso dell’onore, e di conseguenza coraggio davanti agli abusi di potere”.
L’analisi di Tocqueville fa particolarmente risaltare che la libertà politica, dando a tutti, in modo diverso, titolo a partecipare sugli affari comuni creava senso di appartenenza, di reciprocità, di mutuo riconoscimento, cioè coesione. Essendo legati gli uni agli altri da una rete di interdipendenze, gli uomini pur diversi, erano uniti dalla reciprocità di diritti e di doveri: il feudatario aveva molti poteri, ma anche il dovere di provvedere ai bisogni dei villaggi nelle carestie, e di garantire l’uso di beni comuni; poteva fare obiezione al re, ma in un vincolo di fedeltà che lo obbligava a farlo in modo leale.
Riflettere su questo significa porsi il problema di come mantenere e diffondere sentimenti civici qualil’onore e l’orgoglio, il senso dei propri diritti e dei propri doveri nella società ‘atomistica’ di uomini tutti eguali e svincolati da legami reciproci, e solleva la provocatoria idea di libertà nella diversità. Le idee dell’ordine antico offrono dunque un punto di vista importante per valutare il portato delle vicende pubbliche che ad esso sono seguite, e per rapportarsi a molte delle domande che oggi investono la convivenza civile.




































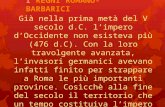
![GEBEL SANHUR ARTICOLO[1] - Qattara - Daniele … STRUZZO_FILES/GEBEL_SANHUR_ARTICOLO[… · Il cimitero non esisteva più se non come buchi e ... contro vipere, freddo e scorpioni.](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5b9b42a009d3f2dc408cc3be/gebel-sanhur-articolo1-qattara-daniele-struzzofilesgebelsanhurarticolo.jpg)

![[PPT]Progetto: “Alla scoperta del tuo paese”scuolamuseo.arcadeisuoni.org/uploads/slides/castello... · Web viewNel Quattrocento il territorio dellafuturaFicarazzi - fu concesso](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c65e75c09d3f2e4308b6cd8/pptprogetto-alla-scoperta-del-tuo-paese-web-viewnel-quattrocento-il.jpg)




