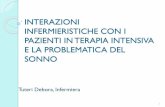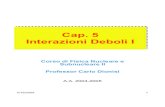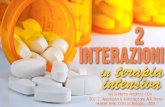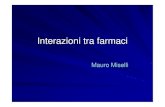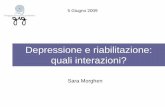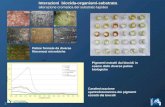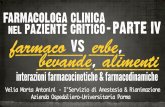Interazioni tra uomo, gruppo e beni comuni
-
Upload
mara-passuello -
Category
Leadership & Management
-
view
147 -
download
1
Transcript of Interazioni tra uomo, gruppo e beni comuni

Master World Natural Heritage Management
3 ed.
Verifica conclusiva
Traccia 1
Variabili di contesto politico, di processi psico-sociali, di fattori antropologici e
di risonanza incarnata sembrano regolare il rapporto tra individui, gruppi e
patrimoni ambientali, producendo un continuo processo di traduzione.
Descrivere gli aspetti essenziali di questo processo e almeno una/alcune
indicazione/i per governarlo e gestirlo
Allievo:
Passuello Mara

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 1
1
Crisi dal greco Krino = separare, cernere, giudicare;
quindi riflessione, valutazione.
Se è vero che le nostre scelte determinano il futuro che costruiamo, è anche vero che queste vengono
influenzate dalla visione che abbiamo della realtà, della narrazione che dispiega i fatti che accadono intorno a
noi.
Come afferma schiacciante Serge Latouche ne L’invenzione dell’economia «oggi vediamo il mondo attraverso
i prismi dell’utilità, del lavoro, della concorrenza e della crescita illimitata» e si domanda «cosa ha portato
l’Occidente a costruire un mondo in cui nulla ha più valore, e tutto ha un prezzo?» ed è forse questo tipo di
narrazione quella che ci guida oggi nel preferire i fusion restaurant “all you can eat” a Lissone, le formule Bravo
club “all inclusive con braccialetto azzurro” o ci spinge a indebitarci col negozio chic in centro ad Arezzo per
comprare a nostra figlia il visone a rate.
Ma oggi quando scegliamo, cosa scegliamo? Anzi, quando scegliamo siamo sicuri di scegliere?
Una frase emblematica echeggia in Pensieri lenti e veloci di Daniel Kanheman, Premio Nobel per l’economia
nel 2002, «un modo sicuro di indurre la gente a credere a cose false è la frequente ripetizione, perché la
familiarità non si distingue facilmente dalla verità».
Questo ragionamento tocca due aspetti fondamentali: da un lato l’azione dei media che clusterizza la
popolazione secondo il concetto di target e bombarda in orari e giorni astutamente studiati sotto forma di
informazione, intrattenimento o messaggio pubblicitario nella versione di “generatore” di necessità e
mancanze; dall’altro lato la rinuncia alla propria identità e unicità (e quindi alla propria libertà, ma anche alle
proprie responsabilità di essere umano pensante) a fronte dell’appartenenza ad un gruppo, per consegnarci,
come teorizzato da Ugo Morelli in Mente e bellezza, al conformismo semplice e rassicurante.
In una narrazione filo-economica dei fatti, dove l’individualismo capitalista sfocia in una lotta predatoria per la
sopravvivenza e la creazione di disuguaglianza sociale, il termine crisi assume un’accezione negativa e se
anche non indicasse per forza un passaggio da un periodo di sviluppo e crescita ad uno di depressione
rappresenterebbe comunque un cambiamento e quindi un aumento del rischio.
Viene illustrato chiaramente in Homo pluralis di Luca de Biase come in altri contesti storici e sociali la parola
crisi abbia assunto un significato totalmente differente, partendo dall’antica Grecia dove rappresentava l’atto
finale della trebbiatura in cui veniva separata la granella di frumento dalla paglia e dalla pula, fino ad arrivare
ad un senso più figurativo e attuale con il quale si indica il cernere, lo scegliere tra ciò che ci viene proposto,
ad esempio dalle informazioni che ci provengono dai media.
La crisi quindi assume un’impronta positiva, costruttiva e non distruttiva se decontestualizzata dall’ambito che
principalmente l’ha fatta sua.
Ciò che si può quindi creare deriva a sua volta da una nuova definizione dell’Io all’interno del Noi
(abbandonando invece l’annegamento di uno all’interno di un aggregato omogeneo dei tanti e quindi forti).
La naturale diversità, che emerge inevitabilmente una volta appurata l’unicità di ognuno, è decisiva all’interno
di un gruppo, come si legge in un estratto pubblicato su TED di Margaret Heffernan The secret ingredient that
makes some teams better than others. Riprendendo uno studio compiuto da Thomas Malone insieme a un
team di ricerca del MIT, afferma come ciò che contraddistingue il valore di un team non sia da ricercarsi
nell’intelligenza dei singoli componenti o di poche star all’interno di esso. Caratterizzante invece, secondo lo
studio, sarebbero tre fattori:
- Concedere uguale tempo per parlare a ciascun membro, valorizzandone l’intervento e considerando
utile e indispensabile l’apporto di ognuno (da cui si registra l’importanza data all’eterogeneità degli
apporti sia all’interno di una discussione, sia, in senso più ampio, all’interno di un aggregato di persone;
- Capacità di “social sensitivity” ovvero abilità empatica nel capire pensieri e sensazioni dell’altro,
strettamente correlata all’accettazione del diverso all’interno di un gruppo;

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 1
2
- Presenza femminile all’interno del gruppo, che statisticamente mostrano maggiori capacità empatiche.
Come illustra Luca de Biase, un gruppo ben assortito eleva la condizione individuale a quella collettiva in cui
«l’intelligenza plurale non appiattisca l’individuo, ma metta insieme le esigenze di libertà, creatività, efficienza,
inclusione, equilibrio, rispetto e collaborazione».
L’intelligenza plurale non è statica, ma evolve come anche i gruppi di individui, che in maniera plastica possono
essere modellati sulla base delle esigenze di una comunità o di momenti storici.
Appare sempre più incalzante la nuova domanda di qualità della vita imperniata su una logica di “ecologia
integrale”, come divulgato anche nella prima Enciclica di Papa Bergoglio, che reclama il bisogno di riconoscere
i valori inestimabili di beni ambientali e culturali agendo a partire dalla dimensione umana e sociale.
È proprio quindi nell’aspetto integrale della questione che va riscontrata la necessità di una intelligenza
collettiva al servizio di un problema globale e controverso.
« Compass over maps »
Joi Ito, Want to innovate? Become a "now-ist" TEDTalk marzo 2014
L’aspetto chiave del concetto di ecologia integrale è quello di essere «inseparabile dalla nozione di bene
comune».
L’umanità si trova ad affrontare la questione inedita dei commons cioè «i beni economici e sociali decisivi per
la qualità della vita sulla Terra e forse per la sua stessa sopravvivenza, che utilizziamo contemporaneamente
in tanti (rivali e per i quali non vi è escludibilità), e che sottostanno a leggi ben diverse da quelle che regolano
la produzione e il consumo dei beni privati, quelli studiati dalla scienza economica in questi due secoli » come
spiega Luigino Bruni in L’economia nell’era dei beni comuni: la tragedia, le sfide, le possibili soluzioni.
Se finora il perseguimento antropocentrico dei propri interessi conduceva in maniera commutativa al
perseguimento del bene comune, secondo la metafora smithiana della mano invisibile, oggi invece appare
sempre più chiaro che questa legittimazione etica non regga più il discorso all’interno di una società
globalizzata.
Oggi i beni comuni strategici dell’umanità sono le energie non rinnovabili, foreste, laghi, mare, beni ambientali,
acqua, discariche e non possono essere trattati come i beni di consumo privati con cui siamo abituati ad avere
a che fare: secondo Bruni diventa imperante la ricerca di nuovi sistemi di governance improntati su una
maggiore responsabilità verso il presente (le popolazioni colpite da fame, schiavitù e processi di sfruttamento
che ignorano i diritti fondamentali) e il futuro (nell’ottica di uno sviluppo sostenibile).
L’esempio di Garrett Hardin sul pascolo comune e libero nel celebre paper The tragedy of the commons
raffigura la tensione fra libertà individuale e bene comune e racconta la riluttanza ad agire di fronte ad una
tragedia che ineluttabilmente ci viene incontro.
Da un lato ci comportiamo come se da un problema comune diventasse un problema di nessuno, ci culliamo
nella provvisoria fase di stallo indifferente non consci che, quando si tratta di beni comuni, il non agire
corrisponde alla distruzione del bene.
Dall’altro lato siamo guidati dalla percezione del rischio, dalla tendenza, di fronte a problemi inediti (per i quali
non abbiamo ancora stilato un modello comportamentale) ad applicare la teoria della scelta più semplice ed
economica, che riporti risultati (o meglio palliativi) immediati. Centrali a questo punto si rivelano, come scrive
Ugo Morelli in Mente e paesaggio, i fattori cognitivi ed affettivi. L’azione più urgente in questo momento è
quella che punta sulla «plasticità della mente razionale umana» per favorire il cambio di idee e comportamenti
e abbattere le istituzioni immaginarie che vincolano e ostacolano l’innovazione, decisiva per la progettualità

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 1
3
sociale e la democrazia; d'altronde la democrazia altro non è che «la ricerca per elaborare i vincoli e le
possibilità, le aspettative e la paura, che provengono dalla necessità di vivere e agire con gli altri».
Ecco come l’innovazione impone di affrontare la paura del conflitto col consueto rassicurante, mette nella
condizione di rifigurare noi stessi e la nostra posizione e contempla il rischio di chi si avvia per un cammino di
cui non ha la mappa, ma sa, attraverso una bussola, dove puntare.
Dodecaneso, Grecia 2012 […] l’Egeo non è un mare pescoso, ma forse la navigata di
vela tranquillizzò i pesci; così abboccò alle canne da pesca, montate sul retro del catamarano, un pesce spada di 80 cm. Lo pulimmo, rimontammo le canne e, con gli scarti del primo
rigettati come pastura, ne abboccò un altro più grosso. Esaltati e non contenti rimontammo le canne da pesca,
ma il capitano ce le tolse dicendo che due pesci sarebbero stati sufficienti.
Fu uno degli insegnamenti più belli della mia vita. […]
Esiste un pascolo comune e libero, dove ogni contadino di quella comunità porta a pascolare le proprie
mucche. La scelta che massimizza la libertà e l’interesse individuale è quella di aumentare il bestiame al
pascolo, e ciò rappresenta il vantaggio individuale, mentre la diminuzione del bene comune “erba” è soltanto
di una frazione del vantaggio, poiché il danno è collettivo e si ripartisce su tutti gli altri contadini: ciò garantisce
per ogni singolo contadino un vantaggio individuale maggiore del costo individuale e questo vale anche
quando ci si avvicina all’ultima frazione di erba al pascolo. Questo implica l’incentivo individuale (per ognuno)
ad aumentare sempre più i capi di bestiame al pascolo fino ad arrivare alla distruzione del pascolo stesso.
Una volta oltrepassato il limite, il punto critico, il processo che porta alla tragedia diventa irreversibile.
Nel 1968 il biologo Garrett Hardin in un paper pubblicato dalla rivista Science denuncia, con il celebre racconto
del pascolo, il fatto che le risorse materiali (e immateriali) del pianeta sono destinate a esaurirsi perché, in
quanto beni comuni, troppo sfruttate. La sua teoria (che da lì in poi diventa dominante) è nota con il nome di
Tragedy of commons.
Le scienze economiche hanno studiato la tragedia di Hardin utilizzando la teoria dei giochi, da cui si evince
che, a meno che non si trovi una soluzione, non si riesce ad uscire dalla tragedia e l’esaurimento della risorsa
è inevitabile: il singolo individuo infatti sarà portato a compiere la scelta razionale, nella quale ciascuno
considera il proprio vantaggio individuale, forte del fatto che se si autolimitasse, perderebbe il totale vantaggio
e perderebbe anche l’indomani che la risorsa erba sarà esaurita (poiché nel frattempo anche gli altri avranno
fatto la scelta razionale e avranno consumato la risorsa).
Hardin aveva teorizzato due possibili soluzioni: da un lato la privatizzazione del bene in singole proprietà
private, che tuttavia non è applicabile a tutti i commons in quanto, come l’aria e l’acqua, difficilmente
frazionabili; dall’altro quella del contratto sociale in cui si presuppone un ente superiore, un sistema di leggi e
sanzioni, che preservi la risorsa uscendo dalla tragedia e quindi evitando la distruzione del bene; chiaramente
così facendo si limita la libertà individuale; anche questa rimanda a uno sviluppo difficilmente applicabile
poiché necessiterebbe di un sistema di contratti, o comunque un istituzione, globalmente valida.
Nel 1990 Elinor Ostrom, premio Nobel per l’economia nel 2009, al termine di ricerche in collaborazione con
un network di 2000 ricercatori in tutto il mondo e l’ International Association for the Study of Common Property
(IASCP), pubblica Governing the commons con il quale smentisce l’asserzione di Hardin, secondo il quale era
impossibile uscire dalla tragedia a meno che non si seguisse la strada della privatizzazione o della gestione
statale, accreditando la strada dell’autogestione da parte delle comunità di utilizzatori del bene.

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 1
4
Secondo la Ostrom le comunità possono imparare ad autoregolarsi, in maniera inedita poiché, avendo studiato
centinaia di casi al mondo, si rende conto che non esiste una ricetta preconfezionata, ma piuttosto una visione
innovativa, efficiente e sostenibile basati sul controllo degli utilizzatori, l’istruzione ai comportamenti etici ed
eventualmente sanzioni e leggi per regolare il processo.
Un sistema di organizzazione e gestione policentrico come quello teorizzato sopra è certamente complesso
da comprendere ma anche da installare tuttavia racchiude in sé tutti i benefici della molteplicità di apporti,
soluzioni, idee e formazione ed esige il rispetto delle idee, delle visioni eterogenee e delle identità altrui.
Come scrive Luca de Biase in Homo pluralis «non può esserci sostenibilità senza pluralità» e ancora «i
problemi che mettono in crisi le soluzione adottate in passato non possono essere affrontati da un’intelligenza
procedurale, incapace di imparare e creare innovazione».
Un altro termine che negli anni ha assunto una connotazione negativa è quello di limite.
La finitudine di qualcosa ci spaventa; accade così che la finitudine di una risorsa non viene recepita e il monito
(che ormai siamo abituati a considerare stantìo) di limitare la nostra impronta ecologica, generi la
«consapevolezza che non eccede al cambiamento» descritta in Mente e Paesaggio di Ugo Morelli; il racconto
secondo cui la crescita e il progresso infiniti sono insostenibili su un pianeta dalle risorse finite di Latouche è
passato dall’essere una novità sponsorizzata da una piccola setta di irriducibili disfattisti ad una fastidiosa e
ripetitiva nenia senza prove a suo favore. Eppure mentre l'idea dell'Institute for the Future sembra essere
quella per cui «una delle leggi fondamentali degli studi sul futuro è che su questo tema non ci sono fatti. Solo
narrazioni» la maggioranza degli individui è ancora convinto che l’imperativo di invertire senso di marcia
nell’impatto sociale e ambientale sia una corrente politica un po’ freak.
La natura, le sue regole e i suoi ritmi, come spesso accade, hanno molto da insegnarci; ad esempio potremmo
trarre insegnamento dalla lumaca di Ivan Illich su come fondare la “civiltà del limite”. Certamente come
conclude Ugo Morelli nel breve saggio Scoprire la bellezza del limite è importante, mai come ora, evidenziare
la bellezza e la sobrietà del limite.
« Di sicuro avrebbe ricordato molte più cose, se un giorno avesse mai pensato di tornare indietro »
Manoscritto inedito del Milione
L’aspetto affascinante dell’attuale crisi (intesa come passaggio e trasformazione) è la destituzione della specie
umana da super partes a parte del tutto e tale ri-figurazione della nostra posizione e del nostro significato
all’interno della storia della Terra, che vanta quatro miliardi di anni, sta emergendo poco alla volta in tutte le
discipline.
La nostra auto-incoronazione, che abbiamo provato ad accreditare con anni di scoperte scientifiche, non ci ha
comunque reso né creatori nè custodi dei processi della natura, anzi ha reso ancora più difficile da accettare
la nostra reale finitudine e fragilità di fronte ad essi.
Le scoperte scientifiche che sembravano incalzare la nostra pretesa di auto-elevazione andavano forse lette
in chiave diversa; accade infatti che Copernico pone la Terra non più al centro del sistema solare, il quale
sistema solare Galileo scopre essere infinito e quindi subiamo quell’ulteriore rimpicciolimento figlio
dell’aumento di scala. Successivamente Darwin identifica la specie umana frutto di un «processo evolutivo
casuale e non necessario» e certamente non centrale. Il principio heisenberghiano di indeterminazione ci ha
dimostrato inoltre come sia possibile non comprendere qualcosa, come la realtà sia molto più complessa del
determinismo causa-effetto tipico della meccanica newtoniana e di come la casualità possa regolare il
comportamento di due elettroni in movimento a distanza ravvicinata.

Mara Passuello World Natural Heritage Management 2015 Traccia 1
5
La certezza e la completezza dovrebbero essere abbandonate a favore dell’accettazione del nostro limite e
del nostro vincolo per tradurli in potenzialità; scrive Ugo Morelli in Mente e paesaggio come «chi sa riconoscersi
transeunte, errante e passeggero e per questo suo essere vulnerabile, si dissolve nei mondi che incontra per
appartenere a essi».
La nostra incompletezza, la mancanza generano una tensione verso la conoscenza che comunque non
annulla la nostra approssimazione ma la riduce asintoticamente. Il proprio accrescimento, la formazione,
l’arricchimento hanno le sembianze di movimenti e azioni, come l’andare incontro, lo scambio, la relazione, il
gesto e il conflitto.
Appare chiaro che il modo di fare educazione debba essere completamente rivisto e allontanato dalla pratica
di riempire degli involucri di nozioni confezionate e aride, come viene chiaramente denunciato in Conflitto
generativo di Ugo Morelli; educare dovrebbe assomigliare più alla valorizzazione di ciò che è presente
nell’allievo, dovrebbe richiamare all’elaborazione delle potenzialità e dei limiti «accompagnando e creando
opportunità» (G.Cepollaro, Introduzione a Mente e paesaggio).
Il salto di qualità della formazione dovrebbe essere frutto di due importanti rivoluzioni: da un lato l’abbandono
del concetto di apprendimento come azione di accoglimento passivo di informazioni trasmesse da una figura
che si pone in maniera asimmetrica e accanitamente pedagogica rispetto all’allievo; dall’altro l’abbattimento
delle barriere disciplinari «erette come steccati per proteggere lo specialismo» (L.Mori, Recensione a Conflitto
generativo), a fronte di «un approccio interdisciplinare che […] porti l’urbanistica, l’architettura, l’ingegneria,
l’economia e la psicologia a ricerca ed agire, non separatamente, per problemi e progetti» come suggerito in
Mente e Paesaggio.
Se ammettiamo che l’apprendimento si fondi sul conflitto per arricchirsi attraverso la relazione con gli altri e le
loro diversità, è importante in quel momento anche saper sospendere i domini di senso per favorire la creatività
e concepire l’inedito.
In una brillante TEDTalk del 2006 Do schools kill creativity?, Ken Robinson racconta di come man mano che
l’allievo cresce, gli insegnanti (e gli insegnamenti) si concentrino su una parte sempre più ridotta e sempre più
nella parte alta del corpo: dall’intero corpo, al busto, fino alla sola testa, per agire esclusivamente su parti del
cervello. Questo è in totale disaccordo con ciò che scrive Ugo Morelli in Linguaggio e arti sono incarnati in
proposito « il corpo parla e non lo fa solo con la parte alta, la testa e con la bocca. Noi pensiamo, ma senza
movimento non avremmo avuto acceso e non accederemmo al pensiero». Egli parla di gerarchie nel sistema
di insegnamento di tutto il mondo, denunciando il fatto che le discipline artistiche siano posizionate all’ultimo
gradino per importanza e che, in particolare, quelle che includono tutto il corpo nella sua interezza (ad esempio
danza o recitazione) siano le più discriminate.
Questo, come spiega, è un retaggio del XIXsec. dove la formazione era al servizio dello sviluppo industriale e
perciò le capacità richieste erano legate a questo ambito. L’evoluzione del sistema educativo è proseguita
senza particolare innovazione cosicchè anche ora l’abilità accademica è la sola presa in considerazione e il
solo metro di misura per parlare di intelligenza e capacità. Ciò che appare invece dagli studi di Robinson
(autore e studioso di educazione, creatività e innovazione) è che dell’intelligenza sappiamo tre cose: essa è
assolutamente varia, grazie alla percezione incarnata che abbiamo degli stimoli provenienti dal mondo, delle
relazioni che viviamo e delle esperienze che facciamo, è dinamica, poiché parti differenti del cervello co-
operano e la creatività si propone come «l’interazione di modi differenti di vedere le cose» ed infine è distinta.
Con questo presupposto Robinson conclude paragonando l’emergenza ecologica all’emergenza per il futuro
di adottare una nuova concezione di ecologia umana, nella quale ricominciare a valorizzare la ricchezza delle
capacità umane; «Il nostro sistema educativo ha sfruttato le nostre teste come noi abbiamo sfruttato la terra:
per strapparle una particolare risorsa».
Il compito più urgente per il futuro è l’educazione nella sua interezza, incoraggiando ad esprimere, ma
soprattutto allenando a sviluppare, le capacità creative di ciascuno, da ricchezza che sono.


Bibliografia
Articoli
Bruni, Luigino, L’economia nell’era dei beni comuni: la tragedia, le sfide, le possibili soluzioni
disponibile al sito web
http://matematica.unibocconi.it/articoli/l%E2%80%99economia-nell%E2%80%99era-dei-beni-comuni-la-tragedia-le-sfide-le-possibili-soluzioni
Buck, J. Susan, Governing the commons: Book review
disponibile al sito web http://lawschool.unm.edu/nrj/volumes/32/2/06_ostrom_governing.pdf
Giordani, Serena, Recensione di Ugo Morelli, Il conflitto generativo. La responsabilità del dialogo contro la globalizzazione dell’indifferenza, Città Nuova Editrice, Roma 2014 disponibile al sito web http://www.ugomorelli.eu/hn/conflitto.pdf
Marroni, Carlo, L'ecologia “integrale” di Papa Francesco: la terra è la casa comune dell'umanità
disponibile al sito web
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-18/l-ecologia-integrale-papa-francesco-oggi-enciclica-ambiente-120836.shtml?uuid=AC9lenC&p=2
Mori, Luca, Recensione di Ugo Morelli, Il conflitto generativo. La responsabilità del dialogo contro la globalizzazione dell’indifferenza, Città Nuova Editrice, Roma 2014 disponibile al sito web http://www.ugomorelli.eu/hn/LucaMoriRecensioneUgo%20MorelliConflittogenerativo-1.pdf
Morelli, Ugo, Scoprire la bellezza del limite
disponibile al sito web http://www.ugomorelli.eu/hn/211.html
Morelli, Ugo, Laudato sì
disponibile al sito web http://www.ugomorelli.eu/hn/430.html
Morelli, Ugo, Finitudine, risparmio, rinnovabilità energetica: oltre il mito
disponibile al sito web http://www.ugomorelli.eu/hn/291.html
Morelli, Ugo, Linguaggio e arti sono incarnati
disponibile al sito web http://www.ugomorelli.eu/hn/36.html
Morelli, Ugo, Mente relazionale, esperienza estetica e innogenesi
disponibile al sito web http://www.ugomorelli.eu/doc/menterelazionale.pdf

Ostrom , Elinor , Governing the commons : The evolution of institutions for collective action
disponibile al sito web http://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf
Il Sole 24 Ore, Il futuro è l'opera narrativa in azione
disponibile al sito web
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-10-12/il-futuro-e-opera-narrativa-azione-081157.shtml?uuid=ABbk5P2B
TEDTalks
Heffernan, Margaret, The secret ingredient that makes some teams better than others TEDTalk, 2015
disponibile al sito web http://ideas.ted.com/the-secret-ingredient-that-makes-some-teams-better-than-others/
Ito, Joi, Want to innovate? Become a "now-ist" , TEDTalk, 2014
disponibile al sito web https://www.ted.com/talks/joi_ito_want_to_innovate_become_a_now_ist
Robinson, Ken, Do schools kill creativity?, TEDTalk, 2006
disponibile al sito web https://www.ted.com/playlists/171/the_most_popular_talks_of_all
Libri
Aime,Marco, Il primo libro di antropologia, Einaudi, Torino 2008
De Biase, Luca, Homo pluralis. Essere umani nell’era tecnologica, Codice edizioni, Torino 2015
Farinelli, Franco, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Einaudi, Torino 2003
Latouche, Serge, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Bordigheri, Torino 2008
Latouche, Serge, L’invenzione dell’economia, Bollati Bordigheri, Torino 2010
Latouche, Serge, La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano 2007
Morelli, Ugo, Il conflitto generativo, Città nuova editrice, Roma 2014
Morelli, Ugo, Mente e paesaggio. Una teoria della vivibilità, Bollati Bordigheri, Torino 2011
Morelli, Ugo, Mente e bellezza. Arte, creatività e innovazione, Umberto Allemandi & C. editore, Torino 2010
Rockström, Johan, Natura in bancarotta. Perché rispettare i confini del pianeta, Edizioni Ambiente, 2014