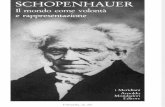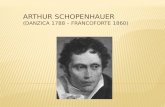Instagram come volontà e rappresentazione
-
Upload
elena-tosato -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
description
Transcript of Instagram come volontà e rappresentazione

Instagram come volontà e rappresentazione
Dialogo tra Socrate e Mimesio
Raccolto e trascritto da Elena Tosatohttp://unaltraversione.blogspot.it
1

Socrate: Eccoti dunque, Mimesio. Ti ho cercato tutto il giorno per discorrere con te, ma non riuscivo a trovarti.
Mimesio: È un periodo che me ne sto per conto mio, Socrate. Mi sento angustiato e triste.
Socrate: Ti conoscevo come uomo saggio e virtuoso, amante della compagnia e dei discorsi. Che t’è preso dunque?
Mimesio: Duro è il trascorrere del tempo, qui tra le ombre dei trapassati, o Socrate.Socrate: È da vedere, o Mimesio: tra i vantaggi c’è il fatto che possiamo vedere come è
andato avanti il mondo, e conoscere noi stessi in base a quanto apprendiamo.Mimesio: Non v’è dubbio, o Socrate. Purtuttavia, oggi la mia condizione di defunto mi
duole.Socrate: Siamo morti ormai da quasi duemilacinquecento anni, o Mimesio.Mimesio: Dici bene, ma solo adesso ne assaporo per intero l’amarezza. Socrate: Perché mai, Mimesio? Mimesio: Perché solo oggi mi interrogo appieno sull’esistenza e sulla qualità della mia
immagine come ombra dei vivi, o Socrate. Mi chiedo se la mia parvenza possa essere puro pensiero o sia ancorata al mondo sensibile e, nel caso, di come lo sia.
Socrate: Vediamo ombre proiettate dal fuoco, amico mio. Forse non siamo che quello. Pensa all’analogia tra ciò che è il bene per l’intelletto e ciò che è il sole per la vista.
Mimesio: Siamo artefatti, noi, forse?Socrate: Se ti riferisci all’arte come imitazione della natura, allora...Mimesio: Ma quale imitazione, caro Socrate: quel che mi angustia è molto peggio.
Trattasi, lo vedi, di questa applicazione per cellulari...Socrate: Oh, ma è Instagram. La conosco. E perché ti angustia, o Mimesio?Mimesio: Dovrò partire da lontano, o Socrate, e dire tante cose.Socrate: E sia. Debbo però confessarti di non essere appassionato di fotografia. Mimesio: Ma non ne parlerò, non almeno di questioni tecniche.Socrate: Da dove intendi cominciare, allora?Mimesio: Dalle immagini e da chi le produce.Socrate: Uh! Questa è davvero una questione tanto grossa quanto spinosa. Temo che chi
produce immagini non conosca gli oggetti veri, e che non sia adatto all’educazione dei cittadini, Mimesio.
Mimesio: Il mio discorso va oltre, ed è ancor più tragico e doloroso, Socrate.Socrate: Allora mi accingo a seguirti e a cercare di capire.Mimesio: Partirò dunque non dalle fotografie, ma da un quadro. Il corpo di Cristo
morto nella tomba è un’opera di Hans Holbein il Giovane, pittore e incisore tedesco che lo dipinse nel 1521. Il quadro è tuttora esposto al Kunstmuseum di Basilea: è una
2

tavola lunga e stretta, orizzontale, in cui è ritratto il cadavere di Gesù prima della resurrezione, livido, con la bocca e gli occhi aperti e le membra rigide. Tre secoli e mezzo più tardi, nel 1889, il dipinto entra nella storia della letteratura attraverso le pagine dell’Idiota di F. Dostoevskij, che come è noto parla della storia del principe Myskin, l’Idiota del titolo, uomo epilettico e intrinsecamente buono, la controfigura russa di Cristo, fulcro della concezione messianica e della visione apocalittica di Dostoevskij; Myskin è il latore del messaggio di Cristo nel XIX secolo, l’uomo secondo il quale “la bellezza salverà il mondo”. Il dipinto di Holbein fa la sua comparsa sotto forma di una riproduzione davanti alla quale Myskin - che, come Dostoevskij, ha visto l’originale in Svizzera - si ferma a discutere con il tormentato Rogozin e tramite la quale l’essenza e la missione del principe trovano una loro espressione. Così racconta l’autore:
“Mi piace guardare quel quadro,” mormorò, dopo un po’ di silenzio, Rogozin, come se avesse già dimenticato la sua domanda.“Quel quadro!” esclamò il principe, colpito da un pensiero subitaneo: “quel quadro! Ma quel quadro a più d’uno potrebbe far perdere la fede!”“Si perde anche quella,” confermò in modo inaspettato Rogozin. [...]Con che aria tetra Rogozin aveva detto poco fa che ‘perdeva la fede’! Quell’uomo doveva soffrire profondamente. Diceva che ‘gli piaceva guardare quel quadro’: no, non gli piaceva, ma sentiva il bisogno di guardarlo. Rogozin non era solo un’anima appassionata, era anche un lottatore: voleva riconquistare per forza la fede perduta. Ne aveva bisogno fino al tormento... Sì, credere in qualche cosa! credere in qualcuno! Eppure com’era strano quel quadro di Holbein!
Socrate: Conosco il romanzo, conosco anche il quadro. Della bellezza ho già parlato con Ippia, come ben sai. Il bello non è l’utile, non è l’appropriato. Le cose belle sono difficili.
Mimesio: Certo, ma non è tanto sulla bellezza che intendo soffermarmi, quanto su altre qualità. Che un’immagine possa tanto, in letteratura lo si sa da tempo: in versione salvifica, con Perseo che può guardare Medusa solo riflessa nello scudo, tema a sua volta ripreso nelle arti figurative innumerevoli volte; oppure come dannazione e scaturigine per una crisi identitaria, basti pensare a Vitangelo Moscarda in Uno, nessuno e centomila di Pirandello e alla sua reazione davanti alla propria immagine ritratta dallo specchio. (“Mi pende? a me? il naso?”)
3

L’argomento fa parte dei tanti problemi legati alla rappresentazione. Dicono, e me ne sono persuaso, che il mondo non esista se non come rappresentazione, fatta ad opera di un soggetto che tutto conosce e che da nessuno è conosciuto, che non sta nello spazio e nel tempo: dove finisce il soggetto comincia l’oggetto, che come tale è sottomesso al principio di ragione.
Socrate: Invero io ti seguo, Mimesio. La materia non è rappresentabile al di fuori dello spazio e del tempo. Ma mi pare che tu ti stia allontanando dalla meta che ti eri preposto.
Mimesio: Ho pur detto, ahimè, o Socrate, quanto il percorso sarebbe stato tortuoso! Ma io intesi, un tempo, tutto il mondo anche come volontà: tutto è volontà, sicché l’idea è l’oggettivazione di quella volontà. Ed è l’arte a riprodurre le idee eterne che ha afferrato tramite la contemplazione pura, strappando l’oggetto della sua contemplazione dal mondo e tenendolo isolato davanti a sé.
Socrate: E qui arriva il tuo cruccio a proposito di Instagram, non è vero?Mimesio: Quasi ci sono arrivato. La rappresentazione grafica è un fatto che crea da
sempre guai agli uomini: se ti ricordi i problemi delle prime carte geografiche...Socrate: Eccome. Conobbi, in vita, solo i risultati di Anassimandro; ma so che in
seguito Ipparco ed Eratostene ebbero i loro grattacapi.Mimesio: Esatto, o Socrate: vi sono intrinseci problemi topologici, nonché proiettivi,
che implicano sempre una distorsione di almeno uno dei parametri rappresentati. Socrate: Ricordo con sgomento la volta in cui cercai di far comprendere a uno schiavo
imbecille il teorema di Pitagora, o Mimesio. Sudo ancora freddo.Mimesio: Perfetto, mio caro Socrate! Ci intendiamo a meraviglia, noi due. Il tutto è
ovviamente cruciale nei campi più disparati. Rappresentazioni che interagiscono con i personaggi, o direttamente con le leggi che descrivono fisicamente il mondo. A questo proposito pensiamo infatti a quel che succede in matematica, oltre al ben noto concetto di immagine di una funzione e ai problemi legati alla proiezione: basti considerare in tal proposito il teorema di Frigyes Riesz sulla rappresentazione in analisi funzionale, che stabilisce il legame tra uno spazio e lo spazio dei funzionali lineari su di esso (cioè il suo duale), oppure il concetto di ritratto di fase, elemento chiave per la lettura del comportamento dei sistemi dinamici, che prevede la rappresentazione delle traiettorie nello spazio delle fasi, ossia nello spazio i cui punti determinano univocamente la posizione e la velocità di un oggetto, e nel quale si possono vedere graficamente le particolarità del sistema, dagli equilibri agli stati di instabilità; o ancora, in maniera più profonda e basilare, alle questioni sul denotare e sulle classi discusse da Russell nei suoi Princìpi.
4

Socrate: Io sono stato ritratto come torpedine e come Sileno, pensa un po’ come mi devo sentire.
Mimesio: A ciascuno il suo, Socrate...Socrate: Ma prosegui pure nel tuo discorso, Mimesio. Comincio a capire dove vuoi
andare a parare.Mimesio: In letteratura non c’è solo Dostoevskij a parlare di un ritratto e della sua
potenza evocativa. Ci sono anche opere, ti dicevo poc’anzi, in cui il ritratto interagisce direttamente con i personaggi, diventando esso stesso parte fondante del tessuto narrativo. Te ne voglio citare quattro. Tre sono racconti: in ordine cronologico, il primo è Il ritratto di Nikolaj Gogol’, che è del 1835. La storia è quella di un pittore, tanto squattrinato quanto ambizioso e talentuoso, che acquista da un rigattiere un vecchio dipinto raffigurante un vecchio misterioso:
Il ritratto sembrava incompiuto, ma la potenza della pennellata era eccezionale. Più straordinari di tutto erano gli occhi: pareva che l'artista vi avesse messo tutta la forza del suo pennello e tutta la passione della sua arte. Essi guardavano, guardavano, si sarebbe detto, fuori del ritratto, quasi distruggendone l'armonia con la loro strana vivezza.
Il quadro, va da sé, possiede una malia tale da influenzare la vita del pittore; gli occhi dell’uomo raffigurato dardeggiano nel buio fino a turbarne i sogni, ed oltre a ciò il ritrovamento di un rotolo di monete d’oro all’interno della cornice cambia le prospettive economiche del giovane, che si dà quindi alla bella vita. Abbandonata l’arte intesa come talento e ricerca, si fa strada nella buona società in qualità di ritrattista convenzionale e compiacente: la felicità completa, però, non arriva. Anzi, a tradimento lo coglie l’invidia per un suo allievo, che ha continuato a studiare per perfezionare la propria tecnica e la propria espressività, e non ha ceduto alle lusinghe del denaro facile; impazzito dal dolore, il pittore si lascia andare a una furia iconoclasta che distrugge tutto quello che ha guadagnato in anni di carriera, fino a morirne. Il quadro viene successivamente messo all’asta e qui se ne apprende la storia: la sfortuna ha sempre perseguitato chi ne è stato possessore, quasi avesse contratto un patto col diavolo, in un concatenarsi di storie disgraziate che sembra non aver fine: Gogol’ lascia il finale minacciosamente aperto.Un paio d’anni dopo, da tutt’altra parte del mondo, Nathaniel Hawthorne dà alle stampe il racconto I ritratti profetici. Qui è una giovane coppia di fidanzati che, in previsione del prossimo matrimonio, ingaggia un rinomato pittore affinché li ritragga. La fama del pittore si è fatta strada fra le colonie, dove il talento artistico è tanto raro; e i ritratti sono davvero particolari e ben fatti.
5

Egli aveva scrutato nelle loro anime con l’osservazione più penetrante, e ne aveva dipinto le conclusioni sui loro lineamenti, co quella estrema abilità che la sua severa concezione mancava solo per quella misura che nessun genio mai raggiunse. Egli aveva tolto dalle tenebre del futuro, almeno così immaginava, un terribile segreto, e l’aveva oscuramente rivelato sui ritratti.
L’inquietudine espressa dai due ritratti è una profezia che si avvera: i due fidanzati, diventati ormai marito e moglie, si lasciano plasmare dalle loro immagini, fino ad un epilogo tragico cui assiste il pittore stesso.
Socrate: Ahimè no! Questa è una narrazione falsa, Mimesio. Inutile incolpare quadri, destino o dèi di quel che accade di noi, quando sono le nostre scelte a portarci al delitto. La storia di Er non ti ha detto nulla?
Mimesio: Mi faccio interprete della narrazione di un barbaro, Socrate. Nulla più.Socrate: Possa quest’uomo scegliere di reincarnarsi in un corpo più saggio.Mimesio: Sempre che si possa davvero: noi due siam qui da ben più di mille anni, e non
ci è stato dato di scegliere uno straccio di corpo nuovo. La strada della filosofia è dura, o Socrate! Ma non è ancora concluso il mio elenco...
Socrate: Ben lo so: dovevi parlarmi di quattro storie, ne hai toccate soltanto due. Continua, te ne prego, Mimesio.
Mimesio: Ebbene! Non ci allontaniamo di molto né nel tempo né nello spazio. Arriviamo al 1842 e ad Edgar Allan Poe con il suo racconto Il ritratto ovale. Anche qui, la storia parla di un pittore che si mette a comporre l’immagine di una fanciulla, che diviene poi sua moglie. Il ritratto lo ossessiona: carpisce l’anima della moglie, e quando lui completa il ritratto, lei muore.
Ed egli non voleva vedere come i colori che stemperava sulla tela, erano tolti dalle guance di quella che era seduta e posava presso di lui. E quando furono trascorse lunghe settimane e non restava ormai che ben poco da fare, null'altro che un ultimo tocco alle labbra e un tratto all'occhio, lo spirito della giovane donna palpitò ancora un istante come l'ultimo guizzo della fiamma d'una lampada. E allora il tocco fu dato e il tratto fu posto, e per un momento il pittore si trattenne in estasi davanti il proprio quadro – quel quadro che egli stesso aveva dipinto; ma un momento appresso, mentre egli stava tuttora contemplando, prese a tremare, si fece pallido in viso e, come colpito di repentino spavento, gridando con voce possente: “Davvero è la vita stessa!”
6

Socrate: Uh! Una resa pittorica migliore dei grappoli d’uva dipinti da Zeusi, da quel che mi par di capire.
Mimesio: E di quanto! Finisce il ritratto, muore la persona che vi è ritratta. È più che possibile che Oscar Wilde conoscesse questo racconto, quando nel 1891 scrisse il quarto esempio che voglio portarti, Socrate, e che di gran lunga il più noto ai mortali: si tratta di un romanzo, Il ritratto di Dorian Gray. La storia la conoscono tutti. Dorian è un giovane innamorato della propria bellezza al punto di farne un culto, ed esprime il desiderio che sia il suo ritratto ad invecchiare in sua vece, caricandosi addosso anche tutta la malvagità e la sua corruzione morale, fino al delitto.
Socrate: Confesso che avrei dialogato volentieri con Henry Wotton.Mimesio: E sarebbe stato un bel dialogo, Socrate. Socrate: Chissà che non se ne riparli! Ma ti ho interrotto di nuovo. Perdonami.Mimesio: Sì, ritorno al punto. Dice Wilde:
Una volta gli faceva piacere osservare il suo mutarsi e invecchiare, ma negli ultimi tempi non provava più alcun diletto. Gli aveva fatto trascorrere notti insonni; quando era lontano rabbrividiva all’idea che altri occhi potessero guardarlo. Aveva rattristato le sue passioni, il suo ricordo gli aveva guastato tanti momenti di gioia. Era stato per lui come una coscienza, sì, era stato la sua coscienza. L’avrebbe distrutto.
È invero un’interazione suprema tra il segno e il significato, tra l’artefatto e la realtà! Tra la bellezza, oserei dire, e la morte e l’immoralità.
Socrate: La morale è materia troppo importante per lasciarla agli artisti, mio caro Mimesio. E sono più che sicuro che sarebbero essi stessi d’accordo con me! Lasciamoli dunque ai loro ritratti e occupiamoci della rappresentazione del vero.
Mimesio: Ben più saggi eravamo noi greci, Socrate! E pensare che, almeno per la cultura di derivazione giudaico-cristiana, il ritratto nasce dall’avere infranto un divieto, che è quello di rappresentare figure umane: “Non ti fare nessuna scultura, né immagine delle cose che splendono su nel cielo, o sono sulla terra, o nelle acque sotto la terra” (Esodo, 20, 4), anche se si cominciarono a fare distinzioni tra statue intere e mutile, tra intagli e rilievi, e anche se l’iconoclasi ebbe, per quanto riguarda le immagini sacre, alterne fasi di fortuna, scontrandosi con la tradizione classica, poi mutuata dai bizantini, di rappresentare figure umane, sante, civili o divine che fossero, con una funzione commemorativa, celebrativa o didattica, almeno secondo la descrizione che Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia fa della destinazione del ritratto; la problematica di rappresentare figure, legata al rapporto con il divino, è presente anche in altre culture, dall’islam alle religioni orientali - sette iconoclastiche
7

si hanno tra i buddisti e tra i giainisti, tanto per dirne due, ma per quel che ci riguarda resteremo all’occidente. Scansando il divieto biblico la rappresentazione umana si fa dunque strada tra i primi autoritratti di artisti o nei ritratti degli amanuensi tra il sesto e l’ottavo secolo, e poi nella corte di Federico II, nell’occidente carolingio sotto forma di statua-reliquiario, nelle corti italiane ed europee nel Trecento, e sfocia poi nel Quattrocento e nel Cinquecento, con l’ascesa della borghesia, per avere una maggiore complessità narrativa e sostegno teorico pieno, da Pisanello a van Eyck; per il Trattato della pittura di Leonardo la pittura “è una poesia che si vede e non si sente” “ti si rappresenta con quella dimostrazione per la quale il suo fattore l’ha generata, e dà quel piacere al senso massimo, qual dare possa alcuna cosa creata dalla natura”. Ancora, “La deità che ha la scienza del pittore fa che la mente del pittore si trasmuta in una similitudine di mente divina”; in seguito l’autore si perita di spiegare per filo e per segno come si debbano ritrarre i volti, e i corpi, e i movimenti; le donne e i vecchi, i riflessi della carne.Realtà e astrazione, sintesi e simbolismo si danno vicendevolmente il cambio; al classico ritratto si affiancano ormai caricature (da Carracci a Daumier) e miniature. Immediatezza e idealizzazione, realismo borghese e indagine psicologica, fino a finire con l’alterazione del soggetto dall’espressionismo in avanti, segnano la storia della ritrattistica.
Socrate: E tutto questo si ripercuote nella fotografia, almeno, vuoi intendere tu, in quella versione social che è veicolata da Instagram.
Mimesio: Sì, o Socrate; ma voglio dire di più. Instagram è l’apoteosi della visibilità come tale, senza che il bello sia stato preventivamente concettualizzato, senza alcun richiamo all’idea assoluta. È la diluizione del ritratto. Conosci come è cominciato il tutto: una banale applicazione per apporre filtri vintage alle proprie fotografie digitali, che è evoluta poi in un mezzo diabolico per la diffusione dei propri artefatti, come spore d’un fungo trasportate dall’etere. Sono tutte etichettate, le puoi cercare, le puoi seguire, le puoi condividere. E la cosa più spettacolare, e se vuoi anche inquietante, Socrate, è che le foto così filtrate sono così comuni, così immediate nel loro messaggio, che prendono il posto del reale.
Socrate: Mi sembra di essere tornato ai vecchi tempi. Ah... la chiara luce del mattino ateniese, i rumori dell’agorà, lo sciabordio delle acque, lì, al Pireo. Si ritorna sempre a parlare dei problemi del Vero, caro Mimesio.
Mimesio: Ai problemi del Vero, carissimo Socrate, e a tutti quelli connessi alla teoria dell’errore e alla modellizzazione, e alla riproducibilità, alla falsificabilità e alla consistenza. È che di processi cognitivi e di linguaggi non sappiamo mai abbastanza, non trovi?
8

Socrate: Condivido la tua opinione, per quanto la possa comprendere. Lo dico con dolore.
Mimesio: Diceva Walter Benjamin che “l’intero ambito dell’autenticità si sottrae alla riproducibilità tecnica”, la riproduzione non viene bollata come falsa, va incontro al fruitore; e l’autenticità è ciò che può essere tramandato, come durata materiale e come testimonianza storica. Nel caso di Instagram, il fruitore dell’applicazione diventa interprete e artista a sua volta - anche senza, ahimè, nessuna perizia tecnica o benché minimo buon gusto - e gli viene dato modo di impossessarsi e manipolare la realtà senza averla necessariamente prima capita, bensì solo mediata tramite filtri preconcetti in una urgenza di testimonianza dell’attimo comune che non è molto dissimile dal marcare il territorio, e che ne ha la ritualità: è questa ritualità che rende autentica la foto condivisa, in una sorta di iconodulia social. Del resto, la familiarità con i filtri e l’intuitività dell’utilizzo dell’app (che sono chiave del suo successo) ostacolano l’acquisizione di una comprensione razionale: non ci si pensa, sono già lì, ci hai già fatto l’abitudine. La storia della fotografia non fa testo: al più l’iconografia di riferimento è mutuata dalla televisione commerciale, divertente nella sua noia prevedibilmente accessibile, o dai videogames, senza però il talento e la sperimentazione che sono presenti nel videogame di buon livello. L’arte ci potrebbe essere, ma non se ne sente l’esigenza (e qui puoi trarne le conseguenze estetiche, intellettuali, politiche e morali che preferisci). Rimpinzata di hashtags e condivisa in rete, si celebra la propria immagine come merce di consumo, il compimento dell’estraniazione estetizzante, altro che imitazione della natura, o Socrate. L’altro giorno sono rimasto due ore a guardare immagini quadrate di bizzarri poeti giambici, ornati di pesanti monili d’oro e attorniati dalle loro etere; la veste delle fanciulle appariva barbaramente strappata...
Socrate: Dicono si tratti di rapper, o Mimesio. Sono autori di una derivazione della lirica monodica, cultori della poesia giambica, interpreti di un genere che peraltro ha avuto anche momenti di funzionalità politica e sociale.
Mimesio: Io bado alle immagini, Socrate, ché di queste si parla. L’estetica che ne esce fuori è tale: se consideriamo l’immagine filtrata in Instagram come processo di autosviluppo formativo dello spirito e come sua liberazione (Bildung, si sarebbe detto un tempo), e se lo scopo della fotografia filtrata e pubblicata è, in quanto pretesa opera d’arte, quello di rivelare la verità sotto forma di configurazione artistica sensibile, se ne deduce che la manifestazione dello spirito che pensa se stesso ha molto a che fare con: la quotidianità della propria faccia, dei propri piedi, della propria ebbrezza alcolica (ma privata dello scandalo, quindi svuotata), del proprio cibo di riferimento, del proprio specchio del bagno, del proprio tramonto e del
9

proprio amore - oltre che, ovviamente, trattandosi di internet, del proprio animale domestico, meglio se debitamente antropomorfizzato. Insomma, se la grandezza è ciò che deriva da una lunga meditazione, qui siamo all’anti-sublime: nonostante l’autore degli scatti sia spesso preda di entusiasmo e di un pathos disordinato, si scade spesso e volentieri nella sciatteria inconsapevole, anche a causa della standardizzazione dei filtri che svuota in parte l’attività autocosciente. L’annientamento di tutto ciò che è magnifico e grande non si risolve nell’ironia, nonostante ogni immagine proponga una vacua, vana manifestazione della soggettività. Detto fuor di filosofia, è come quando venti o trent’anni fa si era costretti a casa di amici e parenti a guardare le diapositive delle vacanze, fatto in sé che deve aver rovinato più di qualche rapporto umano e che è minante per ogni ipotesi di tenuta del contratto sociale, o almeno per la tenuta dei miei account Facebook e Twitter, in quanto le fotografie sono o prive di significato universale o brutta interpretazione di tale significato, e comunque imposizione di una affezione soggettiva.
Socrate: Se mi ricordo, o Mimesio! Ancora mi sento male se penso a certe serate a guardare le diapositive delle vacanze di Protagora. C’era solo lui, sempre lui, tutto che si commisurava alla sua figura...
Mimesio: Vedi? Adesso lo chiamano selfie. E poi bisogna considerare la scelta del formato: le foto di Instagram sono quadrate, il che è un richiamo vintage che rimanda alle polaroid; come le polaroid, si tratta di lingua franca visuale, immediatamente riconoscibile; e come ammiccamento rétro, la composizione dei ricordi predomina sull’esigenza creatrice.
Socrate: L’evocazione del ricordo tramite l’oggetto sensibile o la sua rappresentazione, Mimesio, mi sembra possa condurre l’uomo alla conoscenza delle idee eterne. È l’immortalità dell’anima, che si manifesta così, mio buon amico: le idee già presenti nella tua anima vengono riscoperte gradualmente nel tuo intelletto.
Mimesio: Sì, Socrate, ma se la composizione dei ricordi sovrasta la curiosità di scoprire oltre, la memoria, dall’essere una necessità storica, diventa uno strumento esclusivo e potenzialmente reazionario. Per tornare all’interazione con chi guarda, con cui avevo cominciato il mio discorso, in queste immagini io riscontro la perdita o la presenza di una capacità ammaliante o evocatrice come poteva essere il Cristo di Holbein, il ritratto di Dorian Gray, o almeno l’utilità di un ritratto di fase: le foto comunicano con il fruitore, in un metaromanzo che si svolge sui social network e celebra, in fondo, solo se stesso; la profusione di immagini è tale da sfondare ampiamente la soglia dell’ipertrofia e dell’inservibilità, si rischia di togliere all’oggetto-foto anche la sua singolarità
10

sensibile o intuizione singola, benché più d’uno si senta, magari inconsapevolmente, una diabolica sintesi tra Helmut Newton e il protagonista di un reality o di un talent, o - se proprio va bene - un apologeta e un estensore dello screen test di Warhol. È comunque un’altra delle tante facce del feticismo tecnologico che ha, a dispetto di tutto, poco di scientifico e molto di religioso, o al più qualcosa di futurista, banalizzato e ripassato dai filtri dell’immagine, o qualcosa di facilone e tanto bisognoso quanto carente di analisi serie, un mezzo ove tutto si immagina e tutto, in teoria, si costruisce, a prescindere dalla puntuale smentita dei fatti.
Socrate: Ma non è di questo soltanto che ti preoccupi, dell’ammaliamento, non è vero? Ti preoccupa la fruibilità e la diffusione di questo meccanismo. L’abbattimento dei costi si è riflesso su quello del valore, dunque? È questo che, in quanto sofista, ti cruccia?
Mimesio: Non in quanto sofista, in quanto uomo. E temo che la tua domanda rimarrà irrisolta. Questa immagine quadrata desta l’animo? Comunica il contenuto, o è solo apologia del contenitore?
Socrate: Ti chiedi dunque se vi sia un fine sostanziale.Mimesio: È così, Socrate.Socrate: Solo questo? Non ti preoccupa anche la durata di tale fenomeno? Della
potenziale eternità promessa dal supporto? Aggiungo: sostiene il tuo Walter Benjamin, nello stesso testo che hai citato in precedenza, che “l’adeguazione della realtà alle masse e delle masse alla realtà è un processo di portata illimitata sia per il pensiero sia per l’intuizione”. Ti chiedo quindi: le immagini elaborate tramite Instagram e condivise tramite social network (adesso, in futuro chissà) - al netto di tutti i problemi di censura e privacy che internet si porta dietro, e per i quali all’epoca mi sarebbe stata comminata con ogni probabilità un’altra tazza di cicuta - sono vittima della caducità?
Mimesio: Mi sovviene a questo riguardo, Socrate, quel dialogo che Leopardi fece sostenere alla Moda e alla Morte. Lo ricordi? Sorelle, perché entrambe figlie della caducità, nonostante la Morte dica di sé di essere nemica capitale della memoria, ma entrambe destinate a rinnovare continuamente il mondo con il loro operato. La Moda, anzi, sottolinea la propria potenza! E quindi ho sperato e tuttora spero, Socrate, che sarà ancora la Moda, se non la Morte, ad avere ragione di questo obbrobrio di fotografie ipersemplificate, di comunicazione urlata, leziosa, precostituita, figlia di un benessere benedetto e avido. Ma allo stesso tempo temo che verrà poi qualcosa di simile, o addirittura di peggio. Non devi pensare che io sia un nostalgico dei tempi passati, Socrate; anzi, son tanto curioso e speranzoso dei nuovi
11

che rimpiango di essere morto. Ma vorrei tanto che la complessità non fosse demolita e irrisa.
Socrate: Parli bene; non lo vorrei nemmeno io.Mimesio: E forse ho addirittura sbagliato a tirare in ballo l’arte, sai? Per quanto
Instagram non sia un progetto artistico, lo oltrepassa addirittura, influisce sul nostro modo di comportarci, di vedere e quindi di esprimerci.
Socrate: Esprimersi lenisce gli affanni, e poi ne crea di nuovi.Mimesio: Io penso questo, Socrate. Sono immagini che vivono nella Stimmung della
frammentazione, nell’emozione immediata che è a suo modo esperienza religiosa e tragica, e mi chiedo se ormai non sia da considerarsi insanabile la cesura tra etica ed estetica. Mi chiedo, guardando queste terribili fotografie quadrate, se siano lecite le domande sull’essere e sull’esistere, o se esse stesse, le immagini dico, non siano il monito che scolpisce in noi l’angoscia rivelatrice del Nulla.
Socrate: Mi diventi esistenzialista, Mimesio?Mimesio: Ma sai, forse è vero che credere che esistiamo per essere felici è un grande,
colossale errore innato. E che sbagliavi a pensare alla felicità come piacere della conoscenza, oddio, scusami Socrate, divento amaro: nascere è una colpa, essere fotografati un accidente, appoggiarsi a filtri di altrui coscienza un vizio, forse un’ignavia, ma la diffusione compulsiva di tutto ciò è una tragedia.
Socrate: Parli bene, Mimesio: ridotti come siamo a un brullo piattume senza speranza, zattere smarrite tra i flutti della felicità e della disperazione, vaghe approssimazioni della trascendenza dell’apparire di ciò che appare, da cui non si possa trarre né insegnamento né consolazione, né riduzioni eidetiche! Gli uomini hanno interiorizzato l’amara intenzione di non essere altro che conati, suoni inarticolati e grezzi; sono, nonostante i filtri oppure proprio a causa di essi, monumenti all’indiscernibile. Ahimè! Mi appellerò al mio Daimon per tirarmi su di morale. Mi domando infatti quale sia la mia preoccupazione attorno al cogitare e al percipere, e suppongo dovrò ragionarci un bel po’.
Mimesio: Non mi perdi l’ironia, Socrate.Socrate: Be’, in effetti, dopo duemilacinquecento anni uno comincia anche un po’ a
rompersi, Mimesio. Mimesio: Te l’avevo detto che era dura, quaggiù, Socrate.Socrate: Eh.
© Elena Tosato, febbraio 2014
12

Bibliografia
Anonimo, Del sublime, a cura di G. Guidorizzi, Mondadori, 1991V. I. Arnold, Metodi matematici della meccanica classica, trad. di R. Bernieri e B. Tirozzi, Editori Riuniti
1979 e 2010W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, (1955)
trad. it di Enrico Filippini, Einaudi, 1966, 1991 e 1998L. Da Vinci, Trattato della pittura, a cura di A. Borzelli, Carabba editore, 1947F. Dostoevskij, L’idiota, trad. di A. Polledro, Einaudi 2005N. Gogol’, Il naso - Il ritratto, trad. di T. Landolfi, BUR, 1989J. Goody, L’ambivalenza della rappresentazione, trad. di M. Gregorio, Feltrinelli, 1997N. Hawthorne, Wakefield e altri racconti, trad. di E. Montale, Bompiani 1994-2012V. Heffernan, How we all lerned to speek Instagram, 2013, in Wired: http://www.wired.com/magazine/
2013/04/Instagram/G. W. F. Hegel, Estetica, trad. di N. Merker, N. Vaccaro, Einaudi, 1978S. Kierkegaard, Aut-Aut, trad. di K.M. Guldbransen e R. Cantoni, Mondadori, 1993G. Leopardi, Operette morali, Feltrinelli, 1976, 1992, 1999L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Garzanti, 2007Platone, Repubblica, trad. di N. Marziano e Giorgio Verdi, Mursia, 1990Platone, Opere complete vol. 5: Eutidemo - Protagora - Gorgia - Menone - Ippia maggiore - Ippia minore - Menesseno, trad. di F. Adorno, Laterza 2003E. A. Poe, I racconti (1831-1849), trad. di G. Manganelli, Einaudi, 2009W. Rudin, Real and Complex Analysis, McGraw-Hill, 1970B. Russell, I princìpi della matematica, trad. di E. Carone e B. Destro, Newton Compton editori, 1971,
1989 e 2008A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. di P. Savj-Lopez, G. De Lorenzo,
Laterza, 2009O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, trad. di U. Dettore, BUR, 1951, 1975 e 1989A.W. Wood, Hegel on Education (1998) in www.stanford.edu/~allenw/webpapers/
___________________________________________Copertina: Testa di Socrate, marmo, opera romana, I secolo, forse copia di un bronzo di Lisippo. Conservata al Musée du Louvre, Parigi. Immagine tratta da Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Socrates_Louvre.jpgElaborazione grafica di Elena Tosato, sullo spunto dell’immagine dell’articolo di Wired citato in bibliografia.Incidentalmente, Socrate fu il primo filosofo di cui sia stato fatto un ritratto.
Rilasciato sotto licenza Creative Commons 3.0 - Attribuzione, non commerciale, non opere derivate.
13