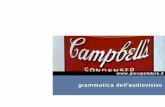Inquadrature
-
Upload
ada-manfreda -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Inquadrature

giovedì 7 ottobre 2010L’L’ultima
12ilPaese
nuovo
Nota all'illustrazione
Riviste/ Amaltea
È consultabile suwww.amalteaonline.com
il numero 3,del trimestrale di cultura
Amaltea, giuntoal suo quinto anno
di pubblicazione.Proponiamo alla vostra
attenzione l'editoriale deldirettore Ada Manfreda
Inquadrature• Ada Manfreda
i può imbellettare uno scenario di spiaggia e mare deturpato, facen-dolo vedere per come non è, tagliando fuori i particolari scomodi. Bastaun’inquadratura opportuna per cancellare lo scempio. Ma ancor più, si puòcostruire un’inquadratura nell’inquadratura, che disvela lo scempio e ri-flette contemporaneamente sullo statuto dell’inquadratura, sul suo potere:di velare, di svelare e ancora di svelare il suo potenziale di velamento.
Frammenti di realtàInquadratura: ovvero decontestualizzazione di un frammento di realtà
dalla realtà. Interpretazione, o re-interpretazione. Immaginazione emer-gente dalla realtà, e da essa dettata, quasi, all’inquadratura.
È taglio, separazione di qualcosa da qualcos’altro.Inquadrando individuo una demarcazione tra un dentro e un fuori, trac-
cio dei confini, sottolineo differenze. Costruisco significati. Inquadrare èdare senso. O esserne raggiunti un attimo dopo: ci si può sempre sorpren-dere del senso inaspettato che si è trovato senza averlo cercato.
Il potere dell’inquadratura. Il potere di far esistere ciò che voglio, graziea ciò che metto dentro e a quello che lascio fuori. Il potere anche di far ve-dere l’invisibile incorniciando il visibile, un suo particolare angolo pro-spettico, un suo elemento, porte di accesso ad un ulteriore, a quello che losguardo vede non con gli occhi. Una bella inquadratura è quella che riescea trovare e isolare le porte di accesso al senso. Inquadrare e narrare.
L’inquadratura dice dello sguardo che guarda. Poi la fotografia, precipi-tato dell’inquadratura, oggettiva lo sguardo soggettivo, nel senso che locattura in un oggetto. Lo fa anche una videoripresa, cogliendo in più il di-namismo di quello sguardo soggettivo che guarda/inquadra/narra. Sguar-do e racconto.
S/guardareLo sguardo che guarda non è innocente. Perciò è racconto e non mecca-
nica ricezione.Lo sguardo dell’altro ci racconta. Ne abbiamo bisogno per scoprirci e
riconoscerci. Ci mette in gioco e noi possiamo giocarci. Grazie allo sguar-do dell’altro sappiamo di esistere. Il giochino dei bambini di far finta dinon vedere l’amichetto, anche se lui parla, grida, si agita davanti ai loro oc-chi, altro non è che un’esplorazione ludica (non per chi lo subisce) del po-tere dello sguardo di far o meno esistere qualcosa/qualcuno, di includere edi escludere, di accettare e rifiutare.
Lo sguardo dell’altro c’è sempre anche quando non c’è. Ci manifestia-mo nel mondo, con le nostre parole e con il nostro corpo riferendoci ad unpotenziale sguardo che ci guarda (ipotetico, a volte anche eccessivo, irrea-le o addirittura patologico). C’è anche quando ci proponiamo di ignorarlo:dobbiamo pur sempre rappresentarcelo per sapere quale inquadratura diquello sguardo stiamo rifiutando. Certo si può anche dipendere dallosguardo dell’altro, al punto da espropriarci di noi stessi: per compiacerequello sguardo, riscuoterne l’approvazione. È un rischio. È ambivalente illegame dello sguardo, tra chi guarda e chi è guardato. È solo in chi guardail potere di condizionare, determinare, possedere? Oppure è anche in chi èguardato: potere di indovinare lo sguardo che ti guarda e assecondarlo percondurlo, orientarlo, manipolarlo?
Lo sguardo co-implica biunivocamente chi guarda e chi è guardato: chiè guardato a sua volta guarda colui/colei che lo sta guardando; simmetrica-mente chi guarda è a sua volta fatto oggetto dello sguardo di colui/coleiche egli sta guardando.
Facciamo e rifacciamo e modifichiamo continuamente inquadraturedella realtà e degli altri e ne riceviamo.
Le pagine, la scritturaCos’è una rivista se non una carrellata di inquadrature? Che si succedo-
no, si confrontano, dialogano tra loro e con le inquadrature dei lettori? E iracconti, le storie? Noi stessi? L’inquadratura è una straordinaria metaforaper generare e alimentare discorsi, un luogo ad alta densità semantica.
E poi possiamo anche rifletterla la metafora, fare cioè – come abbiamofatto qui – l’inquadratura dell’inquadratura: un’operazione di secondo li-vello, che possiamo continuare ancora, ripetere, esplorando il terzo, ilquarto, il quinto, l’ennesimo livello.
La scrittura può proliferare all’infinito perché lo sguardo non cessa maidi guardare/inquadrare e di raccontare.
Lisette Model nasce a Vienna nel 1901 inuna famiglia benestante di origine ebreae prima di stabilirsi a �ew York dove in-
contrerà la sua fortuna artistica, vive quindicianni in Francia. Qui comincia a fotografare e lesue immagini sulla Promenade des Anglaisvengono pubblicate sulla rivista PM di �ewYork: uno strepitoso successo a cui seguono nu-merose mostre. Lisette collabora con Harper’sBazar e diventa docente della �ew School for
Social Research dove insegnerà fino al 1983,anno della sua morte. Tra i suoi allievi DianeArbus. L'opera di Model consiste in gran partein una straordinaria galleria di ritratti al con-tempo grotteschi e carichi di umanità, inaugu-rando uno stile fotografico “immediato” espontaneo volto ad immortalare gli aspetti effi-meri di una realtà in perenne mutamento. Conil suo lavoro di sguardo Lisette Model si è gua-dagnata un ruolo di spicco nell'ambito della co-
siddetta Street Photography newyorkese deglianni '40. �el 1942 scatta il suo clic più celebre:accovacciata con le mani sulle ginocchia, unadonna cannone sorride spavalda in costume dabagno. Dalle spiagge ai locali fumosi di musicajazz, dalle sfilate di moda ai quartieri di perife-ria, Lisette è costantemente alla ricerca di unarealtà che ai suoi occhi e ai nostri diventa poe-sia, disincanto, inquietudine, libertà assoluta.Scompare nel 1983
S