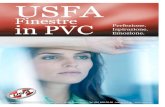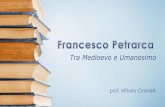Il tramonto della vita. [Sonetto 73] [Testo: W ...e+catullo.pdfEredità culturali.Il respiro dei...
Transcript of Il tramonto della vita. [Sonetto 73] [Testo: W ...e+catullo.pdfEredità culturali.Il respiro dei...
![Page 1: Il tramonto della vita. [Sonetto 73] [Testo: W ...e+catullo.pdfEredità culturali.Il respiro dei classici Nella sua ispirazione profonda il sonetto riecheggia fonti classiche di grande](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022092615/5ad822a07f8b9af9068d1ca2/html5/thumbnails/1.jpg)
Il tramonto della vita. [Sonetto 73]
[Testo: W. Shakespeare, Sonetti, a cura di G. Melchiori, versioni di A. Rossi e G. Melchiori,
Einaudi, Torino, 1963]
Il sonetto, ritenuto tra i più significativi della raccolta, svolge iltema della vecchiaia, contemplata
nell’uomo che si fa protagonista del testo e descrive, con successive metafore, il tramonto della sua
vita.
parole chiave: Tu, crepuscolo, tramonto, notte, morte, amore
motivi chiave: la contemplazione del tramonto, l’esortazione all’interlocutore metro: 12 decasillabi articolati in tre terzine a rime alternate e in un distico conclusivo a rima baciata.
Contempla in me quell’epoca dell’anno l’autunno della vita
Quando foglie ingiallite, poche o nessuna, pendono
Da quei rami tremanti contro il freddo,
nudi cori in rovina1, ove dolci cantarono gli uccelli.
Tu vedi in me il crepuscolo di un giorno, il tramonto del giorno
Quale dopo il tramonto svanisce all’occidente,
Subito avvolto dalla notte nera,
gemella della morte, che tutto sigilla nel riposo.
Tu vedi in me il languire di quel fuoco, lo spegnersi del fuoco
che aleggia sulle ceneri della propria giovinezza,
come sul letto di morte su cui dovrà spirare2,
Consunto da ciò che già fu suo alimento.
Questo tu vedi, che fa il tuo amore più forte, cogli l’attimo
a degnamente amare chi presto ti verrà meno.
(trad. Alberto Rossi e Giorgio Melchiori)
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang.
In me thou seest the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west,
Which by and by black night doth take away,
Death's second self, that seals up all in rest.
In me thou see'st the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed whereon it must expire
Consumed with that which it was nourish'd by.
This thou perceivest, which makes thy love more strong,
To love that well which thou must leave ere long.
l’autunno della vita
Guarda nella mia persona [in me] quella stagione dell’anno in cui le foglie ingiallite, ormai rare o
del tutto assenti, pendono dai rami che tremano al freddo, come le cantorie [cori] di una cattedrale
ormai in rovina, rami dove un tempo cantarono gli uccelli.
1. nudi cori in rovina: si tratta delle cantorie delle chiese, forse con riferimento ai cori lignei delle
abbazie, cadute in rovina dopo di Enrico VIII, che aderì alla Riforma, dopo essere stato a lungo
alleato del Papa. I rami degli alberi, che possono alludere alle membra ormai fragili della persona
anziana, e dove cantavano festosamente gli uccelli, sono deserti e perciò paragonati alle cantorie
abbandonate.
il tramonto del giorno
![Page 2: Il tramonto della vita. [Sonetto 73] [Testo: W ...e+catullo.pdfEredità culturali.Il respiro dei classici Nella sua ispirazione profonda il sonetto riecheggia fonti classiche di grande](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022092615/5ad822a07f8b9af9068d1ca2/html5/thumbnails/2.jpg)
Tu vedi in me il tramonto [crepuscolo] di un giorno, come [quale] dopo il tramonto svanisce lungo
l’occidente, subito inghiottito [avvolto] dalla notte, gemella della morte, che chiude [sigilla] tutto
nel sonno [riposo]
lo spegnersi del fuoco
Tu vedi in me l’indebolirsi [languire] di quel fuoco, che brucia debolmente [aleggia] sulle ceneri
della sua stessa giovinezza, come sul letto di morte su cui dovrà soffiare, consumato [consunto] da
ciò che prima lo alimentò [fu suo alimento].
2. fuoco... spirare: il fuoco che spira debolmente, cioè l’energia ormai spenta e il respiro lento
dell’anziano, languisce in una sorta di profezia dell’agonia.
cogli l’attimo
Tu vedi questo, che rende [fa] il tuo amore più valido [forte] ad amare profondamente [degnamente]
chi presto non ci sarà più [verrà meno].
Analisi. La contemplazione di un tramonto.
Una struttura bipartita. Il sonetto presenta una chiara suddivisione in due parti: nella prima,
costituita dai primi dodici versi, sono presentate diverse metafore, con alcune variazioni interne, che
esprimono la vecchiaia del soggetto che si rivolge a un tu, interlocutore fittizio chiamato ad
assistere al suo declino, e sottolineato dalla ripresa anaforica Tu vedi in me (In me thou seest). Nel
distico conclusivo, in un movimento inaspettato, l’esortazione, rivolta allo stesso personaggio, è un
invito ad amare, a godere del tempo rimasto, e destinato a concludersi repentinamente. Le terzine
sono scandite dalle immagini successive dell’autunno, non indicato esplicitamente, ma evocato da
due immagini, quella delle foglie ingiallite e quella dei rami tremanti, alle quali si abbinano altre
due immagini collegate, quella degli uccelli, che prima cantavano ed ormai hanno abbandonato i
rami tremanti, a loro volta paragonati ai cori delle chiese, deserti come i rami, ormai nudi e privi di
cantori. A questa serie di metafore segue l’evocazione della fine della giornata, prima indicata nel
crepuscolo, momento immediatamente successivo al tramonto, che precipita, in un lasso di tempo
assai più breve del tramonto, nella notte, esplicitamente indicata come gemella della morte, in una
successione chiusa dal termine riposo, rest, che assume il significato ambiguo del riposo della notte
e della morte: è dunque il riposo che chiude una vita, e nello stesso tempo quello che chiude la
giornata, a sua volta metafora dell’intera vita. L’ultima metafora coglie nell’immagine del fuoco
che languisce, non brucia, ma ormai aleggia, lo spirito, il respiro dell’anziano, presagio del suo
estinguersi sul letto di morte: l’evento, evocato prima in rapporto alla notte, diviene qui vero e
proprio cuore tematico, nel quale si chiude non solo la terzina, ma tutta la prima parte del sonetto.
Amare presto. L’esortazione conclusiva, che caratterizza il distico, muove dal deittico questo, this, richiamo oggettivo e concreto alla situazione descritta, per indurre l’interlocutore alla vita, espressa
dall’amore, cui è presente la minaccia della morte.
Interpretazione. L’ultimo fuoco prima del riposo.
La contemplazione del tramonto. Il sonetto è caratterizzato dall’esortazione rivolta
all’interlocutore fittizio, cui il poeta si rivolge, istituendo un continuo richiamo dal suo io al tu, che
è chiamato a guardare segni concreti dell’età ormai matura, rappresentati da metafore efficaci: sono
lo spegnersi della stagione viva nell’autunno, raffigurato dalle foglie ingiallite, il declinare del
giorno, colto nei momenti successivi di tramonto, crepuscolo e notte, a sua volta metafora della
morte, lo spegnersi del fuoco, che ormai svanisce sulla cenere e prelude anch’esso alla morte
contemplata nell’immagine fosca e definitiva del letto di morte, death-bed, anche questo richiamo
concreto, oggettivo all’atto conclusivo della vita.
L’esortazione all’interlocutore. Il tramonto della vita, quindi, non è considerato in una condizione
solitaria dall’io, ma oggettivato nel suo rapporto con chi gli sta di fronte, e da qui scaturisce l’invito
inatteso, la reazione forte ad amare ciò che dilegua, in un disperato attaccamento alla vita nelle sue
ultime espressioni. La fine del sonetto supera la sua netta ripartizione proprio grazie alla presenza di
questo interlocutore, che dà la motivazione vera di quel contemplare: non un rassegnato attendere la
morte, ma un estremo desiderio di vita e di amore, nella consapevolezza della fine imminente.
![Page 3: Il tramonto della vita. [Sonetto 73] [Testo: W ...e+catullo.pdfEredità culturali.Il respiro dei classici Nella sua ispirazione profonda il sonetto riecheggia fonti classiche di grande](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022092615/5ad822a07f8b9af9068d1ca2/html5/thumbnails/3.jpg)
Eredità culturali. Il respiro dei classici
Nella sua ispirazione profonda il sonetto riecheggia fonti classiche di grande impatto: l’immagine
della giornata che volge al tramonto, sovrapposta alla vita umana che declina nella vecchiaia,
deriva dalla lettura degli elegiaci latini, e di Catullo innanzitutto, con la sua consapevolezza che
mentre il tramonto del sole prelude a un nuovo giorno della natura, il sole della vita umana conosce
nella morte il tramonto definitivo. Analogamente sembra agire in questo testo l’ispirazione di
alcune odi oraziane, nelle quali alla contemplazione della natura nello scorrere delle stagioni, si
sovrappone la consapevolezza della vecchiaia imminente, quindi della morte, alla quale si deve
reagire amando e godendo le gioie effimere del banchetto, unica consolazione per la vita dell’uomo.
Nello schema classico della sovrapposizione tra la vicenda umana e quella naturale, che ha la sua
prima origine in Omero, subentra la consapevolezza che la vicenda delle stagioni è ciclica, e quindi
la vita della natura è un cosmo che si riproduce, mentre la vicenda umana, sentita nella sua
individualità e unicità, scivola verso il nulla. Negli antichi come nel poeta secentesco il sentimento
della natura può appagarsi dell’attesa di una nuova primavera, il sentimento della vita umana si
effonde nel desiderio di un ultimo aggrapparsi all’amore come reazione vitale.