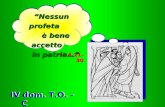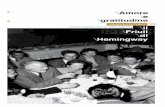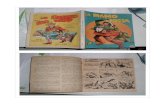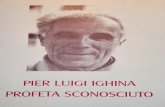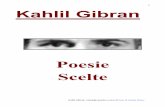IL PROFETA DELLA CRISI. 19 - Fondazione Zaninoni · intitolato il Dipartimento di Scienze...
Transcript of IL PROFETA DELLA CRISI. 19 - Fondazione Zaninoni · intitolato il Dipartimento di Scienze...
19IL PROFETA DELLA CRISI.TRIBUTO AHYMAN MINSKYpresentazionePia LocatelliAnnalisa Cristinivideo messaggioEsther MinskycomunicazioniPiero FerriElisabetta De AntoniAnna Maria VariatoDomenico Delli GattiMarco PassarellaJan Kregeltavola rotondaRoberto PetriniJan KregelMarco VitaleFrancesco ArcucciLaura PennacchiRiccardo Bellofiore
5 dicembre 2011
Quadernidella
Fondazione A.J. Zaninoni
Quaderni della Fondazione A.J. ZaninoniEditore: Associazione Amici della Fondazione Zaninoni,
via Zambonate 33, 24122 BergamoDirettore responsabile: Augusto BenvenutoRegistrazione: Tribunale di Bergamo n. 32 del 27 giugno 2002Stampa: Stamperia Stefanoni - Bergamo
Anno VIII - n. 1 - maggio 2012Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Bergamo
PRESENTAZIONE
Hyman Philip Minsky(Chicago, 23 settembre 1919 - Rhinebeck, 24 ottobre 1996)
A quindici anni dalla morte del professor Hyman Minsky,la Fondazione A.J. Zaninoni, in collaborazione con il Di-partimento di Scienze economiche dell’Università di Ber-gamo, ha organizzato un incontro, di cui pubblichiamo
3
4
gli atti, per rendere un tributo a questa figura di economi-sta fuori dalla mainstream economics e mantenere vivo ilsuo intenso legame con la città e l’Università di Berga-mo.Il professor Minsky è nato a Chicago nel 1919 dove hastudiato fino alla laurea, ha conseguito il dottorato adHarvard, ha insegnato in numerose università americaneed ha concluso la sua carriera alla Washington Universitydi Saint Louis che nel 1990, anno del suo pensionamen-to, gli ha attribuito il titolo di professor emeritus. Dopoaver concluso la carriera universitaria, è stato distingui-shed scholar al Levy Economics Institute of Bard Collegedi New York.Il legame del professor Minsky con l’Italia è iniziato nellaseconda metà degli anni Settanta e lo dobbiamo al pro-fessor Jan Kregel, economista statunitense che, chiama-to dall’allora presidente di Confindustria, Guido Carli, afar parte del Centro studi istituito in Confindustria, indicòil nome di Hyman Minsky, che si trasferì per un anno aRoma con la famiglia.Fu a Bergamo grazie ai rettori Giorgio Szegö e soprattut-to Piero Ferri, quando in Università circolavano nomi pre-stigiosi come Merton, Modigliani, Strauss-Kahn, Far-mer... personaggi dalle visioni molto diverse e proprioper questo stimolanti. Dal ’78 Hyman Minsky venne si-stematicamente a Bergamo e di questo legame, che siinterruppe soltanto con la sua morte, ebbero merito, in-sieme all’Università, altri amici che crearono le condizioniperché la sua permanenza si intensificasse negli anni,anche grazie all’acquisto di una casa che tuttora la fami-glia possiede in Città Alta e dove la moglie Esther tra-scorre sempre le estati, continuando così a essere “ber-gamasca”.Il professor Minsky, che è stato studente di Schumpetere la cui formazione ha come radice la tradizione istituzio-nale di Chicago, era molto orgoglioso del suo legamecon la nostra città, tant’è che soleva attribuirsi una dop-pia appartenenza universitaria: si presentava come Min-sky della Washington University di Saint Louis e dell’Uni-versità di Bergamo. Considerava questa relazione conBergamo come un riconoscimento, che invece non ave-va nel mainstream. Hyman Minsky ha amato Bergamo, in
particolare Città Alta, e Bergamo ha ricambiato il suo af-fetto attribuendogli post mortem la cittadinanza onoraria,con una medaglia d’oro che la moglie Esther porta congrande orgoglio. Nel 1998 l’Università di Bergamo gli haintitolato il Dipartimento di Scienze economiche comesegno di gratitudine e affetto, ma soprattutto comeespressione di stima nei confronti del suo lavoro e con lasperanza che il suo approccio allo studio dell’economiae il suo metodo di ricerca possano continuare ad esserefonte di ispirazione.Minsky è noto per la sua rilettura di Keynes come econo-mista eterodosso, dove la moneta e i mercati finanziarisvolgono un ruolo essenziale. In un mondo caratterizzatodall’incertezza, gli investimenti privati determinano il ci-clo, e sono a loro volta influenzati dai rapporti finanziari.L’ultimo Minsky ha sottolineato il ruolo cruciale dei mo-ney manager e della cartolarizzazione. Voci autorevoli, ela stessa stampa, hanno sostenuto che la crisi dei sub-prime fosse una conferma della sua ipotesi dell’instabili-tà finanziaria: un vero e proprio Minsky moment, l’esplo -sione di una bolla finanziaria dovuta all’eccesso di inde-bitamento privato (questa volta delle famiglie, più chedelle imprese). Dalla fine del 2008 si è profilato l’incubodi un Minsky meltdown: il collasso delle economie deter-minato dalla deflazione da debiti. L’idea che nel capitali-smo finanziariamente evoluto la ‘stabilità sia destabiliz-zante’ e che la crisi discenda da una fragilità finanziariacrescente è tornata al centro del dibattito. Minsky comela Cassandra che aveva anticipato la crisi. Ancora più at-tuale è forse la sua proposta di superare in avanti il key-nesismo, muovendo verso una radicale socializzazionedell’investimento, una significativa regolazione della fi-nanza, lo Stato come fornitore diretto di occupazione.Hyman Minsky, economista dal pensiero pluridimensio-nale, aveva un’idea dell’economia come un insieme direlazioni sociali e ci ha lasciato alcuni insegnamenti, cheil professor Piero Ferri ci ha ricordato nel corso del suocontributo al convegno: la sfida principale è capire l’eco -nomia contemporanea; l’economia non è un dato di na-tura ma è plasmabile con politiche economiche ed istitu-zionali; infine e soprattutto la sfida va vinta con tecnichedi frontiera. Per questo nell’invito al convegno abbiamo
5
voluto riportare una frase di Keynes che ci sembra parti-colarmente appropriata per il nostro tributo a HymanMinsky: “Dobbiamo inventare una nuova saggezza peruna nuova epoca. Nel frattempo, se vogliamo veramentefare qualcosa di buono, dobbiamo apparire eterodossi,importuni, pericolosi, ribelli nei confronti di chi ci ha pre-ceduto”.
Pia Locatelli
6
IL PROFETA DELLA CRISI.TRIBUTO A HYMAN MINSKY
Pia Locatellipresidente della Fondazione A.J. Zaninoni
La padrona di casa, professoressa Cristini, è in ritardoper un contrattempo improvviso, quindi inizio io e quan-do arriverà la direttora del Dipartimento prenderà lei laparola e condurrà l’incontro.Benvenuti a tutti e a tutte. Prima di spiegare il significatodi questo convegno e la sua “forma” insolita rispetto agliincontri che la Fondazione A.J. Zaninoni organizza concadenza semestrale, voglio ringraziare l’Università diBergamo che ci ospita e il suo Dipartimento di Scienzeeconomiche che ha collaborato all’organizzazione. Rin-grazio il rettore, professor Stefano Paleari, che purtropponon potrà raggiungerci perché trattenuto da un impegnoa Roma, e la professoressa Annalisa Cristini, direttora delDipartimento.Questo convegno è un Tributo a Hyman Minsky, un eco-nomista americano, ma anche un po’ italiano e pure unpo’ bergamasco, morto quindici anni fa, un economistache è rimasto isolato in una professione egemonizzatadal pensiero neoclassico. Il professor Minsky ha passatomolti anni della sua vita a studiare i mercati finanziari e acercare di convincere i suoi colleghi, a Chicago, a Berke-ly e infine alla Washington University di Saint Louis, chequesti mercati sono intrinsecamente instabili. Non lohanno ascoltato per decenni, fino a che la crisi di questianni ha convinto tanti che aveva ragione ed è diventatofamoso. Forse qualcuno di voi avrà visto la vignetta pub-blicata sul New Yorker di qualche mese fa dove si vedo-no dei professori, o forse finanzieri, intenti a studiare isuoi libri.Non credo di dover spiegare perché lo ricordiamo al-l’Università di Bergamo, la maggior parte dei presenti neconosce la ragione, lo faccio per i pochi, credo, che nonne sono a conoscenza. Il professor Minsky è stato perdiversi anni una presenza importante nella nostra Univer-sità e dobbiamo questa relazione al professor Ferri che
7
lo conobbe attraverso l’allora rettore Giorgio Szegö, du-rante un anno sabbatico che Hyman Minsky trascorse inConfindustria a Roma. Era la seconda metà degli anniSettanta. Questo legame si intensificò negli anni e si in-terruppe soltanto con la morte di Hyman Minsky. Ma ri-mane con la famiglia, che continua a essere bergamascaperché la moglie Esther tutte le estati viene a Bergamo.Esther sarebbe voluta venire anche oggi, ma non è gio-vanissima, anche se ancora vivace, e non si è sentita difare un secondo viaggio transoceanico, ci ha quindimandato un saluto attraverso un video.Dicevo che dobbiamo a Piero Ferri il merito di aver por-tato Hyman Minsky a Bergamo, ma un po’ di meritol’han no anche altri di noi che hanno contribuito a tenerlonella nostra Università per periodi sempre più lunghi an-no dopo anno. Troppo preziosa la sua presenza per non“approfittarne” al massimo. Ricordo un episodio diver-tente: Piero Ferri ha “sfrattato” da casa loro per qualchegiorno Riccardo e Daniela Leoni, che si erano appenasposati, per lasciare il loro piccolo appartamento a di-sposizione della famiglia Minsky per qualche tempo. Mipiace ricordare anche i pranzi domenicali della famigliaMinsky con la famiglia Ferri a Caravaggio a casa dell’al-lora rettore. E ricordo ancora la trepidazione con cui miomarito ed io abbiamo deciso di dare la caparra per la ca-sa in Città Alta che avevamo pensato per Hyman Minskyprima ancora che lui la vedesse e desse il suo consenso.
8
Hyman Minsky ha amato Bergamo, in particolare Città Al-ta, e Bergamo ha ricambiato il suo affetto attribuendoglipost mortem la cittadinanza onoraria, con una medagliad’oro che la moglie Esther porta ancora con grande orgo-glio. E ricordo che alcuni giorni dopo il professor MarcoVitale scrisse un bellissimo articolo sul Sole 24 Ore.Ha scritto Riccardo Leoni che se in questi giorni Minskyfosse ancora fra noi, riunirebbe gli estimatori del suopensiero sparsi in diverse università italiane (Bergamo,Siena, Trieste, la Cattolica di Milano, Roma, Ancona…),aprendo l’incontro con: «Ah, ve lo avevo detto!», e ricor-derebbe quindi i passi pertinenti dei suoi lavori. La Fon-dazione Zaninoni ha voluto in qualche modo sostituirsi alui in questo e allo stesso tempo rendergli un tributo,chiamando le persone che gli sono state più vicine.Io naturalmente non parlo della sua collaborazione conl’Università, o del suo pensiero, della sua rilettura di Key-nes come economista eterodosso, perché lo faranno irelatori e le relatrici che, come vedete dal programma,sono più numerosi del solito.Abbiamo pensato di organizzare questo tributo in duesessioni diverse; nella prima, dal taglio più “accademi-co”, sarà presentata una serie di comunicazioni di pro-fessori di diverse università: Bergamo ovviamente, conuna doppia presenza, Trento, la Cattolica di Milano, Sie-na, per chiudere con il Levy Institute del Bard Collegedello Stato di New York, un istituto fondato da HymanMinsky; la seconda prevede una tavola rotonda sulla cri-si, coordinata da Roberto Petrini, giornalista di la Repub-blica che ha scritto un libro dal contenuto interessante edal titolo provocatorio Processo agli economisti, e a cuiparteciperanno degli economisti, che non so se si faran-no processare o meno.Per concludere: questo convegno intende ricordare la fi-gura di Hyman Minsky, dibattere il suo contributo scienti-fico, ma anche o forse soprattutto l’attualità politica delsuo pensiero, di un economista sempre “fuori dal coro”,che amava la musica, in particolare il jazz, e l’arte, curio-so di tutto e informato su tutto, che ha costituito unapresenza molto importante per la nostra Università doveper molti è stato amico oltre che maestro. A lui è statointitolato il Dipartimento di Scienze economiche subito
9
dopo la sua morte, legando così il suo nome alla nostraUniversità. Vorrei che questo legame permanesse, anchese la riforma Gelmini prevede cambiamenti nella strutturadei dipartimenti, non ho ben capito se spariranno, saran-no accorpati o cosa succederà. Ma credo che si può, sesi vuole, trovare il modo per continuare ad associare ilnome di Hyman Minsky alla nostra Università e colgol’occasione di questo tributo per avanzare questa richie-sta formale al rettore e chiedere a tutti di sostenerla.Grazie. È arrivata la nostra ospite e le passo subito la pa-rola.
Annalisa Cristinidirettrice del Dipartimento di Scienze economiche,Università di Bergamo
Mi scuso per il ritardo dovuto a un contrattempo, e salu-to cordialmente tutti a nome del Dipartimento di Scienzeeconomiche; è un piacere ritrovarci in questa occasionee ringrazio particolarmente Pia Locatelli e la FondazioneZaninoni che hanno organizzato questo incontro: le sia-mo sicuramente debitori.Vorrei anch’io, brevemente, ricordare il legame tra HymanMinsky e il Dipartimento di Scienze economiche. Durantei periodi che trascorreva a Bergamo Hyman frequentava ilDipartimento, che lo ospitava con grande piacere. Sicura-mente, come ricordava Pia, la decisione che prendemmonel 1998 di intitolargli il Dipartimento di Scienze economi-che fu mossa da gratitudine e affetto, ma soprattutto fuun modo per esprimere il nostro rispetto e la nostra stimanei confronti del lavoro di Hyman, e la speranza che il suoapproccio allo studio dell’economia e il suo metodo di ri-cerca potessero in qualche modo ispirare anche noi stes-si, i nostri ricercatori, il nostro lavoro.Sono molti ovviamente gli elementi distintivi dello stile diricerca di Hyman: sicuramente la coerenza e uno stile in-dipendente, ma anche – e a questo ho associato dei ri-cordi significativi – l’osservazione acuta e intelligentedella realtà, una conoscenza profonda della teoria eco-nomica e una motivazione intrinseca molto forte percomprendere i meccanismi che regolano il funzionamen-
10
to del sistema economico. Questi ingredienti sono tutto-ra essenziali per la ricerca economica in genere, sia essadi natura macroeconomica, microeconomica, teorica oapplicata, e lo stile di Hyman rimane una valida guida.Per quanto riguarda l’apporto fondamentale di HymanMinsky alla comprensione dell’instabilità finanziaria, èchiaro che ha avuto un’eco importantissima e potente inquest’ultima crisi, appunto perché il modello minskianospiega esattamente come strutture finanziarie inizialmen-te stabili possano evolvere facilmente in strutture fragili,o – per usare le parole di Abba Lerner – come “la stabili-tà sia destabilizzante”. E vorrei citare qui alcune righe diun lavoro che Hyman Minsky scrisse nel ’951, proprioper metterne in risalto l’attualità: “Global financial inte-gration is likely to characterize the next era of expansivecapitalism. The problem of financial that will emerge iswhether the financial and fiscal control and support insti-tutions of national governments can contain both theconsequences of global financial fragility and an interna-tional debt deflation”2. E concludeva: “Once again, the
11
1 Longer Waves in Financial Relations, in Journal of Economic Issues,vol. XXIX, n. 1 March 1995.2 L’integrazione finanziaria globale caratterizzerà, probabilmente, laprossima era di capitalismo espansivo. Il problema per la finanza di-penderà dalla capacità delle istituzioni di controllo e supporto fiscale efinanziario dei governi nazionali di contenere le conseguenze della fra-gilità finanziaria globale e della deflazione debitoria internazionale.
past is not a good guide to the future”3. Credo che que-ste parole siano illuminanti sulla situazione attuale e met-tano in evidenza quanto fosse ampia e lungimirante la vi-sione economica di Minsky. Grazie a questo, Hymancontinua a darci suggerimenti sia dal punto di vista inter-pretativo della crisi attuale sia dal punto di vista delle po-licy.Infine, vorrei ricordare come la ricchezza del pensiero diMinsky fosse difficilmente contenibile in un solo modelloe questa ricchezza, infatti, ha via via dato i suoi fruttigrazie agli approfondimenti di molti ricercatori e studiosi,alcuni dei quali sono stati collaboratori o studenti dellostesso Hyman, e continuano ad essere ispirati dalla suaricerca. Oggi abbiamo il piacere di avere tra noi alcunedi queste persone e termino quindi lasciando a loro laparola e augurando a tutti una conferenza proficua. Gra-zie.
Pia Locatelli
Grazie Annalisa ma di fatto tu sei l’ospite quindi siamonoi che ringraziamo te. Ora guardiamo un breve video: èil saluto di Esther Minsky, che ha voluto in qualche modoessere con noi. Prima però devo esprimere il mio debitodi riconoscenza nei confronti di Riccardo Bellofiore chemi ha dato la spinta, quasi un calcione per la verità, per-ché avessi il coraggio di organizzare questo convegnocome Fondazione Zaninoni. A me sembrava una cosatroppo grande e a volte di fronte alle cose grandi si esita,ma lui mi ha detto “bisogna farlo” e così è stato e glienesono riconoscente. Ed ora il messaggio di Esther.
Esther Minsky
Good afternoon and welcome to the conference. Specialthanks to Pia Locatelli and Riccardo Bellofiore for organi-zing this tribute to my husband, Hy Minsky. I truly regretnot being in Bergamo to welcome you personally.
12
3 Ancora una volta, il passato non è una buona guida per il futuro.
As you know, Hy adopted Bergamo as his second homein 1980 and with it his colleagues in the Economics De-partment at the University of Bergamo. Many of thesecolleagues continue Hy’s work – his ideas, his policies,many formulated as far back as 1970, today more rele-vant than ever.Hy would be very pleased with your ongoing research;and also proud to learn that through the good offices ofPiero Ferri the Economics Department at the Universityof Bergamo bears his name.Fifteen years after Hy’s death, I continue to go to Berga-mo enjoying not only the city, but the strong ties that en-dure with his colleagues and friends.I am very grateful to the Zaninoni Foundation and to theUniversity of Bergamo for sponsoring this event. To theparticipants, whose papers I look forward to reading, andto the students who I hope will carry on the legacy of HyMinsky, thank you. Enjoy the conference.
Buon pomeriggio e benvenuti alla conferenza. Un ringra-ziamento speciale a Pia Locatelli e a Riccardo Bellofioreper aver organizzato questo tributo a mio marito, HyMinsky. Sono davvero dispiaciuta di non essere a Berga-mo per darvi il mio personale benvenuto.Come sapete, Hy ha scelto Bergamo come sua secondacasa nel 1980 e insieme alla città i suoi colleghi del Di-partimento economico dell’Università di Bergamo. Molti
13
di questi colleghi danno continuità al lavoro di Hy, allesue idee e alle sue politiche, molte della quali formulategià nel 1970, oggi più attuali che mai.Hy sarebbe molto contento del fatto che continuiate la ri-cerca e orgoglioso nell’apprendere che, grazie ai buoniuffici di Piero Ferri, il Dipartimento economico dell’Uni-versità di Bergamo porta il suo nome.A quindici anni dalla morte di Hy io continuo ad andare aBergamo godendo non solo della città ma anche dei fortilegami che perdurano con i suoi colleghi e amici.Sono molto grata alla Fondazione Zaninoni e all’Universi-tà di Bergamo per avere promosso questo evento. Gra-zie ai partecipanti, i cui interventi non vedo l’ora di legge-re, e agli studenti che mi auguro porteranno avanti l’ere -dità di Hy Minsky. Buona conferenza.
1ª sessione - comunicazioni
Pia Locatelli
Entriamo ora nel merito della prima sessione, che natu-ralmente aprirà Piero Ferri perché gli vanno tutti i meritidi questa seconda casa bergamasca di Hyman Minsky.Tutti ovviamente conosciamo Piero Ferri, ma per i pochi
14
milanesi che non hanno frequentato né la Cattolica néBergamo voglio ricordare che ha una laurea in Economiaall’Università Cattolica di Milano, un phd a Oxford, ha in-segnato a Torino, a Trento, alla Cattolica di Milano ed èstato per quindici anni rettore dell’Università di Bergamo,è professore onorario della Washington University diSaint Louis, che è stata l’ultima università americana incui Hyman Minsky ha insegnato.
Piero FerriUniversità di Bergamo
Ringrazio Pia per aver organizzato questo incontro e dalmomento che il tempo stringe entro subito nel merito.Secondo il settimanale The Economist questi tempi diturbolenza e di crisi economica possono essere definiti i“momenti di Minsky”, a significare il fatto che costitui-scono l’ambiente tipico di riferimento dell’analisi di Min-sky. Non a caso Can it happen again? (cioè: può capitaredi nuovo?, dove it è appunto la Grande depressione) èun suo libro famoso e per di più stampato nell’82, quan-do il tema del giorno era il ciclo economico obsoleto, equindi questo vi dà già la misura della distanza tra il pen-siero di Hyman e quello che allora si diceva in giro. Nonsi può certo sostenere che Minsky abbia previsto la crisi,nessuno può farlo se per prevedere si intende definire
15
con precisione i tempi e le modalità della crisi, e quindinemmeno Minsky – non possiamo santificarlo dicendoche l’aveva previsto –, tuttavia fu uno dei pochi economi-sti attrezzati non solo a capire che la grande depressioneera sempre una possibilità latente ma anche che occor-resse studiare politiche e forgiare istituzioni perché que-sto non succedesse nuovamente. Val la pena ricordareche in un recente convegno a Washington un oratore hadefinito i quattro grandi economisti necessari a capire lecrisi attuali: Marx, Keynes, Galbraith e Minsky. Fa unacerta sensazione sentire queste cose oggi, quando Min-sky è scomparso da quindici anni, in una società liquidain cui l’orizzonte temporale e culturale di riferimento si vasempre più accorciando. Non solo, ma la sensazione distupore cresce se si pensa all’isolamento che ha patitoquando era in vita, isolamento accademico intendo dire,perché Hyman ha sempre avuto un seguito nel mondobancario e finanziario. A cavallo fra le discipline dellescienze economiche e quelle bancarie, è riuscito a spiaz-zare i suoi interlocutori su entrambi i fronti: troppo eco-nomista per gli uni e troppo bancario per gli altri per es-sere adeguatamente compreso da entrambi. Certo unruolo l’ha giocato anche l’economia reale che ha sfode-rato, lui vivente, una tra le più grandi e durevoli espansio-ni della storia che rendeva indigeribili riflessioni sulla in-stabilità del capitalismo, l’ultima essendo stata la Grandedepressione, un accidente di manzoniana memoria per ipiù. È vero che c’erano state due crisi petrolifere, chenell’87 ci fu un crack improvviso alla Borsa di New York,così come è vero che ci fu un fallimento di qualche ban-ca di risparmio, ma niente di comparabile a quello chesta oggi succedendo, dalla crisi dei mutui sub-prime finoalla crisi del debito sovrano. Hyman non ha potuto pur-troppo partecipare a questi eventi, se ne sarebbe certa-mente esaltato, non perché li aveva ritenuti possibili maperché si sarebbe sforzato di cercare di individuare lepossibili vie di uscita. Minsky non era un doomster, ossiaun personaggio catastrofista, ma fondamentalmente unkeynesiano che credeva nella dialettica fra economia,politiche economiche e istituzioni.Poco tempo fa il Wall Street Journal mi ha contattato percapire quali fossero le ragioni della maggior popolarità di
16
Minsky in Italia rispetto agli Usa e come mai avesse de-ciso di scegliere Bergamo come punto di riferimento inEuropa. Vorrei approfondire questo aspetto, non rispon-dendo alla prima domanda – perché Jan e altri possonofarlo meglio di me – quanto piuttosto tentando di rispon-dere alla seconda. E qui faccio un po’ di storia, per meinteressante, non so quanto interessi anche voi. Ci era-vamo conosciuti nel 1978 quando Hyman era in sabbati-co presso la Confindustria a Roma, e penso che di que-sto il merito sia di Kregel perché anche lui era in Confin-dustria e vi invitò Hyman. Io mi ero trasferito a Bergamoda Trento da meno di un anno quando Hyman venne aBergamo invitato da Szegö, un rettore che ricordo conmolto affetto e molta gratitudine, per un convegno sullafinanza. A quei tempi circolavano all’Istituto università diBergamo, così si chiamava allora, nomi prestigiosi: daMerton, premio Nobel, a Modigliani, Strauss-Kahn (poidiventato famoso per altre cose), Farmer, Feldstein, Jor-genson; la coesistenza di visioni così diverse potevasembrare imbarazzante ma non lo era, infatti era assaistimolante perché illustrava contemporaneamente sia lanascita di un nuovo sapere, che si stava creando e chestava creando una nuova attività – la finanza –, sia lacomprensione della fragilità sistemica di un approccioche molto prendeva a prestito dalla mainstream econo-mics, come invano reclamava Minsky. In questo affasci-nante intreccio di situazioni è cominciata la mia avventu-ra con Hyman, che non si sottraeva al compito di gua-stafeste, guastafeste in quel contesto, anzi lo faceva conuna certa forza ed eleganza e con molto mestiere; pensoche anche la sua statura fisica facilitasse il suo ruolo diclassico dell’economia, lui studente di Schumpeter e conla radice nella tradizione istituzionale di Chicago: incute-va timore anche in Merton. Questo tema di ricerca, cioèla finanza, era per me nuovo e del tutto estraneo alla miaformazione – avevo studiato a Oxford e fatto una tesi sulmercato del lavoro con il premio Nobel Hicks – e quandoHyman arrivò a Bergamo stavo lavorando ad un articolosu distribuzione del reddito, inflazione e produttività;Minsky ne restò incuriosito e volle invitarmi a Roma aConfindustria. Però a continuazione del colloquio, conmia grande sorpresa, scoprii che il paper era stato sotto-
17
posto a una cura intensiva, dove con cura intensiva in-tendo dire che neanche una parola era rimasta intoccata,l’approccio oxfordiano si era nel frattempo arricchito ditemi alla Cambridge; mi resi conto che avrebbe potutodiventare un joint paper, cioè un paper fatto insieme, einfatti lo divenne nel 1983, pubblicato sul Journal of PostKeynesian Economics. Dopo di che ci furono altri incon-tri, altri articoli – che vi risparmio per mancanza di tem-po. È importante invece la nostra consuetudine di lavoro,perché dovete sapere che Minsky aveva un inglese im-possibile, perlomeno per me all’inizio, non si riusciva acapir bene, io venivo da Oxford quindi capivo la Reginama non Minsky, e allora avevo studiato una tecnica mol-to particolare che ho chiamato socratica: io scrivevo ledomande sul personal computer, che a quei tempi eraun po’ più ingombrante di oggi, e lui rispondeva. Per cuiio ho ancora i file di questo dialogo bellissimo. Con que-sto metodo siamo riusciti a produrre altri due lavori, unopubblicato su Revew of Political Economy e l’altro suStructural Change and Economic Dynamics.Dal ’78 poi venne sistematicamente in Italia e di questoebbero un grosso merito Riccardo Leoni, che gli cedettel’appartamento mentre era in viaggio di nozze (non è cheio l’abbia proprio sfrattato come ha detto Pia), e Pia Lo-catelli, che gli ha trovato la casa proprio qui a cento me-tri di distanza: questi gli amici bergamaschi che hannocontribuito al fatto che sia rimasto a Bergamo. La colla-borazione tuttavia era simmetrica perché dall’80 mi invi-tò alla Washington University per un seminario, nell’83gestimmo un gruppo di lavoro molto interessante suSchumpeter e Keynes, dove c’erano altri economisti di-ventati poi illustri, tipo Egidi che è diventato ora rettoredella Luiss. Quindi in questo scambio non solo ci fu unrapporto di persone ma anche un rapporto istituzionale,nel senso che il Dipartimento di Bergamo e quello dellaWashington University sono rimasti collegati in modomolto stretto. Avevamo anche in programma di scrivereun libro, ma i miei impegni di rettore da una parte e il suocrescente coinvolgimento nel Levy Institute dall’altra im-pedirono la conclusione di un volume sul ciclo economi-co che è rimasto in progress. Fu in quel periodo, siamonegli anni Novanta, che passai idealmente il bastone da
18
staffetta a due giovani emergenti, i cosiddetti “due gatti”,two cats, Domenico Delli Gatti, che è qui, e Mauro Galle-gati.Che cosa mi ha lasciato Hyman Minsky? Mi ha lasciatotre insegnamenti: il primo è che la sfida principale è ca-pire l’economia contemporanea, occorre conoscere lastoria, occorre conoscere la storia del pensiero, però èfondamentale che l’obiettivo sia quello di capire l’eco no -mia contemporanea, questo è stato il suo appello co-stante; il secondo è che l’economia non è un dato di na-tura ma è plasmabile con politiche economiche ed istitu-zionali; terzo: la sfida va vinta con tecniche di frontiera.Vorrei soffermarmi su questo aspetto perché i primi duesono abbastanza accettati mentre il terzo lo è molto me-no. Minsky era laureato in matematica e capiva l’im por -tanza dell’approccio formalizzato. La sua insistenza per-ché riconsiderassi il suo articolo sul ciclo economico del’59 alla luce del contributo di Hicks del ’50 costituisceuna prova di questa sua inclinazione; non solo ma insi-steva perché mi familiarizzassi con i nuovi contributi cheprovenivano dalla teoria del caos, che lo interessava inmodo particolare. Secondo me è proprio questa apertu-ra che fa di Minsky un keynesiano di tipo particolare, an-zi vorrei dire che a lui non piaceva essere chiamatopost-keynesiano, se non ricordo male, già keynesianoera più che sufficiente. Nel mio ultimo libro, che si intito-la Macroeconomics of Grouth Cycles and Financial In-stability, ho voluto rispettare questa ispirazione di Min-sky e allo stesso tempo pagare un tributo al mio vecchiomaestro John Hicks – mi rendo conto di appartenere aun sotto-insieme che i matematici definirebbero di mea-sure zero, cioè di dimensione zero. Hicks è stato fonda-mentale per me non solo per capire Minsky ma ancheper stringere un’amicizia così forte con lui. Una dedicache Hyman scrisse sul frontespizio del volume JohnMaynard Keynes, datata 5 maggio 1979, recitava: “Acollaborator, a colleague and a friend”; spero di avermantenuto fede, nell’esposizione precedente, a questadefinizione. Grazie.
19
Pia Locatelli
Questa comunicazione di Piero Ferri ha dato propriol’idea di com’era il rapporto di Hyman Minsky conl’Università: una mescolanza di rigore scientifico e di re-lazioni umane, che fa commuovere di fatto. Ti ringrazia-mo e mi dispiace un poco che tu abbia rispettato i quin-dici minuti perché sarebbe stato bello continuare. La seconda comunicazione è della professoressa Elisa-betta De Antoni, laurea in Scienze politiche all’Universitàdi Bologna, master in Economia alla London School ofEconomics, docente di Economia all’Università di Trento.La sua comunicazione sul ruolo di Minsky nell’evoluzionedella teoria macroeconomica, in particolare all’internodel pensiero eterodosso, illustra il contributo chiave diMinsky in termini sia di teoria sia di aderenza alla realtà.Grazie
Elisabetta De AntoniUniversità di Trento
Prima di cominciare vorrei innanzitutto ringraziare il pro-fessor Bellofiore, la Fondazione e il Dipartimento che ciospita e grazie anche naturalmente a voi che ascoltate;spero di essere in qualche modo utile. Il titolo della miarelazione è: “Il ruolo di Minsky nell’evoluzione della teoriamacroeconomica”; le vere domande che mi sono postasono: perché tornare a Minsky come economisti e per-ché studiare Minsky come studenti e per rispondere hoconcepito un excursus sulla macroeconomia dopo Key-nes, iniziando dall’ortodossia ovverosia dal mainstream.L’ortodossia fa riferimento al mondo ideale della generalequilibrium theory, la teoria dell’equilibrio generale.L’Olim po neoclassico è un mondo perfettamente coordi-nato, popolato da semidei, in cui le politiche possonosostanzialmente fare solo danno. I pilastri della teoriadell’equilibrio generale sono la perfetta razionalità indivi-duale e collettiva; perfetta razionalità individuale: l’agenteneoclassico è un olimpico semidio, ha già imparato tutto,conosce il presente e prevede il futuro, individua istanta-neamente le scelte intertemporali ottimali di qui alla notte
20
dei tempi; perfetta razionalità collettiva: in fisica c’è laforza di gravità per cui un uovo non si regge sulla suapunta – è una citazione di Samuelson –, in economia c’èla mano invisibile per cui i prezzi equilibrano tutti i mer-cati, ne segue che gli stati di disequilibrio sono tempora-nei, conviene concentrarsi sugli stati di equilibrio e il ri-sultato è la teoria dell’equilibrio economico generale, ge-neral equilibrium theory, con annessa quantity theory ofmoney, teoria quantitativa della moneta. Il mondo realeperò è ben diverso da questo Olimpo (pensiamo a ciòche stiamo vivendo sui mercati finanziari oggi, speriamonon un terremoto dell’euro, ma le scosse, e molto forti, cisono), nel mondo reale ci sono gravi patologie: disoccu-pazione, inflazione, instabilità finanziaria, per di più mo-neta e finanza sono tutt’altro che neutrali. Come raccor-dare teoria e realtà? La strategia seguita dall’ortodossiaè prendere la teoria dell’equilibrio economico generale eusarla come standard di riferimento, in questo contestointrodurre delle imperfezioni di breve periodo che fannoda ponte tra la perfezione della teoria e l’imperfezionedella realtà. Questi maladjustments, queste imperfezioni,questi ponti tra teoria e realtà scandiscono l’evoluzionedella macroeconomia dopo Keynes.Iniziamo dalla sintesi neoclassica o controrivoluzionekeynesiana. Questa scuola di pensiero trae origine conHicks nel 1937, un anno dopo la teoria generale di Key-nes, cioè la rivoluzione keynesiana. A questo filone ap-
21
partiene una schiera nutrita di premi Nobel (Samuelson,Hicks, Klein, Tobin, Modigliani, Mundell). La patologia diquegli anni è la disoccupazione: come conciliare l’equi -librio generale neoclassico con la disoccupazione keyne-siana? La soluzione è sempre quella: equilibrio generalepiù maladjustment di breve periodo. Il problema del ma-ladjustment è costituito dalla rigidità verso il basso delsalario e del saggio di interesse nominale. Keynes nonha inventato proprio nulla, dice questa corrente di pen-siero, ha solo introdotto queste rigidità: la disoccupazio-ne involontaria keynesiana è il semplice effetto di un ec-cessivo costo del lavoro e del denaro, alternativamente aseconda delle teorie. Lo squilibrio di breve periodo key-nesiano dura a lungo perché le distorsioni sono persi-stenti, i salari sono fissati di qui a N anni, quindi le distor-sioni sono persistenti e le politiche devono intervenireprincipalmente sulla spesa pubblica.Passiamo al filone successivo (siamo negli anni dal 1956al ’77): il monetarismo Mark 1, di tipo 1. Qui abbiamo unNobel solo, ma ne vale tanti perché è una persona moltobrillante, Friedman, che rifiuta il maladjustment, la solu-zione della sintesi. Quel che conta, dice Friedman, sono iprezzi relativi; se questo è vero, i prezzi assoluti e le lororigidità non sono rilevanti, tanto più che le rigidità nonsono ottimali, se un mercato non va all’equilibrio ci per-dono tutti, perché l’equilibrio è la soluzione ottimale,quindi non sono sostenibili. Allora Friedman risposta in-dietro la puntina e propone di partire dalla general equili-brium theory, dalla perfezione più la teoria quantitativadella moneta e difatti il monetarismo di Friedman ci diceche la moneta determina la spesa e il reddito nominale.A quel punto il problema di Friedman è come spiegare glieffetti reali della moneta, perché nell‘Olimpo neoclassicola moneta dovrebbe determinare solo la scala nominaledell’economia. Friedman risponde introducendo un nuo-vo maladjustment di breve periodo. Ci sono delle asim-metrie informative, queste danno luogo ad errate aspet-tative inflazionistiche dei lavoratori e questo altera l’of -ferta di lavoro e fa sì che la moneta abbia effetti reali. Insoldoni: in un contesto inflazionistico gli imprenditorisanno tutto perché conoscono sia i salari sia i prezzi chefanno, invece i lavoratori conoscono il proprio salario ma
22
non i prezzi e quindi in un contesto di prezzi crescentipercepiscono l’aumento del proprio salario ma non l’au -mento dei prezzi, credono di essere pagati di più quandonon è vero, e offrono più lavoro. Ovviamente è solo unerrore, il breve periodo di Friedman, dove ci sono questiscollamenti dall’Olimpo ideale, tende rapidamente ascomparire, perché le statistiche sui prezzi e sull’offertadi moneta tendono ad essere pubblicate molto presto,per cui gli squilibri di breve periodo sono davvero tali,durano davvero poco. Quanto alla politica monetaria,può essere utile nel breve ma è meglio non usarla, diceFriedman, perché nel lungo può essere fonte di grosseinstabilità.Successivamente, negli anni Settanta, abbiamo il mone-tarismo numero 2 o nuova macroeconomia classica. An-che qui ci sono dei premi Nobel significativi (Lucas, Sar-gent), che contestano il maladjustment precedente. Gliagenti imparano gli uni dagli altri, le asimmetrie informa-tive inevitabilmente scompaiono, quindi questi economi-sti rispostano indietro la puntina, si torna alla teoria del-l’equilibrio generale più teoria quantitativa aggiungendol’ipotesi di razionalità. Questa è una grandissima inven-zione degli ortodossi. Evitando errori sistematici gliagenti finiscono per comprendere la parte deterministicadella realtà, la parte non stocastica, quindi rimane fuorisolo la parte stocastica che continua ad essere ignota.Pertanto il maladjustment di breve, secondo il monetari-smo numero 2, è rappresentato da sorprese inflazionisti-che di tipo stocastico. L’equilibrio di breve periodo tenderapidamente all’equilibrio di lungo, di nuovo, i dati sull’in-flazione sono disponibili in tempi brevi per cui gli errori siriassorbono non appena i dati giusti vengono pubblicati,la politica monetaria è inefficace anche nel breve, nellamisura in cui viene anticipata dagli operatori la politicamonetaria non sorprende, non c’è nessun maladjustmente noi restiamo in equilibrio generale.Da ultimo, negli anni Ottanta, abbiamo la teoria del realbusiness cycle, del ciclo reale; anche qui abbiamo deiNobel (Kydland e Prescott). Questi economisti respingo-no il maladjustment di Lucas, la moneta è endogena, ècreata dall’economia, non viene dall’esterno, per cui nonpuò essere fonte di shock perché si adatta al comporta-
23
mento del sistema. Alla teoria dell’equilibrio, all’Olimpointurbabile della teoria neoclassica, bisogna aggiungereshock reali che riguardano la produttività e riflettono ilcomportamento aleatorio della tecnologia. Non c’è nes-sun maladjustment, dice questa teoria, il sistema è sem-pre in equilibrio generale e le fluttuazioni sono ottimali,c’è un cavallo a dondolo che dondola per gli shock e lepolitiche non devono preoccuparsi perché siamo semprein equilibrio.Potrei continuare con le teorie dell’equilibrio generale di-namico e stocastico e con la nuova sintesi neoclassicache ripete questa procedura inserendo nuovi maladju-stment in una teoria dell’equilibrio generale che è moltopiù raffinata della precedente.Facciamo un bilancio di tutta questa carrellata – con cuispero di non avervi annoiato –: le teorie considerate, equesto è un punto che va ricordato, hanno dato tutte im-portantissimi contributi, ovviamente se premi Nobel sisono cimentati in tutto questo è stato anche per portarea degli avanzamenti, se non altro sul piano delle tecni-che, ma è la strategia di base che desta perplessità: imaladjustment sembrano avere il fiato corto, essendo in-compatibili con la perfezione dell’Olimpo neoclassico fi-niscono per essere oggetto di critiche e per essere re-spinti. Se leggo la storia del pensiero – forse una letturamacroeconomica, forse una lettura parziale – vedo che,al di là delle indubitabili conquiste, degli indubitabili pro-
24
gressi, in realtà poi questa è sempre la fine della storia:la general theory tende a riemergere in tutto il suo splen-dore, le fluttuazioni sono fenomeni di equilibrio, la disoc-cupazione – e questa è una cosa che io non ho mai dige-rito – è un fenomeno volontario, è una scelta dei lavora-tori che preferiscono evitare di lavorare, eventualmenteper lavorare domani. La realtà va tuttavia nella direzioneesattamente opposta. La mia conclusione da questa let-tura è che la general equilibrium theory rappresenta unbenchmark troppo irrealistico per tenere nel tempo.Un’am missione in questo senso viene del resto dallostesso Lucas, leggo solo le frasi rilevanti: “Le teorie in-corporate nella dinamica dell’equilibrio generale, quelleche usiamo molto bene noi ortodossi, non ci fanno pen-sare sull’esperienza americana degli anni Trenta [cioè del-la Grande depressione], o sulle crisi finanziarie comequelle dell’Asia e dell’America Latina [1997 e poco do-po]”; la citazione è del 2003 e ce ne sono anche succes-sive di questo tipo. Possiamo domandarci allora: chesenso ha un’economia come quella ortodossa che valesoltanto per i tempi buoni? che senso ha una medicinache vale solo per i pazienti sani?A questo punto arriviamo alla strategia eterodossa e tro-viamo due amici: Keynes e Minsky. L’eterodossia rifiuta ipilastri della razionalità, almeno uno dei due, l’Olimpodella teoria dell’equilibrio generale non sta su questa ter-ra, la razionalità collettiva è limitata, la mano invisibile èinvisibile perché non esiste, viviamo in un perenne dise-quilibrio, la razionalità individuale è limitata, non abbiamoinformazioni sul futuro, non sappiamo se tra mezz’orasaremo ancora qui, possiamo contare solo sull’esperien-za recente, l’ora è l’immediato passato, e siamo soggettiad ondate di ottimismo quando le cose vanno bene,pessimismo quando le cose vanno male. Questa è l’ete -ro dossia e vi troviamo entrambi i nostri autori. Tra i dueci sono anche differenze. L’uovo di Keynes sta sulla suapunta, non c’è alcuna tendenza all’equilibrio di pieno im-piego, responsabile principale è la moneta che catalizza ilimiti della razionalità individuale, nello specifico l’in cer -tezza induce a domandare moneta invece che a investireimpedendo così il raggiungimento del pieno impiego, ladisoccupazione si sviluppa perché la gente vuole la luna,
25
che è la moneta, e volere la moneta vuol dire non creare,non attivare la produzione, non attivare l’occupazione.L’uovo di Minsky invece rotola in continuazione, la sua èun’economia in disequilibrio che segue un andamentociclico scandito da depressioni e crisi, nei picchi di Min-sky troviamo le crisi finanziarie, nei punti di minimo tro-viamo le depressioni.La grande intuizione di Minsky è questa, a mio avviso: lafinanza ha un ruolo attivo, non è il mercato residuale,l’equilibrio generale ci dice che quando N-1 mercati so-no in equilibrio l’Nunesimo è automaticamente in equili-brio per cui non ce ne dobbiamo occupare, possiamo la-sciarlo perdere quando ne abbiamo N-1 a posto. Qual èla logica? supponete che noi possiamo scegliere tra Nbeni e scambiare tra mele pere pesche e così via, se sia-mo contenti degli N-1 beni che abbiamo vuol dire chenon vogliamo né averne di più né averne di meno, quindiimplicitamente non siamo disposti né a darli né a cederli,implicitamente siamo contenti anche dell’Nunesimo be-ne, quindi la finanza non è un mercato residuale, ha unruolo molto attivo nel sistema e tutto questo è confer-mato. Essa capitalizza l’ottimismo del boom e fa sballarei vincoli di bilancio: nel periodo zero facciamo investi-menti finanziandoci con credito, l’aspettativa è che i pro-fitti dell’anno dopo copriranno il nostro indebitamentocon i suoi costi, ma se le nostre aspettative sono ottimi-stiche e i profitti veri, non quelli attesi, non quelli ottimi-stici del boom, cadono sotto i debiti che abbiamo con-tratto, abbiamo un’insolvenza. Quindi il vincolo di bilan-cio non è una cosa che possiamo prendere alla leggeraperché necessariamente, non riuscendo a prevederecorrettamente il futuro, possiamo sbagliare e fallire, cosìil boom con il suo ottimismo culmina endogenamente inuna crisi finanziaria che spinge il sistema in una profon-da recessione. Per concludere: nell’economia di Minskyle patologie non sono ignorate a priori – non è la medici-na dei malati sani questa –, sono un aspetto fisiologicodella realtà. La teoria questa volta collima pienamentecon i fatti e la conferma è sotto i nostri occhi. Non hofatto un’analisi particolarmente raffinata delle citazioni diMinsky, ma ho comunque verificato che c’è un certo le-game tra episodi di instabilità e aumento delle citazioni,
26
e dati i tempi presumo che cresceranno sempre di più. Èpresumibile, secondo tutte le valutazioni, che non cisbarazzeremo facilmente di questa instabilità, ormai ibuoi, che Keynes aveva tanto chiesto di tenere dentro ilrecinto attraverso i vincoli alla libertà dei capitali, sonousciti dal recinto e sarà molto difficile rientrare, quindi miaspetto un successo crescente di Minsky e debbo direche questo Dipartimento e gli studiosi che oggi parleran-no avevano intuito da tempo le potenzialità dell’econo-mia di Minsky, senza bisogno degli shock che abbiamoavuto di recente.Sino ad ora ho voluto fare una panoramica per inquadra-re il contributo di Minsky e dire perché val la pena leg-gerlo, perché val la pena studiarlo, ma vorrei chiuderecon un piccolo spunto personale, perché per me Minskyè stato un grande stimolo. Nel suo libro Una stanza tuttaper sé Virginia Woolf dice che i pensieri sono come i pe-sciolini d’argento che emergono dalle acque e poi si ina-bissano, e per me Minsky è stato una vera miniera di pe-sciolini d’argento. Ne voglio citare uno perché è l’ultimo.Nelle mie ricerche ho scoperto che Minsky e Keyneshanno un diverso concetto della finanza speculativa. PerMinsky la speculazione è connessa al mercato primario,cioè ha a che fare con l’indebitamento e in particolarecon un indebitamento eccessivo che viene pagato attra-verso nuovo debito. Per Keynes (e mi riferisco al capitolo12) la speculazione è connessa al mercato secondario, laborsa valori consente di rivendere gli asset prima dellaloro scadenza, nello specifico i beni reali, i beni di inve-stimento, e in questo modo gli asset, che sono illiquidiper la collettività, diventano liquidi per l’individuo, maquesto è un imbroglio, Keynes ci dice che questo è unfeticcio della liquidità perché l’investimento è illiquidomentre per l’investitore diventa liquido quando può ven-derlo sul mercato borsistico. Quindi sono due diverseconcezioni e nella crisi sub-prime troviamo entrambe,perché i sub-prime erano mutui ma attraverso le cartola-rizzazioni sono stati venduti in Borsa allo scopo di trarneprofitto, quindi abbiamo tutti e due i fenomeni e questadistinzione non è di lana caprina, è molto rilevante inconcreto perché le terapie contro i due tipi di instabilitàsono diverse: se voglio limitare l’indebitamento devo
27
porre delle restrizioni in termini di liquidità di capitale allebanche, se voglio limitare le compravendite di attivitàfaccio la Tobin Tax. Un invito quindi a studiare Minsky, astudiare Keynes e il confronto tra loro, perché in base al-la mia esperienza è una miniera di stimoli, di pesciolinid’argento. Grazie
Pia Locatelli
Grazie Elisabetta per averci fatto ripercorrere l’evoluzionedella teoria economica e per aver messo in evidenza ilcontributo chiave di Minsky in termini sia di teoria sia diaderenza alla realtà. E grazie anche per questa bella im-magine dei pesciolini d’argento.Ora è il turno della professoressa Anna Maria Variato,una laurea in Economia e Commercio a Bergamo e dot-torato di ricerca a Bergamo, dottorato di ricerca in Mer-cati dei capitali ed intermediari, professora associata diEconomia politica all’Università di Bergamo. Il suo con-tributo naturalmente riguarda Minsky, l’instabilità del ca-pitalismo e le triadi eccellenti e io, come credo altri inquesta sala, voglio capire bene cosa sono queste triadieccellenti. Grazie
Anna Maria VariatoUniversità di Bergamo
Per questo mio intervento ho cercato di trovare un equili-brio tra la necessità di riassumere in modo divulgativo enon troppo tecnico il contributo di un economista a cuisono particolarmente legata e la tentazione di entrare neldettaglio, di spiegare, e questo mi ha spinto a scegliereun titolo in qualche modo provocatorio e anche un po’schematico. Ho cercato quindi di sintetizzare la rilevanzadel contributo di Minsky attraverso una serie di triadi,che pullulano nella sua teoria.Prima di iniziare, una brevissima premessa sulla rilevanzadel pensiero di Minsky. In quest’aula oggi si trovano benquattro generazioni di economisti che hanno avuto a chefare con Minsky nel loro percorso intellettuale: si trovano
28
i pari, cioè coloro che quando l’hanno conosciuto eranogià degli economisti, avevano già completato il loro per-corso formativo, quindi sono stati influenzati dalla suapresenza successivamente e di conseguenza hanno da-to e ricevuto dalla presenza di Minsky; si trovano anchegli alunni della fase uno, per esempio il professor DelliGatti, che ha avuto una conoscenza diretta di HymanMinsky quando non aveva ancora terminato il suo per-corso formativo e quindi Minsky è stato anche un suo in-segnante; gli alunni della fase due sono gli economisticome me, coloro che hanno avuto una conoscenza diret-ta di Minsky, l’hanno avuto come insegnante, come sti-molo intellettuale, ma sono anche stati alunni di coloroche erano o pari o alunni di fase uno, ad esempio io so-no stata alunna di Piero Ferri e e ho studiato i contributidi Delli Gatti; infine ci sono gli studiosi più giovani, tutticoloro che hanno avuto una conoscenza di Minsky sol-tanto indiretta, non l’hanno conosciuto perché purtroppoè morto, oppure ne hanno semplicemente letto i contri-buti. Perché soffermarsi su questo? Perché a mio avvisoquando un economista ha questo tipo di rapporto con larealtà, con l’accademia è sicuramente un economistache dimostra di avere anzitutto una fortissima feconditàintellettuale e, dato che almeno quattro generazioni dieconomisti se ne occupano, anche un forte carisma per-sonale. Carisma che per certi tratti è anche pericoloso,nel senso che quando ci si misura con un economista di
29
questa levatura è difficile evitare il rischio di farne unasorta di “santino” al quale ci si sottomette con un’ade-sione intellettuale poco critica, però appunto lo sforzo ècontinuamente quello di andare a leggere il contributodell’autore senza farsi troppo dominare dalla personalitàche si sta studiando e cercando di comprendere. Questequattro generazioni di economisti ci permettono oggi divalutare con maggior rigore interpretativo la vera potenzaed efficacia, i limiti e i pregi del contributo di Minsky. E iolo faccio appunto attraverso questa provocazione di pre-senza di triadi nel percorso minskiano.La prima triade che mi sembra opportuno sottolineare, eche è uno dei fondamenti dell’insegnamento minskiano,è che il sistema capitalistico è intrinsecamente dominatoda incoerenza, dinamicità e instabilità.L’incoerenza è pervasiva e sistematica, cioè Minsky pro-pone una visione macroeconomica in cui l’incapacità delsistema capitalistico di muoversi in modo coerente è untratto persistente, quindi non è una occasionale imperfe-zione, non è un accidente. Questa pervasività interessatutta la macroeconomia e quindi tutti gli elementi, i ma-cro settori dell’economia che andiamo a studiare, per cuiriguarda il mercato dei beni nella dimensione reale delladomanda aggregata, mercato dei beni in cui l’incoerenzaè rappresentata dal fatto che si diffondono degli shockche vengono mediati attraverso i mutamenti delle aspet-tative e dei cash flow che mutano sul lato degli investi-menti ma possono essere anche sul lato dei consumato-ri, può anche essere lo Stato – lo vedremo dopo. C’è unaincoerenza nel mercato della moneta, quindi nella dimen-sione monetaria sempre sul lato della domanda aggrega-ta, perché nel mercato monetario dominano gli aspettispeculativi, e c’è incoerenza nel mercato del lavoro, cherappresenta il lato dell’offerta aggregata, perché nel mer-cato del lavoro esistono rigidità, viscosità salariali e co-munque un processo di contrattazione, un processo diistituzionalizzazione che è ben diverso da quello immagi-nato e rappresentato dall’economia neoclassica.Il secondo elemento, ossia la dinamicità del sistema ca-pitalistico, dà luogo a una seconda triade importante.Nel momento in cui sottolineiamo che il sistema capitali-stico è dinamico in senso sostanziale, introduciamo la
30
variabile tempo che anch’essa deve essere sostanziale,quindi il tempo che consideriamo è un tempo storico,non più una categoria logica, e nel momento in cui iltempo è storico c’è la possibilità che ciò che noi pensa-vamo ex ante, cioè a priori, non coincida con quello chepoi effettivamente succede dopo, quindi la potenziale di-vergenza ex ante – ex post ci porta all’emergenza di altritre aspetti in cui questa divergenza ex ante – ex post sipuò manifestare, ovvero il fatto che le aspettative posso-no non verificarsi a posteriori, quindi ci si possa attende-re un risultato positivo che a posteriori non si manifeste-rà. C’è un problema di coordinazione perché i profili deiflussi di cassa e dei flussi reddituali non coincidono, imercati non si coordinano perfettamente data la com-plessità del sistema economico e questo porta poi comeconseguenza anche a dover considerare che, essendostorico il tempo nel quale ci muoviamo, il sistema capita-listico si evolve e quindi non è sempre uguale a se stes-so o non condizionato dalla storia che passa, questorende la conoscenza degli individui e le loro relazioni for-temente strutturate su una base convenzionale e rendeimportante il riferimento degli individui alle istituzioni.L’al tro elemento legato alla dinamica sostanziale cheporta a osservare una ulteriore triade rispetto al ruolo deltempo è che nel processo dinamico, che secondo Min-sky è un processo di natura ciclica persistente ed endo-geno, si alternano di fatto una fase di normalità, che èquella che normalmente osserviamo, il ciclo economicocon le sue fasi di espansione ripresa recessione e de-pressione, che possono essere descritte dalla normaleteoria del ciclo economico, ma esistono anche due altrefasi patologiche, che in Minsky hanno una rilevanza par-ticolare, che sono appunto le fasi cosiddette irrazionali,estreme: la fase di panico e la fase di euforia, e Minsky ciillustra perché si manifestano.Il terzo elemento è rappresentato dalla instabilità che,come vedete dalla rappresentazione grafica (vedi paginasuccessiva), è fatta di una serie di triadi che si nidificano.In particolare, la micro-fondazione del funzionamento delsistema capitalistico è la natura umana che, come scriveKeynes nella sua Teoria generale, ha un legame con treleggi fondamentali della psicologia che operano nei mer-
31
cati macroeconomici: la propensione marginale al consu-mo, cioè cosa determina per la categoria dei consuma-tori la decisione di consumare oggi o di consumare in unperiodo successivo; l’efficienza marginale del capitale,che è l’elemento fondamentale per la decisione dell’inve-stimento da parte delle imprese – come fa un’impresa adecidere di quanto e come investire (l’efficienza margina-le del capitale è una misura della potenziale redditivitàdell’attuazione di un progetto di investimento, che però èpsicologica perché l’investitore che deve decidere quan-to capitale investire lo fa sulla base di valutazioni sogget-tive non conoscendo che cosa ci sarà in futuro); e la pre-ferenza per la liquidità, che è la legge psicologica cheopera sui mercati monetari: perché un individuo deve de-tenere in moneta piuttosto che in altre attività finanziarie,perché detenere un’attività che non dà rendimento quan-do invece ci sono altre attività potenzialmente redditizie?Queste leggi psicologiche fondamentali determinano unprimo elemento della natura instabile del sistema.Un secondo elemento è legato all’estensione dell’infor-mazione che gli individui posseggono. L’informazione li-mitata in Minsky ha tre caratteristiche, anche se non so-no spesso esplicitate: il riconoscimento che c’è una di-mensione di informazione asimmetrica, cioè gli individui
32
detengono in uno stesso istante informazioni diverseperché sono individui diversi e quindi naturalmente sispecializzano e non possono avere lo stesso tipo di in-formazione; una dimensione di rischio, quindi una situa-zione che pone tutti sullo stesso piano di fronte a eventifuturi che però, pur avendo una dimensione stocastica,hanno una possibile rappresentazione in termini di pro-babilità di funzioni tabulate, per così dire; la dimensionedell’incertezza fondamentale, cioè una situazione nellaquale gli individui non conoscono e non possono utiliz-zare delle distribuzioni probabilistiche per formare la pro-pria previsione del futuro. Queste dimensioni fondamen-tali dell’informazione – asimmetria, rischio e incertezza –sono tutte presenti nell’analisi di Minsky e costituisconouno dei suoi dati caratteristici che lo differenziano tantodal filone neo-keynesiano, che invece focalizza quasiesclusivamente sull’informazione asimmetrica o even-tualmente sul rischio ma non sull‘incertezza fondamenta-le, quanto dai post-keynesiani, che invece enfatizzano ilruolo della sola incertezza fondamentale.Infine abbiamo la triade più importante che appunto èanche fisicamente la più grande, rappresentata dal ruoloessenziale della dimensione finanziaria. Nella visioneminskiana il sistema capitalistico non può essere inter-pretato senza far riferimento al fatto che c’è una dimen-sione finanziaria, che nella teoria di Minsky trova una suarappresentazione sottolineando che le relazioni degli indi-vidui a livello micro o macro si possono rappresentarecome delle relazioni di bilancio, quindi il sistema econo-mico è rappresentabile come una stratificazione di rela-zioni di bilancio. Le unità economiche sono tanti stati pa-trimoniali a profitti e perdite che si intersecano, di conse-guenza le posizioni creditizie di un individuo si specchia-no nelle posizioni debitorie di un altro, le posizioni reddi-tuali, i flussi di cassa, i flussi finanziari in positivo di un in-dividuo sono le posizioni negative di un altro. In questarelazione appunto contabile, molto chiara a chi si occupadi contabilità, abbiamo tipi di flussi di cassa che possonoessere flussi di reddito, flussi di bilancio e flussi di porta-foglio, flussi di cassa che hanno differenti gradi di liquidi-tà; abbiamo diversi tipi di unità che sono le unità coperte,quelle speculative e le Ponzi; e diversi tipi di asset ovvero
33
attività finanziarie che possono essere viste come sicure,protette o rischiose. Ora, nella visione minskiana la rela-zione tra i flussi di cassa, i tipi di unità e i tipi di attività di-pende dall’andamento del ciclo economico.Non c’è ovviamente tempo per addentrarsi in questiaspetti di dettaglio della teoria di Minsky, tuttavia le con-seguenze di queste triadi importanti sono a loro volta del-le triadi, ovvero – ovviamente lo dico a livello di provoca-zione, perché ci sono anche altri elementi più ricchi – ilnocciolo della questione ruota intorno a questi elementi,che sono tutti molto eterodossi: da un lato è rilevante ilruolo della domanda aggregata e quindi è la domandaaggregata che traina l’andamento dell’economia, se c’èun ruolo per l’offerta, l’offerta che è rilevante è quella fi-nanziaria, ovvero di fondi e quindi che esistano degli stru-menti finanziari che riescono a finanziare l’at ti vità econo-mica; il motore della dinamica economica è la specula-zione che ha i caratteri che sono stati prima illustrati dallacollega De Antoni, e questa situazione di instabilità intrin-seca rende necessario un intervento di politica economi-ca particolarmente incisivo e pervasivo. Questa è la cosaimportante che spesso viene tralasciata o non sottolinea-ta quando si studia Minsky, perché viene visto soprattut-to nella sua dimensione di teorico dell’instabilità finanzia-ria ma si lasciano di solito in disparte gli altri aspetti.In sostanza l’intervento di politica economica suggeritoda Minsky si articola su tre forme di intervento. Uno: ilbig government, ovvero lo Stato che deve intervenire nelmercato dei beni attraverso l’espansione della spesapubblica, o la riduzione delle tasse, ma soprattutto attra-verso la spesa pubblica. Deve poi intervenire nella di-mensione finanziaria dell’economia svolgendo il ruolo distabilizzatore attraverso la funzione di lender of last re-sort, ovvero prestatore di ultima istanza: lo Stato, attra-verso la Banca centrale, non deve lasciar fallire gli inter-mediari finanziari quando si presentano problemi di liqui-dità e di insolvenza. Il terzo fattore è il ruolo dello Statocome datore di lavoro di ultima istanza, ovvero comeStato che si preoccupa non solo della dimensione del-l’efficienza ma anche dell’equità, della dignità dell’essereumano, del fatto che non si deve semplicemente sussi-diare un individuo per stimolare la domanda ma si deve
34
anche dare una dignità di lavoro. Questa dimensione,cioè l’insieme di big government, lender of last resort eemployer of last resort, che devono essere tutti insiemeattuati per cercare non di eliminare ma di attenuarel’instabilità del sistema capitalistico, è la ricetta di quelloche è un tentativo di migliorare il funzionamento del si-stema capitalistico e di fatto, se osserviamo i tempi at-tuali, questo non è attuato in molteplici dimensioni.Queste caratteristiche però possono essere ritrovate inmolti contributi keynesiani e quindi perché considerareMinsky un economista particolarmente originale? perchéil passo in più fatto da Minsky è che sì sottolinea il ruolodella moneta, ma mette in evidenza anche il ruolo impor-tantissimo della finanza. Minsky, oltre al tema della solvi-bilità, sottolinea il ruolo della liquidità, cioè che il sistemacapitalistico per entrare in crisi non necessariamente de-ve avere dei problemi seri, deve innescare catene di falli-mento, prima delle catene di fallimento bastano crisi di li-quidità. I tempi recenti sicuramente mostrano la corret-tezza di questa idea: il sistema capitalistico è fragile e loè perché appunto la finanza rappresenta la croce e la de-lizia del suo funzionamento. È la delizia nel senso che lafinanza agisce, nei momenti di aspettative e di conven-zione positive, come un propulsore dell’attività economi-ca e rende possibile il raggiungimento di risultati che al-trimenti non sarebbe possibile ottenere – nel senso chebanalmente ho una buona idea ma non posso finanziar-la, vengono perse delle possibilità, se invece c’è una fi-nanza che dà questi strumenti ovviamente l’attività eco-nomica progredisce. Ma nel momento in cui progrediscelo fa in un modo più fragile perché espone l’individuoche ha una buona idea al mutamento repentino dellecondizioni esogene; se l’individuo è piccolo queste con-dizioni non sono particolarmente preoccupanti, maquando le dimensioni dell’individuo rispetto al sistemaeconomico cominciano ad espandersi la fragilità aumen-ta e porta gli attori che subiscono il ruolo della finanza adessere attori che distruggono il funzionamento del siste-ma economico creando gli eventi essi stessi.Direi che questo è in estrema sintesi quello che mi sentodi sottolineare del contributo minskiano. Ringrazio tutti eringrazio gli economisti che mi hanno reso economista.
35
Pia Locatelli
Grazie Anna Maria. Ora la parola al professor DomenicoDelli Gatti, economista di seconda generazione, secondola definizione di Anna Maria Variato. Il professor Delli Gat-ti è laureato in Economia e Commercio alla Cattolica diMilano, poi un phd presso il Consorzio delle tre Universi-tà milanesi, professore ordinario di Economia politica al-l’Università Cattolica di Milano; è coordinatore europeodel progetto di ricerca FP7: Monetary, Fiscal and Structu-ral Policies with Heterogeneous Agents, organizzato dalleIstituzioni europee. La parola al professor Delli Gatti.
Domenico Delli GattiUniversità Cattolica di Milano
Sono stato anche assistente del professor Piero Ferri inCattolica e posso cominciare da un aneddoto. Piero Ferriinsegnava Economia II, io ero suo assistente e quindicorreggevamo insieme i compiti in questo modo: in pra-tica io stavo sul foglio e Piero mi chiedeva quanto dare,se andavo oltre un minuto per correggere mi diceva cheero troppo lento, non capivo abbastanza rapidamente.Oggi vorrei fare una personale recollection con riferimen-to però anche al mio modo di vedere la ricezione di Min-sky.
36
Direi che possiamo cominciare con il distinguere tra unMinsky senza virgolette, cioè i suoi lavori sull’instabilitàfinanziaria, e un Minsky tra virgolette: la sua ricezionenella professione degli economisti e sui media. Questidue Minsky sono molto diversi, c’è un Minsky beforeMinsky, perché la sua ipotesi di instabilità finanziaria eraben nota agli economisti anche di tipo mainstream, an-che negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, manon lo si citava mai, sostanzialmente per due motivi: pri-mo perché l’approccio teorico e modellistico era chiara-mente non standard – e le presentazioni di Elisabetta DeAntoni e di Anna Maria Variato sono state molto eloquen-ti da questo punto di vista – e secondo perché le previ-sioni sembravano catastrofiche e non realistiche in tempinormali. Minsky non si riteneva un doomster, si ritenevaun osservatore oggettivo dell’economia capitalistica, madal punto di vista di molti esponenti dell’economia main-stream era sicuramente un mister Doom, prima di NourielRoubini. Cito un esempio: una volta Mauro Gallegati (chenon può essere qui ma parlo anche un po’ a nome suo),uno dei “due gatti”, chiese a Phelps che ne pensava diMinsky e Phelps, che è un recente premio Nobel, rispo-se: “Ah sì Minsky: catastrofe, disgrazia, terremoto”; que-sta era sostanzialmente la visione delle previsioni di Min-sky che circolava nel mainstream e badate che Phelps ètutt’altro che un economista standard, per certi versi hadato contributi non riconducibili all’approccio stretta-mente neoclassico. Per cui prima del Minsky tra virgolet-te la ricezione nella professione era modesta o assente,c’erano i libri di Minsky nei bookshelf degli economistimainstream, ricordo di averli visti nella biblioteca di Ger-tler nella New York University, ma sicuramente non tra ibusiness practitioner che Minsky conosceva molto bene.Poi c’è il disgelo, le cose sono cambiate nella secondametà degli anni Ottanta, c’è stata una rivoluzione micro-economica, la rivoluzione dell’informazione asimmetrica,nel senso preciso e non strettamente minskiano di Aker-lof e dei suoi seguaci, e questa rivoluzione dell’informa-zione asimmetrica ha marginalizzato il contributo di Mo-digliani e Miller – che sostanzialmente dice: la strutturafinanziaria degli agenti è totalmente irrilevante nelle lorodecisioni di investimento – e quindi ha indotto una rivisi-
37
tazione del contributo di Minsky. Basta citare alcuni nomi– naturalmente mi riferisco prevalentemente a colleghieconomisti che forse per la audience più ampia sono illu-stri sconosciuti –: Bernanke e Gertler. Bernanke è uneconomista accademico – oggi noto soprattutto per es-sere presidente della Federal Reserve – e alla fine deglianni Ottanta insieme a Gertler ha pubblicato articoli incui enfatizzava il cosiddetto rischio del prestatore, ossiaun elemento che trovate in Keynes e in Minsky. Poi ci so-no stati i lavori, sempre fine anni Ottanta inizio Novanta,di Greenwald e Stiglitz che hanno utilizzato il rischio delprenditore, altro elemento che trovate di nuovo sia inKeynes sia in Minsky. Un terzo elemento importante è larivisitazione della razionalità e la nascita dell’idea di ra-zionalità limitata nella formazione delle aspettative, chec’è anche nel contributo di Sargent.Consentitemi ancora una personal recollection: Minskyera in punto di morte, alla metà degli anni Novanta, maera molto attento a quello che diceva Sargent, il qualeaveva pubblicato nel ’93 una bella serie di lecture sullarazionalità e Minsky, che si ricordava di lui essendo statoSargent un suo studente a Berkeley, mi disse di tenerlod’occhio perché avrebbe potuto nascere da qui una rivo-luzione anche nel modo in cui si ragiona sulla formazionedelle aspettative. E anche da questo punto di vista Min-sky è stato profetico, perché oggi come oggi il fatto chele aspettative siano eterogenee, che non siano formate inmodo razionale e così via è diventato in un certo sensomoneta corrente, almeno per una parte non irrilevantedella professione.Quindi a questo punto, a metà degli anni Ottanta inizi an-ni Novanta, c’è un po’ di Minsky nell’aria, peccato cheHyman purtroppo queste cose non le ha viste di personaperché nel ’96 ci ha lasciati. Cito l’incipit di un articolofamoso di Bernanke, Gertler e Gilchrist – Bernanke quinon è ancora presidente della Federal Reserve, lo diven-terà solo nel 2006 –, pubblicato su Handbook of Macroe-conimics. Si tratta di un grosso articolo, sono quasi cen-to pagine, intitolato The Financial Accelarator in a Quan-titative Business Cycle Framework ed è pionieristico pertutta la parte della letteratura che si rifà alla cosiddettanuova sintesi neoclassica di cui parlava Elisabetta prima.
38
“How does one go about incorporating financial distressand similar concepts into macroeconomics? While it se-ems that there has always been an empirical case for in-cluding credit-market factors in the mainstream model,early writers found it difficult to bring such apparently di-verse and chaotic phenomena into their formal analyses.As a result, advocacy of a role for these factors in aggre-gate dynamics fell for the most part to economists outsi-de the US academic mainstream, such as Hyman Minsky,and to some forecasters and financial market practitio-ners”4. Questo per dire che c’è ben presente questopezzo del discorso nella letteratura financial acceleratorche è partita negli anni Novanta. Purtroppo poi però ilmodo in cui queste cose vengono infilate nei modellistandard dà luogo a dinamiche che sono di nuovo stan-dard, cioè l’economia è sostanzialmente stabile ed è col-pita da shock, soltanto che i fattori finanziari amplificanola risposta agli shock.Minsky dopo Minsky. La crisi finanziaria globale ovvia-mente ha cambiato le cose e ha riportato in auge il pen-siero di Hyman, è il Minsky moment non soltanto neimercati finanziari, nella macroeconomia, ma anche suimedia, che sono molto attenti al contributo di Hyman eci sono decine di articoli sui principali quotidiani e rivistestatunitensi e mondiali. Ma in un certo senso è il Minskymoment anche nella professione, sebbene continui adessere non citato, se non da alcuni, ma la professionescopre cose che sono ben note ai cultori dell’instabilitàfinanziaria, tipo il procyclical leverage. Cito ad esempio ilavori di Adrian e Shin che sono largamente conosciutiper l’analisi della crisi finanziaria e richiamano concettiche sono ben noti a chi di Minsky è stato in un certosenso uno studente.
39
4 Come si possono incorporare il financial distress e concetti simili nel-la macroeconomia? Mentre c’è sempre stata una motivazione empiri-camente fondata per includere nei modelli dominanti fattori riconduci-bili al mercato del credito, coloro che se ne sono inizialmente occupatihanno trovato difficile introdurre un insieme di fenomeni così diversi ecaotici nelle loro analisi formali. Pertanto la rivendicazione di un ruoloper questi fattori nella dinamica macroeconomica è venuta in buonasostanza da economisti fuori dal mainstream statunitense, come Hy-man Minsky, e da alcuni analisti congiunturali e operatori dei mercati fi-nanziari.
Quello che però forse è il caso di fare, seguendo anchel’ispirazione che Hyman ci ha dato – io e Mauro siamostati appunto tra i suoi studenti di prima generazione – èandare un po’ anche oltre Minsky, un Minsky senza levirgolette, cercando di costruire una research agenda inqualche misura post-minskiana. Hyman ha dato enormicontributi per l’analisi degli sviluppi correnti e incredibiliinsight sul futuro: ricordo le sue analisi sul money mana-ger capitalism negli anni Ottanta che erano assoluta-mente profetiche rispetto a quello che sarebbe successovent’anni dopo, però ovviamente gli mancavano – comemancavano a noi e come mancano tuttora a molti eco-nomisti – strumenti anche di tipo analitico che si sonoresi disponibili solo successivamente e che a volte ven-gono da discipline che all’economia sono soltanto conti-gue, in particolare la fisica in cui ci sono due punti chesecondo me e Mauro sono molto importanti, andrebberosviluppati e dentro i quali gli insight di Minsky si trovanomolto bene. Uno è costituito dai modelli macroeconomi-ci ad agenti eterogenei, i cosiddetti agent-based models,dove vengono incorporate nozioni di teoria della com-plessità. La teoria della complessità in realtà si applica amolti campi, è largamente interdisciplinare, la si trova infisica, in biologia, nella fisiologia, e si può applicare an-che ai modelli macroeconomici; per fare questo bisognaovviamente andare oltre l’approccio standard. I modellimacroeconomici ad agenti partono dall’ipotesi che gli
40
agenti siano eterogenei e quindi si rifiuta l’ipotesi diagente rappresentativo; molto spesso utilizzano l’ipotesidi razionalità limitata per costruire teorie dei comporta-menti individuali e giungono poi a studiare gli esiti ag-gregati come proprietà emergenti dell’interazione traagenti eterogenei, quindi un approccio radicalmente di-verso da quello standard. L’altro punto che mancava ne-gli anni Ottanta è l’idea dei financial networks; qui, dinuovo partendo dagli agenti individuali e dalle loro inte-razioni, occorre enfatizzare il ruolo della struttura a retedei rapporti tra agenti, quindi quello che una certa lette-ratura – a cui noi abbiamo provato a contribuire – ha en-fatizzato è il fatto che le relazioni di debito-credito traagenti costituiscono delle partnership, in queste reti gliagenti sono nodi e i rapporti debito-credito sono link.Quando la fragilità finanziaria è importante alcuni di que-sti link possono saltare perché alcuni agenti vanno inbancarotta, siano essi imprese o banche o banche di in-vestimento; e le bancarotte nei modelli con network pos-sono essere fenomeni che creano contagio, quindi cipossono essere bancarotte che avvengono a cascata, eovviamente questo crea un grosso problema di regola-mentazione per il policy maker. Sono tutti argomenti chestanno dentro una research agenda che noi consideria-mo post-minskiana ma che da Hyman ha tratto un’ispi-razione fondamentale.Non posso far altro quindi che concludere richiamandogli insegnamenti che Minsky ci ha dato, che sono esat-tamente quelli che ha richiamato Piero Ferri, né più némeno: guardare all’economia di mercato così come èoggi sulla base dell’assetto istituzionale che l’economiaha e che si evolve continuamente, quindi una fortissimaattenzione al dato empirico e al dato istituzionale (que-sto differenzia Minsky non soltanto dagli economistineoclassici standard ma anche da economisti che hannoripreso l’approccio classico o marxiano, per certi versiperlomeno); lavorare quindi sugli aspetti di carattere isti-tuzionale, ovviamente questo significa conoscere la sto-ria e conoscere le istituzioni; cercare di trovare un lin-guaggio che consenta di convincere anche la professio-ne, perché Hyman era molto convinto dell’opportunità diriuscire a creare un breakthrough dentro la professione,
41
senza questo varco in larga misura i messaggi rilevantirimangono non ascoltati. Perché poi è la professioneche diventa il cornerstone anche della policy consultan-cy, cioè i politici usano gli economisti, sono per certiversi, usando l’espressione di Keynes (ultima pagina deLa teoria generale), schiavi di qualche economista de-funto, è importante quindi che gli economisti a cui i poli-tici prestano orecchio siano quelli che di queste cose edell’approccio minskiano sono ben consapevoli. Grazieper la vostra attenzione e ovviamente grazie per avermiinvitato.
Pia Locatelli
Grazie a te e ora passiamo a un economista di quartagenerazione: Marco Passarella, che si è laureato all’Uni-versità di Bologna, poi un phd all’Università di Firenze,assegnista di ricerca in Economia politica presso il Di-partimento Hyman Minsky dell’Università di Bergamo,dove ha appena chiuso un corso di Approfondimenti dimacroeconomia. Il titolo della sua comunicazione è:“Minsky dalla fiera del villaggio a Wall Street” e siamomolto curiosi di sentirla.
Marco PassarellaUniversità di Siena
Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori per averpensato a me e avermi invitato; devo confessare chesperimento oggi una sensazione, che ho già provato: misento un po’ come quei gruppi spalla che generalmenteaprono i concerti e che nella migliore delle ipotesi vengo-no ignorati, nella peggiore vengono fischiati, dal pubblicopagante in attesa del gruppo principale, ma è comunqueuna buona sensazione quella di salire sul palco
Domenico Delli Gatti
I gruppi di spalla poi diventano leader.
42
Marco Passarella
L’augurio naturalmente è che questo accada. Il mio inter-vento di oggi si basa in realtà su un lavoro che ho scrittoin tempi record e che non pensavo che avrebbe ricevutoaddirittura la possibilità di essere pubblicato, pure que-sto in tempi record, e che per me è un esperimento. Inquesti anni, anche quelli trascorsi all’Università di Berga-mo, ho cercato di dare alla teoria di Minsky, o meglio asingole parti della teoria di Minsky, una veste formale, inquesto lavoro invece ho fatto tutt’altro: ho realizzato al-cune interviste a molti dei protagonisti di cui hanno giàparlato la professoressa Variato e il professor Delli Gatti,cioè quelle persone che hanno avuto un rapporto direttocon Hyman Minsky, e ho cercato di trarne in qualchemodo la storia del rapporto tra Minsky e il nostro Paese.Naturalmente si tratta appena di un abbozzo e ho inten-zione di continuare a lavorarci, ma di questo vi parleròoggi.Prima due parole su Minsky, anche ad integrazione diciò che è stato detto sino ad ora. Io credo che il tentati-vo di Minsky consista nel mettere insieme alcune partidella teoria di Keynes con proprie intuizioni dando al tut-to una rilettura nel complesso originale anche della teo-ria keynesiana. In particolare Minsky si propone di co-niugare la teoria del ciclo economico – derivabile dallateoria generale di Keynes come ciclo determinato so-
43
prattutto dall’andamento degli investimenti, cioè dallacomponente autonoma della spesa privata – con unateoria finanziaria dell’investimento. Minsky rilegge lateoria degli investimenti di Keynes come una teoria delciclo, dunque non come una teoria della stagnazione, ela rilegge in chiave finanziaria. In particolare si proponedi indagare quali siano le cause dell’investimento, le de-terminanti ultime di investimento, e le rinviene nella sfe-ra finanziaria. Le decisioni di investimento degli operato-ri economici sono determinate e condizionate dalla di-sponibilità di finanziamenti esterni. Il finanziamentoesterno di un investimento tende generalmente a cre-scere nel corso della fase ascendente del ciclo econo-mico e questo fa sì appunto che il leverage, la cosiddet-ta leva finanziaria – cioè il grado di indebitamento, dettoin termini semplici – di ciascun operatore economico, inparticolare delle imprese ma come abbiamo sperimenta-to di recente anche delle famiglie, tende a crescere nelcorso del boom e tende invece a ridursi nel corso dellafase discendente del ciclo. Questo non basta, perchéc’è un altro elemento forte di fragilità individuale e siste-mica che emerge nel corso delle fasi di crescita del-l’economia ed è il fatto che non solo gli operatori tendo-no ad indebitarsi sempre di più ma tendono a farlo sem-pre più a breve termine, cioè a fronte di un’attività a lun-go termine qual è in genere l’attività di investimento ten-dono a contrarre debiti a breve termine. Questo perchéè meno costoso, consente di realizzare profitti maggiorie un margine di profitto sul capitale investito superiore,dunque il motivo per cui ci si indebita non è che gliagenti siano irrazionali, è al contrario che gli agenti sonorazionali e perseguono la massimizzazione del profitto.Sulla base di questi due pilastri Minsky deriva la propriaipotesi di instabilità finanziaria, in realtà non di un’ipotesisi tratta ma di una vera e propria teoria basata su alcuniassiomi, cioè alcune ipotesi che possono essere più omeno definite, su queste non c’è accordo. L’idea di fon-do però, come è già stato detto, è che la stabilità siadestabilizzante, Minsky dice che è proprio nel corso del-le fasi di crescita tranquilla – definizione icastica cheMinsky mutua da Joan Robinson e quindi anche conuna certa dose di sarcasmo – che vengono poste le pre-
44
messe per la successiva inversione del ciclo, è proprionelle fasi di crescita tranquilla che gli operatori si sento-no più sicuri perché il passato è via via migliore, perchéle previsioni rispetto al futuro sono via via migliori sia ri-spetto alla propria capacità di generare profitti sia ri-spetto alla propria liquidità. Ciò fa sì che le unità tenda-no via via ad indebitarsi e di conseguenza si arriva a unmomento di insostenibilità nel quale, o a causa di feno-meni endogeni o anche a causa di shock esterni, si ot-tiene un’inversione del ciclo economico. Sulla base diquesta considerazione Minsky deriva anche un cosid-detto teorema anti laissez-faire. L’idea di Minsky è moltosemplice: le politiche economiche liberiste non sono po-litiche economiche di destra come qualcuno ha sempreritenuto, né di sinistra come per esempio ritengono al-cuni economisti italiani come Francesco Giavazzi e Al-berto Alesina, sono semplicemente politiche illusorieche non hanno mai trovato reale applicazione nelle eco-nomie occidentali, fatta forse eccezione per l’economiainglese e forse quella olandese di metà Ottocento. Que-sto perché in realtà le nostre economie sono sistemi in-trinsecamente, endogenamente instabili in cui le istitu-zioni e in generale l’intervento pubblico – banca centralee governo – svolgono un ruolo di cuscinetti, in qualchemodo attutiscono questa tendenza all’instabilità del si-stema.I riferimenti teorici di Minsky, come avete capito, sonoanzitutto Keynes, sul quale non tornerò, ma un riferimen-to altrettanto importante, anzi secondo alcuni degli autoriche ho intervistato anche più importante, è il primo tutordi Minsky quando fece il proprio phd: Schumpeter. In ef-fetti la rilettura che Minsky dà della teoria keynesiana èschumpeteriana, è cioè una rilettura ciclica e non invecestagnazionista come è tipicamente quella di Keynes.Credo che questo derivi anche dal diverso periodo stori-co che i due autori hanno in mente. Un secondo riferi-mento molto importante, sottolineato anche dal profes-sor Ferri nel suo intervento introduttivo, è quello degliistituzionalisti americani, della Chicago istituzionalista enon naturalmente di quella monetarista, da cui Minskytrae non solo la propria sensibilità nei confronti del con-testo istituzionale ma anche la propria attenzione nei
45
confronti delle politiche economiche. Più controverso in-vece secondo me è il rapporto con altri due mostri sacridel pensiero, economico e non solo, come Michal Kalec-ki, un economista polacco di formazione marxista mache ottenne nel corso degli anni Trenta risultati che oggidefiniremmo keynesiani, e come lo stesso Karl Marx.L’integrazione con Kalecki è stata tentata dallo stessoMinsky ma credo che sulla fecondità di questa interpre-tazione – anzi sono sicuro sulla base delle interviste cheho realizzato – non ci sia in realtà un parere unanime tra isuoi allievi. Quanto a Karl Marx quello che è sicuro è cheMinsky da un lato, al pari di Marx, considerava le nostreeconomie intrinsecamente instabili, dall’altro però nonc’è traccia di una sua adesione alla teoria del valore la-voro di tipo marxiano, che è poi il nucleo analitico dellateoria di Marx, e di certo Minsky non apprezzava il livellodi aggregazione dei modelli marxisti, che riteneva ecces-sivo.Come Minsky arrivò in Italia? È già stato detto che inrealtà curiosamente Minsky ha intrattenuto fino al suoarrivo in Italia un rapporto privilegiato più con il mondodegli economisti applicati intesi in senso lato e deglihigh-level practitioners che non degli economisti teorici,almeno degli economisti teorici in senso stretto. In parti-colare: correva l’anno 1978, Minsky fu invitato in Italiada Paolo Savona, all’epoca direttore generale di Confin-dustria, che gli chiese di collaborare con il Centro studidi Confindustria. Dovrebbe sorprendere che Minsky ab-bia avuto i primi contatti con economisti applicati, ripetoin senso lato, o con il mondo degli operatori finanziari,dei banchieri? No, non dovrebbe sorprendere, per duemotivi: il primo è che lo stesso Minsky aveva un’espe-rienza diretta del mondo bancario; il secondo è che inquel periodo il mondo accademico italiano era dominatoè vero da economisti che oggi definiremmo eterodossi –in qualche modo all’epoca, siamo negli anni Settanta, ilmainstream italiano era ancora in larga misura eterodos-so –, e tuttavia quegli economisti si occupavano di que-stioni che dovevano sembrare molto distanti dal para-digma di Wall Street di Minsky, in quegli anni in Italia sidiscuteva di condizioni di equilibrio naturale, di sisteminaturali, di riproduzione del sistema, di caduta del sag-
46
gio di profitto, di trasformazione dei valori impressi e co-sì via, e questo livello di astrazione siderale degli ap-procci classico marxiano da un lato e cantabrigense dal-l’altro mal si conciliava invece con l’analisi della realtàconcreta che Minsky proponeva. Che cos’è il paradigmadi Wall Street? È l’idea che le nostre economie debbanoessere guardate con l’occhio a cui ad esse guardano glioperatori di mercato, per esempio un banchiere della Ci-ty londinese o uno speculatore di Wall Street, cioè so-prattutto privilegiando i flussi di cassa. Quale fu dunquel’impatto di Minsky con il mondo accademico italiano?In realtà, a dispetto di queste differenze, l’impatto fu de-cisamente buono; certo (questo me lo disse il professorDelli Gatti) non ci fu una vera e propria integrazione con imodelli teorici che proponevano i grandi economisti del-l’epoca – penso ad Augusto Graziani, a Pasinetti, a Ga-regnani, a Sylos Labini e così via, che in questo sensoerano come monadi – e tuttavia proprio questi padri fon-datori del pensiero eterodosso economico italiano con-tribuirono indirettamente alla diffusione delle idee diMinsky cogliendo l’eccezionalità del suo pensiero espesso invitando i propri allievi a seguire Minsky negliStati Uniti o semplicemente a leggerlo, come avvennenel caso del professor Delli Gatti o del professor Galle-gati, e dunque ci fu comunque una notevole influenzaquantomeno sulla seconda generazione di economistiche entrò in contatto con Minsky. Uno dei motivi delladifficoltà dell’impatto iniziale tra Minsky e gli altri econo-misti eterodossi italiani sta nel fatto che Minsky non solonon amava l’etichetta di post-keynesiano ma è difficil-mente catalogabile come tale, anzi direi che è difficil-mente catalogabile tout court. La definizione di post-keynesiano può risultare utile solo in prima approssima-zione, per distinguerlo per esempio da quegli autori chetuttora continuano a mantenere una derivazione nomina-listica da Keynes, come gli autori nuovo-keynesiani, etuttavia è certo che Minsky abbia un’autonomia teoricapropria rispetto a quella degli altri autori post-keynesianie che il suo contributo non possa essere schiacciato suquello per esempio di Paul Davidson, di Pasinetti, diKaldor, di Joan Robinson, cioè di quello degli altri grandipadri del pensiero economico non mainstream. Un
47
aspetto interessante, già emerso nel corso di questo po-meriggio, è che raramente il contributo di Minsky è statoriconosciuto dal mainstream economico. Per la verità cisono evidenze del fatto che in Italia, e non solo in Italia,nel corso degli anni Ottanta tutti gli economisti che sioccupavano di finanza e in generale del nesso tra finan-za ed economia reale conoscessero Minsky, in ogni li-breria c’era un volume o c’erano articoli di Minsky, tutta-via le citazioni sono molto rare e tra queste fa eccezioneappunto Ben Bernanke, l’attuale presidente della Fed. Inquesto senso Minsky sembrerebbe essere entrato nel-l’Olimpo di quegli autori maledetti che sono più noti tragli addetti ai lavori, e sono molto ricercati dagli studentie in genere dagli studiosi eterodossi, che dal mainstre-am economico, anche se effettivamente il prolungarsidella crisi, anzi il fatto che la crisi dei debiti privati si siatrasformata rapidamente in crisi del debito pubblico,porterà probabilmente nei prossimi anni nuove genera-zioni di economisti ad avvicinarsi al pensiero di Minsky.Minsky era consapevole di questo punto e nonostante siconsiderasse un autore anti-neoclassico (per neoclassi-co intendeva soprattutto gli autori monetaristi dell’epo-ca) tuttavia riteneva necessario che le sue tesi non tantofossero condivise dal mainstream ma quantomeno fos-sero capite dalla comunità degli economisti eterodossi.Ed emerge nel corso della sua carriera una sorta di pa-radosso: da un lato il Minsky della maturità, essendo diformazione matematica, si mostrava sempre meno inte-ressato agli aspetti matematico-formali della teoria es-sendo più interessato invece agli aspetti istituzionali ealle implicazioni in termini di politica economica, dall’al-tro tuttavia ha sempre continuato ad avere rapporti dicollaborazione soprattutto con gli economisti italiani neltentativo di dare una veste formale alla propria teoria, inaltri termini a parlare con gli economisti mainstream uti-lizzando l’unico linguaggio che questi capiscono, che èquello matematico.Il mio lavoro prosegue con una carrellata degli economi-sti e delle posizioni, delle teorie e anche delle scuole chein qualche modo sono state influenzate dal pensiero diMinsky; naturalmente non vi proporrò tutta questa carrel-lata oggi, vi mostro solo uno schema
48
e semmai vi rinvio al mio lavoro. Quello che posso dire èche tutti questi contributi rinviano secondo me a dueidee. La prima è quella, come dicevo, che, benché i pro-cessi di formalizzazione matematica implichino inevita-bilmente un impoverimento della teoria di Minsky, è tut-tavia necessario dare a quella teoria una veste formale.La seconda, a mio parere più importante dal punto di vi-sta del contenuto, è che quello capitalistico è un sistemainstabile, che questa instabilità se non adeguatamentecontrollata, se non adeguatamente vincolata può portareil sistema ad un collasso, e dunque spetta alla strutturaistituzionale, agli interventi del governo, agli interventidella banca centrale, porre dei limiti alla ciclicità del si-stema mantenendo le fluttuazioni delle principali variabilimacroeconomiche, in particolare dei livelli di disoccupa-zione, entro limiti socialmente accettabili.Mi fermo qui; il mio augurio, che è poi l’augurio con cuichiudo lo scritto che ho proposto oggi, è che ci sianonuove generazioni pronte a raccogliere l’eredità di Min-sky e in questo senso sono molto fiducioso perché, co-me dicevo prima, Minsky sta diventando a poco a pocoun classico, un autore per certi versi maledetto, ma è illato cattivo quello che fa la storia diceva un signore diTreviri che si definiva socialista scientifico, e nella miabreve esperienza di insegnamento qui a Bergamo possoassicurarvi che ho notato tra gli studenti un interessecrescente per la teoria di Minsky e credo che questo fac-cia ben sperare per il futuro. Vi ringrazio.
49
Pia Locatelli
Grazie Marco, economista minskiano di quarta genera-zione ma ha concluso come se fosse un anziano docen-te che dava i consigli ai giovani; grazie davvero e speroche riusciremo a riaverti all’Università di Bergamo.Concludiamo con Jan Kregel. Sono molto contenta cheJan sia venuto da New York per essere con noi in questagiornata e lo sono ancor di più avendo saputo da Pieroche di fatto dobbiamo a Jan Kregel l’aver portato Minskyin Italia per la prima volta; da lì è poi partita tutta una reteche ce lo fa avere ancora oggi nella nostra Università.Jan Kregel ha un curriculum lunghissimo che sintetizzomolto e cito solo i ruoli attuali: è un senior scholar al LevyEconomics Institute del Bard College – che Hyman Min-sky ha fondato andando in pensione dalla WashingtonUniversity –, dove è direttore del programma di Politicamonetaria e Struttura finanziaria; distinguished researchprofessor al Centro di Pieno Impiego e Stabilità dei Prez-zi all’Università del Missouri a Kansas City; è professoredi Finanza dello Sviluppo all’Università della Tecnologiadi Tallinn. Ricordo che è stato rapporteur nella Commis-sione per le Riforme del Sistema monetario e finanziariointernazionale voluta dal presidente dell’Assemblea Ge-nerale delle Nazioni Unite, credo un’esperienza partico-larmente interessante. Ha studiato all’Università di Cam-bridge, un phd all’Università Statale Rutgers del NewJersey. Da pochissime settimane è socio dell’Accademiadei Lincei, cosa che gli fa grande onore. Jan Kregel, alquale abbiamo chiesto di intervenire anche nella secon-da sessione, parlerà della crisi dell’area euro come unMinsky moment preannunciato. Grazie
Jan KregelLevy Economics Institute of Bard College, New York
Grazie Pia. Inizierò il mio intervento, prendendo spuntoda Piero, con la mia esperienza personale con Minsky,per trattare poi gli aspetti tecnici della crisi dell’euro.Ci sono vari avvenimenti che possiamo definire insolitinel percorso intellettuale di Minsky, per esempio è stata
50
citata la sua permanenza in Confindustria, insolita sì eno, perché ogni cosa ha una sua ragione. Innanzitutto èstrano che sia stato chiamato io da chi era alla presiden-za di Confindustria, Guido Carli, per formare un Centrostudi in cui era rappresentato il mondo ma che in effettiera italiano. Se ricordo bene, quello era un momento ca-ratterizzato da problemi sociali abbastanza seri nell’eco-nomia italiana e quando Carli venne nominato presiden-te di Confindustria si trovò senza il sostegno – che avevain Banca d’Italia – di un Centro di studi, provò quindi afondarne uno. Nominò Paolo Savona direttore generaledi Confindustria e insieme cercarono degli economisti,ma non c’era un solo economista italiano disposto adandare a lavorare in Confindustria. Un giorno Carli, cheaveva dato a Paolo Sylos Labini un passaggio sul suoaereo da Milano a Roma, si lamentò con lui di questadifficoltà e Sylos gli consigliò di cercare qualcuno fuorid’Italia; Carli chiese suggerimenti sui nomi e da lì uscì ilmio, fra altri, e così sono arrivato in Confindustria. Ab-biamo fatto ricerche sui problemi dell’industria italiana inquel momento – se ricordo bene era il periodo delle con-vergenze parallele, tra l’altro – e avevo redatto uno stu-dio in cui dicevo che il vero problema dei costi della pro-duzione nell’economia italiana non era veramente il co-sto del lavoro ma il costo del finanziamento. Abbiamoutilizzato questo studio per più o meno trovare un accor-do con i sindacati, per creare una specie di sostegno a
51
questa idea delle convergenze parallele, la possibilità diun governo alternativo. Dopo aver iniziato sulle questionidi finanza, c’era la possibilità di ampliare questa linea diricerca, ma io in quel momento avevo necessità di as-sentarmi per un semestre perché ero stato nominatoprofessore alla Rutgers University negli Stati Uniti, michiesero quindi chi si potesse prendere per proseguirequesta linea ed io, dopo averci pensato un momento, horisposto che non ce n’erano molti ma forse Hyman Min-sky aveva la possibilità di sviluppare questi studi. E così,con un’apertura molto grande, perché sicuramente néCarli né Savona erano eterodossi nel loro pensiero, la ri-sposta è stata positiva e hanno invitato Minsky. Che èarrivato con tutta la famiglia per passare un anno in Ita-lia, dove, come abbiamo sentito, ha lasciato un segnosignificativo. Quando è arrivato non aveva alcuna cono-scenza diretta dell’Italia e degli Italiani; c’erano Italianiche conoscevano il lavoro di Minsky, in particolare Pier-luigi Ciocca e Fausto Vicarelli, tutti e due furono amicimiei e insieme abbiamo più o meno costruito l’inse ri -mento per Minsky. Posso dire che Minsky ha avuto unimpatto sull’Italia probabilmente più grande di quello chel’Italia ha avuto su di lui, a parte il fatto che ha compratouna Fiat e veniva con me ogni giorno a mezzogiorno apranzare nella mensa di Confindustria, dove si mostraval’impossibilità per lui di imparare la lingua italiana: dalprimo all’ultimo giorno ogni volta prendeva un’insalata dipomodori che chiamava “tomatate”, il suo modo per in-dicare i pomodori.Non dico nulla sul suo legame con Bergamo, è già statodetto, tranne il fatto che ne parlava con grande orgoglio,anche all’estero si presentava come Minsky della Wa-shington University di Saint Louis e dell’Università diBergamo. Considerava questa relazione con Bergamocome un riconoscimento, che invece non aveva nelmainstream.Arriviamo al Levy Institute – dove lavoro io – dove Miskyè arrivato alla fine della carriera, perché ha raggiuntol’età della pensione l’anno prima che negli Stati Uniti fos-se abolita l’età di pensionamento e quindi è stato co-stretto ad andare in pensione quando tutti i suoi coetaneisono potuti rimanere dentro le università senza limite.
52
Anche la questione del Levy è abbastanza divertente: ilLevy Institute è stato fondato da uno scalatore di WallStreet che si chiamava Leon Levy il cui padre, JeromeLevy, aveva scoperto, pur non avendo un’istruzione for-male in economia, la cosiddetta profits equation,l’equazione dei profitti di Kalecki. Leon Levy aveva deci-so di fondare questo Istituto in nome del padre con unalinea teorica sull’idea della formazione dei profitti di Ka-lecki. Come abbiamo già sentito, Minsky aveva incorpo-rato questa idea nella sua teoria e il nipote di Jerome Le-vy, che aveva il compito di creare l’Istituto, ha trovato inMinsky una persona abbastanza legata a questa teoria ecosì l’ha invitato al Levy Institute per portare avanti que-sta linea di ricerca. Lui evidentemente ha fatto qualcosadi molto più grande, aveva un progetto sul finanziamentodella struttura produttiva degli Stati Uniti che alla fine hadato avvio a una serie di conferenze che si chiamano ora“Minsky Conferences” e si svolgono ogni anno a NewYork, abbiamo da poco tenuto la ventesima, che ormainegli Stati Uniti è considerato un punto di riferimento nonsolamente per gli accademici ma piuttosto per i profes-sionisti della finanza. Dopo la morte di Minsky la FordFoundation ha dato un contributo sostanzioso a un vec-chio progetto di Minsky, che ora dirigo io al Levy Institu-te. Si tratta di un progetto che abbiamo avviato con uncolpo di fortuna nel 2006, un anno prima che iniziasse lacrisi negli Stati Uniti, e così siamo stati tempestivi a fareanalisi minskiane della crisi. Fa parte del progetto ancheuna biografia di Minsky che sta scrivendo Martin Mayer,uno dei più grandi giornalisti finanziari negli Stati Uniti;più o meno siamo a metà strada, ciò che ho visto fino adora è molto interessante e credo che ne uscirà un’operamolto importante.E veniamo alla seconda parte. La crisi finanziaria è stataun “vantaggio” per i seminari e i lavori di Minsky, tuttiparlano del momento Minsky, del Minsky momentum,parlano dell’ipotesi dell’instabilità finanziaria, ma in uncerto senso è anche uno svantaggio, perché questa èsolo una parte del lavoro di Minsky, infatti possiamo direche il suo era un pensiero pluridimensionale, possiamodefinirlo un pensatore di sistemi, un grande pensatore,nel senso che aveva un’idea dell’economia anche come
53
insieme di relazioni sociali. Consultando le carte che halasciato, e che ora stiamo rendendo disponibili sul web-site dell’Istituto, si vede che la gran parte del suo lavorotratta di quei problemi che sono stati menzionati da PieroFerri: i problemi di distribuzione del reddito, il problemadell’eliminazione della povertà..., e da Anna Maria Varia-to: l’impiego di ultima istanza. C’è un insieme di aspettinella teoria di Minsky che va molto oltre la teoria dell’in-stabilità finanziaria, ed è l’idea di come possiamo co-struire una società civile, una società che non sia domi-nata dai cosiddetti manager dei fondi di investimento,ma da tutte le persone che sono nell’economia e hannoun interesse in questo mondo. Ed è questa la parte piùrecente del progetto all’Istituto: stiamo provando a met-tere al centro della ricerca l’insieme di tutti gli aspetti dellavoro di Minsky. Se ricordate l’ultimo capitolo della Teo-ria generale di Keynes, c’erano riflessioni sui fattori so-ciali che questa teoria implica. La stessa cosa vale perMinsky, che dice di aver individuato l’instabilità comeforza normale nell’economia ma che questo non basta ebisogna anche ragionare sulle conseguenze dell’instabili-tà nel sistema sociale e sulle necessarie politiche da rea-lizzare per migliorare il sistema. Probabilmente questa èla parte più importante del pensiero di Minsky, che rima-ne però tuttora in ombra mentre a mio parere bisogne-rebbe enfatizzarla. Come ha detto qualcuno, Minsky sitrovava a metà strada fra un tecnico e un filosofo socia-le. Richiamando Polanyi: è l’economia che serve la so-cietà o è la società che deve servire l’economia? perMinsky evidentemente vale la prima ipotesi: l’economiadeve essere ciò che rende possibile per la società co-struire qualcosa di piacevole e accettabile per tutti.
Pia Locatelli
Grazie per questa presentazione di Hyman Minsky comeuomo pluridimensionale, che corrisponde assolutamentealla realtà. Soprattutto dopo la sua morte, ho fatto lun-ghe chiacchierate con sua moglie e alla fine abbiamoconvenuto che Minsky era un uomo del Rinascimento,non perché fosse antico ma per la ricchezza della sua
54
personalità, per la capacità di leggere la realtà nel suocomplesso mettendo insieme filosofia, sociologia, scien-za, rigore. Ho incontrato per la prima volta Hyman Min-sky in una cena a casa della famiglia Leoni e sono rima-sta davvero folgorata da questo uomo curioso di tutto eche interrogava tutti con precisione, a volte con petulan-za; a me faceva sempre l’interrogatorio sulla politica equando avevo incertezze mi guardava stupito e mi dice-va che io che ero dentro la politica non potevo non sape-re di ciò che mi chiedeva, ma veramente lui sapeva tuttodi tutti e in tutti i campi, un uomo davvero affascinante.Prima di passare alla seconda sessione dedichiamoqualche minuto a riflessioni o contributi o domande.
Ivan Invernizzi
Da quello che ho capito, dalle conclusioni della profes-soressa Variato sono emersi tre punti, e in particolare lanecessità che lo Stato si faccia prestatore di ultimaistanza, praticamente sia un datore di lavoro, ma io michiedo come questo possa esserci utile nel momento incui la crisi diventa anche crisi del debito pubblico, diven-ta anche crisi dello Stato e non soltanto del sistema eco-nomico privato.
Anna Maria Variato
Certamente non è facile rispondere da un punto di vistapragmatico a come poter attuare queste manovre dispesa pubblica, di datore di lavoro di ultima istanza, inun contesto in cui il debito è enorme. Prescindiamo perun momento dalla situazione attuale e ricordiamo chesecondo Minsky bisognerebbe avere il il coraggio di at-tuare delle manovre di spesa durante le recessioni. In so-stanza l’idea minskiana è che lo Stato debba intervenirein modo assolutamente diverso da come si sta facendoora, perché nei momenti di espansione è poco utile chela spesa pubblica sia ampia, lo dovrebbe essere nei mo-menti di recessione e tutte le manovre di spesa dovreb-bero essere fatte soprattutto nelle fasi discendenti del ci-
55
clo perché è lì che la domanda aggregata del settore pri-vato viene meno. La questione è come si può spenderein un contesto in cui si è già fortemente indebitati e co-me fa lo Stato ad essere datore di lavoro di ultima istan-za, come si concretizzano questi aspetti, cioè come sitraduce in pratica l’aspetto teorico. Sintetizzare in pocotempo la risposta è difficilissimo, diciamo che si può farepuntando sulle proprietà dinamiche del sistema: nellamisura in cui anche gli operatori economici credono nellapossibilità che un certo sistema sia solvibile, il fatto chelo Stato intervenga ampliando il suo debito non rappre-senta una condizione insostenibile perché nel momentoin cui l’economia riparte questa ripresa, con le sue con-dizioni di crescita e di sviluppo della domanda e del red-dito, garantisce il fatto che venga poi ripagato il debito.Quindi il fatto che il debito sia elevato è in un certo sensoun falso problema perché quella minskiana è un’econo-mia di convenzioni, di aspettative e quindi se c’è fiduciada parte degli operatori nella possibilità che uno Statosia solvibile il fatto che il debito sia elevato non rappre-senta una condizione di breakdown. Questo è il senso,dopodiché però l’attuazione pratica del programma diemployer of last resort è molto molto variegata: esistonoPaesi, l’India piuttosto che l’Argentina ad esempio, chehanno attuato praticamente politiche economiche di em-ployer of last resort che concretamente implicano che loStato assuma dipendenti pubblici per fare le stesse cosepagandoli meno di quanto si pagherebbero in termini dilavoro privato; quindi in sostanza è come se lo Statodesse il lavoro assicurando l’esercizio di una funzionesociale e chi lavora nel settore pubblico di fatto ricono-sce di svolgere una funzione sociale e quindi accetta peril bene della collettività di essere pagato di meno, insom-ma fa un regalo alla collettività.
Marco Passarella
Condivido la risposta di Anna Maria Variato ma avendoriconosciuto chi ha posto la domanda, che è stato unodei miei studenti, mi permetto di aggiungere una cosa. Ilpunto è questo: se la Banca centrale agisce da prestato-
56
re di ultima istanza, non esiste alcun limite teorico ogget-tivo al livello del debito pubblico, la Banca centrale è ingrado cioè di fissare il tasso di rendimento dei titoli diStato di fatto a suo piacimento, e questo rende quel ren-dimento compatibile con il dato del tasso di crescita del-l’economia reale. Ciò consente agli Stati di fare politichedi primo impiego che hanno poi come effetto quello diaumentare il reddito e il gettito fiscale e dunque di ripa-gare ex post l’eventuale maggiore debito contratto pri-ma. Il problema che abbiamo in Europa in questo perio-do è tutto politico-istituzionale, o diciamo meglio: ci so-no degli squilibri strutturali reali – su cui non mi soffermoora – ma il problema della speculazione è tutto di struttu-ra istituzionale e finanziaria; le Agenzie di rating e gli ope-ratori finanziari non fanno altro che prendere atto di unasituazione che è instabile politicamente, non economica-mente.
Riccardo Bellofiore
Per rilanciare la discussione, devo dire che le risposte diMarco Passarella e di Anna Maria Variato non mi hannoconvinto molto. Se ho capito bene, Passarella ha dettoche l’instabilità è un problema politico ma dal punto divista economico non c’è. È possibile che sia vero, maquesta è chiaramente una posizione non minskiana. Direiche c’è stata una lunga pretesa stabilità, che si è poi pe-rò rivelata insostenibile, e l’instabilità nascosta è emersaviolentemente. In Europa, certamente, ci sono problemidi disegno istituzionale, ma di qui a dire che in Europanon esiste il problema della stabilità che diviene prima opoi instabilità ne passa. Anna Maria Variato, ma potreianche qui non aver capito, mi pare abbia iniziato dicen-do che effettivamente il ruolo dello Stato occupatore diultima istanza è difficile da portare avanti in un momentoin cui il debito è così elevato. Credo che forse qualchequalificazione ci vorrebbe. Dal punto di vista di un Paeseche pensa che i tecnici hanno sempre ragione – e chel’economia si basa su una teoria sola, quella neoclassica– il debito è sicuramente un problema. Penso invece chesia rilevante il tipo di debito. Il problema è stato un ec-
57
cesso di debito privato delle famiglie, non l’eccesso didebito pubblico, che è una conseguenza della crisi. Masu questo tornerò nella tavola rotonda.Tutte queste questioni conducono a quella che secondome è l’attualità più urgente di Minsky, di cui parlerò nelmio intervento successivo, che si riallaccia a una cosaimportante detta da Jan Kregel: legare l’analisi alla filo-sofia sociale. Minsky non era un keynesiano nel senso incui lo erano tutti gli altri. Minsky veniva da Keynes, lettoperò attraverso Schumpeter, e almeno altrettanto dalNew Deal (che contrariamente alla vulgata, non fu keyne-siano). Le proposte di via di uscita dalla instabilità deglianni Settanta in Minsky non si limitano – includono, manon si limitano – allo Stato che spende in disavanzo e al-la Banca centrale come banchiere di ultima istanza. Lacrisi di oggi ci porta alla necessità di prospettare propriole politiche strutturali che aveva in mente Minsky. Potre-mo discuterne i dettagli, ma quelle politiche strutturali –socializzazione degli investimenti, socializzazione dellabanca, socializzazione dell’occupazione – sono il proble-ma che secondo me abbiamo davanti.
2ª sessione - tavola rotonda
Pia Locatelli
Inizia ora la seconda sessione, la tavola rotonda coordi-nata da Roberto Petrini, che farà forse il processo aglieconomisti, visto che ha scritto un libro su questo argo-mento.
Roberto Petrinigiornalista, la Repubblica
La prima parte del pomeriggio è stata molto interessan-te, con un tratto di esposizione e di concetti piuttostoelevato; nella seconda parte, pur mantenendo natural-
58
mente, visti gli interlocutori, un livello elevato, cerchere-mo di essere più vicini all’attualità e possibilmente piùleggeri. Quindi vi intratterremo sempre nello spirito diquesto convegno dedicato a Hyman Minsky ma cercan-do di alleggerire un po’ il tono, anche se non so se siagiusto parlare di alleggerimento nel momento in cuiscendiamo dalla teoria all’attualità che non ci riserva, co-me dicono le cronache dei giornali in questi giorni, nulladi buono.Passo a presentare coloro che interverranno, economistiche possono essere considerati eterodossi ma anche chepartecipano attivamente al dibattito politico ed economi-co di questo Paese. Oltre a Jan Kregel, già ampiamentepresentato, ci sono Francesco Arcucci, che leggo spessosu Affari e Finanza del mio giornale; Riccardo Bellofiore,che interviene regolarmente nel dibattito e ha ripubblicatorecentemente con una sua introduzione un libro fonda-mentale di Hyman Minsky, Keynes e l’in sta bi lità del capi-talismo; Laura Pennacchi, che è stata sottosegretario alTesoro con il governo Ciampi, animatrice della Fondazio-ne Basso, ha scritto un’immensità di libri contro il main-stream, se posso dire; Marco Vitale, che è tra coloro chein qualche modo avevano avvistato la crisi, che a me pia-ce definire un economista eclettico, mi è sempre piaciutocome personaggio anche se l’ho conosciuto da lontano,un uomo che si occupa di finanza, fa finanza operativa,oltre a essere un rocciatore, uno scalatore, è stato vicino
59
a Minsky, è intervenuto puntualmente negli ultimi anni.Pia Locatelli ha avuto la generosità, di fronte a montagnedi libri importanti scritti dai miei interlocutori, di citare ilmio Processo agli economisti e sottolineo che è un pro-cesso agli economisti neoliberisti, quindi stasera ho pocoda processare, visto che non ce ne sono.Direi che il tema che c’è oggi sul tavolo, e su questo dareisubito la parola a Jan Kregel, è un tema anche di para-digmi, come dicono gli economisti, nel senso che è suc-cesso che nel 2007 – io mi sono convinto di questo dalettore dei testi di coloro che scrivono di economia – lacrisi è scoppiata per colpa della finanza privata – e inqualche modo Minsky aveva ragione, quel tipo di schemache lui aveva ipotizzato si è concretizzato nei fatti – e a uncerto punto questa crisi si è catapultata in Europa. Pur-troppo, tirate le somme, se la colpa è della finanza priva-ta, se la colpa è della cattiva distribuzione del reddito ne-gli Stati Uniti, se insomma la colpa è dei debiti e di queltipo di sistema, poi in questi giorni invece le ricette che sisentono per far fronte a quello che è accaduto sono paro-le spesso uguali al paradigma neoliberista che in qualchemodo ha innescato la crisi. L’indice è puntato nei con-fronti del debito pubblico, si parla di instabilità finanziaria,patto di stabilità e di crescita, si stanno imponendo a tuttigli Stati europei norme che prevedono il pareggio di bi-lancio, quindi sta passando questa versione neoliberistadella instabilità. Quando si parla, come ho sentito nel po-meriggio, di una Banca centrale che debba fare il presta-tore di ultima istanza, anche in questo caso il rigore finan-ziario è ispirato ai no della Merkel e comunque dell’esta-blishment finanziario. Vi chiedo: c’è il rischio che uscire-mo dalla crisi rafforzando quel tipo di sistema e quel tipodi valori che secondo me invece hanno provocato, sonostati a monte, sono stati un po’ il detonatore di questacrisi? Vorrei che, oltre alle cose che naturalmente ci dire-te, Jan Kregel rispondesse a questo tipo di domanda.
Jan Kregel
Abbiamo sentito Piero Ferri dire che nessuno avrebbepotuto prevedere la crisi, questo è vero ma è anche vero
60
che si possono capire i fondamenti di una possibile crisi,e questo è parte del contributo che ha dato Minsky: indi-viduare gli strumenti per capire perché si crea la possibi-lità di crisi nell’ipotesi dell’instabilità finanziaria. E Minskyspiegava non solo perché si crea l’instabilità, ma ancheperché questa instabilità non sfocia sempre in una gran-de crisi tipo la depressione degli anni Trenta. Voglio sof-fermarmi su questo secondo aspetto per spiegare per-ché avremmo potuto o dovuto prevedere la possibilitàdella crisi del debito dentro il sistema dell’euro che stia-mo vivendo oggi. A chi prevedeva le crisi Minsky facevasempre la domanda: ma perché non è ancora successaquesta grande crisi? La risposta era, come avete sentito,piuttosto istituzionale, nel senso dell’azione di quello chelui chiamava il governo grande, the big government ecioè il fatto che la crescita del peso della spesa pubblicanell’economia consentiva una soglia minima del redditoche impediva il crollo totale dei redditi, che abbiamo vi-sto durante la crisi degli anni Trenta. Diciamo che era co-me un cuscinetto, un ammortizzatore sociale, che evita-va queste grandi crisi. A fianco del big government c’è labig bank, la grande banca, cioè una Banca centralepronta a dare un sostegno al valore delle attività, perchéla seconda fase della Grande crisi ha visto il crollo delvalore delle attività. Nella Grande crisi degli anni Trentac’è stato un collasso totale del reddito delle famiglie, in-sieme al collasso dei valori della ricchezza delle famiglie.Queste due istituzioni, big government e big bank, pon-gono un limite al crollo nel reddito e nella ricchezza, dan-do la possibilità secondo Minsky di evitare una grandecrisi, per questo non tutte le crisi possono sfociare inuna grande depressione.Vediamo questi due concetti molto semplici, questa ideadi cuscinetto di sicurezza – che lui utilizzava sempre perspiegare la possibilità di crisi – nella costruzione dell’inte-grazione europea e di una moneta unica in Europa. Il biggovernment non esiste, non c’è un governo europeo, edin più nel Patto di stabilità e crescita ci sono limiti al biggovernment. Questi limiti sappiamo bene essere il vincolodi un deficit al 3% e un debito del 60% sul Pil; questovuol dire che abbiamo inserito nella costruzione dell’Euro-pa un governo di “piccola taglia”, al quale non è possibile
61
giocare questo ruolo di cuscinetto contro la caduta deiredditi. Quanto alla big bank: abbiamo la Banca centraleeuropea, ma il suo nome, banca centrale, è una forzaturadel linguaggio perché in realtà è un istituto di emissioneche immette moneta e basta, non fa nient’altro, ha il com-pito solamente di creare banconote e non ha nessun altrocompito in termini di sostegno dei valori delle attività o disostegno della solvibilità nel sistema bancario. Il grandedibattito di oggi è se sia possibile o non possibile per laBanca centrale europea salvare l’euro. Sì, evidentementeè possibile, come dice Minsky, se la Banca è disposta afar crescere il suo bilancio. Prendiamo la Federal Reser-ve: quando si è trovata di fronte alla crisi ha raddoppiatoil bilancio, ha comprato tutte le attività che il pubblico vo-leva vendere per dare un sostegno alla ricchezza del si-stema. La Banca centrale europea dice che non può far-lo, come è scritto nel Trattato di Maastricht e in quello diLisbona. Evidentemente si è trovata una strada indirettaper intervenire comprando sul mercato secondario il de-bito di Stato. E lo si fa non per dare un sostegno all’eco-nomia ma semplicemente in coerenza con il ragionamen-to secondo il quale, quando c’è un’interruzione nella tra-smissione della politica monetaria ai mercati, la Bancadeve intervenire. Evidentemente quando un governo è indifficoltà a vendere i titoli, questa difficoltà costituisce unintoppo per la politica monetaria. Allora viene utilizzataquesta giustificazione, ma è una giustificazione che non
62
dà un vero sostegno al mercato. Quindi quando si creainstabilità, questa instabilità non ha nessun limite (perl’assenza di big government e di big bank) e facilmentepasserà a una crisi di dimensioni più grandi. Per di più lareazione è stata quella di tagliare il sostegno all’economiaattraverso le politiche di austerità che abbiamo adottato,e questa sarebbe stata la cosa più difficile da capire perMinsky, che voleva sempre capire non solamente l’ope ra -zione tecnica ma anche le ragioni politiche delle decisioniprese da chi manovra la politica monetaria e la politica fi-scale. Nell’ottica del modello dell’euro, il big government,che Minsky pensava come un sostegno all’economia, ef-fettivamente diventa causa di instabilità se la Banca cen-trale non agisce in modo da dare sostegno al mercato.Come abbiamo detto, se il governo è più grande, emettepiù debito; invece, se questo debito crea dubbi nel mer-cato deprivato sulla possibilità del rifinanziamento di que-sto debito, allora automaticamente abbiamo in un certosenso rovesciato l’idea di Minsky di un governo grandecome fattore stabilizzatore, che invece diventa un fattoredestabilizzatore. A questo segue il ragionamento: se il go-verno più grande crea instabilità nel mercato, dobbiamotagliare le spese del governo, e questo ha un impatto ne-gativo sul reddito. E così abbiamo creato ora il paradossoche per salvare il funzionamento del mercato dei capitalidobbiamo abbassare il reddito delle famiglie. Abbiamocreato un sistema dove se si fa una politica per salvare ilfunzionamento del mercato dei capitali si crea recessionedel livello del reddito, e se si vuole creare un sostegno allivello del reddito si provoca una crisi nel mercato dei ca-pitali. Non possiamo scappare, con una politica da un la-to o dall’altro, dalla recessione. Come ho detto questo èun ragionamento molto semplice ma credo abbastanzaimportante da capire: il disegno congegnato dentro il si-stema dell’unificazione monetaria è di creare questa crisi,che è quasi intrinseca alla costruzione europea.
Roberto Petrini
Grazie a Jan Kregel. Mi pare che i margini per uscirnesiano piuttosto stretti: Marco Vitale che ne dice?
63
Marco Vitaleeconomista d’impresa,presidente Fondo Italiano d’Investimento
Vorrei iniziare rievocando alcuni ricordi miei con Minsky,che mi servono anche per dare questa risposta. Io cono-sco Minsky nel ’79, sono uno di quei practitioner di cuiha parlato Passarella che gli davano ascolto, ed ero mol-to amico di Sylos Labini, un economista che aveva moltastima di Minsky, tutti e due erano allievi di Schumpeter.L’ho conosciuto camminando in montagna a Rima in Val-sesia e camminando parlavamo. Lui parlava soprattuttodell’America – verso la quale aveva una grande stima –perché l’economia americana in quegli anni era estrema-mente depressa, estremamente in crisi, era grigia, eraterribile, ma lui diceva sempre che si sarebbe ripresa – lasua frase era: “Don’t sell America short” – e poi si colle-gava alla Grande crisi, dicendo le cose che abbiamo ap-pena sentito. Ma il suo approccio alla Grande crisi nonera da storico, da curioso, era da teorico, è questo chedobbiamo capire, che è la sua forza ed è quello che ame practitioner dava molto: cercava di condurre delleosservazioni empiriche, nelle quali era aiutato dalla storiaovviamente, in conclusioni teoriche, teoricamente rile-vanti. Ricordo la distinzione che faceva tra crisi finanzia-ria, recessione e deflazione, che non sono la stessa co-sa, e io l’ho imparato da lui in quelle camminate in mon-tagna a Rima.Quindi un grande teorico che si sforzava di capire le co-se per dare degli indirizzi, per cui io non credo che seoggi lui fosse qui tra noi si divertirebbe a dire “io l’avevodetto”, perché non era un profeta della crisi, lui cercavadi capire i meccanismi che possono portare a dei mo-menti critici con danni sociali per tutti, come affrontarli ecome evitarli. Oggi se lui fosse tra noi sarebbe proiettatosulla domanda che mi è stata fatta: come ne usciamoora che siamo inguaiati fino al collo? questo sarebbe ilsuo approccio piuttosto che dire “io l’avevo detto”.Lo incontrai qualche tempo dopo, non ricordo bene esat-tamente quando, a Saint Louis alla sua Washington Uni-versity, stemmo un pomeriggio insieme nel suo piccolostudiolo all’americana, continuamente interrotti dagli stu-
64
denti che entravano e io apprezzai moltissimo questa suagrande attenzione agli studenti; era un maestro, diciamo-celo chiaro, non era un professore o un economista, eraun maestro, dello stampo che sembra andato perduto.La nostra conversazione verteva fondamentalmente sudue punti, che sono già emersi ma che voglio riprendereperché sono fondamentali. Il primo è che non c’è distin-zione tra economia reale ed economia finanziaria; io finoa quel momento avevo continuato a ragionare su econo-mia reale ed economia finanziaria, ma invece c’è l’eco -no mia e la struttura finanziaria è funzionale a un certo ti-po di economia e ne determina gli sviluppi, c’è una unio-ne profonda. Ci scambiavamo della corrispondenza el’ultima lettera che Minsky mi ha scritto nel ’92 fu da Mo-sca, dove era andato a vedere cosa succedeva nel pas-saggio verso un’economia di mercato, ed era furente congli economisti americani, anche con i practitioner ameri-cani, che erano a Mosca a insegnare ai Russi cos’è ilmercato, a fare il mercato: vendiamo, liberalizziamo tut-to; e in questa lettera diceva che erano pazzi perché vo-levano fare il mercato dei beni senza avere le istituzionifinanziarie per la gestione del ciclo finanziario e che nesarebbe venuta fuori un’economia violenta e mafiosa:quello che è esattamente avvenuto. Ma questa non èprevisione, è teoria, quando la teoria è giusta permette difare previsione.Il secondo punto è l’instabilità finanziaria. Ho sentito qual-
65
che volta presentare l’instabilità finanziaria come una pa-tologia. Per Minsky non era una patologia, l’instabilità erauna caratteristica del sistema capitalista intrinseca, legataa questo sistema, e quindi non è una patologia, è qualco-sa che succede sempre. Ho messo in fila le crisi finanzia-rie avvenute dal 1987 fino ad oggi: ogni due anni c’è unagrande crisi, è impressionante. Sono partito dal 1987 per-ché nell’ottobre di quell’anno, se ricordo bene era il 17,ero a Wall Street quel lunedì, il venerdì c’era stata unabotta fortissima e lunedì c’era il crollo della Borsa, il piùgrande dagli anni Trenta. Fu un momento di panico spa-ventoso – io presiedevo un grande fondo – che durò finoa metà mattina quando dai teleschermi vennero lette trerighe di Greenspan, presidente della Federal Reserve, chedicevano che la Federal Reserve avrebbe dato al mercatotutto il denaro di cui aveva bisogno; a questa dichiarazio-ne si aggiunse la notizia che le più grandi società ameri-cane, Ibm in testa, avrebbero ricomprato i loro titoli: que-ste due notizie insieme bloccarono la crisi. Poco tempodopo mi trovai a parlarne con Minsky e lui mi disse cheprobabilmente era ciò che bisognava fare, ma se l’unicarisposta che diamo ai momenti di crisi è che daremo almercato tutta la moneta che vuole, cioè stamperemo mo-neta (e qui mi ricollego alla sua domanda), alimenteremoun processo che non sappiamo dove andrà: questa èl’origine della patologia dell’instabilità finanziaria. Allora:l’instabilità finanziaria è una componente normale del ci-clo capitalista, ma poi c’è la patologia finanziaria, che siha quando gli asset finanziari, che all’inizio degli anni Ot-tanta stavano in rapporto di 1 a 1 con il Pil, nel 2007 sal-gono al rapporto di 4 a 1 con il Pil (adesso non so a cherapporto stanno ma forse sono cresciuti ancora). Questaè la patologia finanziaria, che è poi legata a processi so-ciali, a un’ideologia, perché tutte queste cose non vengo-no a caso, e questa è stata funzionale a una grande con-centrazione di ricchezza. Se andate a vedere la ricchezzache aveva l’1% della popolazione americana nel 2007, èesattamente lo stesso livello di concentrazione che c’eranel 1928, uguale, la curva è impressionante. Al ’28 seguo-no poi i decenni della distribuzione della ricchezza attra-verso lo sviluppo, ma a partire dagli anni Ottanta la curvarisale e nel 2008 ha lo stesso livello di concentrazione del
66
1928. Quindi qui si entra in processi di patologia dell’in-stabilità finanziaria che bisogna capire e distinguere.Quando Minsky proponeva di mettere il fuoco sull’instabi-lità finanziaria perché funzionale al sistema, era per direche abbiamo bisogno di istituzioni, di politiche che evitinoche questa instabilità diventi patologica, diventi distrutti-va, la distruzione che viviamo in questi giorni.Credo che da Minsky dobbiamo imparare moltissimo:prima di tutto la libertà di pensiero, la libertà di parola esconfiggere le mode, perché il novanta per cento deglieconomisti mondiali ancora è asservito alle mode, per-ché gli fa comodo, perché sono mode che pagano. Unaricerca empirica molto seria ha dimostrato che il settantaper cento degli economisti americani, per diritto o pertraverso, aveva una parte del proprio reddito riconducibi-le alla Federal Reserve, e allora se uno ha questi condi-zioni come può prendere una posizione ferma nei con-fronti di una Federal dominante come sono state quelledi Greenspan e poi di Bernanke? Dobbiamo avere il co-raggio di fare battaglie di idee, di cambio di paradigma dipensiero. Ancora questa estate ho partecipato a una ta-vola rotonda dove un illustre economista della Bocconiha detto che la crisi del 2008 e del 2009 è una piccolaparentesi già passata e poi tutto ritornerà come prima,invece il mondo sta cambiando e questi signori non lovogliono vedere. Minsky fa parte di quelle persone che ciaiutano a vedere. Quindi, per ritornare alla domanda: sia-mo in una situazione tremenda, difficilissima, senzaprendere paure però ingarbugliatissima, nel 2008 ho det-to ai miei clienti che la crisi durerà almeno dieci anni, misono accorto ora di essere stato terribilmente ottimista.Però dobbiamo mettere a posto cose grosse, cose im-portantissime, per cui bisogna ritornare al grande pen-siero tipo quello di Minsky e non fare niente in fretta, infretta si possono fare le cose che Monti sta facendo be-ne, dopo ricominciamo a pensare, però.
Roberto Petrini
Grazie. Stiamo facendo qualche passo in avanti, a mioparere di operatore dell’informazione la necessità, che ri-
67
cordava Marco Vitale, del cambio di paradigma è impor-tante e Minsky può essere una bandiera anche comuni-cativa nei prossimi anni, per il suo profilo, perché è unpersonaggio interessante e importante che ha detto co-se che oggi sono di grandissima attualità, però bisognatradurlo sul terreno delle proposte. E quando si sente di-re, come ha detto Kregel, che la Banca centrale europeaè semplicemente un istituto di emissione, si entra nel vi-vo di uno dei problemi che stanno sul terreno del dibatti-to europeo proprio in queste ore. Quali sono le altre azio-ni che bisognerebbe mettere in campo nello spirito diMinsky, professor Arcucci?
Francesco ArcucciUniversità di Bergamo
Partirei in un modo molto semplice: mettiamo in collega-mento il discorso di Minsky sul fatto che ci sono tre fi-nanze, la finanza coperta, la finanza speculativa e la fi-nanza Ponzi, che io chiamerei in modo diverso all’italia-na, la catena di sant’Antonio, che poi è la stessa cosa.Ebbene, ci sono anche però tre grandi operatori nel si-stema economico dal punto di vista finanziario, che sonole famiglie, e cioè i centri di formazione del risparmio, equesti appartengono al mondo della finanza coperta cioèhanno la caratteristica che rimborsano, o dovrebberorimborsare, il capitale e gli interessi; poi ci sono attual-mente famiglie o anche altre istituzioni, ma sempre comecentri di formazione del risparmio; infine le imprese, cheappartengono alla finanza speculativa perché tipicamen-te non rimborsano il capitale, non ce lo diciamo moltevolte ma l’impresa paga solo gli interessi, l’impresa nonrimborsa i capitali in condizioni normali, salvo che vengaliquidata o ci siano casi particolari, l’impresa vive della fi-nanza speculativa, la posizione finanziaria netta di un’im-presa tende a essere sempre negativa e tende anche,quando l’impresa si sviluppa, a crescere. C’è poi la fi-nanza patologica, la finanza Ponzi, dal nome di un italia-no imbroglione che subito è stato preso dagli Americanicome esempio dell’italianità. Questo signore – siamo ne-gli anni 1920-’25 – aveva la caratteristica di usare un
68
qualche cosa che in Italia si chiama catena di sant’Anto-nio. Questo terzo tipo di finanza appartiene a un altrooperatore, che si chiama Pubblica amministrazione: laPubblica amministrazione vive di catena di sant’Antoniocioè vive in un contesto nel quale non c’è il rimborso delcapitale – quindi i discorsi sui Tedeschi che rimborseran-no il capitale mentre gli Italiani no li lasciamo a chi noncoglie l’essenza delle cose. Il capitale non verrà mai rim-borsato, il debito pubblico non verrà mai rimborsato etendenzialmente neanche gli interessi, sì forse una pic-cola parte collegata con l’avanzo primario, ma di fatto lafinanza della Pubblica amministrazione è una grande ca-tena di sant’Antonio. Ma come mai sta in piedi, mentre lecatene di sant’Antonio private non stanno in piedi? la fastare in piedi la Banca centrale, la sua disponibilità adacquistare illimitatamente – la parola magica è: illimitata-mente – titoli del debito pubblico. Una volta che la Bancacentrale acquista il saldo fra le vendite di titoli pubblici egli acquisti di titoli pubblici, immediatamente per quattroangoli del globo si presentano degli acquirenti, perché ri-tengono che a questo punto il titolo pubblico è riskless equindi lo comprano.E allora ecco che in condizioni normali di Banca centralenazionale vi è la possibilità di considerare i titoli più ri-schiosi del mondo, cioè quelli pubblici, come titoli menorischiosi, perché c’è la Banca centrale che acquista inasta la differenza. Il Giappone ha un debito pubblico che
69
è il doppio di quello italiano rispetto al Pil, circa 240%,ma c’è la Banca centrale, la Banca del Giappone. GliStati Uniti addirittura hanno due cuscinetti, due mastini:la Banca centrale e le vecchiette ucraine. Cosa fanno levecchiette ucraine? mettono sotto il materasso un po’ didollari, qualche biglietto da cento, e in questo modo fi-nanziano gli Stati Uniti; quando il mondo acquista dollariper pagare, non per finanziare gli Stati Uniti, di fatto fi-nanzia gli Stati Uniti, che quindi hanno due vantaggi. Lealtre Banche centrali, Bank of England, la Banca dellaSvezia, la Banca nazionale svizzera, quella del Giappone,la People’s Bank of China, son tutte Banche centrali na-zionali che quindi hanno questa potenza di poter acqui-stare illimitatamente. In Europa no, in Europa c’è unmeccanismo, che risale alla negoziazione dei Trattati nel1998 inizio ’99, in base al quale questa possibilità nonesiste. E c’è una grossa differenza: un conto è che laBanca centrale europea dica: “posso acquistare un po-co, magari in sede non di asta ma sul mercato seconda-rio”, un conto che possa dire “acquisto illimitatamente”,perché nel primo caso la Banca centrale europea devecomprare, nel secondo caso vi assicuro che dovrebbevendere. Se oggi la Banca centrale europea facessequesta affermazione “possiamo comprare illimitatamen-te”, dicendo illimitatamente tutto il mondo comprerebbetitoli e allora la Banca centrale europea sarebbe costrettaa vendere i titoli acquistati in luglio agosto settembre ot-tobre perché ci sarebbe una tale domanda che sarebbein condizione di rivenderli.Il vero problema è stato questo: nel 2007 si è avuto unoscandalo, che consiste nel fatto che con un tipo di finan-za, quella coperta, quella delle famiglie, si è verificato unfenomeno di scopertura. Perché è costata così tanto lacrisi dei sub-prime? perché le famiglie vivono di finanzacoperta – pensiamo alle rate del mutuo: capitale e inte-ressi, ma anche il prestito personale: c’è un rimborsoche copre capitale e interessi – quindi lo scandalo è sta-to aver avuto nel 2007 un problema finanziario nel setto-re più sicuro dell’economia, quello della finanza coperta.Questo è stato un colpo straordinario a cui gli Stati han-no cercato di mettere una pezza perché il sistema ban-cario si è trovato improvvisamente con delle perdite nel-
70
l’attivo che erano tali che l’attivo stesso era uguale ai de-biti, cioè depositi e obbligazioni, di conseguenza il capi-tale era finito, non c’era più capitale. Quindi i pubblicipoteri sono intervenuti e cos’hanno fatto? hanno acqui-stato, hanno fornito capitali alle banche. Tutto è iniziatocon il fatto stranissimo di una finanza coperta che non ècoperta. Se lo Stato si fosse trovato nella stessa condi-zione non c’era problema, quello vive sempre di catenadi sant’Antonio, ma le famiglie si sono trovate in questastrana situazione di avere una finanza non coperta. Inter-vengono i pubblici poteri, che però fanno un giochino:danno i soldi alle banche ma non li danno con i soldi deicontribuenti, li danno con i soldi delle banche, cioè gliStati salvano le banche con i soldi delle banche, ossiaindebitandosi e l’indebitamento viene in parte collocatopresso il pubblico, cioè i risparmiatori, e in grandissimaparte presso il sistema bancario. Le banche vengonosalvate dagli Stati con i soldi delle banche, un sistemaabbastanza ardito e a questo punto il problema che col-piva le banche colpisce gli Stati, che si trovano loro nellacondizione di essere esposti a un grandissimo rischio, ilfamoso rischio sovrano (che è diverso dal rischio Paese).A questo punto in tutto il mondo si ha un aumento deldebito pubblico rispetto al Pil tra 25 e 30 punti e cioè chistava bene, tipo la Spagna che aveva magari il 60%, vaal 90; chi stava bene come la Germania sale all’85; chistava bene come la Francia sale all’85; l’Italia ha fattoabbastanza benino perché l’Italia, che quando siamo en-trati nell’euro era scesa da 123 a 104, è risalita a 120 enon ha perso 25-30 punti, ne ha persi solo una quindici-na; la Gran Bretagna: un disastro, oggi si trova con undebito Pil pari sostanzialmente al 100%; gli Stati Uniti al100%. Però questi Paesi, Stati Uniti e Gran Bretagna,che sono quelli che già “scalchignavano” e a un certomomento gli capita questo aumento di 30 punti, improv-visamente anche loro dovrebbero avere un problema dicatena di sant’Antonio, un problema di Ponzi schemeper la finanza della Pubblica amministrazione, ma non cel’hanno, perché interviene la Fed e per gli Stati Uniti ad-dirittura anche i milioni di vecchine, non soltanto ucraine,in giro per il mondo, ma anche le multinazionali che vo-gliono comprare il rame, lo zinco, il ferro, il petrolio e via
71
dicendo e detengono saldi in dollari non per finanziare gliStati Uniti ma per pagare le materie prime.Invece in Europa c’è un meccanismo di costruzione del-la Banca centrale europea diverso e quindi in definitivain gran parte la nostra crisi non deriva tanto da un parti-colare scandaloso squilibrio della finanza pubblica, per-ché sì è vero stiamo male, l’Italia 120, la Grecia 160, maanche gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stanno male, ilGiappone 240 e, diciamolo pure, anche la Francia è fal -lita, ma anche la Germania è fallita, sono falliti tutti.Questo può sorprendere: siamo falliti tutti, non comeGermania ma come Pubblica amministrazione tedesca,come Pubblica amministrazione francese, come Pubbli-ca amministrazione spagnola, come Pubblica ammini-strazione italiana, tutti falliti. Perché? perché siamosempre in una logica di Ponzi scheme, di finanza tipocatena di sant’Antonio, ma in più il vero problema cheabbiamo noi, e che non hanno gli Stati Uniti e la GranBretagna, è che non abbiamo la Banca centrale che puòacquistare illimitatamente titoli. E allora ci sono due pos-sibilità: o facciamo una cosa che da 120 scendiamo a42, la Germania da 83 scende sotto i 60, lo stesso laFrancia e così via, e allora evidentemente saremo in uncaso in cui la finanza ritorna ad essere fisiologica inveceche patologica, oppure diamo il potere alla Banca cen-trale europea.Ci serve moltissimo questo schema di Minsky che divideil tipo di finanza in finanza coperta – anche secondo il ci-clo economico naturalmente –, finanza speculativa e Pon-zi scheme, collegandolo con i tre grandi operatori finan-ziari, e cioè le famiglie da un lato, le imprese dall’altro e laPubblica amministrazione, che pur essendo un centro diinvestimento del risparmio come le imprese però ha dellecaratteristiche diverse, mettendo insieme lo schema clas-sico della separazione fra centri di formazione del rispar-mio e centri di impiego del risparmio divisi in imprese,Pubblica amministrazione e in mezzo c’è la finanza – ecosa fa la finanza? non fa nient’altro che mobilizzare le ri-sorse dei centri di formazione e dei centri d’im piego. Ilproblema è che questi tre operatori vivono in tre finanzediverse, come ha spiegato Minsky, e se mettiamo insiemeil discorso dei tre operatori con il discorso delle tre finan-
72
ze riusciamo a interpretare molto meglio l’attuale crisi nel-la quale stiamo vivendo.
Roberto Petrini
Grazie. Mi pare che sul ruolo della Banca centrale euro-pea come prestatore di ultima istanza ci sia una speciedi unanimità. Però io mi chiedo, e chiedo a Laura Pen-nacchi a questo punto di intervenire: se questa bacchet-ta magica della Banca centrale europea, che peraltronessuno è disposto, soprattutto i Tedeschi, a conceder-le, non sia un alibi nei confronti del debito, del welfareeuropeo trasbordante, come spesso viene definito. E co-munque, anche ammesso che non sia un alibi, allora nonc’è un po’ una contraddizione con quello che invece staavvenendo in Europa, perché in Europa invece le paroleche si sentono di più in questo momento sono rigore, ri-duzione del debito, pareggio di bilancio. Non provi disa-gio a sentire questo vocabolario ritornare così mentre ilproblema si potrebbe risolvere con la famosa bacchettamagica della Banca centrale europea?
Laura Pennacchieconomista
In questa settimana cruciale nella quale sono attese lamanovra del governo Monti, di presumibile durezza stan-do alle indiscrezioni e anche alle intuizioni, e tutta unaserie di incontri, di avvenimenti rilevanti, non credo cheservirebbe l’invocazione di questo ruolo di prestatore diultima istanza che dovrebbe svolgere la Banca centraleeuropea, ruolo che del resto sta già svolgendo implicita-mente da un po’ di tempo, per quanto in forma limitata,secondo le linee che Draghi ha già esposto qualche gior-no fa.Io non penso che comunque questa invocazione, per noiunanime, dell’intervento illimitato da parte della Bancacentrale europea significhi un alibi per non affrontare iproblemi del debito, del deficit, i problemi europei, equelli italiani in particolare, che poi sarebbero evidenziati
73
soprattutto dal ruolo che la spesa pubblica ha esercitatonei sessant’anni dalla fine della Seconda guerra mondia-le, che ha portato a un grande sviluppo del welfare Statee che distingue nettissimamente l’Europa dagli Stati Unitid’America, dai Paesi anglosassoni, negli ultimi due de-cenni anche dal Regno Unito. Tant’è vero che all’esplo-dere della crisi nei primi mesi del 2009 l’Argentina ha do-vuto ricorrere alla nazionalizzazione dei dieci Fondi pen-sioni privati con cui aveva privatizzato la Social Securityargentina nel ’94 su indirizzo della Banca mondiale e delFondo monetario internazionale. Tant’è vero che Obamaha dedicato tutto il primo anno del suo mandato – com-piendo anche una serie di errori, quando per esempio, aparere mio come di molti altri economisti eterodossi,avrebbe dovuto nazionalizzare le banche che venivanosalvate –, ha destinato tantissime energie a cercare didotare il popolo americano di una riforma sanitaria ispi-rata ai principi universalistici del modello sociale euro-peo. Tuttavia comunque oggi la situazione è quella chesappiamo, che conosciamo.Io non penso che basti invocare questo ruolo della Ban-ca centrale europea di cui stiamo parlando, penso che cisono problemi specifici che riguardano la finanziarizza-zione che si è messa in movimento negli anni Novanta eDuemila, credo che, rispetto agli insegnamenti enormi epreziosissimi di Minsky, in questa finanziarizzazione c’èqualcosa di specifico su cui dobbiamo soffermarci. C’èuna iperfetazione appunto della finanza, dello shadowsystem, del sistema finanziario ombra talmente mostruo-so che a tutt’oggi ancora non sappiamo quanti sono edove sono i titoli tossici che hanno intossicato il mondo,e qui ci sono problematiche di riforma della finanza cheriportano in auge anche i principi sanciti da Keynes,comprese forme di controllo dei movimenti di capitali, ri-pristino di condizioni di correttezza che erano quelle peresempio fissate dal Glass-Steagall Act, che non a caso èstato abolito nel 1999, con la sua distinzione ferrea traattività commerciali e attività d’investimento nei settoribancari. E qui quindi c’è una prima linea di intervento sucui in questi anni di crisi si è fatto pochissimo, si è moltoparlato, c’è stato tutto un lavoro pregevolissimo fatto dalFinancial Stability Board negli Stati Uniti che ha portato lì
74
a una prima riforma finanziaria tanto lunga nello scrittoquanto complessa nella realizzazione e però molto al diqua della soglia che sarebbe stata necessaria, e poi cisono state le riforme, però molto inadeguate, adottate inEuropa con l’istituzione delle tre Agenzie Authority chedovrebbero guidare un processo di ristabilimento deicontrolli sulla finanza.Un altro aspetto che secondo me dovrebbe essere moltoconsiderato è stato già detto qui, però vorrei fare dellesottolineature rispetto per esempio al ragionamento diJan Kregel che ricordava come nei principi istitutivi delTrattato di Maastricht, del processo di costruzione euro-pea e del processo di unificazione monetaria ci siano deilimiti: la non presupposizione di un big government e poila non statuizione di una big bank, che sarebbero invecei due principi, che mutuiamo da Minsky, che ci potrebbe-ro aiutare molto oggi se avessimo da una parte le istitu-zioni in grado di realizzarli e dall’altra la volontà politicadi farli. Penso che questo ragionamento sia molto condi-visibile, giusto, però per accentuare la considerazionedella complessità degli elementi in gioco voglio segnala-re che sarebbe bastato che alla fine del 2009 e nei primimesi del 2010 la Germania avesse consentito a un salva-taggio della Grecia, che avrebbe potuto essere allora da40 miliardi di euro in su senza arrivare alle cifre terribiliche sono oggi invece richieste e necessarie; se quel sal-vataggio fosse stato fatto alla fine del 2009, quindi muo-
75
vendosi dentro il quadro dei principi del deficit del 3% edel debito del 60%, il contagio spaventoso che c’è statosuccessivamente in tutto il 2010 e nel 2011, arrivato oraa colpire noi e la Spagna, la Francia e la stessa Germa-nia così gravemente, non ci sarebbe stato. Quindi delleazioni diverse, delle linee e dei percorsi diversi erano as-solutamente possibili.E questo mi porta a considerare un altro aspetto che haavuto a mio parere una funzione nefasta e devastantema che mette più specificamente in luce le linee di orto-dossia restrittiva, monetarista e neoliberista che sonostate adottate con il Consiglio europeo del 24 e 25 mar-zo, quando è stata adottata la nuova governance econo-mica europea: è stata assunta tutta una serie di impegni,compreso per l’Italia l’anticipo del pareggio di bilancio al2013, che non era richiesto da niente e da nessuno ed èstato preso da Tremonti in quelle circostanze, in quellafase. Credo che questi non siano piccoli aspetti, pensoche siano fondamentali e il corso degli eventi avrebbepotuto assumere una piega molto diversa da quella cheha assunto fin qui.Oggi siamo comunque in una situazione drammatica, maio penso che anche in una situazione così drammatica eanche supponendo di dover accettare in modo inelutta-bile una manovra da 25 miliardi di euro (perché c’è an-che la contemplazione degli effetti dei 4 miliardi di euronon coperti che vengono dalla delega fiscale che Tre-monti ha lasciato scoperta: sono 4 miliardi per il 2012 e16 miliardi per il 2013, ci sono quindi 20 miliardi in totalelasciati scoperti) dovrebbero essere accolti i tre principidi Minsky, ai quali personalmente mi sento assolutamen-te vicina. Il principio per l’appunto della socializzazionedell’investimento: pensate che ora siamo in una crisi direstrizione del credito, di fatto con una liquidità bloccata,ma fino a qualche mese fa c’era una liquidità dilagantema che non prendeva la via dell’investimento, quindi tut-te le problematiche dell’investimento avrebbero dovutoessere sostenute in un modo diverso; la questione di so-cializzazione dell’investimento è fortissima. Credo chesia assolutamente all’ordine del giorno una questione disocializzazione della banca – come diceva Riccardo Bel-lofiore in un suo precedente intervento – e non a caso
76
Obama per esempio crea una banca pubblica per le in-frastrutture e non a caso nel Regno Unito, governato da-gli eredi, dai nipotini della Thatcher, costituiscono ben trebanche pubbliche che dovranno diventare operative. Mapenso ancora di più che ci sia una questione di socializ-zazione dell’occupazione: anche in una situazione in cuisi interviene così draconianamente per ristabilire gli equi-libri di finanza pubblica, si potrebbe pensare a una patri-moniale che destini una parte rilevante del suo gettito afinanziare un piano straordinario per il lavoro per i giovanie per le donne; che è una cosa che non viene detta sol-tanto da me o da pochi altri, un think tank americano, bi-partisan per altro, Demos, ha prodotto di recente un la-voro che si chiama Back to work: a public job proposal(Ritorno al lavoro: una proposta di creazione di lavoropubblico). L’ispirazione esplicita è proprio al New Deal equi il richiamo alla sorgente di ispirazione che è stata perMinsky il New Deal deve tornare ad essere fortissimo an-che per noi. Agenzie pubbliche, la creazione di lavoropubblico, di lavoro di utilità sociale sono richieste peresempio che fa anche Robert Reich, sono i Democraticiamericani appunto, non sono bolscevichi che sostengo-no queste tesi. E io penso che anche in un Paese comel’Italia, nel quale lavoro socialmente utile fa venire subitol’orticaria perché si pensa ai Forestali della Calabria, bi-sognerebbe avere il coraggio di riprendere questo tipo diproblematiche, dandosi però fino in fondo il compito diidentificare le condizioni alle quali avviene una riqualifica-zione della Pubblica amministrazione, perché se la Pub-blica amministrazione è assolutamente dequalificata co-me oggi è, inefficiente, l’inefficienza si risolve anche interribile iniquità e in assistenzialismo, che non era ap-punto l’assistenzialismo che voleva Minsky. E concludo:Minsky era per la dignità del lavoro, di conseguenza nonsarebbe nemmeno d‘accordo con la prospettiva del sa-lario sociale, che viene molto agitata all’estrema sinistradel nostro Paese e che ha facile presa sui giovani, biso-gnerebbe avere quindi sempre la consapevolezza pienadelle implicazioni di quello che si dice e di quello che sifa – e anche da questo punto di vista il richiamo di Min-sky mi pare ancora oggi attualissimo.
77
Roberto Petrini
Ringrazio Laura Pennacchi in modo particolare perchéha sciolto il dubbio che avevo posto all’inizio, cioè il ri-schio che si potesse uscire da questa crisi in Europa raf-forzando praticamente le politiche che ne erano stateorigine. Quando si parla di socializzazione del credito,degli investimenti, dell’occupazione, ma anche di istitu-zioni, quindi di regole per la finanza, e si pone anche inquesto quadro l’ampliamento del ruolo della Banca cen-trale, penso di poter dire che in questo modo si introdu-ce il pensiero di Minsky in una agenda di azione, se nonaltro come proposta visto e considerato che è minoritariarispetto alle dinamiche oggi sul terreno a livello europeo.Riccardo Bellofiore avrà sicuramente riflessioni utili sututte queste questioni.
Riccardo BellofioreUniversità di Bergamo
Prima di arrivare a questa questione, su cui molto condi-vido ciò che ha detto Laura Pennacchi, vorrei dire duecose. La prima è che Luigi Pasinetti avrebbe voluto es-sere con noi, è stato incerto fino a questa mattina, poiper ragioni familiari non ha potuto. Sarebbe intervenutosulla sostenibilità del debito pubblico, ripetendo in partel’intervento che ha fatto alla Società Italiana degli Econo-misti un mese fa. Mi ha mandato tre slide che posso in-viare a chi fosse interessato e che si trovano, sia pure unpo’ nascoste, sul sito della Sie: la seconda e la terza so-no una serie di formule relative alla sostenibilità del debi-to pubblico, la prima è la lista delle sue cinque-sei pub-blicazioni principali sul tema. Ricordo soltanto che Pasi-netti nel 1998 ha pubblicato sul Cambridge Journal ofEconomics un articolo importante in cui sosteneva che iparametri relativi alla finanza pubblica del Trattato diMaastricht non hanno alcuna base scientifica. Sappiamoche hanno di fatto solo una base “politica”.La seconda cosa che mi pare giusto premettere è que-sta. Vorrei cercare di dare una lettura minskiana della cri-si. Mi vorrei interrogare su quale capitalismo è andato in
78
crisi, su quale crisi globale, ed europea, abbiamo vissutoe stiamo vivendo. Minsky a volte raccontava la storia,che noi conosciamo bene, del comico – lui l’avrebbechiamato “banana” – che fa finta di aver perso le chiavi ele cerca sotto un lampione. Arriva un poliziotto e gli chie-de cosa stia cercando. Lui risponde che cerca le suechiavi, e al poliziotto che a questo punto gli domandadove le ha perse, replica: “le ho perse laggiù”. “Ma comemai allora le cerchi qui?”. “Le cerco qui perché qui è illu-minato”. Minsky polemizzava con le teorie che analizza-no il capitalismo, e dunque le sue crisi, dimenticando lasua natura monetaria. In realtà, se vogliamo sapere qualera il lampione sotto il quale cercava Minsky, lui su que-sto è molto trasparente. Cito da un commento che fecea un convegno, dove disse: “Un altro grande filosofoamericano, Vincent Lombardi, che come già George Al-len era un allenatore di football americano di successo,una volta disse che vincere non è qualcosa, vincere èl’unica cosa. Vorrei parafrasare questo vecchio saggio eproporre l’affermazione radicale che per un’analisi delleeconomie capitalistiche la moneta non è qualcosa, èl’unica cosa”.Credo che nella teoria economica sono abbastanza po-chi quelli che avrebbero aderito a questa impostazione. Ipiù significativi sono Schumpeter, Keynes e Marx. Nelmio caso, ho due lampioni. Credo che per analizzare ilcapitalismo che è andato in crisi dobbiamo analizzare da
79
un lato il lavoro e dall’altro la dinamica della moneta edella finanza. Qui abbiamo un paradosso: perché in que-sto capitalismo che è stato definito, dalla metà degli anniOttanta fino alla crisi del 2007, come il capitalismo dellaGrande moderazione, tutto sembrava andare bene, tuttosembrava stabile. All’improvviso tutto è crollato, è diven-tato insostenibile, e si è avuta la Grande recessione. Inrealtà la domanda “Potrebbe ripetersi?”, perché non èsuccesso di nuovo il Grande crollo come negli anni Tren-ta (per riprendere il titolo del libro famoso di John Ken-neth Galbraith), è una domanda alla quale Minsky avreb-be risposto: non è successo di nuovo perché abbiamoimparato come evitare almeno quella cosa lì.Quella domanda era sul tappeto in realtà di nuovo tra il’79 e l’82 del secolo scorso, con l’applicazione del mone-tarismo. Siamo oggi abituati a dire che è andato in crisi ilneoliberismo e spesso si fa l’equazione neoliberismo =monetarismo. Le cose non stanno così. Mi rendo contodi essermi negli anni avvicinato progressivamente a ciòche qualche volta lo stesso Hy andava dicendo a pranzoo a cena nei primi anni Ottanta. L’esperimento monetari-sta Minsky lo dava abbastanza per morto praticamentegià dal 1982, o poco dopo. Il monetarismo di Volcker,Thatcher, del primo Reagan, vuol dire stretta monetaria,alti tassi di interesse, caduta degli investimenti privati,spesa pubblica compressa (soprattutto quella sociale),inizio della caduta dei salari (relativi e spesso reali), comeanche allora crisi dell’America Latina e rischio di collassodel sistema bancario e finanziario. Quello era un momen-to in cui veramente poteva darsi di nuovo una crisi comenegli anni Trenta. Il Grande crollo non si è ripetuto perchésiamo stati salvati da due grandi “keynesiani”. Il primo èstato Reagan – il secondo Reagan, per così dire, quelloche ha creato il doppio disavanzo: il disavanzo dello Sta-to all’interno, ma poi anche quello della bilancia commer-ciale (e delle partite correnti) con l’estero, che provvede-va domanda al resto del mondo. Così Giappone, EstAsiatico, Germania ed Europa, i Paesi neomercantilisti,facevano profitti con le esportazioni nette. Qui il discorsoincontra un mio vecchio amore: Rosa Luxemburg, che sirivela anche lei abbastanza attuale. Il secondo grande“keynesiano” è Alan Greenspan.
80
Perché in realtà il capitalismo dal 1987 fino al 2007 è sta-to quello che Minsky ha chiamato un money managercapitalism, il capitalismo dei gestori monetari, che sinte-tizzo in tre figure. La prima è “il lavoratore traumatizzato”(qui capirete che c’entra Marx, ma la definizione non èmia, vi assicuro, è dello stesso Alan Greenspan), che dàun problema, perché con lui i costi si abbassano nellaproduzione, ma c’è un problema di realizzazione del va-lore, e i capitalisti non producono per il magazzino, pro-ducono per vendere. Il secondo è “il risparmiatore in fasemaniacale”, le famiglie che sono state incluse nella finan-za, nello stock exchange, e questo finisce con l’esten -dersi alla stessa casa trattata come asset finanziario. Setu hai, o credi di avere, della ricchezza prontamente liqui-dabile, come titoli o case, perché risparmiare sul reddi-to? Puoi persino andare dalle banche, banche di nuovotipo rispetto al modello che aveva in mente Minsky neisuoi primi scritti, che ti prestavano i soldi a fronte di uncollaterale. Così emerge la terza figura, “il consumatoreindebitato”. In questo mondo il traino ultimo della do-manda non erano più gli investimenti, su scala globalenon potevano essere le esportazioni, non era senz’altrola spesa pubblica, vista la compressione salariale nonpotevano neppure essere i consumi dal reddito. Era ilconsumo a debito. Questo è il capitalismo che è andatoin crisi.Ora, molti economisti eterodossi guardano al capitalismocontemporaneo con una gamba sola, quella dell’analisireale. Hanno una narrazione che racconta solo una partedella verità. Questa: è peggiorata la distribuzione delreddito, è caduta cioè la quota dei salari, e di qui emergeuna crisi da insufficienza di domanda effettiva. Si legge ilcapitalismo della Grande moderazione come fosse uncapitalismo stagnazionista. Francamente non lo credo.Secondo me questo capitalismo era in grado di prodursidall’interno la sua domanda, e la produceva proprio per-ché era legato alla finanza perversa. Quello che Marxchiamava il capitale fittizio ha determinato negli ultimidecenni effetti assolutamente non fittizi; marxisticamentepossiamo dire: maggiore sfruttamento e però anche, altempo stesso, maggiore domanda. In alcuni scritti, perdescrivere questa realtà, la chiamo una “sussunzione
81
reale del lavoro alla finanza”, a cui si accompagna unalunga capital asset inflation. Altri economisti guardano in-vece solo all’aspetto finanziario, in una ottica riduttiva.Anche qualche minskiano, anche qualche minskiano ita-liano: che ancora a giugno del 2008 scriveva che il pro-blema era un mero problema di regolazione. In pocheparole, industria buona – finanza cattiva. Le cose secon-do me non stanno così. Vorrei anzi aggiungere che, perMinsky come per Marx, le cose buone del capitalismoche abbiamo vissuto negli ultimi secoli sono venute infondo proprio dalla finanza speculativa, prima che le po-sizioni speculative degenerassero in posizioni Ponzi, nel-la finanza ultra-speculativa. Il vero dramma di questo ca-pitalismo è che la domanda, la produzione e l’espan sio -ne hanno prosperato solo grazie alla finanza ultra-specu-lativa, in simultanea con un cambiamento del sistemabancario enorme. Quando a un certo punto c’è stata lacrisi finanziaria, questa si è immediatamente trasmutatain crisi reale.Minsky ha visto giusto? Sì e no. Troppe cose erano cam-biate. Kregel, in un articolo molto tempestivo del 2008,ha scritto che questa non è una crisi dovuta al passaggioda posizioni coperte a posizioni speculative, che poi de-generano in posizioni Ponzi. Nel nuovo capitalismo, leposizioni erano “delinquenziali” fin dall’inizio. La posizio-ne Ponzi è la degenerazione di posizioni di investimentoche all’inizio non lo sono. La banca era cambiata, nonc’era più la banca in qualche modo schumpeteriana diMinsky, la banca che si teneva il mutuo presso di sé enon lo cartolarizzava, e così via. Ma non è nemmeno uncapitalismo che ha visto crescere l’indebitamento privatodal lato delle aziende non finanziarie, un leverage delleimprese. Negli Stati Uniti, prima della crisi, le impresenon finanziarie avevano un sacco di denaro, erano pre-statori netti. Il fatto è che Minsky ha avuto in fondo ragio-ne perché la sua grande idea è stata quella di analizzarel’economia attraverso gli stati patrimoniali, i loro bilanci.Gli agenti ragionano, tutti, guardando alle loro entrate euscite di denaro. Nel momento in cui l’indebitamentopubblico è stato in qualche modo compresso, l’in de bi ta -mento privato doveva scoppiare, ma è stato l’inde bi ta -mento privato delle famiglie. Ciò risulta molto chiaramen-
82
te anche dagli studi di Wynne Godley e del Levy Institu-te, a cui è stato legato lo stesso Minsky nell’ultima fasedella sua vita. Vorrei peraltro spezzare una lancia a favo-re dell’indebitamento pubblico. L’indebitamento privato èstrutturalmente instabile, prima o poi salta. Il debito pub-blico è sempre credito di qualcuno, è credito dei privati,è ricchezza. Il problema che dobbiamo porci è semmaiper cosa viene acceso, se viene usato per fini di spreco,oppure se viene usato per cose socialmente utili. Que-sto, vi assicuro, non è il mio lato marxista, questo è il miolato puramente minskiano.La crisi scoppia negli Stati Uniti, arriva in Europa. Toglia-moci dalla testa l’idea che la crisi sia dovuta all’Europa oall’euro. La configurazione istituzionale dell’euro ha certomolto aggravato le cose, e noi Europei possiamo sen-z’altro essere la causa di un futuro drammatico aggrava-mento della Grande recessione. Ma la crisi europea è ilrimbalzo della crisi globale. La crisi dei sub-prime ha su-bito colpito le banche francesi e tedesche, e così si sonodiffuse le difficoltà finanziarie. Sono poi saltate le bolle fi-nanziarie in Irlanda e in Spagna, oltre che in Gran Breta-gna. È caduta dunque la loro domanda nei confronti de-gli altri Paesi europei. Visto che intanto andava cadendola domanda negli Stati Uniti, cadeva pure la loro doman-da verso la Cina, cadevano a seguire le esportazioni del-la Germania verso quel Paese, cadeva infine l’indottodell’Italia verso la Germania. È una caricatura di quel cheè successo, ma non lo è poi troppo. Si spiega così per-ché fino quasi a metà 2008 gli esportatori di manufatti inEuropa andavano benissimo e all’improvviso sono andatimalissimo.Condivido ciò che ha detto Kregel prima, ovvero tutti gliargomenti critici nei confronti della inattività della Bancacentrale europea, ma anche della azione delle altre Ban-che centrali a supporto solo della finanza e non dell’eco-nomia reale. Sono pure convinto che non ci sia stata unavera manovra keynesiana di spesa in disavanzo da partedegli Stati Uniti. Obama l’aveva promessa, chi l’ha fattadavvero è stata la Cina all’inizio del 2009. Il problemadell’area europea è quello di un’area in cui le crisi di al-cune regioni nella moneta dell’eurozona, quindi in uncerto senso nella propria moneta, sono state gestite co-
83
me se le nazioni aderenti alla moneta unica si fossero in-debitate in valuta estera. Più o meno, alla fine, l’hannodetto tutti: se la Bce si impegnasse, non necessariamen-te sul mercato primario ma almeno su quello secondario– come poi ha dovuto comunque fare –, con l’annuncioche è disposta a rifinanziare illimitatamente i disavanzidei governi, magari attraverso il sistema delle banchecommerciali, il default non dovrebbe essere una opzionesul tappeto. Il rischio di fallimento della Grecia, del Por-togallo e così via è un malanno che ci siamo auto-impo-sti.Consentitemi di aggiungere che tante delle affermazioniche oggi vanno molto a sinistra, del tipo: meglio il default,meglio il default con la svalutazione, viva il diritto all’in-solvenza sono assolutamente insensate se proposte co-me qualcosa che attivamente si deve fare, e si pensache migliorino le condizioni dei lavoratori. Non sto dicen-do che non ci capiteranno magari sulla testa. Ma non mipare proprio il caso di augurarsele alla stregua del “muo-ia Sansone con tutti i Filistei”. Da questo tipo di crisi siesce, se n’è sempre usciti, o con una lunga crisi – cheMarx avrebbe definito di svalorizzazione del capitale, eche quindi dura come minimo dieci, quindici anni –, op-pure con l’accoppiata di crescita e inflazione. È chiaroche chi pensa di uscire da una situazione di indebita-mento con le politiche di austerità non sa come funzionauna economia monetaria capitalistica.Anche qui non sto dicendo cose rivoluzionarie, l’infla zio -ne tra il 6 e l’8% è stata proposta dall’ex-economista delFondo monetario internazionale Kenneth Rogoff. Il pro-blema è fare in modo che l’aumento dei prezzi non si ac-compagni al deterioramento delle condizioni di vita dellemasse: avere inflazione senza una qualche forma di indi-cizzazione è un bel problema. A questo si aggiunge l’al -tra questione: che tipo di crescita bisognerebbe immagi-narsi; per mio conto penso ci si dovrebbe muovere versoun nuovo sviluppo qualitativo.Nell’arsenale di Minsky di politica economica troviamoben più che i soli big government e big bank, che sono inqualche modo legati a un big labour, le tre cose non acaso sono andate insieme. Se si vuole capire come luiragionasse, non tanto su quale fosse l’uscita definitiva
84
dall’instabilità, che è intrinseca all’economia capitalistica,ma su come minimizzarne gli effetti negativi, bisognereb-be andare a rileggersi proprio il suo Keynes e l’instabilitàdel capitalismo. In inglese il libro è uscito in originale nel1975, ma credo – da quel che mi dice anche Esther Min-sky – fu scritto agli inizi degli anni Settanta, in parte aCambridge, in Inghilterra. Qualcuno si stupirà, ma alla fi-ne del volume, nella parte di filosofia sociale, Minsky ad-dirittura riscopre in qualche modo una sua personale for-ma di socialismo: non bolscevico, sicuramente democra-tico, ma pur sempre socialismo. Minsky scrive che il ca-pitalismo keynesiano è stato un capitalismo che ha risol-to il problema della piena occupazione con la combina-zione di alti profitti, alti investimenti, un welfare fatto ditrasferimenti monetari, in cui lo Stato di fatto non produ-ceva granché. Lo Stato di Minsky dovrebbe invece pro-durre, e più che fornire trasferimenti deve occupare diret-tamente i lavoratori, dando loro dignità e risolvendo inquesto modo il problema della disoccupazione. Vi faccionotare che con la Grande moderazione, un sistema fattoinvece di alti profitti e bassi investimenti, il problema si èripresentato sostanzialmente identico, anzi aggravato.Minsky prosegue: “Siamo costretti a ritornare alla que-stione normativa di fondo per uscire da questo sistema,a favore di chi devono essere fissate le regole del gioco,che tipo di beni devono essere prodotti, perché in questasituazione storica” – e sta parlando del keynesismo rea-lizzato, che lega anche alla prevalente forma militare del-la spesa – “l’ambiente biologico e sociale si inquina”.L’uscita dal keynesismo non ha risolto, ha incancrenito ilproblema che ci squaderna qui Minsky. Ancora: “Durantel’era Kennedy-Johnson viene formalizzata e applicatauna strategia economica basata su investimenti elevati,alti profitti e massicce spese militari”. Oggi c’è un’alter-nativa, sostiene, l’alternativa è “un’economia dove i set-tori guida (towering heights) sono socializzati, dove iconsumi collettivi (communal consumption) soddisfanouna grossa quota di bisogni privati, dove la tassazionedei redditi e della ricchezza tende a ridurre le disparitàeconomiche, dove esistono leggi che limitano le possibi-lità di speculare sulla struttura delle passività: una taleeconomia potrebbe dimostrarsi capace di raggiungere e
85
mantenere uno stato di piena, o quasi, occupazione”.Qui una cosa solo correggerei: il capitalismo la piena oc-cupazione temporaneamente la produce – il neoliberi-smo ha prodotto una piena occupazione di lavoratorisotto-occupati, in mezzo c’è stata una disoccupazionedi massa, adesso stiamo vivendo la fase che va verso lapiena disoccupazione di lavoratori precarizzati. Il puntoè che noi vogliamo una buona occupazione, e questo ri-chiede (mi riaggancio integralmente a quanto detto daPennacchi): la socializzazione degli investimenti, di cuiMinsky dà un’interpretazione un po’ più radicale di quel-la di Keynes; la socializzazione delle banche, che non si-gnifica salvare le banche too big to fail, perché spessonon finanziano attività reali ma solo la speculazione; lasocializzazione dell’occupazione, cioè lo Stato come oc-cupatore diretto. Il modello è chiaramente un ineditoNew Deal, un New Deal keynesiano. Il New Deal storicoera ossessionato dal problema del disavanzo, tant’è chenel 1937 Roosevelt tirò le redini proprio per rientrare daidisavanzi. Si uscì dalla crisi solo con la Seconda guerramondiale. Però l’idea è quella: uno Stato che intervienesul livello e la composizione della produzione, determi-nando una quota significativa dell’occupazione, cosa,come e per chi si produce. Siamo tornati alle questionidi base: chi fissa le regole, che cosa deve essere pro-dotto.
Roberto Petrini
Grazie. Grazie alla Fondazione Zaninoni, grazie a Pia Lo-catelli, grazie a tutti voi per averci seguito e alla prossimaoccasione.
—————————————trascrizione a cura della redazione
86
APPENDICE
La crisi dell’Area Euro come unMinsky Moment preannunciato1
Jan KregelLevy Economics Institute of Bard College
This would have been a particularly satisfying year for HyMinsky. Not because of the evolution of the financial cri-sis, but because the St Louis Cardinals staged an un-precedented come from behind, unexpected victory inthe World Series. For those of you who knew Hy will re-member that while he was fascinated with the behaviourof financial markets, he always checked the sports pagebefore the business section of the daily paper. When hevisited Europe he always sought out the InternationalHerald Tribune rather than the Financial Times because itcontained the USA ball scores. The FT could not com-pete on that score.On the other hand, this year would have been very frus-trating for Hy. Although he was known as a Cassandra,predicting financial crisis at every turn, in fact he spentmost of his later career explaining why a BIG financialcrisis on a par with the Great Depression had not oc-curred. The fact that economists and politicians seem tohave ignored his message would have left him extremelyfrustrated.For most economists, financial crises, like Cardinal WorldSeries wins, are always unexpected. They are comparedto the infamous Black Swans or fat tails of thestatisticaldistribution of the natural world. For Hy they were nor-mal, much like thunder storms. What was not normalwas that they should turn into tornados. So his FinancialInstability Hypothesis had two components. The firstwas the explanation of the ubiquitous nature of financialcrisis – the now well-known theory of how businessesand financial institutions take decisions that reduce their
87
1 Remarks prepared for Fondazione A.J. Zaninoni e Dipartimento diScienze economiche “Hyman P. Minsky” dell’Università di Bergamo Ilprofeta della crisi. Tributo a Hyman Minsky, Bergamo, 5 dicembre 2011.
cushions of safety to the point that they risk beingpushed into Ponzi finance.I should note here that Bernie Madoff has given Ponzifinance a bad name! His scheme was a fraud from thebeginning. For Hy, a Ponzi finance scheme was the resultof good intentions producing disappointed expectations.It was not a design, it was an unintended result of goodintentions.The second part of the theory was why “IT” had not hap-pened again since the Great Depression of the 1930s.This is the part of the theory that has been largely ig-nored and which would have led to Hy’s frustration. Thisis because policy makers and politicians seems to betaking decisions that are more and more likely to convertthe current sovereign debt crisis into another Great De-pression.The explanation that Hy gave of why “IT” had not hap-pened again was in terms of the existence of BIG gov-ernment and a BIG bank. The former represented theability of government to act to provide a floor underhousehold incomes by engaging in what Lerner calledFunctional Finance. When households were holding backon spending and declining business profits induced firmsto cut back on investment and hiring, the governmentcould always step in and stop the cumulative process ofdeclining income. This could prevent the ubiquitousfinancial crisis from producing complete destruction ofincomes as occurred in the Great Depression.The second factor was the existence of a BIG centralbank which could step into financial markets to put afloor on the balance sheets of financial institutions bylending against the assets that financial institutionswanted to sell. The lender of last resort function couldstop a debt deflation before it started, making sure that acollapse in asset values and wealth would not accompa-ny the decline in income produced by ubiquitous crisis.As a result the economy could live with the natural repe-tition of financial instability and financial crisis withoutproducing repetitive BIG depressions.Most analysts consider that we have survived the 2008meltdown of the US financial system; but they have beensurprised by the outbreak of what is now known as the
88
sovereign debt crisis, and in Europe is now known as theEURO crisis. Another of those pesky Black Swans.And this failure to recognise the incipient crisis wouldhave been the source of Hy’s frustration because itshould not have been a surprise. Rather, it should havebeen expected since it was the result of the failure to un-derstand the importance of the second part of the Finan-cial Instability Hypothesis: why “IT” hadn’t happenedagain.Since we are in Europe and the Euro is on everyone’smind it is perhaps best to start with why “IT” could hap-pen here. From Hy’s point of view, the Single Market Actand EMU were designed to produce “IT”. First, considerthe BIG government. There is none. Indeed, the very de-sign of the EU is to ensure that government is never bigenough to ensure that “IT” does not happen again. TheStability and Growth Pact says that government will al-ways be small and constrained in its ability to offset adecline in domestic incomes. This is not a question ofthe lack of a European fiscal agency, it is a question ofpolicy. An EU Ministry of Finance, constrained by theGSP would be no more able to prevent “IT” than the in-dividual national fiscal agencies.With the creation of the Euro came an institute of emis-sion for the European currency, the European CentralBank. But the ECB is a note issuing institute, not a realcentral bank, and it is also constrained to be small. In-deed, it does not even have the formal power to act aslender of last resort. And this is not only Minsky, it is afailure to implement the Bagheot principle which hasbeen accepted by virtually all governments and centralbanks since the Great Depression. Although Hy did be-lieve that Bagheot’s proposal was excessively restrictive.There is thus no BIG bank capable of stabilising financialassets.The European integration process was thus alwaysprone to a Great Depression because it lacked the BIGgovernment and bank that provided the buffer, the cush-ion of safety, that had prevented the US from repeatingthe experience of the 1930s.But the current frustration is not only generated by theabsence of these institutional factors, it is that the poli-
89
cies that are currently being applied can only aggravatethese structural deficiencies of the EU that make it proneto “IT” happening again.As most of you know, Hy’s banking experience camefrom his association with a medium-sized financial insti-tution in the Midwest of the United States. He believed inthe importance of small, local “unit” banks in preventingthe natural buildup of financial instability. It is now alsowell known that the recent crisis required massive gov-ernment support for mammoth financial institutions, thatwere “too big to fail”. The result was a transfer of thelosses on impaired financial assets from the banks’ bal-ance sheets to the government budget deficits that cre-ated increased government debt ratios. Governmentdebt thus substituted for the bad private debts.While this was presented as “Keynesian” fiscal policystimulus it did not have the Keynesian impact of puttinga floor under household incomes. It simply transferredthe losses from the balance sheets of the banks to thegovernment, with virtually no impact on incomes, excepton the income of the bankers. This stabilised the finan-cial institutions, but did nothing to stabilise householdin-comes.Paradoxically, the response to the increased governmentdebt which had prevented the collapse of the financialsystem was a push to reverse that policy and reduce thedeficits and debt burdens on the taxpayer which didhave a negative impact on incomes. So, instead of usingthe BIG government to support incomes, the push forsmaller government puts pressure on domestic incomes.The attempt to create an EU wide agency to imposesmall government and spending constraints on govern-ment income support functions is a clear failure to un-derstand the reasons why “IT” has not happened again.Indeed, this is a structural problem, for the creation ofthe Euro issued by an institute of note issue rather than acentral bank meant that sovereign government debtwould always be considered as Ponzi finance. For a gov-ernment to engage in hedge finance would mean alwaysrunning a budget surplus! Governments seeking to pre-vent crisis would then always be engaging in speculativefinance – that is, with budget balance achieved on aver-
90
age over some short period. Any continued deficit, aswould be required for effective economic stabilisationwould by definition be Ponzi finance! It would requirethat governments borrow to meet debt service, andeventually have to produce a sovereign debt crisis. Thisturns Minsky on his head, or would have him turning inhis grave. The existence of BIG government would pro-duce Ponzi finance and financial instability, rather thanacting to prevent “IT” from happening again.Even more frustrating is the action of the ECB. Virtuallyall economists now believe that the only means to pre-vent the Euro crisis from evolving into a BIG Depressionis for the ECB to act as lender of last resort and to pre-vent a debt deflation by direct funding of governmentdebt markets. Yet, the ECB is legally prevented from do-ing so, although it has found quasi-legal means from do-ing this by acting to ensure the transmission of its mone-tary policy through purchase of government securities insecondary markets. The problem with this policy is thatthe current difficulty is the failure of private market insti-tutions to refund maturing debt, not the need to supportof the prices of existing debt.Under current legal interpretations of the ECB charter,the only way it could act to provide this refunding is ifthere is a case of insolvency of the financial sector whichwould clearly impede the transmission of monetary poli-cy. This means that the financial system has to collapsebefore the ECB could act to prevent that result. Catch22! Or dealing with the barn door after the livestock hasfled.Again, the solution that has been proposed – that theECB will only act if governments decide to deal with theproblem with fiscal measures – say the creation of asupra EU fund by amplifying the resources of the EFSF –can never solve the problem because it would be just asconstrained by the GSP limits as national governments.To be effective, BIG government has to be able to inter-vene without restraint, and this current response is tomake that restraint more binding!Some have suggested that there is a chimeric “German”solution to this conundrum in the form of BIG exportscapable of providing the required support to domestic
91
incomes and financial markets. However, this is achimera because it would first of all drain demand fromthe rest of the world and aggravate the international im-balances that many believe have been a source of globalinstability. Second, it would produce an appreciation ofthe Euro that would erode the competitiveness of EU ex-ports. It would produce a premium for those countriesthat have the ability to offset declining competitivenessin foreign markets with reductions in domestic wagecosts, creating imbalances within the EU such as thosethat have been at the centre of the current crisis between“Northern” Europe and the Periphery. There is no solu-tion by exporting the problem of the lack of a BIG gov-ernment and bank.The source of frustration thus lies in the paradox facedby the EU that the only way that the Euro and the EU canbe saved is if the financial system collapses and the ECBis forced to intervene, making clear the implications ofthe Financial Instability Hypothesis. But by that time itwould be too late.
92
Il 25 ottobre 1990 il Centro culturale Progetto di Berga-mo ha organizzato il convegno Vittoria del capitalismo?,relatore Hyman Minsky. Pochi mesi dopo la caduta delmuro di Berlino, quando c’era chi preconizzava la finedella storia con la vittoria finale del capitalismo, Minskycontrapponeva una lucida lettura, anticipando le caratte-ristiche del nuovo fragile sviluppo capitalistico.Sono trascorsi più di vent’anni, ma vedrete quanto la suaanalisi resti valida e interessante, per questo ci è sem-brato opportuno, in occasione della pubblicazione degliatti del convegno a lui dedicato, aggiungere la sua rela-zione a quell’incontro.
il direttorePAOLO CRIVELLI
Vittoria del capitalismo?
Il collasso delle economie di tipo Sovietico è stato salu-tato come una vittoria del Capitalismo e il crollo simulta-neo dei regimi politici comunisti è stato usato per conva-lidare l’identificazione del Capitalismo con la democra-zia.Da alcune parti si avanza l’idea che questa vittoria segnila fine della Storia così come noi l’abbiamo conosciuta.Ma le vicende del Golfo, la fragilità della prosperità capi-talistica e le pressioni nazionaliste risvegliate dal collassodell’egemonia Sovietica nell’Europa orientale indicanoche la Storia non finisce, ma fluisce come il Mississippiche nella canzone “...continua a scorrere”.Non c’è dubbio che il Socialismo centralistico autoritariodi tipo Sovietivo è crollato. Ma questa forma di Sociali-smo non è la sola possibile. Il modello Sovietico ha sem-pre avuto la caratteristica di non consentire che le prefe-renze e i desideri della gente influenzassero la produzio-ne. Segnali effettivi (decisioni) nel Socialismo di tipo So-vietico andavano dall’alto verso il basso, mai dal basso,
93
dalla popolazione verso coloro che avevano il potere didecidere che cosa e come produrre. Esistono modelliteorici alternativi di Socialismo nei quali regna una sovra-nità del consumatore più ampia rispetto a quella delleeconomie di tipo capitalistico.Questo modello autoritario di economia centralizzata nonè cattivo quando i compiti assegnati all’economia sonosemplici: quando si deve produrre solo pane o carri arma-ti. Un’economia centralistica ha funzionato bene nella tra-sformazione da una società di tipo contadino ad una eco-nomia di produzione di massa limitata nella varietà di beni– quando acciaio, cemento e macchinari sono tutto ciòche deve essere prodotto: questo tipo di economia funzio-na altrettanto bene per la produzione di materiale bellico.Gli approvvigionamenti militati negli Stati Uniti e nel Re-gno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale seguiva-no un modello di economia centralistica.Questo modello di economia però non funziona benequando i processi industriali sono in continua evoluzionee quando il paniere dei consumi è molto più ricco rispet-to a quello richiesto da una semplice dieta a base di pa-ne. Quando le persone non vivono di solo pane il Sociali-smo centralizzato fallisce. C’è una qualche verità nell’af-fermazione che il crollo delle economie centralizzate di ti-po Sovietico è causato dalla “coca-cola revolution”, do-ve per “coca-cola” si intende un vasto insieme di beniche noi qui diamo per scontati, non soltanto una bibitanella quale la caffeina ha sostituito l’iniziale cocaina.Proprio mentre si stava celebrando la Vittoria del Capita-lismo, prima a Parigi, poi a Berlino e ora in tutto il mondooccidentale, diventava evidente che il dominio degli StatiUniti nell’economia mondiale veniva sempre più seria-mente compromesso. Inoltre la stessa prosperità delmondo occidentale era sempre più compromessa dallemassicce perdite che le maggiori istituzioni, finanziarie enon, stavano sperimentando. L’alta quota di impegni dipagamento sui debiti rispetto all’autofinanziamento, im-pegni di pagamento che sono eredità delle massicce ri-strutturazioni finanziarie, sono alla base di queste perdite.Ma prima di andare troppo oltre nell’interpretare il falli-mento del Socialismo stalinista come vittoria del Capita-lismo, deve essere chiaro che:
94
1) il Capitalismo che noi abbiamo nel mondo occidenta-le è solo uno dei possibili modelli di Capitalismo,
2) che il buon funzionamento delle economie capitalisti-che è un fatto nuovo,
3) che il buon funzionamento è un fenomeno fragile.In particolare, quello che ha vinto è un Capitalismo carat-terizzato da un intervento consistente dello Stato e dauna potente Banca centrale, Capitalismo nel quale gliStati Uniti sono stati capaci di agire come motore dellaprosperità. La debolezza economica e finanziaria degliStati Uniti è ora così evidente che è dubbio se gli StatiUniti possano agire come motore dell’espansione inter-nazionale. È dubbio se le nuove potenze finanziarie inter-nazionali, Germania e Giappone, abbiano la volontà diassumere questo compito, sebbene, come voglio sottoli-neare, i costi della unificazione possono essere così po-co definiti che la Germania può involontariamente agirecome motore dell’espansione e catalizzatore delle attivi-tà per l’Europa e per gli Stati Uniti.
Insuccessi del capitalismo
Nel 1933 il Capitalismo si trovava in una situazione falli-mentare. Il Capitalismo è un sistema economico che haconseguito un relativo successo nel 1990, anche se ilsuo successo è limitato nella portata ed è sempre in pe-ricolo. Proprio mentre il successo del Capitalismo nelMercato Comune e negli Stati Uniti ha aiutato la rivolu-zione nell’Europa orientale, il Capitalismo rimane un si-stema che non ha conseguito buoni risultati in Argentina,Brasile e Messico. Inoltre negli Stati Uniti, nell’Europaoccidentale e in Giappone questo successo mostra de-bolezza mentre il 1990 volge al termine.Ci sono molte varietà di Capitalismo. I Capitalismi hannomostrato capacità di adattamento ed evoluzione, anchese il successo comporta una resistenza all’adattamento,al cambio. Ci sono sempre aspetti negativi, che sonospesso politici, che sono difficili da cambiare. Il grandefallimento del Socialismo burocratico Sovietico sta nellasua rigidità nella produzione, nelle tecniche e nell’orga-nizzazione.
95
Negli Stati Uniti e nell’Europa il Capitalismo del 1990 nonè il Capitalismo del 1933. Il Capitalismo che è crollato trail ’29 e il ’33 era molto più vicino a un’economia “laissezfaire” che ai Capitalismi che ebbero successo nel periodopost-bellico. L’economia del 1929 aveva come caratteri-stica un Capitalismo con un limitato intervento del Gover-no in cui le Banche centrali erano legate alle regole checonseguivano dal sistema monetario aureo, regole che li-mitavano la possibilità di intervento della Banca centrale.Ad esempio, la spesa totale del Governo federale am-montava al 3% del prodotto interno lordo degli Stati Unitinel 1929. In questi anni la spesa totale del Governo fede-rale degli Stati Uniti supera il 20% del prodotto nazionalelordo. La stessa dimensione dell’intervento del Governostabilisce il limite inferiore della gravità della recessioneche si può determinare in un sistema economico.Un detto di Jefferson, che ha guidato a lungo il pensieroe l’azione americani, è “il miglior Governo è quello chegoverna meno”. Questa affermazione è vera quando è ri-ferita alle libertà individuali: il Governo non si deve intro-mettere nelle relazioni private. Sfortunatamente questaastratta affermazione filosofica non vale nella determina-zione della domanda aggregata.Gli economisti ora sanno che il fallimento del Capitali-smo degli anni ’30 è stato determinato dalla caduta delladomanda aggregata e questa caduta ha avuto originedal collasso del sistema finanziario la cui drammatica fa-se iniziale fu il crollo del mercato azionario del 1929. Tut-tavia il 1929 non si è collocato nel vuoto, perché durantegli anni ’20 il sistema finanziario degli Stati Uniti e dellealtre nazioni capitalistiche si era progressivamente infra-gilito. Il messaggio di Keynes nella sua “Teoria Generale”del 1935 era che sia la fragilità finanziaria che la doman-da aggregata possono essere tenute sotto controllo daun’appropriata politica pubblica.Un’appropriata politica pubblica richiede una Banca cen-trale flessibile e la disponibilità di un’economia che godedi indipendenza fiscale, nel senso che le sue passivitàsono internazionalmente accettabili cosicché essa possafunzionare in un contesto di deficit commerciale, a go-vernare la domanda aggregata e a consentire, attraversoil deficit fiscale, di sostenere i profitti.
96
Negli Stati Uniti le intuizioni dell’Amministrazione politicanei primi anni ’30 (gli anni di Roosevelt) portarono all’ado-zione di misure che promossero la costituzione di una ro-busta struttura finanziaria e integrarono la domanda gene-rata dagli investitori privati e dai consumatori con la spesapubblica finanziata da deficit. Le riforme fondamentali delsecondo New Deal, che furono attuate nel 1936, primache il messaggio della Teoria Generale di Keynes fosseassimilato dagli economisti americani, liberarono la Fede-ral Reserve dalle costrizioni del sistema monetario aureo eampliarono il livello della spesa del Governo federale.Queste misure furono prese prima della spiegazione diKeynes del finanziamento in deficit e le riforme finanziariefossero necessarie. La teoria seguì ciò che era già pratica.La caduta della domanda aggregata, che portò al decli-no della produzione durante la grande depressione e cheporta a moderate diminuzioni che caratterizzano le piùfrequenti recessioni, contrasta fortemente con il crollodell’offerta che caratterizza l’attuale “depressione” nelblocco Sovietico.Gli economisti sono in grado di fornire rimedi al crollodella domanda aggregata che consentono una rapida ri-presa della produzione, ma essi non possiedono rimediprontamente disponibili per il crollo dell’organizzazione edella motivazione che caratterizza una caduta dell’offertaquale quella cui assistiamo nell’Est.Un aspetto del crollo sul lato dell’offerta è la motivazionedei lavoratori: come si può indurre i lavoratori a lavorare.Viene alla mente la vecchia storia su come si può indurreun asino a muoversi: il problema è se usare la carota o ilbastone. Le economie prospere usano la carota dei benidi consumo, le economie più povere usano il bastonedella fame o della costrizione fisica. L’apertura delle eco-nomie di tipo Sovietico ha eliminato il bastone, ma nonc’erano carote per i lavoratori.
Fragilità finanziaria
Il Capitalismo è sostanzialmente un sistema finanziarioche trasforma la ricchezza incorporata nei macchinari enegli impianti produttivi nella ricchezza degli individui.
97
Ciò che i Paesi Socialisti stanno imparando è che la tran-sizione dal Socialismo al Capitalismo richiede la creazio-ne di un sistema finanziario. Smith ha scritto della “Ric-chezza delle Nazioni”, ma in verità il sistema finanziariodelle economie capitalistiche trasforma la ricchezza diuna nazione nella ricchezza degli individui di una nazio-ne.La caratteristica evidente dei Capitalismi che si sviluppa-rono negli Stati Uniti e in Europa nella Seconda GuerraMondiale è che la ricchezza degli individui in queste na-zioni era molto più distribuita di quanto forse non lo saràd’ora in poi. La distribuzione della ricchezza può non es-sere sostanzialmente più egualitaria di quanto non lo siastata fino ad ora, tuttavia, rispetto al passato, una sem-pre maggiore porzione di popolazione possiede validi di-ritti a redditi provenienti da beni reali. Per molti questaricchezza è legata ai fondi pensionistici, per altri la solaricchezza significativa è la casa. Tuttavia, proprio mentregli anni più recenti hanno visto il sorgere di una classe disuper ricchi, lo spirito di partecipazione nel detenere ric-chezza è un nuovo fenomeno. La forma di Capitalismonel quale una porzione significativa dell’economia pos-siede ricchezza è definita “Capitalismo popolare”.Eppure, negli Stati Uniti la forma di proprietà di beni piùdiffusa non è quella della semplice proprietà. Piuttostol’individuo tipo possiede partecipazione in fondi di pen-sione, in fondi comuni e in riserve delle assicurazioni.Questi intermediari emettono passività che sono posse-dute dalle famiglie. Essi possiedono titoli emessi da so-cietà e compagnie a loro volta proprietarie di capitale im-mobilizzato.Nella sua forma più semplice la struttura finanziaria diuna economia capitalistica prende il reddito (i profitti)prodotto dalle unità operative e lo distribuisce agli indivi-dui nelle economie. Ma questo processo implica l’esi -stenza di istituzioni che si collocano tra le famiglie e iproprietari nominali del capitale immobilizzato. Questeistituzioni sono le banche e gli amministratori di fondi.Queste istituzioni sono guidate dal desiderio di profittoche esse ottengono mediante un guadagno dalle attivitàdel loro portafoglio che è maggiore di quanto non paghi-no per le loro passività; nella finanza, così come in altri
98
ambiti, i profitti si ottengono perché c’è un eccesso dientrate sui costi. Ma nel processo di conseguimento deiprofitti i banchieri e gli amministratori di fondi seleziona-no le attività. Una delle attività che dipende dal finanzia-mento dei banchieri e degli amministratori di fondi èl’investimento. I banchieri di una economia capitalisticaselezionano ciò che deve essere finanziato e perciò in-fluenzano lo sviluppo del capitale dell’economia.Le attività, finanziarie e capitali, hanno dei prezzi. Il Capi-talismo è tipicamente un sistema a due prezzi: un insie-me di prezzi per la produzione corrente e un secondo in-sieme per i beni capitali e finanziari. Il sistema combinatodi prezzi ci dice a quali condizioni le alternative sono di-sponibili, tuttavia i principi che guidano la determinazio-ne dei prezzi della produzione e dei titoli sono notevol-mente diversi. I prezzi della produzione sono il modo incui i produttori coprono i costi, inoltre essi sono ancheportatori di profitti. I prezzi dei titoli sono indipendenti dailoro costi e sono legati all’aspettativa corrente del reddi-to atteso e del tasso di capitalizzazione (l’incremento deivalori dei titoli); questo tasso atteso rappresenta l’aspet -tativa nei confronti dei comportamenti dell’economia econtemporaneamente tiene conto delle imperfezioni chegovernano la conoscenza presente del futuro.A fianco della struttura finanziaria che trasforma la rendi-ta proveniente dal capitale nel reddito delle famiglie sottoforma di dividendi, rendite, interessi e utili non distribuiti,c’è una struttura dei debiti delle famiglie nella quale alcu-ne famiglie pagano consistenti premi per avere i titoli.Le case e i beni di consumo di ogni tipo possono essereacquistate mediante l’emissione di debiti nel processoche trasferisce reddito agli intermediari, i quali a loro vol-ta trasferiscono parte delle loro entrate nella forma di in-teressi e dividendi ad altre famiglie.La moderna economia basata sulla carta di credito portail fenomeno dell’indebitamento delle famiglie a nuovi li-velli.
99
Dallo STATUTO della “FONDAZIONE A. J. ZANINONI”
Art. 3
La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo didare continuità alla presenza non conformista e stimo-lante di A. J. Zaninoni, imprenditore, fondatore del grup-po “Jack Better”, che opera nel settore tessile-abbiglia-mento, attraverso un’attività di promozione culturale e diformazione riferita a tutti i livelli professionali – dalle man-sioni operaie a quelle imprenditoriali – a partire dall’ambi-to territoriale dove lo stesso ha operato, la Valle Serianae la Bergamasca, fino alla internazionalizzazione dellasua attività.Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione:• promuoverà la diffusione della cultura del lavoro, an-
che nella sua accezione più ampia di progetto di vita;• studierà i trend dell’economia, approfondendone le di -
namiche;• analizzerà i meccanismi del mercato del lavoro, la sua
complessità ed i suoi processi attuali e futuri;• favorirà opportunità equivalenti e percorsi tendenti al-
la parità, intesa come possibilità per donne ed uominidi realizzarsi nella vita privata, professionale e pubbli-ca;
• contribuirà alla formazione di cittadine e cittadini con-sapevoli, non conformisti e socievoli, anche medianteil sostegno e la collaborazione alle attività del “Centroculturale Progetto” di Bergamo.
Ai fini suddetti la Fondazione – utilizzando ogni strumen-to informativo – potrà promuovere e realizzare:• studi e ricerche, raccolta di materiali e documentazio-
ne, seminari, convegni, conferenze, dibattiti, mostre,corsi di formazione e di aggiornamento, pubblicazio-ni, anche periodiche;
• la istituzione e la erogazione di borse di studio.La Fondazione svolgerà la propria attività senza limita-zioni di ambito territoriale.
101
Consiglio d’Amministrazione Collegio dei Revisori
Pia Elda Locatelli - presidente Franco Tentorio - presidenteRoberto Bruni - vicepresidente Luciana Gattinoni - revisorePaolo Crivelli - direttore Maria Silvia Bassoli - revisoreMaria Laura Baruffi - consigliera SupplentiRaffaella Cornelli - consigliera Barbara Botti - revisoreItalo Lucchini - consigliere Alessandro Redondi - revisore
Comitato tecnico-scientifico
Francesca Bettiodocente di Politica economica, Università di Siena,esperta per la D.G. V della Commissione europeaMauro Cerutisenatore, già preside della facoltà di Scienze della Formazione,Università degli Studi di BergamoMario Comanadocente di Tecnica bancaria,Università Luiss “Guido Carli”, RomaSergio Fumagallidottore in fisica, consulente del Garante della PrivacyDonata Gottardiprofessoressa ordinaria di Diritto del Lavoro,Università di VeronaRiccardo Leonidocente di Economia del Lavoro,Università degli Studi di BergamoMarina Piazzapresidente di Gender, consulenza formazione ricercaDonald Sassoondocente di Storia europea comparata,Queen Mary University of LondonOrnella Scandellaricercatrice, esperta di formazione e orientamento,collabora con l’Università degli Studi Milano Bicoccae con l’ISFOL area sistemi formativiPaola Villadocente di Economia industriale,Università degli Studi di TrentoVera Zamagnidocente di Storia economica e Storia dell’Industria,Università di Bologna
Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni
Augusto Benvenuto - direttore
Fondazione A.J. Zaninoni - Ente Moralefondo di dotazione € 2.582.284,50 - cf 95116380163via Zambonate 33, 24122 Bergamo - tel 035/240907 - fax 035/3831903e-mail: [email protected] - http://www.fondazionezaninoni.org
102
DELLA STESSA COLLANA:
• L’EUROPA E IL LAVORO. Flessibilità, diritti, tutele
• IL LAVORO CAMBIA, IL WELFARE QUANDO?Parti a confronto
• GENDER AUDITING DEI BILANCI PUBBLICI
• UNA GIORNATA CON RITA LEVI-MONTALCINI
• LA SOCIETÀ ITALIANA ALLA FINE DEL 2004presentazione del Rapporto annuale del Censissulla situazione sociale del Paese
• LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA,CHIAVI DEL FUTURO DELL’EUROPALinee guida per la politica di sostegnoalla ricerca dell’Unione.Risoluzione del Parlamento europeo. Rapporto Locatelli
• TESSILE: TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
• NULLAFACENTI: luogo comune o grave ingiustizianella pubblica amministrazione?
• 1957-2007. L’EUROPA COMPIE CINQUANT’ANNI.Realizzazioni e prospettive
• DONNE IN POLE POSITION:il futuro è già cominciato?
• TESSERE IL FUTURO: guardare avanti e OLTRE...
• Finanza ed economia in crisi:QUALE FUTURO PER IL CAPITALISMO?
• Presentazione del libro:LA CULTURA DEGLI EUROPEI DAL 1800 A OGGI
• Superare la crisi:UN PATTO GLOBALE PER L’OCCUPAZIONE,predisposto dall’ILO
• UN PAESE PER GIOVANI: idee e proposte
• DOPO LA CRISI.RITORNA IL GOVERNO DELL’ECONOMIA?
• L’UNITÀ DELLE DIVERSITÀ.Tempi, luoghi, problemi di 150 anni di patria
• COSA STA CAPITANDO AL MONDO?
103