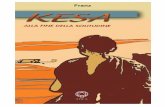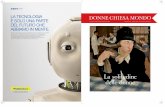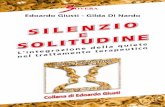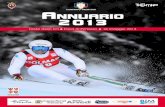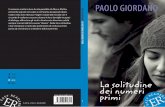il corpo solo - Rocca · 2016-09-16 · tarie, problemi di sonno, Alzheimer e altre forme di...
Transcript of il corpo solo - Rocca · 2016-09-16 · tarie, problemi di sonno, Alzheimer e altre forme di...
34
RO
CC
A 1
OT
TOB
RE
201
6
i può essere soli per carattere, percircostanze momentanee, per forzadi cose, o perché tutto sommato sista bene così. Ma quando non è unascelta deliberata, bensì una condizio-ne vissuta con disagio, la solitudine
può essere anche una malattia. Non unmero effetto di condizioni sociali svantag-giate, o di altri disturbi come la depressio-ne o una estrema ansia sociale: proprio unamalattia a sé stante, che modifica la psichee il cervello e si ripercuote anche sul corpo.Lo sostengono vari esperti, primo fra tuttiJohn Cacioppo, psicologo all’Università diChicago che studia il tema da oltre vent’an-ni e vi ha dedicato molti libri (in italiano:Solitudine. L’essere umano e il bisogno del-l’altro, Il Saggiatore, 2009).
il corpo solo
L’ultima attestazione di quanto la solitudi-ne danneggi anche il nostro fisico è venutapochi mesi fa sulla rivista «Heart» da Nico-le Valtorta, dell’Università di York nel Re-gno Unito. Mettendo insieme i dati di unaserie di studi in materia condotti negli annipassati, che nell’insieme avevano indagatooltre 180.000 persone adulte, Valtorta haconcluso che le malattie coronariche e l’ic-tus sono più frequenti del 30% fra chi sof-fre di isolamento sociale.Infarto, angina e ictus si aggiungono così auno stuolo di disturbi che include iperten-sione, indebolimento delle difese immuni-tarie, problemi di sonno, Alzheimer e altre
forme di demenza, come conseguenze fisi-che della solitudine cronica. Che aumenta-no anche il rischio di morte prematura, enon di poco: gli effetti della solitudine sullasalute sono simili per entità a quelli delfumo o dell’eccesso d’alcol. Il rischio dimorte prematura, secondo Cacioppo, au-menta in media del 20%. E se si pensa chesecondo le sue stime ne soffre un quarto dellapopolazione, e altre indagini in vari paesidanno valori fra il 20% e il 40%, si capiscel’entità del problema non solo sul piano so-ciale ma anche su quello sanitario.«Si sa da oltre 25 anni che l’isolamento so-ciale cronico aumenta il rischio di amma-larsi e di morire» spiega Cacioppo. All’ini-zio lo si è visto con studi che considerava-no misure obiettive delle scarse relazionisociali: la mancanza di un coniuge, l’averepochi contatti con amici e familiari, nonfar parte di organizzazioni, club, gruppireligiosi o altre aggregazioni. Poiché si sa-peva già che lo stile di vita ha forti riper-cussioni sulla salute, la prima spiegazioneche si è data a queste osservazioni è stataquella del cosiddetto «controllo sociale»:amici e familiari ci inducono a comporta-menti più sani – per esempio a mangiaremeglio, a dormire bene, a fare esercizio fi-sico, non fumare o bere troppo, o a consul-tare il medico se abbiamo un disturbo eseguire le cure prescritte – sia stimolando-ci direttamente a farlo, sia perché ci sen-tiamo più obbligati nei loro confronti.Tutto questo ha senz’altro un’influenza, maapprofondendo gli studi si è visto che la
GiovanniSabato S
35
RO
CC
A 1
OT
TOB
RE
201
6
SALUTE
quando la solitudineci fa ammalare
spiegazione non può stare tutta qua. Peralmeno due ordini di ragioni.Innanzitutto si è scoperto che quel che piùconta nel determinare i danni non è la quan-tità di contatti, la rete sociale obiettivamen-te misurabile. È invece lo stato di solitudineche una persona percepisce soggettivamen-te. Persone che hanno poche amicizie, maintime e solide, stanno bene, mentre chi hareti di contatti anche folte ma superficiali,con una vita sociale intensa ma non appa-gante, ne risente anche nel corpo. «Fra lasolitudine oggettiva e quella percepita puòesserci o meno un nesso. Puoi ritrovarti conpersone che ti fanno sentire solo o minac-ciato (come un parente inaffidabile o un ri-vale al lavoro), o al contrario puoi cercaremomenti di solitudine pur continuando asentirti in contatto con gli altri (come unaneomamma che prende una pausa dall’ac-cudimento del neonato)» spiega Cacioppo.Per inciso, mentre una mera misura quan-titativa non basta a valutare la solitudine,la nostra sensibilità personale ci consentedi solito di farci un’idea abbastanza atten-dibile di quanto sia sola un’altra persona.Maike Luhmann, psicologa all’Università diColonia, lo ha mostrato pochi mesi fa sul«Journal of Research in Personality», chie-dendo a 400 giovani quanto si sentisseroesclusi, ignorati, privi di un confidente ecosì via, e confrontando le loro risposte conquelle di un genitore, un partner sentimen-tale (se presente), e un amico di ciascunodi loro. Tutti e tre, ma specialmente il part-ner, riuscivano a valutare abbastanza corret-
tamente quanto si sentisse solo il giovane.La seconda ragione per cui il controllo so-ciale non spiega tutto è che noi umani nonsiamo i soli a patire tanto la solitudine: pro-blemi simili affliggono anche altri mammi-feri sociali. I topi tenuti in gabbia da soliper esempio dormono peggio di quelli chevivono in coppie. E una ricerca su topi dilaboratorio che subivano un ictus ha mo-strato che quelli tenuti soli morivano inproporzioni molto maggiori di quelli chevivevano in gruppo. In casi simili ovviamen-te gli stili di vita e l’influsso degli altri sullasalubrità dei comportamenti non c’entra-no: la causa deve stare in qualche meccani-smo biologico.
la mente sola
La chiave secondo Cacioppo sta nel fattoche per un membro di una specie sociale,la cui sopravvivenza dipende in modo de-cisivo dal gruppo, lo stato di solitudine èavvertito come una grave minaccia. Se unindividuo si percepisce solo, quindi, mettein atto una serie di meccanismi difensivipsicologici e fisici, che nell’immediato aiu-tano a proteggersi dai rischi; per esempiostando più in allerta per essere reattivi al-l’eventuale comparsa di un predatore, datoche non si può contare sulla sorveglianzacollettiva del gruppo, o sui meccanismi col-laborativi per eluderlo o allontanarlo.Tuttavia, come spesso accade (per esempiocon la paura o con lo stress), questi mecca-nismi che per brevi periodi aiutano a soprav-
36
RO
CC
A 1
OT
TOB
RE
201
6
vivere, se superano certi limiti e diventanocronici si fanno controproducenti e innesca-no un circolo vizioso che si autoalimenta.Oltre al piano fisico gli adattamenti inclu-dono quello psicologico, di particolare ri-lievo nella nostra specie, per difenderci an-che dagli aspetti negativi della socialità,come le situazioni già accennate in cui irapporti infelici con gli altri, paradossal-mente, possono far sentire ancora più iso-lati o più minacciati.Gli studi psicologici hanno mostrato peresempio che le persone sole sono più sensi-bili ai segnali sociali negativi. Se si fannovedere loro disegni di visi che includono, nonmolto evidenti, alcuni tratti indicativi di tri-stezza, chi si sente solo riconosce più facil-mente questi accenni di mestizia. Se si elen-ca una serie di vocaboli, quelli dalla conno-tazione sociale negativa provocano in lororeazioni più forti. Gli studi sul funzionamen-to del cervello poi mostrano che le personecronicamente sole traggono meno gratifica-zione dagli aspetti piacevoli delle interazio-ni con gli altri, e sono quindi meno propen-se a cercarle, cosa che ovviamente riduce irischi di delusione o di difficoltà nei rappor-ti, ma inasprisce ancor più la solitudine. Neitopi si è visto poi che il cervello diventa menoplastico, meno propenso a rimodellarsi conle esperienze, il che, se accade anche nel-l’uomo, può essere una delle cause della cre-scente rigidità e chiusura in se stessi che siosserva in queste persone.Il cervello solitario entra insomma in quel-la che Cacioppo definisce una «modalitàdi autoconservazione sociale»: instaurauna serie di meccanismi di difesa dalle dif-ficoltà e dalle minacce della socialità, cheda un lato riducono le fatiche dei rapportie i rischi di delusioni, ma dall’altro perpe-tuano l’isolamento. Così ci si chiude sem-pre più in se stessi e la solitudine divieneuna condizione stabile. Che dal cervellocoinvolge il resto del corpo.Per un animale che vive in gruppo infatti,come si diceva, la solitudine è una condi-zione pericolosa che innesca meccanismidi difesa anche fisici. Un’allerta utile a di-fendersi dai pericoli, se momentaneo, mache logora l’organismo se diventa continuo.Per esempio Steven Cole, dell’Universitàdella California a Los Angeles, ha mostratosu Pnas che, sia negli esseri umani sia neimacachi, la solitudine modifica sia i segnalinervosi e ormonali con cui il cervello con-trolla vari organi, sia l’attività dei geni, atti-vando un «programma di difesa dalle av-versità» che fa calare gli anticorpi e aumen-ta invece lo stato di infiammazione: unaforma di difesa meno specializzata e sofi-
sticata rispetto agli anticorpi, ma di azionepiù immediata e generalizzata. È ben notoche l’infiammazione protratta favorisce asua volta molte malattie croniche, comequelle cardiovascolari, l’ictus o la demenza.
i rimedi
Per contrastare la solitudine e le sue conse-guenze sono state messe in atto molte ini-ziative. Cacioppo stesso ci ha lavorato e,qualche anno fa, ha condotto un esamecomplessivo degli studi sui vari interventisviluppati fino a quel momento dal suogruppo e da altri, per stabilire quali sianole soluzioni più efficaci.Al livello più semplice e diffuso ci sono tan-te iniziative per offrire occasioni d’incontroa chi nella quotidianità rischia di trovarnepoche, e in particolar modo agli anziani. Lacosa magari è utile a livello preventivo se gliincontri sono piacevoli e vissuti bene, manon è necessariamente efficace a scalzareun atteggiamento solitario già instauratosi,con le conseguenti difficoltà a condurre unavita sociale soddisfacente di cui si è parlato.Anche perché, se le persone che si rivolgonoa questi programmi sono proprio quelle ten-denzialmente più sole, si rischia di mettereinsieme tante persone che faticano ad avererelazioni soddisfacenti e che quindi si fan-no del male a vicenda.Anche gli interventi volti a potenziare lecapacità sociali di un individuo, di per sé,si sono mostrati di utilità relativa, perchéanche le persone solitarie di solito hannogià la capacità di vivere bene fra gli altri, sesi tolgono di dosso la cappa della solitudi-ne che glielo impedisce.Le azioni più efficaci, quindi, sono risultatequelle che modificano gli atteggiamenti concui si affronta la vita sociale; che portanocioè a cambiare la percezione di sé, deglialtri, di come gli altri ci vedono e delle inte-razioni, spezzando il circolo vizioso di pen-sieri e percezioni negative e facendo riassa-porare il piacere di stare insieme, di averescambi. Così pian piano si impara ad anda-re in cerca delle persone giuste con cui ci sitrova a proprio agio, consci che non contala quantità ma la qualità delle interazioni. Eal contempo si abbandonano quegli schemimentali e quegli atteggiamenti che induco-no a temere e rifiutare l’incontro, evitando-lo del tutto o, pur stando in compagnia, re-stando chiusi in se stessi per proteggersi, leg-gendo in chiave negativa le azioni altrui, nonmostrando empatia e reciprocità, e di fattoaggravando quindi l’isolamento.
Giovanni Sabato
SALUTE