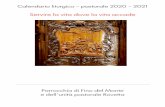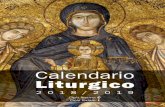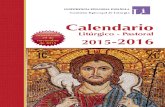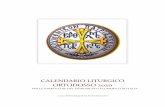Il Calendario Liturgico
-
Upload
tefan-nuica -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Il Calendario Liturgico
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
1/14
Metodo storico e metodo teologico
Critiche alla sua conferenza: poco storica?
Prima parte: criticare storicamente il neonicenismo
Seconda parte: non teologica opposta a storica, ma ancora una parte storica
Differenza tra un metodo puramente storico, e un metodo storico teologico. Il punto di
vista teologico aiuta a riconoscere aspetti che gli storici non vedono. Ma non è il punto.
Il punto
Studio su storia e fede nelDe Trinitate di Agostino. Agostinian Studies 1(1997); cf.
Marrou,Connaissance Historique, in cui insiste sugli aspetti soggettivi della ricerca storica. Chi
crede ha un punto di vista soggettivo, e questo punto di vista domina la sua ricerca. Cf. suo
libroDio Salvatore nei Padri, pg. 21 ss.
Definizione di Congar: triplice funzione della teologia: dogmatica, apologetica,sistematica.
La visuale di S. Agostino. Distinzione tra fides historica, e fides religiosa; la fides
religiosa supera la pura e semplice fides historica. I giudei credono che c'è stata la morte di
Gesù; ma non credono nella morte di Gesù come salvezza.
Agostino ammette una possibilità di ricerca, anche con mezzi razionali.
Es: Paolo fu un uomo giusto (De Trin. VIII). Noi crediamo questo. E' fede perché
accettiamo un'affermazione di testimoni. Quando abbiamo testimonianze di altri, abbiamo
sempre fede; ci affidiamo all'autorità di coloro che ci presentano determinate testimonianze.Possiamo in effetti verificare se queste testimonianze sono credibili, il loro gradi di
attendibilità; possiamo anche riflettere sul significato dei termini "uomo" e "giusto". Abbiamo
dunque un'affermazione di fede; ma abbiamo anche la possibilità di un lavoro di riflessione
sulle fonti, e sulle affermazioni in esse contenute: è dunque possibile "cogitare" con la fede. Se
però noi stessi possediamo la giustizia, la nostra riflessione diventa ancora più profonda.
Tutto questo resta nell'ambito della fides historica, e può essere ricercato con criteri storici,
antropologici, etc. Forse lo storico di professione non si interessa agli aspetti esistenziali.
Es di fides religiosa. Gesù di Nazaret è risorto dalla morte. Anche in questo caso la
nostra fede è basata su testimonianze. Ci basiamo sull'esperienza di uomini di secoli fa. C'èdunque una distanza da superare, come nel caso della fides historica. Siamo però fiduciosi
che le testimonianze ci riferiscono un'esperienza fatta a Gerusalemme duemila anni fa. Atti
degli Apostoli: fides historica; riferiscono i fatti dell'esperienza pasquale della prima
comunità. La nostra fiducia però non si basa sulle testimonianze storiche, ma anche sulla
vocazione di quelle comunità, sulla singolarità delle testimonianze scritte che riflettono
quell'esperienza. Ricorriamo a mezzi storici, filosofici, sociologici; ma il nocciolo rimane
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
2/14
inaccessibile a questi mezzi. In ultima analisi, l'accettazione della risurrezione non deriva dai
mezzi storici, sociologici, filosofici. Non possiamo spiegare a un non credente perché
accettiamo quella testimonianza. Non ci riferiamo solo alla parola di Dio, ma anche alle
esperienze religiose dei martiri, dei santi, all'autorità della Chiesa...
Quando diciamo Cristo è (sottolineato: è) risorto, la nostra accettazione è basata suqualcosa di qualitativamente diverso dalla storia. Cf. Studer, contributo per la Storia della
Teologia, capitolo VI; anche in questo capitolo VI c'è un piano storico, un piano di fides
storica; e la condivisione di affermazioni al di là della storia.
Sul piano storico: ammettiamo che Agostino ha scritto questo, lo approfondiamo
filologicamente, lo riesprimiamo in termini attuali
Sul piano religioso: condividiamo quello che Agostino ha scritto e facciamo nostre le
sue affermazioni, riconoscendole derivate dalla Parola, e conformi al progetto di Dio.
Terzo punto della terza parteDopo aver parlato del metodo da seguire. Divisione del corso. Qualche indicazione nel
calendario.
Didimo: le prossime lezioni (morto nel 298?)
Ambrogio (morto nel 393)
Giovanni Crisostomo (407)
Teodoro di Mopsuestia (428)
Agostino (430)Se possibile, una parola su Cirillo di Alessandria (444)
Teodoreto di Ciro (466)
Leone Magno (471)
Non riusciremo a farli tutti
Sarà impossibile essere completi. Dobbiamo scegliere, limitarci a certi testi. Per
Crisostomo: limitarsi ai commetti su Mt 11,25?
Bibliografia:Darà la bibliografia per gli autori dei quali si parlerà.
Considerazioni:
Studer,Dio Salvatore, 1985; nelle edizioni più recenti bibliografia aggiornata
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
3/14
"La teologia trinitaria in Agostino d'Ippona", atti di un convegno del 1993, Ephemerides
Augustinianae; tiene presente le critiche di Rahner, e le critiche fatte a Rahner; vedi anche la
tesi di Hübner
Conferenza su storia e fede; 1996, Agostinian Studies (1997); riflette le discussioni negli
USA sulla tematica theologia-oikonomia;
Miscellanea sui professori Löhrer-Tragam, S. Anselmo, 17 novembre alle 17:00.
Studi generali:
- Kelli, Early Christian Doctrins
- Katholisch Dogmengeschichte;
- Grillmeier, Jesus Christus **Kirche*? pagine interessanti su Didimo
Aspetti storici:
- Simonetti,La crisi ariana nel IV secolo, (1974)
- Hansen,La dottrina su Dio nel IV secolo (1988)
- Leggersi su Didimo il Cieco
- Dizionario Patristico; studi degli ultimi vent'anni.
**manca il primo quarto d'ora del 27 ottobre: bibliografia
Didimo il Cieco
Bibliografia:
1. Informazioni generali
a. Clavis Patrum Graecorum 2544-2572 (1974)
- si son scoperti testi in una biblioteca egiziana che non sono ancora pubblicati;
b. DPAC
- presenta gli scritti;
c. Theologische Realenziklopädie;
d. Patrologie (introd. ai padri dei secoli IV-V);
e. Introduzioni nelle edizioni (volumi di SChr 83-85);
f. Il volume che contiene il “Trattato sullo Spirito Santo” con una introduzione;
g. Introduzione al volume di testi patristici
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
4/14
2. Studi speciali
a. Bardy, Didyme l’Aveugle (1910)
- riassunto nel D.S. 1957;
b. Steiner (1960)- difende la tesi che Didimo avrebbe scritto una tesi sullo Spirito Santo che oggi non
viene amessa fra gli scritti di Didimo;
c. Gesché
- testi sui salmi;
d. Laminski
- pneumatologia di Atanasio di cui Didimo dipende molto;
e. Bienert,Introduzione all’esegesi di Didimo, 1957f. cavalcanti,Studi eunomiani, (Contra Eunomio IV eV che sono atribuiti a Didimo)
g. Prinzivalle
h. Grünbeck,Christologische..., 1994
- storia dell’esegesi sul Salmo 44;
- conosce il metodo di Didimo
3. Studi storici
a. Kelly,Christian Doctrines
b. Grillmeier,Cristologia antiapolinarista di Didimo
c. Simonetti,Dogma fondamentale sul arianesimo
d. Huy
e. Hansen
f. Hauschiebt,Controversia penumatologica nel IV° sec.
Introduzione
Didimo viene chiamato “cieco” perché soffriva di questa malattia dalla sua infanzia.
Visse tra gli anni 313-398. Nel 375 scrisseDe Spirito Sancto, ma è meglio metterlo dopo il
Concilio, quando divene maestro della scuola alessandrina, fondata da Origene, durante la
recesione della fede nicena.
L'interesse per Didimo
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
5/14
Didimo fu capo e rappresentante della scuola di Alessandria nel IV secolo, durante la
recezione del Concilio di Nicea. Il termine di "scuola" è più pertinente ad Alessandria che a
Nicea.
Didimo è stato riconosciuto da Atanasio come il suo vescovo. Anche Atanasio è
[moderaramente] origenista, muovendosi sulla scia di questo grande maestro. Didimo vieneconsiderato come docente e direttore della scuola. Gli studiosi discutono il tipo di scuola che
sta dietro a Didimo: scuola pubblica della Chiesa alessandrina, o un circolo monastico
chiuso? Una parte degli scritti di Didimo è strettamente legata all'insegnamento. I salmi
ritrovati a Tura(?) sembrano appunti degli studenti, lezioni per un pubblico elitario non per
qualsiasi fedele di Alessandria.
Didimo sta tra Atanasio e i Cappadoci. Dipende da Atanasio e in alcuni punti sembra
precedere i Cappadoci. Ma non conosce il niceo-costantinopolitano e né i canoni. La sua
terminologia rimane ancora vaga come quella di Atanasio e non ha idee chiare nelle sue
ipotesi. Nel 553 viene condannato insieme ad Origene; la condanna comportò la mancataconservazione dei suoi scritti; aveva scritto commenti sul A.T. che sono scomparsi.
- Didimo: alessandrino, origeniano, grande rappresentante dell'origenismo durante la
recezione della fede di Nicea. Didimo fu un grande rappresentante della Scuola di
Alessandria. soprattutto uomo della Scrittura. Compose molti commenti biblici che si sono
conservati nelle catene o nei manoscritti della biblioteca egiziana di Tura. (cf. DPAC)
Girolamo voleva dimostrare i plagi di Ambrogio, e perciò traduce gli scritti di Didimo
(De Spirito Sancto). A questi si aggiungono i tre libri delDe Trinitate e i tre libri delContra
Eunomio, che non è riconosciuto di tutti I studiosi come autentico. Anche gli scritti teologici sidistinguono per il loro orientamento biblico. Una continua discussione dei testimonia citati
contro o a favore della divinità dello Spirito Santo. De Spirito Sancto: una teologia biblica
dello Spirito Santo. Né i commenti né i libri dogmatici sono particolarmente polemici. Non
polemizza con gli eretici, essendo molto moderato, e conduce la controversia senza eccessi di
animosità.
- Rispetto ad altri padri, Didimo si interessa soprattutto alla Scrittura. Ci mostra che
cosa sia l'esegesi dogmatica. L'interesse per la Scrittura lo porta a uscire dal ristretto ambito
dell'ortodossia, a valicare i confini della formula.
- Esercita un grande influsso sullo sviluppo della teologia. Ambrogio conoscevaDeSpiritu Sancto nell'originale greco (lo aveva ricevuto nel 381), già prima della versione di
Girolamo. Girolamo lo conosceva personalmente, e gli aveva chiesto di commentare Zaccaria
ed Osea. Egli stesso prende molto da Didimo nel suo commento a Zaccaria. Didimo in questo
modo dà un influsso notevole al pensiero latino. Si discute spesso sulla differenza tra la
teologia trinitaria orientale e occidentale: orientale dalla distinzione, occidentale dall'unità.
Didimo mostra l'inadeguatezza della tesi. Egli parte dall'unità.
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
6/14
- L'insegnamento di Didimo. Una teologia monastica. Era un professore, ma non
conosciamo esattamente il livello del suo pubblico. L'indirizzo spirituale del suo
insegnamento è ovvio. Certo che tra i suoi ascoltatori c’erano uomini interessati alla vita
monastica. Tra i suoi ascoltatori: Rufino, Girolamo; anche Evagrio è grande amico di Didimo.
Si parla anche di contatti personali con Antonio, facendo scambio delle visite. Didimo non fusolo dottore della contemplazione, ma anche maestro dellafede semplice.
Dal suo Commento su Zacharia si vede che "Didimo insegnò la dottrina della Chiesa
per tutta la Chiesa".
Riassunto:
- origeniano, alessandrino, rappresentante dell’origenismo nel IV° s.
- ci fa capire che cosa sia l’esegesi dogmatica, dottrina della fede fondata sulla Bibbia,
che l’ha fatto uscire dal orizonte stretto dell’ortodossia
- ha avuto un grande influsso sul Occidente
- inizi di una teologia monastica.
Le opere e le caratteristiche del pensiero teologico di Didimo
a) Opere teologiche.
1.De Spiritu Sancto
l’opera più conosciuta è stata composta prima del 380 (381: utilizzato da Ambrogio;
385: tradotto da Girolamo). Non si ammette più l'opinione della Sheiner: 350 circa. L’opinione
dei salesiani sceglie l’anno 375. Dipende dalle lettere a Serapione di Atanasio; non citaBasilio, (scritto nel 375).
L’opera è divisa in 5 parti (nell’edizione di SChr):
Parte I: Introduzione 1-9:
- sottolinea la difficolta di parlare di questo argomento e che si deve tener presente la
Scrittura;
Parte II: natura e attività dello Spirito (10-131)
1. Natura ed attività per se stesso (10-73)
2. ------ “ ------ “ ----- nella Trinità.
Parte III: discussione di Testimonia (132-230)
- testi pneumatologici interesanti per lui: Gv 15; Gv 16; Rm 6; Is 63
Parte IV: riflessioni complementari (231-271)
Parte V: Conclusione (272-277)
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
7/14
Sottolinea che si è attenuto al proposito: seguire la Bibbia.
Attribuiti a Didimo 2 libriContra Eunomium. In Basilio 5 libriContra Eunomium, di cui ultimi
due sono attribuiti a Didimo; sono però molto simili; possono essere attribuiti o rifiutati in
blocco a Didimo. Simonetti lascia aperta la questione (crisi ariana); grande conoscitore,
ammette l'autenticità, però pare che ultimamente Simonetti la neghi.
De Trinitate:- primo libro: il Figlio
- secondo libro: lo Spirito Santo
- terzo libro: riassunto.
L'autore segue Atanasio. Secondo Girolamo Didimo è ortodosso. Nel primo libro
contro gli ariani, nel secondo contro i macedoniani. L'esposizione non è sistematica, ma
procede attraverso i commento di passi biblici la documentazione essendo quasi tottalmente
biblica. Composto nel periodo 395-398, poco prima della morte.
Grande differenza tra ilDe Trinitate e ilDe Spiritu Sancto, sulla base della quale si può
rifiutare l'autenticità (cf. Hansen,La ricerca di Dio nel IV sec.).
Ma se ammettiamo uno sviluppo nel suo pensiero, non risulta difficile accettare queste
divergenze. Ultima edizione: Göttscheidt e Scheiler, 1975, con traduzione in tedesco.
Contra Eunomium.
- primo libro: argomenti di carattere biblico, concernenti la divinità del Figlio;
- secondo libro: tratta dello Spirito. Cerca di dimostrare che non è creatura, ma
immagine perfetta del Figlio (difende l’omousios dello Spirito Santo).Simonetti (Vetera Christianorum 1964) gli attribuisce anche il cosiddetto Sermo Maior,
da altri attribuito a Eustazio o Marcello.
b) Opere esegetiche
Girolamo e la tradizione delle catene: molte le sue opere esegetiche.
Scritti di Tura*?: Commento a Zaccaria; commento sui Salmi; altro commento sui Salmi
conservato nelle Catene e pubblicato da *?
Commento di Tura. Appunti dei discepoli durante le lezioni. Commento ai Sal. 20-44. Anni
370-385; pressoché contemporanei allo Spirito Santo. Particolarmente interessante: commento
al Sal 44, cristologico. Nell'interpretazione del Sal 44 non solo riferisce le immagini ad altri
testi; ma vede nelle immagini il vestigium trinitatis. Una serie di immagini, spiegate con altre
immagini bibliche. Ma approfondisce anche il fatto della varietà di queste immagini. Per
esprimere in qualche modo il mistero trinitario occorrono molte immagini, molte espressioni;
questo va contro Eunomio, che postula identità tra nome e natura. Segue la lina origeniana
delle Epinoiai.
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
8/14
Commento a Zaccaria. Gutlo*? lo caratterizza come dottrina della Chiesa per la Chiesa.
Ortodossia non accentuata, manca la terminologia tecnica del tempo. Nel IV libro combatte il
concetto di uiopater, attribuito a Sabellio. Avendo a che fare con l'esegesi di una profezia,
l'esegesi sull'incarnazione è più importante della trinitaria. La profezia è sempre interpretata
come profezia del Cristo: il profeta si riferisce all'incarnazione, e non alla teologiac) le caratteristiche del pensiero teologico di Didimo.
Gli scritti di Didimo sono da considerare in gran parte come compilazione di argometi biblici
a favore della divinità dello Spirito. Riprende gli argomenti a favore e contro, li raccoglie
(senza eccessivo ordine). Le sue opere riflettono le condizioni della teologia nicena nella
seconda metà del sec. IV. Prima del 70: difficoltà di recezione; dopo il 70: approfondimento.
Pensiero di Didimo: a metà tra Atanasio e i Cappadoci. Dipende da Atanasio, ma va oltre.
Atanasio: symmetria tra Figlio e Spirito. Meno accentuata in Didimo: prima il Figlio, poi lo
Spirito. Didimo conferma insieme ad Atanasio che lo Spirito non è un angelo, una creatura.
De Sp. Sanct. 7,25-28. Cf. Peri archon 7,3*?
Più di Atanasio prende le distanze sia dagli eunomiani, sia dai sabelliani, contro Marcello di
Ancira (in cui Atanasio non è eccessivamente incavolato). Parla di proprietas personarum, ma
è più direttamente interessato all'unità della natura. La formula mia ousia treis upostasei"
non si trova ancora in lui.
Però le tre ipostasi abitano in noi nell'unità dell'unica natura. Comunque non arriva alla
definizione dei cappadoci;
riassumendo, rispetto ad Atanasio:
- pneumatologia indipendente dalla cristologia
- lo Spirito non è angelo, non creatura.
- presa di posizione contro gli eunomiani.
- anche dopo Costantinopoli, manca la formula mia ousia treis upostaseis; forse un indizio
che non era una cosa tanto importante? Va oltre Atanasio, senza arrivare al livello dei
Cappadoci.
- Ignora il De Spiritu Sancto di Basilio, ma stranamente difende con maggior vigore la
divinità dello Spirito: applica ad esso l'omoousios; e parla anche della consustanzialità dellatrinità. Mentre Basilio ha difficoltà a spiegare l'origine dello Spirito, l'autore del De trinitate è
più chiaro sulla differenza tra generazione e processione; sviluppa l'origine dello Spirito per
mezzo del Figlio (come Gregorio di Nissa).
Paragone riguardo al metodo.
Più vicino ad Atanasio che ai Cappadoci.
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
9/14
Procedimento prevalentemente biblico. Ha premura di confutare interpretazioni false, e
proporre esegesi corrette. Si accontenta di fare esegesi dogmatica. cf. Pollard*?, DPAC,
Giovanni, che riassume il suo libro sull'esegesi giovannea. Le riflessioni di carattere filosofico:
solo i molti nomi per indicare Dio, la varietà di nomi per l'unico mistero. De Trinitate I,11.
Qualcuno dice che avrebbe sviluppato una teoria del linguaggio per combattere gli ariani.Altra idea filosofica presente: il concetto di analogia.
Non fa pure dimostrazioni di concetti teologici, ma vuole presentare la retta fede,
illustrandola con la Bibbia. Far vedere come si presenta la fede, attraverso l'uso della Parola.
** Mancano due lezioni su Didimo il Cieco
Ambrogio di Milano
Bibliografia
Beatrice: 1874-1974
Studer, "Ambrogio teologo mistagogico", in Vescovi e pastori nell'età teodosiana Conferenza
al Convegno Patristico del '96
Testi
CSEL/SAEMO edizione milanese, che riprende gli ultimi volumi dell'opera di Vienna
TRE, articolo del '78,
DPAC, uno studio dello stesso, ma più corto
Pasini, una sorta di vita di S. Ambrogio, dove si trovano tutte le opere.
Studi speciali
Atti dei convegni ambrosiani:
1974: "Ambrosius episcopus",
1997: "*? altro convegno importante; gli atti dovranno uscire.
Toscani G., Teologia della Chiesa in S. Ambrogio", Studia Patristica Mediolanensia
Pizzolato ., L'esegesi di Ambrogio,
Pizzolato ., Introduzione al commento sui SalmiRossato
Graumann, *? buona opera, ma non ha un sufficiente concetto di storia
Jakobs, sulle catechesi di Ambrogio
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
10/14
Markschien, La trinità in Ambrogio, *? Studer la critica molto; buona per la conoscenza della
storia del IV secolo e dei suoi rapporti con l'Oriente; troppo pretenzioso il titolo; accetta la
categoria di neonicenismo; limitato il discorso propriamente teologico.
Una teologia predicata
Tutte le sue opere riflettono la sua predicazione. Non ci è rimasto nessun sermone, ma le
prediche sono tutte integrate nelle sue opere. Diversi autori hanno rilevato questo fatto:
Graumann, Pizzolato, Halfmauer, *?l'esegesi dei Salmi in Ambrogio, *?.
L'iniziazione ai misteri della Chiesa
Jakobs ha pubblicato una bella tesi sull'influsso della liturgia sull'esegesi di Ambrogio. Tesi
valida, ma non è da esagerare l'importanza di questo approccio. Cf. le Catechesi. cf.
Calcaterra, La catechesi pasquale di S. Ambrogio di Milano, Milano 1973.
L'iniziazione al mistero di Cristo
Riprende la tesi di Graumann: Cristo Dio e uomo è la chiave dell'esegesi ambrosiana, ma non
presenta i suoi testi in cui Ambrogio insiste sull'unità di Cristo.
Il mistero di Dio
Il cristocentrismo di Ambrogio (Christus omnia) ha sullo sfondo il mistero di Dio. Mysterium
paternitatis/charitatis.
Nuova conferenza quest'anno: Cristo in Origene e in Ambrogio
Stesse idee, con in più il paragone con Origene.
Due parti:
Il contesto cristico, il cristocentrismo (oikonomia)
La teologia trinitaria (teologia)
Il cristocentrismo
Ambrogio vive circa nel 380, in un tempo in cui la fede nicena viene definitivamente recepita,
in cui comincia anche la discussione propriamente cristologica. Anche lui deve occuparsi
della tematica oikonomia/theologia.
De Fide, in cinque libriDe Spiritu Sancto
De Incarnatione
Tre opere teologiche che si possono ricondurre alla nostra tematica. Ma anch'esse vanno viste
nel quadro della predicazione. Cf. Studer, articolo sull'inizio del IV libro del De fide, 1974 che
non è altro che un sermone per il giorno dell'Ascensione.
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
11/14
Il suo cristocentrismo si riassume nell'espressione "Christus omnia"; "Omnia habemus in
Christo". Esso riguarda sia il metodo esegetico, sia la spiritualità ambrosiana.
Cristocentrismo ed esegesi
L'ermeneutica biblica
Christus-Veritas Per avere un'idea della Bibbia in Ambrogio è utile Toscani, tutto il capitolo
sul Sacramento della Scrittura; poi Madec, a Milano, conferenza di quest'anno. Per Ambrogio
la Bibbia è un discorso su Cristo. Un grande sermone sul Cristo. Addirittura, è il suo corpo; in
questo corpo sono presenti tutti i misteri. Ignoratio scripturarum ignoratio Christi (Girolamo).
Nota esistenziale: nella Bibbia incontriamo Cristo. Nella Chiesa la Bibbia edifica l'unità dei
fedeli. Da notare anche che Ambrogio quando parla dell'utilità della Bibbia parla sempre del
progresso spirituale. Leggendo la Biba avanziamo, facciamo sempre più progressi verso
Cristo.
Prologo al Exp in Psal 1, 118.L'immagine della scala di Giacobbe è ripresa a proposito delle Scritture. Salire a piccoli passi
la scala della virtù, verso mete che superano apparentemente la natura umana.
Exort de Viginitate 9,56.
La Scrittura è dunque corpo di Cristo; mezzo di progresso, mezzo di unione. Cristo è dunque
l'interprete delle Scritture. Ambrogio spiega la Scrittura nell'ambito della Storia della
Salvezza, utilizzando il trinomio umbra-imago-Veritas. Umbra sono le profezie; imago la
presenza di Cristo sulla terra; Veritas la visione/contemplazione delle verità. Per capire la
profondità della Scrittura occorre capire la presenza di Cristo nell'ombra, nell'imago, nellaVeritas.
De excessu fratris 2,109.
Expos Psal 38, 24ss.
Questa teoria proviene da Origene. In lui troviamo il tema fondamentale di Mysterion tou
logou (cf. Balthasar, famoso articolo sul Mysterion). Cristo presente nella Scrittura, nella
Chiesa, nei sacramenti, nella singola anima....
Concetto di sacramentalità: che risente della distinzine tra sensibile e intellettuale; che risente
anche della riflessione biblica sul simbolismo.
Ambrogio riprende da Origene il concetto di sacramentalità della Bibbia, del senso nascosto
tropologico o cristologico-mistico.
Quando la lettera rende non si cerca un senso metaforico; ma per Origene anche la lettera è
spirituale, riguarda il nostro cammino verso Cristo. Ambrogio riprende il senso spirituale-
sacramentale da Origene. Ma c'è anche il concetto di rivelazione: abbiamo a che fare con la
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
12/14
Verità; bisogna scavare il senso cristologico in tutte le Scritture; occorre cercare l'aletheia della
Scrittura; secondo determinati criteri (cf. introduzione del peri archon).
Altro aspetto preso da Origene: la ricerca dell'aletheia, Cristo, nella Chiesa. Una serie di testi
in cui si parla della casa di Gesù: occorre entrare con lui nella casa, insieme ai discepoli; solo
nella Chiesa si trova il vero significato della Bibbia.
peri archon 2,2;
In Lev 5,5
Disp. con Heraclide 15
La differenza tra Origene e Ambrogio.
1) il contesto antiariano. Tra i due, la rottura rappresentata dal Concilio di Nicea. Ambrogio
intende con Cristo, Dio e Uomo. Ambrogio legge la Bibbia sulla linea della distinzione tra
umanità e divinità in Cristo. Anche in Origene abbiamo testi in cui si distingue il divino
dall'umano. Ma nel IV secolo, sotto l'influsso delle discussioni antiariane, si sviluppa la
"regula canonica", con cui si distinguono gli attributi umani e divini in Gesù. La distinzione
oikonomia/theologia, intrapresa da Origene, è puntualizzata nelle discussioni del IV secolo.
Ambrogio si trova in una fase di sviluppo cristologico avanzato, e pertanto presenta molti
passi in cui si afferma il concetto dell'unità di Cristo.
2) l'importanza data alla liturgia. Origene: doppia esegesi. I dati biblici sono spiegati con lo
stesso metodo dei dati liturgici. Ma per lui la liturgia non ha la stessa importanza. Ambrogio
va oltre Origene. Anche Origene parla del Battesimo, parla dell'unione tra l'anima sposa e
Cristo sposo; tutto questo in Ambrogio è molto più importante. Egli è vescovo, a contatto conil popolo, in un periodo di grande sviluppo liturgico: le catechesi mistagogiche non erano
ancora attestate nel terzo secolo.
3) Ambrogio poeta. Origene è filologo, ma resta arido sul piano della letterarietà. Ambrogio
deve tradurre dal greco al latino; deve inventare molte parole per permettere la traduzione. Il
genio poetico di Ambrogio si vede anche nel fatto che egli ama il Cantico; e presenta il
Battesimo e l'Eucaristia come incontro con Cristo.
Origene più profondo e creativo di Ambrogio, da un punto di vista teologico. Ambrogio però
ha un concetto più chiaro dell'Incarnazione, una maggiore sensibilità liturgica, una maggiore
capacità letteraria.
Aspetto spirituale: spiritualità cristica.
Baus*?, Das *? des Origenes in der *? Ambrosius; Dassmann*? ha pubblicato una sua tesi
sulla spiritualità ambrosiana, in italiano: Sobria ebrietas.
Baus descrive come Ambrogio è entrato nel mistero di Cristo. Riassunto nella formula: Omnia
habemus in Christo. De Trinitate*?
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
13/14
Creazione-Redenzione: speculativi
imitazione-preghiera: pratici
Creazione
Cristo è Verbo (cf. Szabò, Le Christ créateur chez S. Ambroise, *?; altri studi su Ambrogiointerprete di Gen)
Redenzione: tema famoso della subiectio. Cristo ha sottomesso tutte le cose a Dio, e ha
sottomesso se stesso a Dio, affinché Dio sia tutto in tutti.
Exp. in Ps 36,16. Sviluppa la tematica della subiectio; soteriologia cristica. Per Christum, sub
Christo.
Aspetti pratici: imitazione
La sequela di Cristo: Cristo è tutto
Hom in Luc, 2,38. Spiega l'inizio del Vangelo e la necessità di confessare l'incarnazione: da cui
deriva la nascita del Verbo in noi (cf. Hugo Rahner, Simboli della Chiesa,*? ). Si intende:
diventare immagine di Dio cioè diventare come Cristo.
Aspetti pratici: la preghiera cristica
Baus rileva la prevalenza delle preghiere indirizzate a Cristo sulle preghiere indirizzate al
Padre. madec nella sua conferenza sulla centralità di Cristo in Ambrogio ha sottolineato
queesti aspetti liturgici: la preghiera indirizzata a Cristo.
Hom in Luc 2,38; la meditazione è interrotta dall'invocazione a Cristo; così anche a 97, in cui
si indirizza a Dio.
Questa spiritualità proviene, come Baus ha dimostrato, da Origene. Origene ha tre grandi
idee, che si ritrovano in Ambrogio: mistica del logos, mistica di Gesù; mistica sponsale.
Si tratta di idee legate alle epinoiai: sophia e logos; poi medico, redentore, vigna etc che sono
come una scala verso Dio (cf. articoli di Crouzel, e Grillmeier *?; primi capitoli del commento
a Giovanni)
De Trinitate 16,99.
Differenze. Ambrogio semplifica la ricchezza della dottrina origeniana. Ambrogio dà più
importanza alla redenzione. Soteriologia della felix culpa, presa da Atanasio. In Origene ha
un significato conservativo, un ritorno alle origini. In Ambrogio si va oltre le origini.
Un'altra differenza: in Ambrogio una riduzione cristologica. Origene molto più trinitario (cf.
struttura del perì archon).
Ambrogio presenta una teologia molto più politica. Vescovo di una Chiesa imperiale, amico
di imperatori. Le immagini politiche diventano importanti: il triumphus di Cristo, la vittoria;
-
8/18/2019 Il Calendario Liturgico
14/14