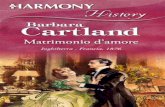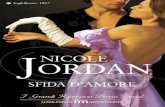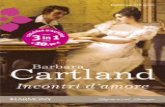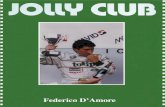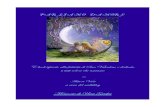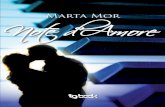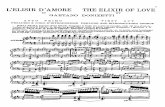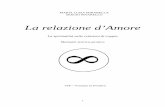I Fedeli d'Amore
-
Upload
pierluigi-caravella -
Category
Documents
-
view
220 -
download
1
Transcript of I Fedeli d'Amore
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
1/111
Quaderni del Gruppo di Ur
XIII FEDELI D'AMORE
I Ediz. Gennaio 2006 - II Ediz Ottobre 2006 - III Ediz. Settembre 2007
Dante Gabriel Rossetti - Dantis Amor - 1860
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
2/111
Ogni quaderno del Gruppo di Ur raccoglie, in forma organica e sintetica, quanto emersonell'omonimo forum, in relazione ad un determinato argomento. In esso si trovano, perci, siacitazioni degli autori studiati, sia commenti. I quaderni si devono considerare in continuoaggiornamento, dal momento che l'emergere di nuovo materiale sull' argomento trattato purendere opportuna una nuova edizione.
Questo Quaderno non ovviamente esaustivo dell'immensa materia, relativa ai Fedeli d'Amore.Attraverso gli esempi forniti, si cercato di far emergere soprattutto il significatoanagogico dei loro scritti. Non si troveranno in questa sede quei brani che, pur riguardando iFedeli d'Amore, costituiscono parte organica di altri quaderni: ad es. quello del nostro Ekatlos,nel quale si dimostra che Dante era a conoscenza della falsit della cosiddetta "Donazione diCostantino" (vedi quaderno "Sul Papato"). Nella II ediz. stata aggiunta l'analisi della Canzone"Donne Ch' avete" e sono stati corretti alcuni refusi di stampa. Nella III ediz. stata ampliato ildialogo su "Maometto e Al all'Inferno".Il presente Quaderno perci suddiviso nelle seguenti sezioni:1) Ida La Regina:Introduzione2) )A cura di P.Negri: Due Saggi Anteriori a Ur di Arturo Reghini2a) Arturo Reghini: L'allegoria esoterica in Dante2b) Arturo Reghini: Il Veltro3) Ercole Quadrelli: I Fedeli d'Amore4)A cura di P.Negri: Luigi Valli e Il Gruppo di Ur4a) Luigi Valli:Testimonianze di Studiosi delle Tradizioni5) AAVV:Per una Determinazione del Significato Anagogico5a) J. Evola: Sulle Esperienze Iniziatiche dei Fedeli d'Amore
6) A cura di Fabritalp ed Ea: Dante e Pitagora di Vinassa de Regny6a) Fr. Petrus: Ciclo Vitale dell'Uomo secondo Dante7) Sipex: Quadro Generale della Commedia8) Afrodite U. e Fr. Petrus: Datazione del Viaggio Dantesco9) AAVV: Maometto ed Al all'Inferno10) Fr. Petrus: Nicol de Rossi e Guido Cavalcanti10a) Sipex: La canzone dantesca Donne ch'avete11) Fr. Petrus: Il Filostrato di Boccaccio12) Fr. Petrus ed Altri: Il Filocolo di Boccaccio12a) Appendice: Sogni Inventati e Sogni Reali13) Venvs G. e Fr. Petrus: Fedeli d'Amore e Via del Sacro Amore.
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
3/111
1) INTRODUZIONE
di Ida La Regina
Col termine Fedeli d'Amore vengono generalmente intesi gli aderenti ad una confraternitainiziatica, presente nel XIII secolo in Italia, Francia (particolarmente in Provenza) e Belgio.Essi veneravano la Donna (o Dama) Unica, una figura simbolica simile alla gnostica PistisSophia, di cui la Beatrice dantesca l'esempio probabilmente pi noto. Simbolicamente affinealla Vergine Maria Nera e isiaca, che adorna tante cattedrali europee (come la Madonna Neradi Loreto o quella di Czestochowa), descritta da Guido Cavalcanti, come "una giovane donnadi Tolosa", citt che non pu non far pensare a connessioni con Catari e Albigesi.
Da: "Rime" di Guido CavalcantiXXIX - Una giovane donna di Tolosa
(sonetto)
Una giovane donna di Tolosa, bell'e gentil, d'onesta leggiadria, tant'e dritta e simigliante cosa,
ne' suoi dolci occhi, della donna mia,
che fatt' ha dentro al cor disiderosa
l'anima, in guisa che da lui si svia e vanne a lei; ma tant'e paurosa, che non le dice di qual donna sia.
Quella la mira nel su' dolce sguardo,
ne lo qual face rallegrare Amore perch v' dentro la sua donna dritta;
po' torna, piena di sospir', nel core, ferita a morte d'un tagliente dardo che questa donna nel partir li gitta.
Un altro dei Fedeli d'Amore, Francesco da Barberino (che ebbe, come maestro, lo stesso diDante, cio Brunetto Latini), nell'opera "Del Reggimento e de' Costumi delle Donne", ladescrive invece con questi versi:
Ella colei, ch' compagno il figliuoloDel Sommo Iddio, e sua Madre con esso:Ell' colei, che con molte siede in cielo,Ell' colei, che in terra ha pochi seco.
Il valore iniziatico del simbolo della Donna confermato dal fatto che Beatrice, nella Divina
Commedia, ha la funzione di condurre Dante in Paradiso, da vivo e non da morto.
I Fedeli d'Amore si esprimevano in un linguaggio segreto, il "parlar cruz", atto a non farsicomprendere dagli altri, la "gente grosa". Una parte del loro stesso nome, "Amor", cela
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
4/111
probabilmente il termine composto "A-mor(s)" (= senza morte), a significare che la loro praticainiziatica aiuta a non morire spiritualmente. Lo stesso Dante del resto afferma esplicitamenteche il significato vero delle proprie parole nascosto, ora molto, ora poco. Ad es., in Purgatorio,VIII, 19-21 dice:
aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero,che 'l velo ora ben tanto sottile,
certo che 'l trapassar dentro leggiero
Non a caso, in un sonetto toscano del quattrocento, attribuito al Boccaccio (ad es da FrancescoDe Sanctis nella Storia della Letteratura Italiana), Dante paragonato ad una "Minervaoscura", delle cui opere necessaria "temporale e spiritual lettura".
Dante Alighieri son, Minerva oscurad'intelligenza e d'arte, nel cui ingegnol'eleganza materna aggiunse al segno,
che si tien gran miracol di natura.
L'alta mia fantasia pronta e sicurapass il tartareo e poi il celeste regno,e il nobil mio volume feci degnodi temporale e spirital lettura.
Fiorenza gloriosa ebbi per madre,anzi matrigna a me pietoso figlio,colpa di lingue scellerate e ladre.
Ravenna fummi albergo del mio esiglio;ed ella ha il corpo, e l'alma il sommo Padre,
presso cui invidia non vince consiglio.
2) A cura di P. Negri
DUE SAGGI ANTERIORI A UR DI ARTURO REGHINI
Prima del saggio "Il Linguaggio Segreto dei Fedeli d'Amore", pubblicato su Ur come PietroNegri, Arturo Reghini aveva scritto altri saggi sull'argomento. Il primo dei due che proponiamovenne pubblicato nella rivista Nuovo Patto del Settembre-Novembre 1921. A differenza dellamonografia di Ur, non mai nominato Luigi Valli. Questi, pur essendosi segnalato gi nel 1906per una "Lectura Dantis" dedicata al canto XIX del Paradiso, inizi a essere veramente noto
solo dopo che, nel 1922, cominciarono ad apparire le prime opere di pi ampio respiro quali: "IlSegreto della Croce e dell'Aquila nella Divina Commedia" e "Il Simbolo Centrale della DivinaCommedia: La Croce e L'Aquila". Seguirono, nel 1925, "La Chiave della Divina Comedia" e, nel1928, "Il Linguaggio Segreto di Dante e dei Fedeli d'Amore".
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
5/111
2a)ARTURO REGHINI
L'ALLEGORIA ESOTERICA IN DANTE
Sotto il senso letterario della Commedia, ossia sotto la peregrinazione di Dante attraverso i treregni delI'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, si nasconde senza alcun dubbio una allegoria.Non c' bisogno delle esplicite dichiarazioni di Dante in proposito per esserne certi. Questaallegoria non semplice, ma molteplice e dai commentatori ne vengono di solito riconosciutidue aspetti, quello morale e quello politico. L'interpretazione morale, o filosofico-morale, vedeallegoricamente raffigurata nella Commedia la via che l'uomo deve percorrere per superare ilpeccato e raggiungere la virt in modo da sfuggire all' inferno ed al purgatorio e da guadagnarecolla perfezione morale il paradiso.Questa allegoria, come del resto il senso letterale del poema sacro, ha innegabilmente unaspetto nettamente cristiano pure abbondando di elementi pagani; e sulla scorta di Aristotile, di
S. Tommaso e della scolastica stato profondamente penetrato dai commentatori.L'allegoria pollticaha per base la lotta tra l'impero ed il papato, e vi figura largamente anche lapersecuzione dei templari da parte di Fillppo il Bello e di Clemente V. Naturalmente vi sono deipassi suscettibill della sola interpretazione morale, altri rivestiti del solo simbollsmo politico, edaltri ancora che comportano una doppia interpretazione morale e polltica.L'allegoria politica quasi sempre trasparentissima e molte volte Dante fa addirittura a meno diogni velo e fa manifesta tutta la sua visione lasciando pur grattar dove la rogna. L'allegoriamorale ha una apparenza talmente cristiana da autorizzare tutti i cristiani e tutti i frettolosi nelconcludere ad attribuire a Dante una ortodossia cattollca, mentre l'allegoria politica ci rivela contutta sicurezza un Dante partigiano dell'impero e nemico acerrimo della Chiesa, difensore a visoaperto di quell'ordine dei Templari condannato e ferocemente perseguitato per eresia dallaChiesa, un Dante che esalta Cesare, l'Impero romano, la civilt classica, e che elegge a propriaguida, maestro e signore Virgilio pitagorico ed imperialista.I motivi che hanno indotto Dante a servirsi dell'allegoria non sono dunque di natura politica,inerenti alla sua posizione nella lotta tra guelfi e ghibelllni, perch in tal caso sarebbe naturale ditrovare pi fitto il velo nei passi che trattano di politica, mentre invece il velo si fa pi spesso neipassi che trattano argomenti di morale, di filosofia, di religione, di metafisica; e talora per quantoi commentatori aguzzino gli occhi non riescono a chiarire il senso, oppure ognuno di essi finiscecoll'intendere diverso dagli altri.Quale dunque la ragione che ha spinto Dante all'uso dell'allegoria, anche a costo di non farsifacilmente capire?
Fantasia di poeta? Passione per l'enimmistica? No certo, perch noi sappiamo che una dottrinasi asconde sotto il velame delli versi strani. E se l'apparenza cristiana non potrebbe la sceltadifferire dall'apparenza? Non potrebbe la dottrina cos gelosamente nascosta essereeterodossa, molto eterodossa? Sicch Dante puzzerebbe forte di eresia e sarebbe un nemicodella Chiesa anche sul terreno religioso oltre che su quello polltico?Le professioni di fede cristiana che egli fa ripetutamente non bastano ad eliminare il dubbio. Seegli infatti era eretico o pagano e non voleva finire arrosto, era forzato a professarsi cristiano. Especialmente volendo levarsi il gusto di esaltare Virgillo, Cesare, Roma che il buon mondo feo, illatin sangue gentile, e gli imperatori che avevano aspetto gentile ossia pagano, occorreva inqualche modo tranquillizzare i sospetti facendo anche l'apologia del cristianesimo. Bisognaricordare che in quei tempi la carit cristiana poteva sbizzarrirsi a suo piacimento; i numerosi
seguaci di quel S.Domenico che negli sterpi eretici percosse animato dal santissimo zelo disalvare le anime (nonch la Chiesa pericolante) andavano per le spiccie e Dante stesso avevaumani corpi gi veduti accesi. A che pr fare la fine che poi tocc a Cecco d'Ascoli, quando erapossibile dedicare la vita, e l'enorme ingegno e sapienza ad un grandioso disegno polltico ereligioso? Nonostante le sue professioni di fede cattolica, Dante aveva amici che andavan
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
6/111
cercando come Dio non fosse, ed eretici dello stampo di Sigieri egli ficca tranquillamente inparadiso, mentre popola di papi l'inferno. Dante stesso fu accusato di eresia secondo risulta daantichi documenti, e secondo narrano i suoi primi commentatori. L'eresia pagana di Dante fusostenuta dal Foscolo, e poi dal Rossetticon enorme copia di argomenti, ed infine dal pretecattolico Aroux. Un gesuita che volle fare la critica delle opere del Rossetti si ebbe da questitale esauriente replica che pi non fiat.Non si pone mente che anche nell'apparenza Dante non segue sempre pedissequamente SanTommaso; ne differisce apertamente in questioni importantissime; p.e., nella dottrinaescatologica (Purg. XXV 88-102) per adottare una teoria delle ombre dei defunti che inperfetto accordo colla concezione pagana. Egli fin da principio si inspira a Virgilio, da cui soloprende lo bello stile che gli ha fatto onore. Il suo poema non che una commedia; e comunquesi intende la parola, nel senso moderno od in quello dionisiaco, si sempre condotti lontanodall'apparente senso cristiano. Nelle grandi llnee la Commedia uno sviluppo del VI cantodell'Eneide, e Dante ripete quanto Virgilio fa fare ad Enea. Enea scende vivente nell'Ade,rinviene nella selva il ramoscello di mirto degli iniziati, ed apprende de visu la verit dei misteriorfico-pitagorici sopra l'uomo e la immortallt condizionata. Ed anche Dante corruttibile ancora,ricalca la medesima strada collo stesso scopo e facendo uso del medesimo simbollsmo. Scopofondamentale, come oramai noto e provato, dei misteri orfici, pitagorici, eleusini, isiaci, era
quello di conferire all'iniziato la conoscenza vera dei principii della vita (Cicerone -De Lege II,14), la beatitudine, l'immortallt privilegiata. Ci si otteneva mediante la iniziazione che constavadi prellminari pratiche catartiche, di cerimonie simboliche e di vere e proprie estasi come ciaffermano Plutarco, Apuleio, ed altri antichi scrittori e come oramai si viene riconoscendo daimoderni (Vedi p.e. Macchioro-Zagreus). Per tal modo l'uomo veniva rigenerato e dopo la mortelo attendevano i campi Elisii.Il soggetto della Commedia l'uomo, o meglio la rigenerazione dell'uomo, la sua metamorfosiin angelica farfalla, la Psiche di Apuleio. dunque il medesimo soggetto dei misteri.Non le sole qualit morali cambiano; Dante si purifica di grado in grado, passa per crisi ecoscienze varie e numerose, cade come corpo morto, sviene, rinviene, si addormenta, siravviva nell 'Euno, la sua mente esce di s stessa, si illuia, si india, si interna, s'infutura,
s'insempra, passa al divino dall'umano, all'eterno dal tempo; e finalmente dislega l'anima sua daogni nube di mortalit. Questo non un perfezionamento morale, una vera pallngenesi di tuttol'essere che si attua nel simbolico viaggio. Il velame asconde non soltanto delle disquisizionimorali sopra i peccati e le virt, ma l'esposizione di mutamenti interiori nella coscienza delpellegrino.I due fiumi del paradiso terrestre sono un evidente imprestito ai misteri orfico-pitagorici.Scoperte archeologiche recenti han fatto rinvenire le cos dette laminette auree di Turii, chevenivano sepolte insieme al defunto orfico, cui dovevano servire di viatico, quando arrivavanell'Ade. Quivi egli incontrava due fonti, quella del Lete e quella di Mnemosine, ossia quelladell'oblio e quella della memoria. Bevendo all'acqua del Lete, il defunto perdeva ogni memoria,e finiva, miserabile larva incosciente nel fango. Bevendo alla fresca sorgente di Mnemosine si
salvava, ed andava tra gli immortali, nei campi elisii. La formula contenuta nella laminetta orficaaffermava: Son figlio della terra e del cielo stellato. Fammi dissetare alla fresca sorgente diMnemosine, perch io possa essere nume divino e non pi mortale. Questo il senso dellaformula invocatoria orfica; e questa concezione orfico-pitagorica analoga alla concezioneescatologica dei misteri eleusini, ed svolta nella teoria platonica delle anime e dellaconoscenza. Dante, a meglio affermare il carattere pagano delle catarsi del purgatorio, da cuiesce puro e disposto a sallre alle stele, introduce alla fine della cantica non solo il Lete, ma ilmeno familiare Euno (Purg. XXVIII, 131; XXXIII, 127-145), come egli lo chiama, che latramortita sua virt ravviva, ossia che d a chi morto la resurrezione, la seconda nascita.Dante vorrebbe pur cantare in parte lo dolce ben che mai non l'avria sazio; ma si d lacombinazione che ei non ha pi lungo spazio, sono piene tutte le carte ordite a questa canticaseconda; e sopra tutto non lo lascia pi ir lo fren dell'arte. Adelante, Pedro, con juicio. Siamo inpieno mistero pagano.E chi consideri quale sia stata la guida di Dante capisce che doveva condurlo proprio l. Dantesmarrito nella selva selvaggia ed aspra e forte dei pregiudizi e dell'ignoranza cristiana, incontra
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
7/111
fmalmente in Virgilio, la personificazione della sapienza esoterica, questa voce che per lungosilenzio (dieci secoli di era volgare) pareva fioca; e Virgilio si presenta immediatamente nellasua qualit di iniziato, che ha trasceso la natura umana:Non uomo, uomo gi fui; ed per questo che Dante lo prende per duca, maestro e signoreche lo inizii e lo renda immortale.Ora la concezione pagana non accordava alle anime umane una vera e propria sopravvivenza;conducevano nell'Ade una vita immemore di larve incoscienti; e solo gli iniziati, gli eroi e queiche Giove rapiva al sommo concistoro erano immortali. Ed il Cristianesimo ebbe il sopravventosopra i misteri, perch mise democraticamente la salvezza e l'immortalit la porte de tout lemonde.Bast andare a farsi battezzare e credere che Ges era risuscitato per essere salvato. Una veracuccagna per tutti i poveri di spirito, e per tutti i delinquenti cui i misteri chiudevano la porta.Arnobio p.e. spiattella pari pari di essersi fatto cristiano perch il cristianesimo a differenza deimisteri garantiva a tutti l'immortalit.Dante, che prende a guida Virgilio, e che tratta paganamente tutta la questione dellapallngenesi, pensava dunque anche egli che non tutti gli uomini potevano eternarsi? che lecredenze cristiane non erano sufficienti allo scopo? che le pecore matte ed i superbi cristianinon avevano diritto di cittadinanza nella citt eterna, e dovevano finire tra la perduta gente?
Parrebbe di s, posto che non dai preti ma da Brunetto Latini egli apprese "come l'uom sieterna". Esaminando l'opera di Dante senza preconcetti e partiti presi, si arriva a riconoscerenella rinascita spirituale mediante la metamorfosi operata dall'iniziazione il soggettofondamentale della Commedia, la dottrina nascosta sotto il velame delli versi strani.L'allegoria dantesca ha dunque un importantissimo aspetto mistico, metafisico, veramenteesoterico. Aspetto che ancora non stato riconosciuto. Esso sfugge anche al Rossetti ed all'Aroux, i quali pure riconducendosi per l'interpretazione dell'allegoria ai misteri classici, siriferiscono sempre alla parte cerimoniale di essi. Ed naturale che sia cos, perch perpotere accorgersi ed intendere le allusioni ed i riferimenti convenzionali od allegorici occorreconoscere l'oggetto dell'allusione o dell'allegoria; ed in questo caso occorre conoscere leesperienze mistiche per le quali passa il mistero e l'epopta della vera iniziazione.
Per chi ha una qualche esperienza del genere non vi ha dubbio sopra l'esistenza nellaCommedia e nell'Eneide di una allegoria metafisico-esoterica, che vela ed espone le successivefasi per cui passa la coscienza dell'iniziando per divenire immortale. Il simbollsmo di cui pifrequentemente si serve Dante quello della navigazione, della peregrinazione. Egli unpellegrino per la diserta piaggia, per lo stretto passo, per l'aspro diserto, prende un'acqua chemai non vi corse, un navigante pel mar dell'essere. Specialmente il simbollsmo del mare, dellanave, della vela sempre adoperato per trattare dei fatti interiori. questo velame che egli alza per correr migliore acqua; e come egli stesso dice sotto questovelame che si asconde la dottrina. un simbollsmo arcaico, mediterraneo, pagano, gi usato da Virgilio e da Ovidio. Esso usatoanche dai cristiani che di navi e navate parlano nei loro templi riferendosi alla navicella di S.
Pietro. Ma questa navicella frutto di una delle tante appropriazioni compiute dai seguaci delprofeta asiatico; non altro che la navicella di Giano; di un dio cio prettamente romano, sposodi Venilla, la dea del mare e delle sorgenti, ed inventore della costruzione dei navigli. Si vedeche cosa diventa l'impresa di Ulisse nella Commedia. Ulisse, il navigatore per eccellenza, ha untale ardore a divenir del mondo esperto, e delli vizi umani e del valore che non vinto dalledolcezze del figlio, dalla piet dl vecchio padre, e dal debito amore di Penelope; e perci simette per l'alto mare aperto; e dopo averne navigato tanto da divenire vecchio e tardo vienefinalmente a quella foce stretta, ov'Ercole segn li suoi riguardi acciocch l'uom pi oltre non simetta. Ma Ullsse ed i suoi compagni non tornano indietro per questo; anzi ricordano che nonsono stati fatti a viver come bruti ma per seguire virtute e conoscenza; e quindi si avventuranocon folle volo nell'alto passo per ottenere l'esperienza del mondo senza gente, di retro al sol;cio di quella condizione in cui la coscienza vive di vita tutta interiore, al di l e fuori di ognicelebrazione dovuta ai sensi umani, ed in cui non c' n gente n sole.Ma questa un'acqua assai perigliosa e non tutti possono trarsi a riva e volgersi a guardare lopasso che non lasci giammai persona viva, e che pu superare solo chi muore di morte
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
8/111
mistica. un varco folle (Parad. XXVII), un'impresa assai ardua, non pileggio da piccola barca(Parad. XXIII), e c' da rimanere travolti e sommersi dal mare dell'essere che si richiude sopra iltemerario. Questo dice Dante, dopo avere premesso: (Inf. XXVI, 21) pi l'ingegno affreno ch'ionon soglio.Ma Dante non va come Ulisse alla ventura; egli guidato da Virgilio, pi savio che ei nonintenda, e per ascoso cammino giunge a riveder le stelle. Per correr migliore acqua alza la velala navicella del suo ingegno; e dopo le varie pratiche e cerimonie che subisce nel purgatorio, sipurga ritualmente e ravvivatosi nel fonte di Euno, ne esce rinnovellato di novella fronda, puro edisposto a salire alle stelle (Purg. XXXIII). Dopodich opportuno invocare il buon Apolloall'ultimo lavoro (Parad.I). All'aspetto di Beatrice ci "si fa tale dentro", qual si f Glauco nelgustar dell'erba che il f consorte in mar degli altri dei (Parad. I, 69-70), ossia si sente morire edivenire immortale come Glauco, quel Glauco che dice di s: Ante tamen mortalis eram, sedscilicet altis deditus aequoribus (Ovid. Met.) Dante non sa proprio dire altro e si scusa dicendoche: Trasumanar significar per verba Non si poria; per l'esempio basti a cui esperienza graziaserba (Parad. I, 70-72). Per verba non si pu, ma per erba s.Egli non ha pi l'illusione del mondo materiale, ha un altro senso della realt: tu non se' interra, s come tu credi ma tu siedi al tuo proprio sito; giacch come dice nel Conv. IV, 28: lanobile anima ritorna a Dio, siccome a quello posto, ond'ella si parti a quando venne a entrare
nel mare di questa vita.Cosa accade delle anime non nobili non detto.Ed ora che si sente del mortal mondo remoto (Par. II) si sente a sua volta in grado di far daguida non agli altri che sono in piccioletta barca, ma a quei pochi che drizzano il collo per tempoal pan degli angeli, l'ambrosia che rende immortali come l'erbetta di Glauco. vero che l'acquache ei prende giammai non si corse; ma egli ci ha tutta la sapienza pagana che lo assiste:"Minerva spira, e conducemi Apollo e nove muse mi dimostran l'Orse" e Dante incoraggia questipochi navigatori a mettere tranquillamente per l'alto sale il loro naviglio, servando s'intende ilsuo solco dinanzi all'acqua che ritorna eguale; e promette loro meraviglie da stare a pari diquelle che videro quei gloriosi argonauti che seguirono quell'altro navigatore ardito checonquist il vello d'oro (Parad. II, 1-18). Ed infatti, giunto alla fine della navigazione, e giunto
l'aspetto suo col valore infinito (Parad. XXXIII), arriva a vedere che nel suo profondo siinterna, legato con amore in un volume ci che per l'universo si squaderna. Crede diavere visto la forma universal di questo nodo, e ne resta ammirato quanto rimase ammiratoNettuno, quando vide l'ombra d'Argo ossia la nave Argo, la prima nave che solc i mari. I pochiche han servato suo solco sino alla fine vedono dunque che Dante mantiene la promessa fattaloro nel canto 11.Cos si spiega questo passo che uno dei pi oscuri di tutto il poema. Ma, intendiamoci, unavera spiegazione si pu dare solo a quelli che passano per consimili esperienze; giacch questo un mistero che intender non lo pu chi non lo prova; ed io non posso che ripetere le paroledi Apuleio dopo l'iniziazione: "Ecce tibi rettuli, quae, quamvis audita, ignores tamen necesseest" (Apuleio - Metam. XI, 23).
***
Un'altro saggio di Arturo Reghini su Dante, pubblicato prima di quello apparso in Ur, "IlVeltro", comparso nel giornale Impero del 24 aprile 1923. Si possono notare diversi accenni aquell'Imperialismo Pagano, che Reghini, aveva teorizzato gi nel 1914 ("Imperialismo Pagano"in Salamandra del Gennaio-Febbraio 1914) e che, per un certo periodo, sogn potesse esereattuato dal fascismo. Ne 1928, Evola ne forn una sua variante in un opera dall'identico titolo(Imperialismo pagano, Atanor, Todi-Roma) che fu la causa principale del deplorevole dissidiotra i due personaggi. Dissidio storicamente inutile, visto il Concordato tra Stato e Chiesa del1929, che faceva diventare utopica la realizzazione a breve di quell'idea, per maiabbandonata da Reghini. Il presente saggio anche utile per riflettere sul concetto tradizionaledi "vaticinio", che non mai stato concepito come previsione di un evento ineluttabile (chetoglierebbe agli uomini la bench minima libert), ma come percezione di una favorevole"tendenza" verso certi eventi, che sta pur sempre agli uomini attuare o contrastare.
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
9/111
2b) ARTURO REGHINI
Il VELTRO
I classici dell'Imperialismo, filosofi, politici, profeti insieme, sono quattro: Virgilio, Dante,Machiavelli, Mazzini; italiani tutti. Coloro che con maggiore coscienza hanno tradotto in attol'Idea son due: Cesare e Napoleone, Italiani pur essi. Virgilio, il cantore delle origini, il foggiatoredi versi perfetti, credette vedere intorno a s i segni precursori dell'ultima et predetta dai Librisibillini, e vaticin la discesa dal cielo di un fanciullo che avrebbe dovuto instaurare l'Etdell'Oro.Sembr avverarsi la profezia colla nascita di Ges, ed il Poeta pagano parve dare la mano alprofeta ebraico, "teste Davide cum Sybilla".Diciamo parve, in quanto che, se a Ges si volesse applicare il vaticinio virgiliano, bisognerebbe
ammettere che non si ancora tutto attuato, perch ben vero che Ges nato (ed anchemorto), ma l'Et dell'Oro ancor da venire. vero che non bisogna aver furia!Ma ogni dubbio ci sembra scompaia quando si ricordi che Virgilio era un Pitagorico, e chel'avverarsi di tale profezia, ad un Pitagorico, in quel momento, doveva apparire sicura edimminente. Infatti la Filosofia pitagorica, che tutto riduce e somma nella Monade universale,porta direttamente alla concezione monarchica; all'unit della Monade corrisponde l'unit delpotere, la monarchia; ed il Fondatore della Scuola Italica attu, come pot, nel suo Sodalizio diCrotone, il concetto sociale unitario. Or quando Virgilio scriveva, l'unit politica era stata attuatasulla maggior parte del mondo conosciuto da quell'immenso Genio di Cesare, che seppecorrere l'alea, ed a tempo debito, marciare su Roma. La concezione pitagorica, l'antica profeziadella Sibilla e la pienezza dei tempi dicevano naturale e quindi fatale che a coronare l'opera
scendesse di cielo in terra una divina progenie. Questo il Veltro virgiliano.Dante, per cui Virgilio duca, maestro e signore, ha tutta l'aria di essere similmente inspiratoquando, a pi riprese, profetizza ed invoca la venuta del Veltro, a fare morire di doglia la lupa,ed in attesa a fare penare assai i commentatori.La concezione politica imperialista ha nell'uno e nell'altro altissimo poeta la stessa impostazionepitagorica. Intorno a questa Idea centrale ruotano secoli e secoli di storia italiana ed europea.Il Veltro dantesco non in modo speciale Arrigo Imperatore, n alcun altro personaggiodeterminato; il Veltro l'uomo divinoche, data la costituzione del mondo, deve fatalmentemanifestarsipresto o tardi. Dante con ardente affetto il sole aspetta, fiso aspettando pur chel'alba nasca; il suo cuore palpita affrettandone, invocandone la venuta, ma la sua mente sa che
cosi scritto. La sua fede nell'avvento fatale di un vero Imperatore poggia sulla prodigiosa suaconoscenza metafisica, sociale, scientifica. Come Virgilio, egli un Vate nel senso classicodella parola.A questa coscienza del divenire politico si accoppia la piena, sicura coscienza del dirittonaturale del Popolo Romano a tenere l'Impero.Virgilio afferma che spetta al Popolo Romano il "regere imperio populos"; Dante lo ripete;Mazzini lo ripeter poi con l'uno e con l'altro. La Romanit era ancora cosi viva nel mondo cheanche se fosse stato un tedesco, come Alberto, l'Imperatore sarebbe stato sempre romano. MaDante vuole che in Roma tenga la sede dell'Impero e da Roma tragga il prestigio; perch Roma,e solo Roma, possiede, quasi per magia, carattere universale ed eterno. E questapredestinazione naturale all'Impero, questa virt del Popolo Romano, potentemente sentita da
Mazzini, esule e povero, alimentava la sua tenacia e fede nei destini della terza Italia, quando ilsacro romano imperio pareva acquisito per sempre a casa d'Asburgo.Le virt romane, quelle autoctone, presentano i requisiti necessari per un ufficio d'imperio.Prima la fortezza, la virt del guerriero, la salda tempra del popolo che non piega ai rovesci,oggi ed allora come a Canne; poi la virt della misura, dell'equilibrio; la prudentia politica di
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
10/111
governo, la giustizia, virt sociale del cittadino, la temperanza, la virt dell'uomo nella condottaprivata. Virt congenite, sane, indipendenti dalle credenze e da sanzioni extra-sociali. VIrt ditutti e per tutti, e non dei pochi come la fede, la speranza e la carit, virt dei santi e per santi,intese a scopi ultra-umani se non inumani. Queste le basi del diritto naturale del PopoloRomano; queste le virt che necessita avere. L'Imperatore, quello auspicato da Dante, il Veltro,non ciber terra n peltro, ma Sapienza, Amore e Virtute. Le virt umane e nemmeno quelleordinarie dei santi non bastano. Occorre la diretta inspirazione divina, bisogna che, come ildivo Giulio, si immedesimi con Giove, con quell'lmperador che lass regna. La supremapotest terrena deve sentire la sua unit colla Monade. Egli deve imperare per volere divino eper diritto divino. Sissignori, per diritto divino, o inconsolabili cortigiani del popolo sovrano! "Voxpopuli non est vox Dei". Che la potest imperiale, del resto, debba derivare e derivi direttamenteda Dio non soltanto un corollario di Filosofia pitagorica; lo afferma anche la religionedominante per bocca dell'apostolo Paolo: "Omnis potestas a deo est". E senza dubbio questopensiero inspir Napoleone quando, nel giorno della incoronazione a Re d'Italia, tolti di mezzogli intermediari, si pose in capo da s la corona. E ben fece perch se, come il Manzoni afferma,Iddio stamp in lui pi vasta orma del suo spirito creatore, da Dio stesso fu suscitato epredestinato. Il Veltro quindi perfettamente al suo posto al sommo della gerarchia.Quando la gerarchia non sussiste, l'assetto sociale precipita. Quando l'Imperatore indulge a
sentimenti personali o pretende volgere l'Impero a beneficio di popolo non predestinato, il Fato,cui sottostanno gli Dei, si abbatte su di lui e sull'opera sua. Carlo V esce di senno, unaincredibile testardaggine determina Waterloo, sulla Marna e sul Piave si noveran miracoli.Oggi l'Italia sta risanando. Affiorano le antiche virt. Il suolo sacro della Patria esprime lesuperbe legioni che Augusto amava; e le masse van ripulendosi del morbo asiatico. "Romalocuta est"; ed i popoli gi tendon l'orecchio alle parole di rinsavimento, gi figgon lo sguardo aisegni precursori della nuova aurora. Ed in verit, il popolo sapr vivere austeramente,virtuosamente, se il Duce avr la fede e la reverenza romana per gli Iddii della Patria; sia lecitoa noi, nel giorno natale di Roma, leggere i segni secondo il costume dei Padri e dichiarare faustii presagi.
3) ERCOLE QUADRELLI
I "FEDELI D'AMORE"
Quel che segue un saggio di Ercole Quadrelli sui Fedeli d'Amore, estratto da "Il progressoreligioso" n2, Rivista bimestrale del movimento contemporaneo, Citt di Castello, 1929. E' unsaggio molto importante per svariati motivi:- E' del 1929 e perci contemporaneo alla rivista Krur. Segue di un anno il saggio di Pietro Negri"Il Linguaggio Segreto dei Fedeli d'Amore", uscito nella seconda annata di Ur e a cui Quadrellifa un brevissimo riferimento finale.- Mostra il vero stile letterario di Quadrelli (che usa ad es. abitualmente l'accento, all'inizio diparola, al posto della lettera h) e conferma perci che gli scritti firmati Abraxa erano sinsegnamenti dati oralmente da Quadrelli, sulla base del Corpus Philosophorum Totius Magiae(*) di Kremmerz, ma trascritti da Evola col suo stile.
- Ridimensiona infine certe pretese di Guenon nel campo degli studi danteschi e soprattuttoalcune critiche guenoniane a L.Valli.
(*) Quello autentico e non quello spesso storpiato gi nel titolo (da taluni trasformato in CorpusPhilosophicum Totius Magiae).
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
11/111
L'ineffabile Essere primissimo - s difficilmente pensabile senza immediato rischio diblasfemamente confonderlo col Nulla - Lui, s pienissimo, con il Nulla vuotissimo - che cosa abaeterno e in eterno lo mosse, e move, a perennemente uscire dall'unit sua semplicissima, perdirompersi in molteplici densit innumerabili? Mistero, a cui non escogitabile nome alcunoadeguato; attivit ineffabile d'ineffabile Agente; necessit libera, nudit sovrabbondante,coerenza di scissione, immobilit di propulsione, slancio dell'uno verso il diverso, impeto dellaRealt ad anche parere ci che Ella gi . Amore? Mistero. Amore di esuberanza, caso mai:traboccamento di plenitudine, effusione di magnificenza: dono. Amori di bisogno - diinvocazione, di dedizione - dopo: dal diverso che riaspira a unit , dal piccolo che bramaampliamento, dal crepuscolare che scongiura pi luce: pi calore, pi forza, pi vita. E cosl'Ineffabile va, della Sostanza, perennemente facendo a s stesso un tramite di cui Egli stesso la sede e il viandante; della Energia, facendo a s stesso un palpito di cui Egli stesso il ritmoed il musico; della Luce, un ammanto di cui Egli stesso la contenuta contenenza,l'unimolteplice vibrazione, la visibile e l'invisibile fiamma, l'immateriale olio, l'occulto Accensore;della Vita, un innumeriforme prorompere di singole affermazioni e di voraci assorbenze, traverso
cui Egli stesso il divorato e il divorante, il sacrificatore e la vittima. Triangolo, che, nelsalomonico esagramma, scende, si immerge, s'involve: traverso alla nebulosit , alla fluenza,alla liquidit , al colloide, al solido, al compattissimo: all'indiscomponibile ione, sedici volte,dicono, pi denso del pl tino: e, dunque, sedici volte pi complicato, pi scomponibile, piinaccessibile, all'infinito: nell'infmito al di dentro: al di dentro di tutto ci che altro non , di Lui, senon esteriorit . Scende, Egli, e si involve: e, naturalmente, n si perde, n si depaupera o ltera, Egli che dovunque e comunque non mai fuori di s: in cui tutto morendo nasce enascendo muore e vivendo dilegua, in Lui che persiste in tutto quanto da Lui emerge od in Lui sisommerge. Non si perde, non s'altera: non c' essere che possa agire a depauperazione di s,se non fosse per incapacit o costrizione. E, come dalla nebulosa al sole - al pianeta, al fluido,alla selce, al metallo - si va Egli pi e pi immateriando, cos dal fango alla mucillagine
all'ameba, al vegetale all'animale all'uomo, si va Egli - triangolo, che, nel salomonicoesagramma, riascende - riliberando, rievolvendo, ridisimpacciando. Tra l'uomo e Lui, quantealtre forme di esseri? E attorno all'uomo, tra gli animali e tra gli alberi - nella terra, nell'acqua,nell'aria - proprio null'altro di vivo? Nulla, nei mari, di pi di fano che le meduse? Nulla,nell'aria, di pi sottile e pi vasto che non le nubi? E, gl'interminabili spazi dell'etere, disabitati?E non altrettante o pi, le sue forme, che quelle dei gas? E la enorme gamma delle vibrazioninote alla Scienza - ignote ai nostri sensi - proprio nessun essere che le percepisca? Quantiinterrogativi di cui non Shakespeare e non il suo Amleto avrebber sorriso; di cui non, permillenni, sorrisero o sorrideranno le umane stirpi. Prima ancora - e fosse pur questa unaconvenzionale priorit di non pi che natura - prima ancora di esprimersi in plasmi di materie -energie meccaniche, si sarebbe Egli espresso in forme di sostanze-potenze. E, curiose di
esperienze anche all'in gi, tante e tante di queste avrebbero anch'esse tentata la sfinge delladiscesa - questo, il peccato originale? di ciascuno di noi? di un'adamica anima universale? - ntroppo si chiesero se altrettanto agevole sarebbe stata poi la riascesa. Pitagorico-platonicisussurri, rintracciabili un po' in tutte le ampie civilt , e sui quali non ha voluto dirci Dante, checosa realmente ei pensasse, o avesse talvolta pensato, o talvolta fosse ancora tentato apensare (Par. IV, 49-63). Sussurri, non di disperazione: difficile la riascesa, ma non impossibile;esistente anzi, per questo, un'apposita tecnica, pazientemente studiata da collegi sacerdotali,traverso a secoli di dominio pacifico, nei penetrali di certi lor templi famosi. Ne abusaronoperfino; ci ch'era dato a redenzione dell'Umanit , ne fecero strumento di privilegio, adominazione di casta; n la punizione si far gran tempo aspettare.
***
Fu Cristo a voler esteso il privilegio, a tutti i semplici di cuore. Fu Paolo, che, cuori ancor pisemplici, volle andarne sopratutto a cercare dove la carnalit era massima. E, tutti
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
12/111
indistintamente, gli Apostoli e i primi Discepoli, non davano semplicemente parole diedificazione: imponevano anzi le mani, e trasmettevano lo Spirito: uno spirito non giimmateriale e impercettibile, ma fluidico, ma sentito, ma trasformante anche i fisici lineamenti,ma raddrizzante le organiche deformit , ma fenomenicamente avvertibile, spesso, anche a tuttii presenti: credenti che diventassero, miscredenti che rimanessero, o immaginantisi magaridiabolicit . Non sono pochi i testi in cui tutto ci chiarissimamente detto, e poco importa senessuno ci abbia ancora pensato: chiarissimamente detto, come si trattasse insomma e su pergi - per ben pi nobili motivi, su ben pi vasta scala intensiva, e con effetti ben pi duraturi dquella fenomenologia prodigiosa, a cui attende finalmente, con scientifici intenti, lametapsichica. Ma non senza motivo aveva ammonito il Maestro, Non vogliate buttarmargarite dinanzi ai porci. Nelle propagande a masse, tanto difficile diventava il passare alvaglio il buon grano, quanto facile lo era invece stato nelle lunghe discipline dei templi. Infatti,una prima ardua impresa degli epscopi, fu appunto il metter freno a cotesto anarchicovisionarismo dei troppo semplici, a coteste apocalittiche glossolale da pitonesse incontrollate. Ele trasmissioni dello Spirito furon nuovamente ristrette ad un clero, e, tra questo stesso, a dellelites direttive: le tante scuole gnostiche, contro cui se la sarebbe presa Plotino, n ci fece lorogran male; ma contro cui sempre pi se la prese la enorme massa dei - prima ammessi eadesso esclusi - cristiani medesimi, il che condusse al disastro. Il disastro - sin dove ci
concepibile e possibile sia - per lo Spirito Santo medesimo. Ch, messa ormai su una viad'inconfessabile diffidenza, drizzava pronte e minacciose orecchie la dirigente Chiesa ufficiale,ad ogni sussurrata eco di Pneuma, di Spirito, di Paracleto. E senza ufficial tempio nriconosciuto altare, rimase lo Spirito Santo per secoli e secoli; e quando per primo Abelardo,verso il 1123 - a futuro, imprevisto rifugio di luce per la sua Eloisa - os intitolare dal "Paraclte"un semidesertico oratorietto di pace vanamente inseguita, ebbe ancora a difendersi, controteologi, con argomenti teologici. E, in Abelardo, sfioramenti molti di eresie molteplici, ma - ascanso di possibili equivoci un po' pi innanzi - nessun sentore, fosse pur minimo, di tradizioniiniziatiche. Due secoli ancora dovr per aspettare la stessa ineffabile Trinit , a che una suaspeciale festa sia ufficialmente sancita (1333) da Giovanni XXII (1). Sbanditi intanto dalladirezione i trasmissori dello Spirito, non eran rimasti - per far Chiesa - che gli accanimenti
dialettici sulle dottrine, e il consolidamento delle gerarchie esteriori: due forze ancora enormi, inquanto attinte dalla Grecia la prima, e la seconda da Roma. Anche rimasero, a dir vero, i riti:quasi tutti i pi importanti riti. Ridotti a valori prevalentemente simbolici, ma spieganti, anchecosi, la vitalit della Chiesa cattolica, di fronte a quelle che, pur appellandosi a una pi astrattaspiritualit , nno sempre pi rinunziato a quelle ultime riconnessioni pratiche, con l'anticaChiesa Vivente. La quale, dicono, non per mai del tutto; e ne vanno ancora cercando il filo,traverso alla storia delle cristiane eresie. E se del tutto non per mai, bisogna pur riconoscereche, per secoli parecchi, dovette vivere piuttosto male: anche esotericamente. Contaminazionidi tradizioni le pi varie - caldaico-egizie, siro-fenicie, manicheo-mitriache, ellenico-celtiche,neoplatonico-gnostiche, ebraico-arabiche - fecero si che nessuna manifestazioneeretico-iniziatica risultasse riannodabile a un dato ceppo indiscusso. In quelle a diffusioni
momentaneamente trionfanti (Albigesi), il peso bruto delle masse avide risoffoc l'internafiamma spirituale. In altre, potentemente organizzate (i Templari), la conquista del mezzo - laricchezza - fece dimenticare la nobilt dello scopo. Bisogna giungere ai Lulliani, aiRosa-Croce,. alla linea degli hermetisti benedettini, alla fiorita mistico-platonica,pitagorico-cabalistica, alchimistico-terapeutica, in Italia e in Europa, per avere un qualcosa di cuianche le forme esteriori appaiano meritevoli di riconnessione alle antiche misteriosofie pi pure.
(1) Cfr. ABELARDO e ELOISA, Lettere; Roma, Formggini.1927; pagg. 46-50, e specialmentepag. 48.[n.d.u. : Prima Traduzione Italiana dal Testo Latino di Ercole Quadrelli. Prefazione di AntonioBruers]
***
E invece, secondo un genialissimo fra i nostri studiosi (2), ecco una insospettata reviviscenza di
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
13/111
esse, anche nella scuola dei Fedeli d'Amore. Insospettata sino ad un certo punto: dimenticatae negletta, piuttosto, dall'ultima generazione di letterati positivisti; qualcosa di quasi identico fuanzi gi sostenuto dall'obliato Gabriele Rossetti; qualcosa di molto prossimo, dal Foscolo e dalPascoli; e appunto a questi tre dedicato il libro che sar pietra miliare. Qualcosa divariamente non remoto fu detto, per i romanzi cavallereschi, dall'Aroux: per la Vita Nova, dalPerez; per il Cavalcanti, dal Salvadori: per l'Acerba dell' Ascolano, dal Crespi: un po' da tutti, perla Donna del Guinizelli, o per la Beatrice di Dante: assolutamente da tutti, per
l'amorosa madonna Intelligenza
di Dino Gompagni, indiscussa e indiscutibile donna non di carne e non d'ossa. E insospettataconvien dir la cosa sino a un certo punto soltanto, anche per l'esser stato ormai vasto ilconsenso dei critici: specialmente quello degli insieme poeti e filologi, i pi competenti, cio,nella fattispecie (3). Il dissenso, da tutti e soli gli ostili per motivi tutt'altro che critico-storici:sentimentalismi femminccei, quietovivere da cristallizzati, preoccupazioni pseudoortodossiche,gelosiucce di scuole e chiesuole. Miserevolissima manifestazione di un po' tutto questo, larecensione del Giornale storico della Letteratura Italiana (n 271-72). Per un tema d'una siffattaimportanza letterario-filologica e religioso-civile-politica, proprio di l doveva venire una
trattazione pi ampia, un'approvazione o un'opposizione pi documentata; una discriminazione,insomma, pi diligente. Invece, adunatosi, pare, un concilietto d'illustri redattori, fu affidato alBertoni l'incarico di lavarsene le mani. Il quale se la cavava infatti con una paginetta di ti vedo(cara) e non ti vedo; ma s, come no?, per, chiss , su bazzecolette culminantinell'insinuazione che ancidere significhi anche altre cose che uccidere. Le quali altre cose(asserite nell'Enciclopedia di quel benemerito Scartazzini che, l'italiano, non era insommaobbligato a saperlo pi che tanto) contraddirebbero addirittura a Dante, nel commento al sonettoVII della Vita Nova; ma se una il Bertoni ne avesse saputa di suo - e si fosse degnato di dircela -ecco ci sarebbe stato, nella sua eiaculazioncella, almeno un protozoo, meritevoledi...microscopio. Certo, non insospettata, la cosa, all'umile (ma non poi tanto) sottoscritto. Ilquale, un quindici anni fa, sospettando che nelle antiche nostre rime il futuro endecasillabo
fosse (e, nella poesia popolare, rimanesse) un variabilissimo verso doppio, or tetra-esatonico edor esa-tetratonico - variabile perci dalle 10 sillabe alle 14 - e normallizzato non gi da unametrica, ma da un pausato ritmo musicale entro cui fosse adagiabile - ne ricercai le prove in unpo' tutti i relativi codici pi antichi; e ve le trovai. Ma che notai strani ritorni di forme o formule daconvenzione segreta: da cos dicibile gergo massonico (1913), stranamente in anticipo. A fiancodei miei estratti ritmicometrici, notai persino, talvolta, qualche interrogativo in tal senso; macredetti la cosa una ristretta singolarit eccezionale, n sospettai possibile ritrovarne la chiave.Sapevo il gran concetto in cui eran stati tenuti - come savi quelli che i nostri professori ci avevanridotti a letterati; ma contro l'esautorazione non protestava neanche il mio cuore: ci che di lorointeressava anche me, era proprio il lor esser anche stati dei talvolta genialissimi perdigiorno; inarmoniose fanfaluche, talvolta anche elevate. - Il pi delle volte, per... - Ma, nella stragrande
maggioranza, ahim... - Come mai tanta gente s'era sobbarcata a tramandarci anche tante -cos a occhio e croce scempiaggini?E la chiave - o la principal chiave - doveva ecco invece ritrovarla il Valli: i pretesi perdigiornoerano, anche in rima, dei combattenti; e, anche le scempiaggini, erano invece documentistrategici. Salute ai sedentari poltroni, che n potuto non restarne commossi: alle femminette inbrache e barbe pi o meno tremu1e, che se ne son sentite montar le bizze negli eviratiprecordii; ma, da personcine posate, non nno osato portarle in pubblico; un universitario, chea Firenze - s, dico! - ai suoi (sperabilmente inobbedienti) pupilli, proibisce lettura e discussionidel libro; ma insomma, forse questo l'unico, disgustoso, mucillaginoso caso del genere;dell'universitario anzi dimenticato, e non voglio certo pi chiedere, il nome. O che d'altronde aFirenze ( gi pensato il Filologo) c' forze, neanche, Universit ?
(2) VALLI LUIGI, Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d'Amore; Roma, Biblioteca diFilosofia e Scienza, n 10, pagg. 454, in 4, 1928.(3) Senza far torto a nessuno - e s per informazioni che impressioni mie - mi sia lecito
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
14/111
menzionare, honoris causa, il Mazzoni, il Cesareo, il Panzini, l'Orvieto, il Bruers, e unamaggioranza grande fra i pi valenti dei giovani.
***
Ma che gran porta spalancata oramai, e che nessuno chiuder pi; grande porta oltre cuibalzare - sperabilmente, in folla - i futuri studiosi, sopratutto italiani, dietro a una letterariainiziativa finalmente italiana. Tutti quegli antichi canzonieri, da ripubblicare: scrupolosamenterispettandone anche i ritmi, e nelle redazioni pi antiche. Tutti quegli aggruppamenti da studiarsiex novo, non tanto come di rime, quanto come d'intenzioni (4).Tanti oscuri da metter in lucecome uomini di fede e di azione che per un'idea lottavano - e bene o male a rimares'industriavano poich questo era il convenuto mezzo di darsi notizie, ammonimenti,incoraggiamenti - e anche lavate di capo - senza rischiar troppo da presso la scomunica o ilrogo. E un'epoca eroica scopriranno, naturalmente, gli studiosi; poi un'epoca di rilassamento, diformulario, d'inflazione, di moda; e riprese, ridecadimenti, risurrezioni, scomparse: come in ogniumano movimento di anime. Tutte intese, le alte gerarchie ecclesiastiche, - alla salvaguardia deilor privilegi, delle loro agiatezze, dei loro ozi, s raramente studiosi. Tutto chiuso, il Monachismo,nell'isolamento suo splendido, e generalmente grasso, e spesso spesso scostumato: vecchio e
durevole bersaglio a tutta la novellistica neolatina, ed, episodicamente, anglosassone. Scarso einascoltato il basso clero, povero e ignaro quanto le sue pecorelle. E perfino esiliatosi adesso ilPapa, l in Avignone: n maggiormente curante dell'italico giardino in convulsione, di quantooccorra a che un pseudo-romano imperatore non vi si stabilisca. Dunque propriomorta-impietrita la Chiesa? Dunque ancora e ancora vacante,
nella presenza del Figliuol di Dio,
il saggio di Pietro? Ma poich invece immortale la Chiesa, dov' dunque mai tra gli uomini, laocculta Ecclesia vivente? E poich il Seggio non deve possibilmente vacare pi a lungo, chidunque vi insedier un successore legittimo? E chi, nell'Italia contro s stessa armata da citt
a citt , da quartiere a quartiere - da torre a torre, o da palagio a palagio - rimetter pace eunit ? - L'Aquila riporr sull'altare la Croce, si era gi detto il Valli che si fosse detto Dante (5);e questo, in sostanza, ridice egli qui che si fossero detto i pi illustri fra i Fedeli d'Amore.Romano Giure, per la cristiana Speranza. Quindi, serrata di alcuni spiriti eletti, intorno a quanti,di quel Giure, rivestissero almeno, ancora, una vistosa ed armata parvenza. Gruppo, perci, diufficialmente eretici, perch, il papato visibile, lo credevano ormai nulla pi che adulterio. Non sivede, anzi, donde la legittima imperiale autorit avrebbe tratto il legittimo insediabile, se non dalsenso della legittima Chiesa: quella stessa, cio, dei Fedeli d'Amore. Ne avrebbe fatto parte,per caso, qualche dignitario ecclesiastico? Ai tempi del Petrarca, certamente s: un cardinaleColonna; e si estendeva tale Chiesa, quanta ne abbracciarono i petrarcheschi viaggi, dallebighellone apparenze ai petrarchisti carissime. Non parrebbe, invece, ai tempi di Dante; n a
Dante poteva risultare (e infatti poi, a dir vero...) niuno pi adatto di s. Sicch la spiegazionelegittima del Cinquecento Dieci e Cinque = DXV , rischia proprio di esser quella che parevala pi abnorme: Dantes Xristi Vrtragus (Veltro), o, secondo altri, Vicarius. Spiegazioniormai antiche, e, in ogni modo, non del Valli, che si accortamente sempre trattenuto dallospingersi a coteste conseguenze particolari. D'altronde, nulla di eterodosso, stavolta, e neanchequasi di nuovo, per Dante. Se il suo Arrigo VII fosse davvero riuscito a coronarlo e mitrarlo interra, come sopra s - sopra al suo stato di laico - lo aveva fatto San Pietro in cielo, e se fraRoma e Avignone fosser poi corse scomuniche - e il definitivo trionfo storico fosse rimasto aRoma - un diverso capitolo esteriore, ecco tutto, avrebbe scritto quella ecclesiastica Historia chene conosce ben altri.
(4) Cfr. EGIDI FRANCESCO, in La Scuola Superiore, Anno 111, 3-4; pagg. 48-52, in fine. Esegnaliamolo doverosamente, questo filologo - uno - che non stato "al ver timido amico"; non avuto paura di compromettere la sua seriet .(5) L'allegoria di Dante, Secondo il Pascoli; Bologna Zanichelli, 1922 - Il segreto della Croce e
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
15/111
dell'Aquila; idem, idem, - La chiave della Divina Commedia; idem, 1926. - Note sul segretodantesco...; in Giorn. dant., I serie, XXVI, 4; II, XXVII, 1; III, XXXIII, 3; IV, XXIX, 4. - Per la Crocee l'Aquila; in Logos, 1924; e in qualche Lectura Dantis.
***
Ma eran tutti di questo parere, i Fedeli d'Amore? Os niun altro di quei laici, sinch laico rimase- e del solo Folchetto ricordo un'ecclesiastica assunzione, se pur non fu conversione - pensarealtrettanto per s? E come mai il Cavalcanti, iniziatore di Dante, abbandon a un certo puntola partita, e i due amicissimi divennero, in sostanza, nemici? E, quella parola iniziatore, quantaestensione aveva di significati concreti? quanto profondamento nella tradizione iniziatica? Uncui costante cardine in Occidente - dalla alchimia egizio-greca alla arabo-europea - si che tresiano le umane sostanze psichiche: la lunare-sensitiva, la mercuriale-razionale, lasolare-angelica. Obnubilata e traviata la seconda, dalla prima; avviluppata e generalmentedimenticata la terza, da entrambe le altre. E iniziazione era ammissione a pratiche di liberazionedella minore e della maggior prigionieria. Tritemiano scioglimento dell'uno in tre, aricomposizione del tre in un nuovo uno, dove il predominio sia ormai dell'angelico: del menoremoto della Deit stessa suprema. Se al di sotto si faccia entrare in cmputo il corpo fisico, e
se, al disopra, una universal Quintessenza; o se anzi si faccia dell'anima lunare e dellamercuriale un'unica psiche, chiaro risulter con quanto varie, e apparentemente contraddittorienumerazioni, abbian potuto gli Alchimisti complicare un mistero abbastanza semplice. Ma se,venendo a noi, mi faccio, di tutti cotesti Fedeli citati dal Valli, a ristudiare pazientemente illinguaggio, non trovo sicuri riflessi di ci, fuorch appunto nel Cavalcanti (p. 34 e 224).
Cosa m'avien, quand'i' le son presente,ch'i' no la posso a lo 'ntelletto dire:
Veder mi par da la sua labbia uscireuna s bella donna, che la mente
comprender no la pu: ch 'mmantenente
ne nasce un' altra di bellezza nova;da la qual, par ch' una stella si muova,e dica: La salute tua apparita .
Si cerchino pure - di questi versi strani quant'altri mai - interpretazioni le pi varie possibili; lapi immediatamente adesiva sar ormai questa sola: che dal corpo fisico si sprigiona l'animalunare, e da questa la mercuriale: da cui eromper ultima l'angelica stella cavalc ntea, moltoanaloga all' angelica farfalla di Dante. E moltissimi invero i riflessi di carattere iniziatico,rintracciabili anche nel sommo nostro Vate: specialmente nel suo Fiore (6), nella Vita Nova, nelConvivio e in qualcuna delle Epistolae, nonch magari delle Eclogae. Per nessuna sicuraallusione, mai, a qualcuno di quei caratteristici fenomeni concreti, inconfondibilmente saltanti
agli occhi, dove siano anche rarissimi e inattesi, come per esempio nel Don Chisciotte. O,meglio, uno di essi, s, anche in Dante: ma proprio nel Fiore, e poi mai pi: e riguardante unacosa subito nota ad ogni primo avviato ai tentativi della Grande Opera. Poi stranissimo, s,anche il fatto del non esserci quasi stucco nella pitagorica Basilica di Porta Maggiore (7), chenon sia commentabile con qualche verso della Divina Comedia; stupefacentissima lacoincidenza che quasi al centro di questa stia un dantesco ratto alla Ganimede come, nel belmezzo del central soffitto di quella, si dianzi, di quel ratto, riscoperto lo stucco. Ma insomma,qui e quasi ovunque, non altro che riflessi dottrinali: evidentemente attinti da buona fonte, manon mai intarsiati d'una qualche concretezza di personali esperienze; simbologie, molte; realtspecifiche, quasi mai nulla. Temperamento enormemente passionale, fin forse a sgomentarsiperfino lui, degli anche sconcertanti fenomeni, a cui dovette probabilissimamente dar luogo losprigionamento dell'anima lunare, e dei quali potrebb'esser riverbero la men castigata parte delFiore. Spirito orgogliosissimo, forse pi ancora s'impazient e irrit d'un troppo lungo durared'alternative incessanti; e riput pi savio il rinnegare la Beatrice sua prima, per la filosoficaDonna Gentile. E quando a Beatrice torn, se la era rifoggiata a suo modo: la aveva
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
16/111
ortodossissimamente teologizzata e cattolicizzata, facendo parte per s stesso anche in ci; efece indubbiamente cosa personalmente bellissima. Per? Per, ecco:
Guardaci ben! Ben sem, ben sem Beatrice.
Stranissimo verso, che mai pi gli si sarebbe neanche affacciato alla mente per quegli istantidivini, se qualche dubbio su quella reale identit , non fosse, talvolta, andata turbando anche lui.Odiosa, poi, quasi stupidamente, la paternale che subito ei si fa rifilare da Lei, se non gli fossepremuto di giustificarsi e riautenticarsi presso terzi, che non tutti gli vollero ancor credere,nonostante tutto. Sin dove gli credettero il Boccaccio e il Petrarca? Sui quali due, i non moltiaccenni del Valli sono quasi pi impressionanti che gran parte di tutto il resto; ma ben altrorimane ancora a scavare da entrambi: specialmente dal Filcolo e dal Bucolicon del primo,nonch dal Secretum e dalle Epistolae del secondo. Fra quelli che intanto a Dante non vollerocredere, fu proprio quell'Ascolano che - rinascituro Bruno? - prefer giungere, per la Donna sua,al papato del Rogo. Per lui (p. 257), n Dante divinizz mai il suo corpo (mai lo rese albergo estrumento di liberata anima angelica), n mai fu in Paradiso con quella sua Beatrice; fu, s gi ininferno e in purgatorio; ma,
fondando li soi pedi - en basso centro,l lo condusse - la sua fede poca,e so ch'a noi - non fe' mai ritorno.
Bellssima cosa, che un inferno e un purgatorio iniziatici li abbia percorsi anche un Dante;bruttissima, che, proprio il paradiso, si riducesse per fede poca a cercarselo altrove. Ma, se cos, cosa farci? Nulla da vantarsene pi del giusto, e nulla da rammaricarsene pi del dovere;verit da indagarsi con precisa freddezza obiettiva, senza preconcetti di sorta. E, senzapreconcetti di sorta, dimostratissima riesce la risollevata e innovata tesi che tutti in genere iFedeli d'Amore fossero dunque una segreta fratellanza filosofico-religioso-politica: a basicertamente mistiche, non per sempre n ovunque iniziatiche. Era semplicemente la Tradizione
Iniziatica, ad attingere, anche tra loro, i pi promettenti per acceso cuore, saldi nervi e mentaleequilibrio. Chi avrebbe mai detto, che, dinanzi al proteiforme Guardiano della Soglia,indietreggerebbe un Dante, dove il Cavalcanti era invece passato? Ma neanche questiprecisamenti interessano ancora il Valli. I cui rammodamenti del movimento, alla misticapersiana, non mi sembrano a proposito, che per le esteriorit di dettaglio. Ma neanchestrettamente a proposito mi sembrano i raccostamenti che un dotto storico ecclesiasticoavrebbe piuttosto voluti, con Gioachino da Fiore. Fiore, s, infatti, anche lui; e, di spiritoprofetico dotato. Ma sembra che, per quei Gioachimiti, fosse il monaco puro e semplice adover prendere una sia pur ascetica - ma completa, assoluta, esclusiva - direzione dell'Umanit, in tutti quanti i poteri: dal papale all'imperiale, e dal dottrinale all'economico. Non bastanodunque coincidenze di qualche terminologia, e nemmeno comunanze di qualche generico
programma a cui accenneremo da ultimo. I Fedeli d'Amore erano, credo, tutti un po' troppo gai,per sognarsi una universale malinconia di quel genere, tra le accese lor rose e i variopinti lorfiori, i lor verdi lauri ed i freschi lor mirti: magari selvaggi talvolta, ma non lungi, mai - non solo inPoliziani, ma neanche in Marsilii Ficini - da chiare acque e da misteriali fontane. E il pipersonale, e pi meritorio sforzo filologico, del Valli? Quello di un ottimo metodo statisticoinduttivo: cercare quale senso, per certe singole ritornanti parole soddisfacesse non in questo oquel passo, ma in tutto un blocco di estratti dagli autori pi vari. E, per esempio, cos trovatoche se per Amore di Madonna s'intenda quello della Sapienza Santa, tutto ci che pareva sspesso metaforico e artificioso, freddo ed enfatico, diventa appropriato e naturale, caldo ecommosso. Ovvio, d'altronde, che Amore e Madonna significassero anche, talvolta, la stessasegreta fratellanza, o locale o totale. Che, oltre alla morte di errore e peccato con la meretricechiesa dirigente, ci fosse in quelle rime una morte mistica: quella che dagli antichi Misteri passanche in Paolo (8) e in Agostino, e via via in altri ed in altri, sino a Riccardo da San Vttore:quella che rinascita in excessu mentis, e principio d'una superior vita; morte di sensitiva erazional Rachele, per apparizione d'un'angelica Beatrice intuitivi-unitiva; niuna meraviglia pi, se
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
17/111
Dante non ne voglia parlare (Vita Nova, XXVIII) anche perch converrebbe essere, me,laudatore di me medesimo . Che le Donne aventi intelletto d'Amore non erano, dunque, che glistessi occulti condiscepoli della Sapienza Santa; non consta infatti che le vere e proprie donnedi allora, avessero, generalmente, maggior intelletto d'Amore, che poco prima o poco dopo diquei lor strani Fedeli. E cos via, per tante e tante interpretazioni novelle, sino a quella che ilpiangere significasse costrizione a simulare; che saluto alludesse a promozione di grado; chepietra sasso, marmo fosse la Chiesa, promiscuamente or corrotta ed or santa, e spessoimprigionante e imprigionata come in sepolcro; donde una luce quasi sempre convincente sulletante rime or petrose, or antipetrose, ed ora insieme l'una cosa con l'altra.(6) D'accordo col Valli - e con egregi assai - in cotesta attribuzione, non posso consentire conloro per la cronologia. Se non giovanilissima, fu certo, il Fiore. primissima opera un po' vastadella futura gran Musa; opera di quando il futuro creatore d'una lingua italiana, si erasemplicemente assunta, anche lui, l'impresa di nobilitare con forme d'una lingua illustre,- colFrancese - il suo dialetto fiorentino: come, per il suo dialetto bolognese, aveva fatto il Guinizelli.Ma, per constatar questo, bisogna tenersi al testo del Fiore cos com' nel manoscritto; e, per ilGuinizelli, alle redazioni pi antiche: non gi alle man mano sempre pi toscanizzate eitalianizzate, dagli stessi successori immediati.
(7) Cfr. CARCOPINO JEROME, La basilique pythagoricienne de la Porte-Majeure; Paris, 1926.Il Carcopino non per pensato a richiami danteschi.(8) Cfr. testo e rimandi di GUIGNEBERT CH. Quelques remarques sur... le Mystre paulinien(Rev. d'hist. et de philos. relig.; sept-oct. 1928). Ma ralisant la vrit dans d'Amour (p. 424)[- ??? (IV, IS) -] sono proprio espressioni da prendersi in tutta la forza della felicissimatraduzione novella, se si voglia penetrare anche il recondito legame fra Sapienza e amore inqualsiasi genere di Fedeli d'Amore. Fra i rimandi. cfr. specialmente MACCHIORO VITTORIO,Orfismo e Paolinismo; Montevarchi, Cultura Moderna, 1922; pp. 311.
***
Quali le resistenze ancor possibili? Quelle dei competenti prosuntuosi e pigri: i quali si credonosapientissimi essi soli, e suppongono possibile che un autore di nuova tesi non sia passato eglistesso traverso alle difficolt, ai dubbi, alle obiezioni che subito si presentano a chiunque, sunon controllate genericit , o in isolati dettagli. E poi quelle dei prima di tutto esteti - e cio poisensuali: quali pi, quali meno - che mal sopportano dedicate ad astrazioni, certe soavimusiche, come "Tanto gentile"; o certe calde scene, come "Guido, vorrei"; o certe realisticheirruenze, come "Cos nel mio parlar" (pp. 351-55). E infatti anch'io avrei talvolta voluto escluderedall'allegoricit, divampamenti e fremenze d'una potenza siffatta. Ma chi vieta, anzitutto, chenell'allegoria complessiva siano introdotti episodici riverberi di vita reale e realistica?Non si fanno, anche oggi, opere di tutta invenzione, materiate, qua e l, di vita vissuta eosservata? E che ne sa la moderna mentalit nostra - scientifica e scettica - delle gamme di
carit e di odio, in medievali passioni di tutt'insieme fede-pensiero-politica? O chi negherebbe,a chi realissimo vedr un suo volo su Gerione, la capacit di rappresentarsi nemica viva epresente, una odiatissirna casta minacemente incombente ovunque e da ovunque? - E poi, nonvedete?
lo mi vendicherei di pi di mille .
O chi era mai dunque
questa scherana micidiale e latra ?
questa traditrice di pi che mille amanti? una qualche vecchia sgualdrina? E infatti poi, s:meretrice e omicida, man mano pi e pi, da ormai un millennio: da Ahi, Costantin. E alleosservazioni, almeno io, non seppi pi che rispondere. Neanche al Valli invece riuscito diavere elementi sufficienti ad una soluzione defmitiva , per quell'enigma forte delle "Tre
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
18/111
donne intorno al cor" (395-65). Quante volte stancatavi sopra, anch'io, la mia multisizientecuriosit ! E, altrettante volte, riconosciuto infrangibile quel superbo divieto:
Canzone, a' panni tuoi non ponga uom mano.
E mano dovrebbe infatti, adesso adesso, avercela posta un qualche mio eccelso buon Angelo,poich semplice, aderentissima, unica, la spiegazione che mi qui balenata inattesa. Laeccelsa fra le eccelse canzoni dantesche, non che una pi sublime trasposizione della favoladei Tre anelli. Sorella a quella ormai onnipresente Sapienza che madre ad Amore, Drittura cio la Legge Mosaica, direttamente data da Dio. Su mistico fonte di mistico Nilo, gener essapoi la Religione Cristiana, che procre, per riflesso, la Metafisica Musulmana. specificatocos, come ai tempi di Dante lo avrebbe fatto ogni uomo di pensiero; e non mi opporr nconsentir a chi, specificando pi ancora, volesse pensare ai tre contenuti esoterici:precabalistico, gnostico, alchimico. Ch tali cose - indistintamente tutte - non mi sembrano chetransitorie maschere della Tradizione Iniziatica, essenzialmente esperienza dapprima econoscenza dappoi; poi, ancora una volta, non credo che, neanche al puro e sempliceunionismo esteriore, si sia mantenuto fedele il maturo Dante definitivissimo. Ma, chel'identificazione di Drittura sia indubbia, risulta anche da quello strano contegno di Amore: pi
interessantesi, persino lui, alle due altre, e, con lei, pietoso, s, ma anche fello, da quando perla rotta gonna (la pi sbrindellata lei fra le tre, e la pi lontana, per tante ragioni, dalla terza),
la vide in parte che il tacere bello.
Fellonera che pareva insomma un po' trivialuccia, e che diventa semplicemente obiettiva erealistica, in quanto allusiva alla circoncisione. E, identificata l'una, seguono spontaneamente lealtre. E poich i tre grandi aggregati spirituali - che, figli d'uno stesso Dio, avrebber dovuto esseruno - erano invece nientemeno che ostili, non era davvero possibile pi di cos, udire al mondo,
... nel parlar divino, consolarsi e dolersi.
cos alti dispersi.
Ed eran dunque le tre chiese, che anche i Fedeli d'Amore speravano conciliabili in unicasapienzial Chiesa d'Amore. Non forse, alla corte del lor Federico, se ne eran date superiorconvegno le tre civilt ? E anche frate Elia vi si era un d rifugiato. Onde, qui s, potevano - inquesto programma pratico - veramente allearsi e confluire i pi vari indirizzi: a tendenze siaeretiche che ortodosse, a programmi s ascetici che attivi, a riti tanto greci quanto latini, aorganizzazioni vuoi monacali o vuoi laiche, e, forse primi fra tutti, i francescani in genere e igioachimiti in ispecie - donde, pi addietro, un inciso non previsto nella mia prima stesura -; ma,quasi al centro di tutti non tanto per intima vita specifica, quanto per episodico programma dioccasionale beneficit anche, s, la Tradizione Iniziatica. Niente bisogno di giungere al Pico, al
Reuklin, al Kunrath; basta gi allora, per tutti, Raimondo Lullo - cotesto infaticabile eimmarcescibile atleta di tante e s varie battaglie - il quale, proprio in quegli anni e per quellaunione (9), percorreva e moveva terre e mari; ma non riusciva a smovere n un papa n unaltro n ancora un altro, sinch, per il suo unicattolico sogno, trovava, ottantatreenne, lo sfidatoe risfidato martirio.Tutte cose, mi pare, che definitivamente troncano la testa al toro, se pur qualche vrtebracervicale potesse ancora resistere, in cotesto sfiancatello toro della opposizione antivalliana.Sfiancato che non fosse, pessime ausiliarie sarebbero alla battaglia, certe iniziatiche recensionicome quella, fresca fresca, di Voile d'Isis. Nella quale, sbito Ren Gunon riconosce alvolume del Valli une documentation formidable (109), ma, non meno subito, al Vallirimprovera de n'avoir pas la mentalit initiatique qui convient (110). Cosa per cui, tanti erroriavrebbe il Valli commessi: - 1 non essersi accorto che il guenoniano Esotrisme de Dante (ionon l' letto ancora) una portata proprement initiatique (111); - 2 aver creduto il Rossettiappartenente a quei Rosa-Croce che erano invece assai prima spariti dal mondo... occidentale;proprio cos: du monde occidental (111). Come se gli aurei Anelli Iniziatici non fasciassero
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
19/111
ormai pi tutta quanta la Terra, magari allargandosi a tutto il cosmo planetario-solare: per chi,anche cos, se ne contenti; - 3 non aver capito i veri significati di tradizionale (per quella che franoi oggi la tradizionale interpretazione dantesca), n di cuore in genere e di cuor gentile inspecie (110-11); - 4 aver creduto autori autorevoli un Mead, un Saunier, un Taxil (cos infascio) e aver citato di seconda mano un segreto Recueil non potuto citare di prima (111-12); -5 aver, in conclusione, mescolato l' sotrique et l' exotrique (112), confuso i punti di vistainitiatique e mystique, e assimilato le cose iniziatiche une doctrine religieuse (113).Fortunatamente il Gunon passa subito ad asserire che une tradition vraiment initiatique nepeut pas etre htrodoxe. Consolantissimo evento. Il Gunon si riconferma, cio, di quei tali -rispettabilissimi - occultisti spiccatamente francesi, che non contenti di accaparrarsi un veroiniziatismo propio, fabbricano anche un vero ortodossismo agli ortodossi, per poi trionfalmenteconcluderne le ortodossie di cui sopra. Ed inutile perseguire l'egregio critico su queste vie,dietro ad appunti, appuntucci e appunterelli, fatti con pur evidenti intenzioni di simpatia. Il Vallinon bisogno che glie lo dica io, di non lasciarsi impressionare da coteste lezioncelleimportune. Continui, in una seconda edizione, cio che gli benissimo riuscito nella prima.Riduca magari, ancor pi, la pur gi discreta e sempre dignitosa polemica, e poi faccia pursempre e soltanto opera di critico puro, di storico puro, di puro esegeta. Fin dove arrivasserogl'intenti eretici, e donde venissero le riconnessioni iniziatiche, le son cose che debbono
sbocciare, man mano, da s. E quando un K, che fra altre iniziali di medaglia volevaprobabilissimamente dire Katholicus, glie lo si voglia far leggere Kadosch (119), si riservi pure ildiritto di chiedere, non dico il diploma originale, ma una qualsiasi ragione che elimini glianacronismi. Il che non vuole affatto dire che il Gunon non sia un iniziato e magari un Adepto -ancora una confusione rimproverata (112) - ma ch'egli potrebbe semplicemente far a meno dicogliere ogni occasione per riasserire che, iniziato, egli lo , ma che gli altri occidentali ingenere, e certi suoi nemici in ispecie - a scanso di equivoci, non mi consta affatto che mi sianopunto amici - h, poveretti! quelli, no, non lo sono; sicch, pour une fois o una volta tanto,contro cotesti odiati nognostiques, perfino la critique (quella profana) a raison (117, nota).Non si potrebbe, tra noi fuori-soglia, sulla soglia, a mezza soglia, smetterla una buona volta diguardarsi in cagnesco? e credere, invece, che anche nel mondo iniziatico ci sia posto per tutte
le buone volont ? che tutte le strade conducono proverbialmente qui a Roma? - Roma e Amor,s (113-14), ma anche (Vergilius) Maro, e anche Orma (10) -? E badare ognuno, per contoproprio, a fare quei tanti passi innanzi che non guastano mai - n mai sono troppi - pur nessuno.E agli altri, augurare che magari ci sorpassino - e cos pur fosse che molti ci sorpassassero -per il gran meglio di loro, e di tutti.Con sollievo si pu quindi ripensare a un'analoga recensione ormai vecchia e con indirizzimagari affini, ma di tutt'altro tono (11). Italiana, questa, e rispecchiante una iniziatica culturaamplissima, occidentalissima, e senza toni maggiori su noterelle minori. Basata talvolta su queidottrinali raffronti a cui mi duole di non poter dare altrettanta importanza, ma anche insistente,pi spesso, su utili dettagli, quasi sempre documentabili.
(9) Cfr. Dr. LUCIEN - GRAUX, Le Docteur lllumin; Paris, Fayard, 1927; un ben informato ecomplessivamente assai cauto lavoro,(10) Un ORMA in cui son certo che "O" non vuoi dire n Occidente n Oriente - n grande npiccolo - ma per la cui "R" un vago sospetto di riferibilit a quei Rosa-Croce che il Gunoncrede rifugiati in ...oriente.(11) PIETRO NEGRI, Il linguaggio segreto..; nella rivista romana UR, anno II (1928), fasc. 3-4,pp. 71-80.
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
20/111
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
21/111
Egli tra coloro che hanno dato alla mia tesi l'appoggio di una approvazione molto calda emolto autorevole. Dir di pi, egli ricorda nel suo articolo di avere augurato dopo lapubblicazione del mio libro Il segreto della Croce e dell'Aquila nella Divina Commedia che ioapprofondissi le opere rossettiane che egli, a differenza della enorme maggioranza dei nostriletterati, aveva lette. Devo in realt a lui l'essermi accostato al Rossetti e mi caroriconfermargli qui la mia gratitudine per il suo prezioso consiglio. Il Bruers espone un dubbiosulla eccessivit della mia tesi simbolica e scrive: Il Valli, afferrato e quasi rapito dalla suamirabile scoperta, tenderebbe ad escludere, in una misura che mi sembra eccessiva, i valoripoetici dei Fedeli d'Amore., valori che a mio parere, si identificano nelle figurazioni femminili enaturali . Riconosco volentieri che il problema del quanto di donna vera o meglio di vereimpressioni amorose e terrene sia rimasto nella poesia dei Fedeli d'Amore, problema nonfacile a risolversi con precisione assoluta. Secondo me (come secondo l Perez) quando Dantenella Vita Nuova dice che i poeti devono rimare su materia amorosa, questa "materia" contrapposta alla "forma" nel senso scolastico. La materia amorosa (cio i ricordi, leimpressioni, le parole dell'amore) costituivano, diremmo noi, il materiale al quale l'idea iniziaticadava forma, col quale cio costruiva la vera poesia. Ora io non ho mai negato (Il LinguaggioSegreto, pag. 417 e seg.) che questa gente sia stata innamorata, il che vuol dire che la materiaamorosa l'abbia tratta da esperienza diretta e personale oltre che da ricordi letterari e da
imitazione di altri. Ma quando era esperienza personale e quando ricordo letterario eimitazione? Difficile dirlo ed cosa da sentire caso per caso. E certo che Dante nel suo sonettoGuido vorrei esprimeva un'idea segreta (come dimostrano la risposta di Guido e il momentoin cui i sonetti sono scambiati) ma ugualmente certo che l'idea gli venuta da un vero sospiroche deve aver fatto un giorno sognando una passeggiata in barca con amici e donne gentili,come, per qnanto abbia adombrato il saluto rituale (cantato dagli altri poeti del dolce sti1 nuovoe da essi soli) nel sonetto Tanto gentile , il sonetto nato, come io ho gi scritto, da un'impressione vera di adorazione per una bella donna che passava pel via tra l'ammirazionecommossa di tutti.Io non escludo dunque la presenza di donne vere e non escludo che in qualche caso si siaavuto lo spunto da ispirazioni realistiche immediate, impressioni d'amore che poi la convenzione
mistica o il pensiero segreto inform di s. Ma non solo l'ispirazione diretta sub l'elaborazionedel pensiero convenzionale, ma per la maggior parte dei casi la presenza di questa ispirazionediretta non appare menomamente e l'evidente convenzionalismo testimonia che si elaboravanoelementi letterari.Un altro dei pochi che non arrivano completamente nuovi a questo argomento S. A. Luciani(Dolce stil nuovo, Tribuna, 22 febbraio 1928). La conoscenza che egli ha dei precedenti gli fatrovare naturalmente la mia tesi molto ovvia. Dopo riassunte le mie idee egli scrive: "Da quantosi appena accennato si pu facilmente argomentare quale importanza oltre che letteraria,filosofica e storica abbia il 'Linguaggio' del Valli, libro geniale e suggestivo, che pu esserel'inizio di una nuova e pi esatta valutazione di tutta l'arte del Medio Evo". Egli fa due riserve,l'una sulla possibilit . che la Pietra sia una donna reale (ma di questo non d nessun
argomento), l'altra sulla possibilit che ci possano essere poesie originariamente erotiche,ridotte poi a significato mistico, cosa che io sono lontano dal negare in modo assoluto: per ilfamoso sonetto Tanto gentile la mia tesi molto simile alla sua. Importante e lucidissima misembra la formula riassuntiva del Luciani , secondo la quale si tratta qui come in tutta l'artemedioevale della incarnazione di una idea, non della idealizzazione di una realt. Egli concludeaccennando ad eventuali attenuazioni della mia tesi: Il Valli ha dato in realt un colpo ditimone troppo brusco alla nave della critica ufficiale, perch essa non dovesse sbandarsi. cosa' inevitabile tuttavia che questa nave muti rotta una buona volta .Pietro Negri ('Ur' Marzo 1928) un profondo conoscitore di tradizioni. Considera il mio librocome uno spezzone di gelatina. gettato in mezzo alle solite idee della scuola e mi indica, comeargomentazioni nuove, alcuni ricollegamenti abbastanza importanti per quanto poco noti, di fattie di idee del mondo iniziatico. Certo importantissimo, a proposito del ricollegamento posto dalRossetti tra l'amor platonico del Medioevo e gli antichi nsteri, il fatto che la Rosa sia anche nellibro di edificazione iniziatica di Apuleio quella che deve salvare l'uomo imbestiato e che siaappunto la mta di tutta la sua avventurosa ricerca, la quale rappresenta indiscutibilmente la
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
22/111
rigenerazione spirituale coronata dalla iniziazione. Il Negri ritiene con me che il Rossetti siastato condotto alla sua interpretazione dalla conoscenza di antiche tradizioni. Il Misterodell'amor platolonico del Rossetti non dedicato come gli par di ricordare a un B. L. chesarebbe Bulwer Lytton, erudito di esolerismo, bens a un S... K. . . Questi Seymour Kirkup cheera per anche lui un erudito di esoterlsmo (I). Ritengo notevolmente importanti anche i moltiraffronti che egli fa del simbolismo dei Fedeli d'Amore con quello che era diffuso in altrimovimenti iniziatici e specialmente nell'alchimia. Torner io stesso sulla importanza del raffrontotra la figura del 'rebis' alchemico da lui riesumata e la figura moglier e marito di Francescoda Barberino.
(I) Dall'epistolario ancora inedito del Rossetti si pu rilevare che mentre Hookam Freer cheaveva dato il danaro per la stampa del 'Mistero dell'Amor Platonico' ne chiese poi ladistruzione, il Rossetti chiedeva al Seymour Kirkup che evitasse questo disastro. Per alcuni anniil libro fu tenuto in casa Rossetti e non diffuso. Morti il Rossetti e i due suoi amici, altri persuasela vedova Rossetti a distruggerlo.
Ercole Quadrelli(Progresso Religioso, marzo 1929) non solo ha accolto con grande fervore lamia interpretazione, ma ha vivacemente polemizzato contro qualcuno dei miei oppositori della
tradizione scolastica e col Guenon al quale rimprovera di fabbricare una ortodossia iniziaticaartificiosa per suo conto, ma io desidero soprattutto di fissare un emendamento che egli haproposto a una mia interpretazione e che mi sembra ottimo.Cecco d'Ascoli nel suo sonetto a Dante scrive:
Usa cautela e spesso la ricapita,e sappiti mostrar Francesco e Rodico.Va, come ti convien, diritto e clodico.
Capiterai, come quei che ben capita. . .
E evidente che qui il consiglio di usare per prudenza un linguaggio o una condotta doppia.
Posta la lotta tra i 'franceschi' (di Filippo il Bello) ed i Templari avevo immaginato che quelRodico potesse alludere a Rodi invece della vicina Cipro, sede dei Templari. Il Quadrelli mi faosservare che Rodico potrebbe benissimo ricollegarsi invece. a 'rdon' (Rosa) e quindisignificare semplicemente 'seguace della Rosa'. L'interpretazione molto pi chiara e piragionevole della mia e merita senz'altro di sostituirla.R. Guenon, studioso ben noto delle tradizioni iniziatiche, ha dedicato al mio libro un lungoarticolo nella rivista Le Voile d'Isis (fvrier 1929). Egli l'autore del libretto 'L'esoterismo didante' (Paris 1925). E' naturale che egli consenta con me perch da lungo tempo le tradizioniiniziatiche avevano rivendicato a s Dante e i Fedeli d'Amore, io anzi ho espresso il dubbio cheil Rossetti, che ebbe le prime idee sul contenuto segreto dell'opera di Dante a Malta, dove eraentrato in rapporto con un gruppo di Rosa-Croce, abbia avuto da loro notizia di questi contenuti
segreti che poi ricerc pi o meno disordinatamente per via critica. Il Guenon trova che la miaargomentazione basata su testi precisi che ne costituiscono tutto il valore e riconoscendo lasolidit del mio metodo e l'importanza della mia dimostrazione, mi espone cortesemente alcuneobbiezioni e alcune conferme. Le obbiezioni si concretano in questo, che io parlo un linguaggioinesatto quando mi riferisco alle tradizioni iniziatiche perch non le conosco.E' verissimo. Non ho mai avuto contatti con tradizioni iniziatiche di nessun genere. La miaformazione spirituale e mentale nettamente critica e finch il Pascoli e il Rossetti non mihanno aperto gli occhi, la tradizione scolastica era riuscita a impormi le sue interpretazioni. Madebbo dichiarare che io insisto nel tenermi al mio metodo critico e storico. La mia frase 'far lastoria per la storia' che al Guenon dispiace, semplicemente l'insegna di un metodo criticopositivo e il fatto che i grandi spiriti del Medioevo dei quali io mi occupo agissero diversamente,come egli mi ricorda, non mi tange appunto perch essi erano uomini del Medioevo e io sono unuomo del secolo xx.Pu anche darsi, come egli dice, che il Rossetti non possa essere stato Rosa-Croce "perch iveri Rosa-Croce erano spariti dal mondo occidentale assai prima ", ma ognuno comprende che
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
23/111
questi problemi interni delle tradizioni iniziatiche, chi siano i Rosa-Croce veri e chi i falsi,rappresentano per me problemi secondari e quasi insolubili. Riconosco perfettamente che allachiarificazione di tutto il problema che io ho posto sar utilissimo il concorso di coloro cheseguono quelle tradizioni; per se io prima di citare uno o un altro storico di tradizioni occultedovessi aspettare da non so quale autorit la lista degli storici accettati e non accettati,ortodossi e non orlodossi, credo che il mio lavoro non potrebbe mai andare avanti. So di certoche c' della gente che si d il titolo di Rosa-Croce anche oggi. Anche chi sa pochissimo degliambienti iniziatici sa che in essi ogni gruppo si attribuisce il titolo di ortodosso e di eredelegittimo vero ed unico dell'antichissima tradizione. Ecco perch non ci troviamo d'accordosull'uso della stessa parola ortodosso, che per me naturalmente significa la dottrina della Chiesadi Roma e per il Guenon significa altra cosa. Sono quelle "mprises que les profanes manquentrarement de commettre" come egli dice ed io riconosco che, essendo profano, parloevidentemente un linguaggio diverso dal suo; ma dove non posso consentire l dov'egli diceche io faccio una confusione tra punto di vista mistico, e punto di vista 'iniziatico'. Non so daquali mie parole possa essere sorto questo equivoco. La confusione sarebbe stata certo grave,perch tutti sanno quanto misticismo niente affatto iniziatico abbia pervaso il Cristianesimo e ilCattolicismo.Ma il Guenon accenna a molti fatti che possono affiancare la mia argomentazione, alcuni dei
quali non privi d'importanza, per esempio quello che non soltanto nel titolo di Rosa Mystica maanche sotto altri aspetti la Vergine stata avvicinata alla figura della Sapienza e con essaconfusa. Altra nota importante: a proposito della terza novella del Boccaccio nella qualeMelchissedec afferma con la parabola dei tre anelli che tra Giudaismo, Cristianesimo eIslamismo 'nessuno conosce quale sia la vera fede', egli mi dice che secondo la tradizioneiniziatica Melchissedec sarebbe appunto il rappresentante della tradizione unica nascosta sottotutte queste forme esteriori. Mi ricorda, a proposito dei probabili rapporti fra i Fedeli d'Amore e iTemplari, che il grido di guerra dei Templari era 'Vive Dieu Saint Amour!'.Naturalmente non posso che consentire col Guenon quando egli accenna ai moltissimi puntidella mia trattazione che avrebbero bisogno di ben altro sviluppo.Concludo. L'incontro delle mie constatazioni con quelle di qualche tradizione iniziatica incontro
di due ordini di pensieri che vengono da vie diverse, con diversi intenti, con diversissimavalutazione forse dei fatti storici che si hanno sott'occhio. Mi compiaccio delle concordanze suifatti, mi spiego le discrepanze sui termini e sui giudizi, sono ben lieto di apprendere dati di fattonuovi, continuo nel mio metodo e nel mio intento che puramente storico. Cosi quando ilGuenon, accennando anche alla mia scoperta delle simmetrie della Croce e dell' Aquila e aquesto venire alla luce del segreto di Dante dopo sei secoli, dice che questo accaduto "parcequ'il tait prvu que le secret devait etre gard pendant six sicles (le Naros chalden)", io permio conto continuo a credere che la cosa si vada chiarendo oggi soltanto perch oggi l'abbiamostudiata senza preconcetti, con molto pi materiale a disposizione e con buon metodo.
5)Per Una Determinazione Del Significato Anagogico
Tullio Quasimodo: Ritengo che uno dei nodi da sciogliere, riguardo alla dottrina dei Fedeli
d'Amore, decidere a che cosa si riferisca esattamente il significato anagogico e perciiniziatico delle loro opere. Mi sembra infatti che i vari studiosi, riguardo a questo pi alto livello disignificato (e perci non considerando altri significati di livello pi basso come ad es. ilsignificato etico-politico), abbiano sostanzialmente suggerito le seguenti soluzioni:a) il linguaggio "amoroso" dei Fedeli d'Amore nasconde delle pratiche esoteriche genericamente
-
8/10/2019 I Fedeli d'Amore
24/111
concepite e perci non necessariamente basate sull'uso iniziatico dell'amore.b) il linguaggio "amoroso" indica proprio l'uso iniziatico dell'amore, ma inteso quale "amorplatonico", cio senza contatto fisico. Per intenderci si tratterebbe di pratiche analoghe a quelleindicate nel primo dei due saggi di Abraxa, dedicati alle "operazioni a due vasi".c) il linguaggio amoroso indica l'uso iniziatico dell'amore richiedente il contatto fisico, comeavviene per le pratiche del secondo saggio di Abraxa.d) il linguaggio amoroso ha pi significati iniziatici tra quelli citati, ad es. b) e c) o addirittura a),b) e c).EA: Penso non vi sia alcuna difficolt ad ammettere tutti e tre i significati anagogicisuggeriti(cio la soluzione d=a+b+c). Riguardo al primo, si pu notare che la pratica esotericaha degli aspetti comuni, qualunque sia la metodologia adoperata, aspetti che perci si ritrovanosempre in qualunque scritto esoterico. Tuttavia la scelta di un linguaggio amoroso come gergonon pu essere casuale. Infatti altri linguaggi tradizionalmente usati (e perci collaudati)nell'esprimere contenuti esoterici erano a disposizione, a es. il linguaggio epico e mitologico.Perci l'uso del linguaggio amoroso si spiega con la necessit di utilizzare (pena un'eccessivavaghezza di significato) espressioni non troppo diverse dalla metodologia effettivamenteutilizzata. Riguardo a quest'ultima, tutte le tradizioni esoteriche indicano che, dal punto di vistadell'esperienza interiore, non vi sostanziale differenza tra le pratiche senza o con contatto
fisico, cos che i testi relativi (non solo quelli dei Fedeli d'Amore) sono applicabili ad entrambe.Tuttavia, dato il periodo storico (dominato dal cattolicesimo exoterico e sessuofobico) e levicissitudini politiche alle quali furono soggetti diversi rappresentanti di questa corrente (acominciare da Dante), reputo non facili pratiche sistematiche con contatto fisico e perci ritengoche siano state prevalenti quelle senza contatto fisico.Frater Petrus:Come mai nonostante i numerosissimi studi su Dante e le molteplici "chiavi dellaDivina Commedia", proposte da illustri commentatori, la principale opera di Dante rimaneancora, per molti studiosi, un enigma?Il pi esoterico tra i grandi commentatori, e cio Gabriele Rossetti(1), aveva soprattutto comeobiettivo di mostrare agli scettici come nell'opera dantesca vi fossero degli evidenti influssi degliambienti iniziatici. In ci egli pienamente riuscito e le conferme venute poi da altri autori, come
lo stesso R.Guenon, non aggiungono proprio nulla alle argomentazioni di Rossetti, n i loroopuscoli sono lontanamente paragonabili alle monumentali opere del Nostro. Questi tuttavia nonvolle o forse non ebbe tempo di affrontare direttamente il significato pi intimo della Commedia.
Luigi Valli, dal canto suo, sulle orme di Rossetti, ma anche di Giovanni Pascoli, illustr s delleimportanti simmetrie, ma pi idonee a disvelare i risvolti politico-religiosi dell'opera, che nonquelli esoterici propriamente detti. Valli, infatti, pur geniale nelle sue intuizioni e meticoloso neisuoi studi, disponeva pi di uno "sguardo" religioso che esoterico.Un autore piuttosto trascurato e che meriterebbe maggiore attenzione Pietro Magistretti, unodei primi membri della Societ Storica Lombarda, che individu nei simboli del "Fuoco" e della"Luce" un aspetto essenziale della Commedia, giacch come egli stesso dice, nella prefazione
della sua opera principale (2), "ove si sottraessero alla Divina Commedia la luce e il calore, essane morrebbe, per cos dire, come l'albero cui fossero tolti tali elementi che l'aria gli trasmette".