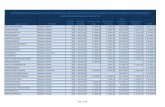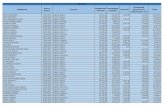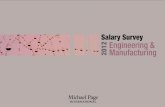Giornalismo online: dalla retribuzione alla visibilità
-
Upload
emanuele-mastrangeli -
Category
Documents
-
view
59 -
download
0
description
Transcript of Giornalismo online: dalla retribuzione alla visibilità
Università degli Studi RomaTre
Facoltà di Scienze della Comunicazione
Giornalismo Online
dalla retribuzione alla visibilità
Candidato
Emanuele Mastrangeli
Relatore Correlatrice
Prof. Roberto Baldassari Prof.ssa Valentina Cecconi
Anno Accademico 2012/2013
Sessione Invernale
5
Indice
Introduzione 7
1 Breve storia del giornalismo online 15
1.1 La nascita del giornalismo online 15
1.2 Dal sexgate all’11 settembre 2001: l’ascesa 19
1.3 Web 2.0: un nuovo modo di fare giornalismo 27
1.3.1 Come cambia la notizia 33
1.3.2 New journalist 47
1.3.3 La dignità del giornalismo digitale 60
2 Forme e modelli di giornalismo online 67 2.1 Modelli di testate passate sul Web 67
2.2 Modelli di testate nate online 87
2.3 La blogosofera 123
2.4 Microblogging: Twitter e il giornalismo 130
2.5 Citizen Journalism 143
3 Il giornalismo in Italia: la legge e il mondo del lavoro 165
3.1 Essere giornalisti in Italia 165
3.2 Il giornalismo all’estero 196
3.3 Giornalismo e precariato 210
3.4 Gli aspiranti giornalisti e la Rete 227
4 Scrivere online: la ricerca 239
4.1 Qualche centesimo ad articolo: chi offre di meno? 240
4.2 Pagamenti a visualizzazioni e Google AdSense 256
4.3 Vinci un contratto di collaborazione: “il giornalismo del
futuro” secondo Italiano Sveglia 263
4.4 Scrivere gratis: il giornalismo online non retribuito 269
4.4.1 L’analisi del fenomeno: per quali ragioni si scrive
gratis 277
4.4.2 Perché scrivere gratis danneggia la professione e
inquina il mercato 289
4.5 Approfondimento: interviste 297
4.5.1 Carlo Gubitosa 298
4.5.2 Silvia Bencivelli 310
6
4.5.3 Francesco Sellari 320
4.5.4 Valentina Orsini 325
4.5.5 Emanuele De Vito 329
4.5.6 Lorenzo Fusco 332
5 L’estero e la situazione economica e sociale 335
5.1 Who pays writers? Il dibattito fuori dall’Italia 339
5.2 A new economy: cosa è cambiato 356
5.3 The post-employment economy 361
5.3.1 Intervista a Sarah Kendzior 372
Conclusione 379
Bibliografia 389
Sitografia 407
7
Introduzione
Internet è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
non retribuito. L’evidente rilettura dell’articolo 1 della
Costituzione italiana1 è la costatazione principale che ha
generato il progetto di questa tesi. La domanda che ne
consegue è limpida nella sua semplicità: perché? E’ intorno a
questo interrogativo che si è sviluppato il lavoro di ricerca,
focalizzando l’analisi sul campo maggiormente caro ad uno
studente di un corso di Laurea come quello di “Informazione,
editoria e giornalismo”. Il giornalismo, per l'appunto. O
quantomeno, dal momento che non sempre è lecito parlare di
giornalismo, la creazione dei contenuti editoriali che
rappresentano il cuore pulsante di ogni sito Web. La conditio
sine qua non di ogni accesso e di conseguenza il mezzo
attraverso cui ottenere guadagni la cui fonte primaria
continua ad essere la pubblicità.
Per cercare di chiarire il proliferare del fenomeno della
mancata retribuzione – o della bassissima retribuzione, come
si vedrà più avanti – dei contenuti editoriali è innanzitutto
necessario delineare le caratteristiche contestuali. La prima
parte di questo lavoro mira quindi a garantire al lettore le
coordinate necessarie per orientarsi poi nella successiva fase
di ricerca, quella che tenta di dare una risposta al quesito
cardine. In primo luogo si traccerà una breve storia del
giornalismo online che mira a ripercorrere alcune tappe
salienti: la nascita negli Stati Uniti, l’arrivo in Italia, le prime
1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, art.1
Costituzione della Repubblica Italiana.
8
difficoltà incontrate nell’individuare un modello di business
efficace sino all’ascesa, favorita da due eventi esogeni come
il sexgate, lo scandalo che ha visto coinvolti l’ex Presidente
degli Stati Uniti Bill Clinton e la stagista Monica Lewinski e
gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001. Si vedrà
tuttavia come si sia dovuto attendere l’avvento del cosiddetto
Web 2.0 per avere da parte del giornalismo online una piena
maturazione, così come una capacità di definirsi autonomo
rispetto alla propria controparte cartacea, tanto da un punto di
vista di prestigio, quanto da un punto di vista di totale
sfruttamento delle caratteristiche del mezzo Internet. Dopo
aver portato a termine un’analisi di tipo storico, si andrà ad
esaminare nel dettaglio gli stravolgimenti provocati
dall’evoluzione tecnologica. La prima domanda che verrà
posta riguarderà i cambiamenti della notizia, ora
caratterizzata da elementi quali la tempestività, l’interattività,
l’ipertestualità e la multimedialità. A queste proprietà vanno
aggiunti l’inserimento nei motori di ricerca, quindi
l’indicizzazione e il posizionamento di ogni contenuto
editoriale e le tecniche di impaginazione ad esso legate. Si
vedrà inoltre come questa serie di stravolgimenti avrà
ripercussioni non solamente sulla notizia concepita, prodotta
e distribuita sul Web, ma anche su quella relegata
esclusivamente ai formati cartacei. Il cambiamento dei mezzi
tecnologici e quello della natura stessa della notizia non
possono che modificare, di conseguenza, l’approccio stesso
alla professione, così come il modus operandi e le abilità
richieste. Verrà tracciato un profilo del cosiddetto new
journalist, il giornalista online, la figura che tra scetticismo e
problemi di adattamento è diventata protagonista del nuovo
modo di fare informazione. A subire maggiori stravolgimenti
è con ogni probabilità – come si vedrà più avanti – il rapporto
9
che il professionista deve intrattenere con i propri lettori, mai
stato così diretto ed immediato in precedenza. Altro aspetto
cruciale a venire riscritto dalle caratteristiche della Rete è uno
dei caposaldi della professione: la verifica della notizia e,
consequentemente, la sua attendibilità. Come viene gestito il
flusso imponente di informazioni? Come il suo
aggiornamento costante? Quali le conseguenze dal punto di
vista della credibilità tanto del mezzo quanto dei
professionisti che su di esso esercitano la propria attività?
Dopo aver risposto a questi interrogativi si cercherà di
delineare i diversi volti del giornalismo online, i formati che
ogni utente/lettore può trovare sulla propria strada durante la
navigazione in Rete. In primo luogo verranno analizzate le
cosiddette testate derivate, ovvero quelle che, forti di un
formato cartaceo in grade di garantire autorevolezza e lettori,
sono approdate sul Web. I casi d’interesse saranno tanto
nazionali (La Repubblica, Internazionale), quanto
internazionali (Daily Mail, New York Times, Guardian) e si
evidenzieranno le caratteristiche distintive della versione
online rispetto a quella cartacea. In seconda battuta si
concederà spazio alle testate nate direttamente sul Web
facendo affidamento su una ricerca pubblicata
dall’Università di Oxford, tramite il suo RISJ, Reuters
Institute for the Study of Journalism, che mira ad indagare la
situazione dell’editoria online. Verranno sottolineate,
attraverso l’analisi di alcuni casi, le difficoltà nel creare un
efficace modello di business in grado di garantire
quantomeno il raggiungimento di un punto di pareggio. Uno
spazio a sé stante verrà infine dedicato al fenomeno
dell’Huffington Post e alle sue innumerevoli controversie, di
particolare interesse – come si vedrà – per i temi trattati da
questa ricerca. Infine sarà la volta di quei formati giornalistici
10
più direttamente figli del Web 2.0: la blogosfera, Twitter e il
citizen journalism. Analizzando queste diverse tipologie si
avrà modo di soffermarsi in particolar modo sul rapporto
sempre più stretto venutosi a creare tra giornalismo
professionista ed amatoriale. Quali le conseguenze per la
professione in seguito alla nascita e al successo di piattaforme
che consentono l’accesso alla produzione dei contenuti
editoriali ad un pubblico precedentemente relegato al ruolo di
spettatore passivo? Come considerare da un punto di vista di
legittimità il lavoro di un blogger? E’ autorevole un portale
di citizen journalism (o giornalismo partecipativo)? Quali le
ripercussioni generate da uno strumento quale è Twitter?
Perché sembra essere il social network preferito dall’universo
giornalistico?
La prima parte di questo lavoro verrà conclusa da una
sezione dedicata alla situazione della professione in Italia:
dalle leggi che la regolano alle modalità di accesso alla
professione; dal fenomeno del precariato al rapporto tra il
sistema editoriale italiano e la Rete. Ho ritenuto fosse
assolutamente necessario, in modo da fornire un quadro
completo in vista della seconda parte di questo lavoro,
soffermarsi su questi aspetti. Si partirà con un’analisi
dell’Ordine dei Giornalisti in Italia: la legge che lo istituisce,
la sua organizzazione, le sue funzioni, la sua legittimità, i suoi
rapporti con la Rete. Ha ancora senso parlare di un Albo
professionale quando chiunque può diventare autore
semplicemente disponendo di un computer e di un accesso a
Internet? L’Ordine è un’anomalia tutta italiana? Quali sono i
criteri d’accesso alla professione nel resto del mondo? In
seguito si delinereanno i rapporti tra l’universo giornalistico
e il fenomeno del precariato. L’analisi farà affidamento sui
11
dati raccolti da Pino Rea ne Il Rapporto sulla professione
giornalistica in Italia, redatto per Lsdi. Uno degli elementi di
maggiore interesse è la constatazione di come l’asse della
professione si stia spostando dal giornalismo dipendente,
tutelato dai contratti e dalle leggi, dalla previdenza e
dall’assistenza sanitaria di categoria, al lavoro autonomo, alle
collaborazioni coordinate e continuative, al lavoro dei
freelance. Si vedrà come le ricadute più pesanti vadano a
finire sulle spalle dei giovani, di tutti coloro che aspirano e
cercano di trasformare il giornalismo in un lavoro di cui si
possa vivere. In questo senso verranno tracciati nel dettaglio
i rapporti che intercorrono tra l’universo degli aspiranti
giornalisti e Internet e che in qualche modo anticipano i temi
della seconda parte di questo lavoro di ricerca. Quali sono le
opportunità a disposizione dei giovani che si ritrovano a
navigare nel mare magnum della Rete in cerca di una
collaborazione che possa garantire loro quei requisiti richiesti
dall’Ordine dei Giornalisti per entrare a far parte dell’Albo
professionale? Quali i compromessi, quali i ricatti? Come si
vedrà, purtroppo, da questo punto di vista i dati raccolti sono
tutt’altro che confortanti e in un contesto dove il celebre
tesserino professionale diventa merce di scambio in uno
scenario spesso d’illegalità, è lecito chiedersi quale sia la
risposta delle istituzioni in tal senso.
Delineato il quadro di riferimento in ogni suo aspetto, la
seconda parte di questo lavoro si concentrerà sull’analisi del
fenomeno del lavoro non retribuito in tutte le sue molteplici
sfaccettature. La prima sezione di questa parte sarà frutto di
un vero e proprio viaggio nel mare magnum della Rete. Cosa
incontra realmente un aspirante giornalista nel momento in
cui si pone alla ricerca di una collaborazione? Quali le
12
opportunità, quali le offerte, i pericoli? Lo scandaglio del
Web porterà alla luce diversi modelli di proposta, nessuno dei
quali particolarmente accattivante per gli aspiranti giornalisti.
Offerte a bassissima retribuzione – pochi centesimi ad
articolo -, pagamenti vincolati, cioè legati al numero di
visualizzazioni ottenuti dal singolo contenuto (sotto quella
soglia il lavoro viene svolto gratis), sino ad arrivare
all’hardcore delle collaborazioni gratuite, quelle dove nella
migliore delle ipotesi viene indicata una possibilità di
retribuzione futura in base al successo del progetto. Nel
mezzo – si vedrà – c’è anche dell’altro: dalla curiosa idea del
portale ItalianoSveglia di pagare i propri collaboratori
attraverso premi – è possibile vincere un contratto di
collaborazione – alle offerte poco trasparenti, dove di fronte
ad elementi non del tutto chiari – come la natura del portale
o la presenza o meno di una retribuzione –, viene garantita
comunque la possibilità di ottenere il tesserino da pubblicista.
In seconda battuta, la ricerca sposterà la propria analisi
sulle ragioni che favoriscono e sorreggono il fenomeno in
questione. Diverse le domande che verranno poste in questa
sede: cosa spinge una persona ad accettare di lavorare gratis?
Perché il fenomeno trova terreno particolarmente fertile
nell’universo delle prestazioni intellettuali? Si tratta di una
scelta consapevole o del prodotto di un sistema tutt’altro che
perfetto? A queste domande verrà affiancata una
considerazione di tipo economico: il lavoro non retribuito
inquina il mercato. Tra i sostenitori di questi tesi due
professionisti come Carlo Gubitosa e Silvia Bencivelli, con i
quali ho avuto il piacere di realizzare un’intervista che troverà
spazio assieme ad altre testimonianze: due blogger, Valentina
Orsini e Francesco Sellari, e due giovani aspiranti giornalisti,
13
entrambi con una storia da raccontare. Ad ogni modo, dalla
ricerca emergerà come il mercato editoriale online si sia
andato a plasmare su di una nuova moneta: quella della
visibilità.
L’ultimissima parte di questa tesi poserà lo sguardo oltre i
confini nazionali cercando di capire se il fenomeno sia
un’anomalia tutta italiana oppure una realtà priva di
attenzione nei confronti di bandiere e culture diverse. Si avrà
modo di vedere come il dibattito fuori dall’Italia sia molto più
vivace: nel momento in cui mi sono trovato a ricercare delle
fonti, la disponibilità delle stesse provenienti dall’estero, in
particolar modo dagli Stati Uniti, era incredibilmente
maggiore rispetto a quella nostrana. Come si vedrà, sono
soprattutto i palcoscenici a cambiare radicalmente: l’analisi
del fenomeno e le diverse posizioni a riguardo sono ospitate
da testate autorevoli come Atlantic o The New York Times. In
questa sezione della ricerca troveranno inoltre spazio i
cambiamenti strutturali, di carattere tecnologico, economico
e sociale, che caratterizzano il proliferare del fenomeno. La
cosiddetta new economy, il dominio di una domanda che
trova nell’incredibile abbondanza dell’offerta il crollo del
valore di quest’ultima, nonché la sua arma di controllo. La
conclusione di questo lavoro sarà affidata ad una riflessione
di carattere più ampio, che partendo dall’universo
giornalistico arriverà ad inserire quest’ultimo in un contesto
economico e sociale definito dall’antropologa e ricercatrice
americana Sarah Kendzior, post-employment economy.
Ovvero, il rimpiazzo di lavori sicuri che permettono il
sostentamento con altri temporanei sottopagati o non pagati
affatto – e l’idea che questo sia normale e che queste posizioni
siano un passaggio inevitabile per raggiungere un “vero
14
lavoro”. Infine ci sarà spazio per l’intervista che ho realizzato
alla gentilissima Sarah Kendzior, dove viene lanciato anche
un importante messaggio da parte dell’antropologa
americana: quello che sprona alla lotta. Gli sfruttatori
dovrebbero vergognarsi, non gli sfruttati.
Questa tesi è il frutto di un utilizzo incrociato di materiale
bibliografico e, soprattutto, articoli pubblicati online. Il
lavoro di ricerca è stato svolto esclusivamente su Internet, ad
ulteriore dimostrazione delle straordinarie potenzialità di
questo mezzo, il cui contributo nel proliferare del fenomeno
descritto in queste pagine dev’essere inquadrato come neutro.
La discriminante in tal senso rimane sempre l’utilizzo che ne
fanno le persone. Non mancano, nella scelta dell’argomento,
un discreto fardello di esperienza personale e il desiderio di
salvaguardare ad ogni costo tanto il mercato, quanto in primo
luogo la dignità inalienabile di qualsiasi tipo di lavoro.
15
1 Breve storia del giornalismo online
1.1 La nascita del giornalismo online
Era il 1992 quando il giornalismo e la Rete si avvicinarono
per la prima volta. L’incontro avvenne negli Stati Uniti, dove
il quotidiano dello stato dell’Illinois, il Chicago Tribune,
tentò un primo approdo online in primavera. Furono piccole
e medie testate, con l’intento di attirare nuovi lettori ed
allargare la propria diffusione territoriale, ad affacciarsi
inizialmente verso lo sterminato universo di Internet. Uno
sbarco meritevole di essere segnalato e raccontato è quello
del San Jose Mercury News. Spettò infatti a questa testata
californiana il ruolo di antesignano del giornalismo online.
Nel 1993, tramite il portale America On Line, il giornale di
San Jose si trasferì sulla Rete con il nome di Mercury Center
(figura 1).
(figura 1 – un’immagine della versione online del San Jose
Mercury News)
16
Il costo del servizio era pari a 9,95 dollari al mese, ma
nonostante ciò un buon numero di utenti decise di abbonarsi.
I punti di forza della versione elettronica erano l’archivio e
l’email. L’archivio storico del giornale consentiva infatti agli
utenti di reperire e consultare qualsiasi numero del quotidiano
cartaceo a partire dall’anno 1985. Il servizio email, invece,
riuscì ad instaurare uno scambio interattivo tra pubblico e
testata, tra lettore e giornalista. Oltre a queste due accattivanti
innovazioni, il Mercury Center offriva agli abbonati anche
delle rubriche non presenti nella versione cartacea. Questi
elementi assicurarono al giornale californiano un discreto
successo, nonostante il canone mensile e l’interfaccia grafica
piuttosto povera. Non passò naturalmente molto tempo dopo
questo esperimento affinché fossero le grandi testate
statunitensi a considerare l’approdo online. Fu a partire dal
1994 che i più importanti cartacei americani incontrarono la
Rete. Come facilmente deducibile, l’obiettivo era quello di
ricercare opportunità economiche alternative per affrontare il
calo di vendite e di introiti di quegli anni. Le strategie
imprenditoriali adottate dagli editori possono essere divise in
due tipi: da una parte c’era il tentativo di concedere i
contenuti online previa sottoscrizione di un abbonamento
mensile; dall’altra si tentò invece di sfruttare gli introiti
derivanti dalle pubblicità, che su Internet prendono il nome
di banner2. L’avvento dell’editoria online non fu inizialmente
2 Il termine banner significa letteralmente bandiera, vessillo o striscione.
Si tratta di un annuncio pubblicitario inserito in una pagina web: un
banner può essere statico oppure attivo o interattivo: quest’ultimo, il più
diffuso, consente, una volta cliccato, di raggiungere un'altra pagina web.
Il pagamento dell’azienda pubblicizzata verso il sito che ospita la
pubblicità avviene in base al numero di click che il banner ha ricevuto
(click through rate). Fonte: Wikipedia.
17
molto fortunato. In primo luogo le risorse disponibili in Rete
non differivano granché da quelle fruibili nella versione
cartacea. Inoltre, come fa pertinentemente notare Emilio
Carelli3, l’utente di Internet è da sempre stato abituato a
reperire le informazioni in forma gratuita (escludendo il costo
del servizio). Infine bisogna ricordare che in quegli anni la
penetrazione del Web non era ancora particolarmente
capillare. Per molti dei grandi gruppi editoriali americani
l’avvento online fu figlio di un errore di valutazione. Si
sopravvalutarono le potenzialità del nuovo canale, mentre i
ricavi si rivelarono inferiori alle aspettative. Emblematico fu
il caso di USA Today. Come racconta Marco Pratellesi nel suo
New journalism, Teorie e tecniche del giornalismo
multimediale4, il quotidiano della Virginia lanciò il proprio
sito (USA Today Online) nell’aprile del 1995. Venne allestita
una redazione web composta da 75 giornalisti e da circa 200
collaboratori, ma in tre mesi di attività vennero raggiunti
solamente 1000 abbonamenti al costo di 12,95 dollari
mensili. Gli editori si resero così conto che, fatta eccezione
per giornali specializzati e settoriali5, la via da perseguire
fosse quella della concessione gratuita dei contenuti editoriali
e il conseguente sfruttamento pubblicitario.
Quest’avvio non esaltante dell’editoria online negli Stati
Uniti fece sì che fuori dai confini americani si guardasse alla
Rete con prudenza. E’ l’inizio della seconda delle quattro fasi
del giornalismo online che Marco Patellesi descrive in New 3 Carelli E., Giornali e giornalisti nella rete, Milano, Apogeo 2004. 4 Pratellesi, M., New Journalism, Teorie e tecniche del giornalismo
multimediale, Mondadori, Milano 2008 5 Il Wall Street Journal, specializzato in economia e finanza e presente sul
web dal 29 aprile del 1996, ottiene un ottimo seguito nonostante richieda
ai propri lettori la sottoscrizione di un abbonamento mensile.
18
Journalism e che vede anche la carta stampata italiana
sbarcare sul Web. Fu l’Unione Sarda a fare da apripista nel
luglio del 1994. L’editore del quotidiano isolano, Nicola
Grauso, affascinato dalle potenzialità del nuovo mezzo e
avvalendosi delle competenze tecniche del centro studi CRS4
(Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna),
fondò a Cagliari il primo grande Internet provider italiano,
terzo al mondo per dimensioni: Video On Line. La prima
pagina dell’Unione Sarda (figura 2), sviluppata con il
linguaggio HTML, presentava una grande novità per quegli
anni: i collegamenti ipertestuali, i link.
(figura 2 - la prima homepage della versione online dell’Unione
Sarda)
Un’altra importante novità arrivò nuovamente dagli Stati
Uniti: si trattava di Msnbc, il primo giornale online, seppure
19
legato alla rete televisiva NBC. Dietro questo progetto c’era
una redazione di 150 giornalisti che si occupava di costruire,
riprendendo in modo originale i contenuti delle news
televisive, un vero e proprio giornale online. Fu tuttavia nel
1996 che approdò la prima testata completamente ideata per
la Rete, slegata da qualsiasi edizione cartacea o televisiva: si
chiamava Slate. Inizialmente concepito per essere fruito
esclusivamente dagli utenti in possesso di abbonamento
mensile (19 dollari il costo), si tramutò poi in sito gratuito
dato lo scarso successo della fase a pagamento. Nonostante le
grandi testate internazionali (il New York Times, il
Washington Post) e italiane (La Repubblica, Il Corriere della
Sera, La Stampa) intrapresero l’avventura dell’editoria
online, fu solo nel 1998 che la storia del giornalismo online
ebbe una svolta netta. Fu il cosiddetto sexgate, la vicenda che
vide come protagonisti l’allora Presidente degli Stati Uniti
d’America Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky ad
assurgere al ruolo di spartiacque e a segnare il passaggio tra
quelle che Pratellesi definisce seconda e terza fase della storia
dell’editoria online.
1.2 Dal sexgate all’11 settembre 2001: l’ascesa
del giornalismo online
Scrive Pratellesi riguardo al caso Lewinksy: «Al di là delle
considerazioni etiche da fare per la prima volta, in modo
palese, è l’informazione on line a dettare i tempi della
20
notizia6». Lo scandalo scoppiò online, poi venne ripreso e
analizzato sul formato cartaceo; ma solamente dopo essere
già stato portato all’attenzione del pubblico sulla Rete. Fu una
rivista scandalistico-politica ad accendere la miccia. Il 17
gennaio 1998 Drudge Report, guidata da un giornalista
indipendente di Los Angeles chiamato Matt Drudge, creò il
sexgate inviando una email agli abbonati del magazine, il cui
testo era: «NEWSWEEK KILLS STORY ON WHITE
HOUSE INTERN X X X X X BLOCKBUSTER REPORT:
23-YEAR OLD, FORMER WHITE HOUSE INTERN, SEX
RELATIONSHIP WITH PRESIDENT7». Il messaggio
venne pubblicato alle 21:32 del 17 gennaio 1998. Ma Drudge
Report non si fermò qui: esattamente due ore più tardi (alle
23:32) vennero pubblicati ulteriori dettagli e Newsweek, che
aveva tentennato in attesa di ottenere altri riscontri sulla
vicenda, si trovò ormai inesorabilmente anticipato.
«Web Posted: 01/17/98 23:32:47 PST --
NEWSWEEK KILLS STORY ON WHITE HOUSE
INTERN
BLOCKBUSTER REPORT: 23-YEAR OLD,
FORMER WHITE HOUSE INTERN, SEX
RELATIONSHIP WITH PRESIDENT
6 Pratellesi M., New Journalism, cit., p. 22. 7«Newsweek non pubblica un pezzo su una stagista della Casa Bianca. Il
reportage bomba: il Presidente ha avuto una relazione sessuale con una
ex stagista ventitreenne della Casa Bianca»
(http://www.drudgereportarchives.com/data/2002/01/17/20020117_1755
02_ml.htm).
21
**World Exclusive**
**Must Credit the DRUDGE REPORT**
At the last minute, at 6 p.m. on Saturday evening,
NEWSWEEK magazine killed a story that was
destined to shake official Washington to its
foundation: A White House intern carried on a sexual
affair with the President of the United States!
The DRUDGE REPORT has learned that reporter
Michael Isikoff developed the story of his career, only
to have it spiked by top NEWSWEEK suits hours
before publication. A young woman, 23, sexually
involved with the love of her life, the President of the
United States, since she was a 21-year-old intern at
the White House. She was a frequent visitor to a small
study just off the Oval Office where she claims to
have indulged the president's sexual preference.
Reports of the relationship spread in White House
quarters and she was moved to a job at the Pentagon,
where she worked until last month.
The young intern wrote long love letters to President
Clinton, which she delivered through a delivery
service. She was a frequent visitor at the White House
after midnight, where she checked in the WAVE logs
as visiting a secretary named Betty Curry, 57.
The DRUDGE REPORT has learned that tapes of
intimate phone conversations exist.
The relationship between the president and the young
woman become strained when the president believed
that the young woman was bragging about the affair
to others.
22
NEWSWEEK and Isikoff were planning to name the
woman. Word of the story's impeding release caused
blind chaos in media circles; TIME magazine spent
Saturday scrambling for its own version of the story,
the DRUDGE REPORT has learned. The NEW
YORK POST on Sunday was set to front the young
intern's affair, but was forced to fall back on the dated
ABC NEWS Kathleen Willey break.
The story was set to break just hours after President
Clinton testified in the Paula Jones sexual harassment
case.
Ironically, several years ago, it was Isikoff that found
himself in a shouting match with editors who were
refusing to publish even a portion of his meticulously
researched investigative report that was to break Paula
Jones. Isikoff worked for the WASHINGTON POST
at the time, and left shortly after the incident to build
them for the paper's sister magazine, NEWSWEEK.
Michael Isikoff was not available for comment late
Saturday. NEWSWEEK was on voice mail.
The White House was busy checking the DRUDGE
REPORT for details8».
Da questo momento le consuete tempistiche giornalistiche
vennero completamente stravolte. Iniziò un’affannosa e
frenetica caccia allo scoop, dove il desiderio di anticipare la
concorrenza portò anche grandi e prestigiose testate ad
incappare in clamorosi colpi a vuoto. Tutti i giornali ritennero
che per evitare di essere tagliati fuori dall’incredibile
8 Ibidem.
23
macchina di interesse pubblico che era il sexgate dovessero
privilegiare la pubblicazione delle notizie sui propri siti,
piuttosto che attendere l’uscita delle versioni cartacee, alle
quali veniva invece demandata l’analisi degli eventi. Scrive
ancora Pratellesi:
«Il sexgate è uno sfacelo dal punto di vista della
credibilità e della serietà del giornalismo, ma ha
l’indubbio merito di aiutare a capire che qualcosa è
cambiato nel mondo dei media. Con Internet, le
vecchie regole del giornalismo non sono più
sufficienti: la possibilità di editare notizie in tempo
reale rimescola le carte e scardina un sistema dei
media ormai consolidato nelle proprie rigide certezze
dal Dopoguerra, con televisione e radio a dare le
notizie del giorno, e le dirette e i giornali a fornire
commenti, approfondimenti e notizie del giorno
prima9».
Gli anni che seguirono il sexgate furono caratterizzati da
una grande euforia nei confronti di Internet e gli editori
italiani non restarono a guardare. Nel luglio del 1999 sbarcò
online un portale chiamato Quotidiano.net, che consentiva
l’accesso ai giornali della Poligrafici Editoriale: lanazione.it,
ilrestodelcarlino.it, ilgiorno.it. Quasi un anno più tardi, nel
giugno del 2000, fu il Corriere della Sera a rivedere
completamente la propria politica e il proprio approccio alla
Rete. Il sito del quotidiano milanese venne ridisegnato e
trasformato in un vero e proprio giornale online con una
9 Pratellesi M., New Journalism, cit., p. 22.
24
redazione autonoma che pubblicava le notizie in modo
indipendente rispetto alla versione cartacea. La direzione
intrapresa da una testata del prestigio del Corriere della Sera
fu un segnale importante: in quegli anni nacquero
innumerevoli iniziative editoriali che avevano come obiettivo
primario l’avvicinamento al Web. Nacquero portali come
Kataweb (gruppo Espresso), Caltanet (Il Messaggero e Il
Mattino, entrambi riconducibili all’editore Caltagirone) o
Ciaoweb (La Stampa).
Un’altra data cruciale per l’evoluzione e l’affermazione
del giornalismo online è quella dell’11 settembre del 2001.
Come riporta The Pew Internet & American Life Project10,
nei giorni immediatamente successivi agli attentati
terroristici verso il World Trade Center e il Pentagono, da una
parte il numero complessivo di americani che utilizzavano
Internet calò, dall’altra invece un grande numero di utenti –
molti di più che prima dell’11 settembre – si affidarono al
Web per essere aggiornati in merito all’attentato. The Pew
Internet & American Life Project rivelò che oltre due terzi di
utenti americani (il 69%, esattamente) utilizzò la Rete per
ottenere notizie e informazioni relative a quanto accaduto.
Circa la metà invece, qualcosa come 53 milioni di persone,
acquisì informazioni sull’attentato navigando nel Web.
Inoltre, molti cittadini utilizzarono Internet per tenersi
10 Il The Pew Internet & American Life Project è uno dei sette progetti
portati Avanti dal Pew Research Center. La sua funzione è quella di
fornire informazioni riguardo alle problematiche, le attitudini e le
tendenze che caratterizzano l’America e il resto del mondo («a
nonpartisan, nonprofit "fact tank" that provides information on the issues,
attitudes and trends shaping America and the world»).
http://www.pewinternet.org/.
25
aggiornati: alcuni si registrarono per ottenere le news
direttamente via email o sul desktop; altri si affidarono a chat,
forum o siti commemorativi per esprimere la propria rabbia,
il proprio patriottismo o semplicemente per dibattere quanto
accaduto con altri utenti. Dopo il sexgate, l’11 settembre
2001 diede un’ulteriore svolta affinché il giornalismo online
si affermasse e ottenesse credibilità e prestigio. La richiesta
di aggiornamenti costanti e dall’accesso immediato persuase
le testate a riservare alle loro rispettive versioni elettroniche
un’autonomia e un ruolo diverso e complementare al formato
cartaceo, delegato invece all’approfondimento. Non solo:
l’11 settembre 2001 fece emergere un altro fenomeno
destinato ad ottenere un enorme successo nel corso degli anni,
il Citizen Journalism11. Si tornerà successivamente ad
analizzare questa forma di giornalismo, sarà ora sufficiente
darne una definizione ed esaminarne la diffusione in merito
agli attentati terroristici contro gli Stati Uniti. Jay Rosen,
professore della New York University, afferma: «When the
people formerly known as the audience employ the press
tools they have in their possession to inform one another,
that’s citizen journalism12». E questo è ciò che avvenne
11 Conosciuto in italiano come giornalismo partecipativo o collaborativo,
in inglese può essere definito anche come public, participatory,
democratic, guerrilla o street journalism. Fonte: Wikipedia. 12 « Citizen journalism è quando la gente, in altri tempi detta pubblico,
usa gli strumenti della stampa che sono in suo possesso per informarsi
l’uno con l’altro ». Jay Rosen è considerato uno dei maggiori sostenitori
del public journalism. Sul suo sito (http://archive.pressthink.org/) oltre
alla definizione riportata poc’anzi aggiunge: «It's mine, but it should be
yours. Can we take the quote marks off now? Can we remove the "so-
called" from in front?» («E’ mio, ma dovrebbe essere vostro. Possiamo
togliere le virgolette ora? Possiamo rimuovere il cosiddetto “da”
davanti?»).
26
immediatamente dopo e nei giorni successivi all’attentato.
Sia sufficiente pensare che fu grazie ai cittadini (e non tramite
i media, che si limitarono a riprendere e in seguito ad
approfondire) che arrivarono ai nostri occhi le immagini degli
aerei che si schiantavano contro le Torri Gemelle. L’11
settembre 2001 diede per la prima volta autorevolezza a
produzioni giornalistiche amatoriali. I video girati dai
cittadini che si trovavano nei paraggi dei luoghi delle
esplosioni rimbalzarono su tutti i circuiti mediatici
diventando le uniche testimonianze reali di quanto accaduto.
Vennero ribaltati i normali rapporti gerarchici tra pubblico,
non più ricevente passivo e mondo giornalistico. Anche la
blogosfera13, già attiva negli Stati Uniti nel periodo a cavallo
tra 1997 e 1998, vide in seguito agli attentati di New York un
incremento del suo utilizzo e della sua popolarità. I blog
assunsero la doppia funzione di contenitore di notizie
provenienti direttamente dai cittadini e di spazio dove poter
esternare angosce e paure. Da quel momento la fortuna dei
blog continuò a crescere a dismisura, ma questo verrà
analizzato più avanti. Il citizen journalism e l’universo dei
blog sono elementi che caratterizzano una nuova fase del
Web, che coincide con quella che Pratellesi chiama la quarta
fase del giornalismo online.
13 Termine che indica l’insieme di tutti i blog presenti su Internet e le loro
interconnessioni. Si tornerà più avanti a trattare nel dettaglio la
blogosfera.
27
1.3 Web 2.0: un nuovo modo di fare
giornalismo
Negli anni tra il 1998 e il 2001 l’editoria online riuscì a
ritagliarsi un proprio spazio emancipandosi dalla presenza
ingombrante dei cartacei. Il caso Lewinksy e gli attentati
dell’11 settembre 2001 mostrarono le potenzialità del
giornalismo sul Web, oltre a mettere a nudo i limiti della carta
stampata di fronte alle nuove esigenze di un pubblico
affamato di aggiornamenti in tempo reale. Anche le grandi
testate compresero che fosse il momento di affidare alle
controparti online il compito di soddisfare la domanda di
un’utenza sempre più desiderosa di interagire e occupare un
ruolo più attivo all’interno del mercato dell’informazione. A
partire dal 2002, la diffusione della banda larga e la
conseguente alfabetizzazione digitale della popolazione
favorirono questa crescita. Furono quindi molti fattori a
creare le premesse per quella che può essere considerata una
rivoluzione per Internet: il Web 2.0. La caratteristica
principale di questo stato evolutivo della Rete fu il grande
aumento del livello di interazione tra il Web stesso e l’utente.
Il cosiddetto Web 1.0 non consentiva invece al navigatore
alcun tipo di interazione che non fosse l’ipertestualità offerta
dalle diverse pagine, l'uso delle email e dei motori di ricerca.
Ciò che caratterizzava il Web 1.0 era la presenza grossomodo
esclusiva di siti web statici, mentre la versione 2.0 si basava
(e si basa) su siti web dinamici14. Il concetto di Web 2.0 deve
14 Il Web statico indica un paradigma di progettazione nel web che
prevede un'interazione sostanzialmente unilaterale: l'utente può
visualizzare i contenuti di un sito, ma non modificarne lo stato né le
28
i propri natali a Tim O’Reilly15 e alla Web 2.0 conference di
O'Reilly Media tenutasi alla fine del 2004. O’Reilly non
diede una definizione di Web 2.0, ma delineò piuttosto una
serie di principi che caratterizzavano questo stato evolutivo
della Rete e che consentivano di riconoscere un qualcosa
come appartenente o meno a questa nuova versione. O’Reilly,
parlando del Web 2.0, disse: «Like many important concepts,
Web 2.0 doesn't have a hard boundary, but rather, a
gravitational core. You can visualize Web 2.0 as a set of
principles and practices that tie together a veritable solar
system of sites that demonstrate some or all of those
principles, at a varying distance from that core16» (figura 3).
Un altro importante contributo arrivò da Dario De
informazioni. Il linguaggio di marcatura padre del web statico è l'HTML.
Il Web dinamico invece indica tutte quelle applicazioni Web che
interagiscono attivamente con l'utente modificando le informazioni
mostrate all'utente in base alle informazioni ricevute dall'utente stesso e
che consentono anche un più rapido aggiornamento del sito web da parte
dell'amministratore. Fonte: Wikipedia. 15 Tim O’Reilly è un editore irlandese. È il fondatore della O'Reilly Media
(ex O'Reilly & Associates). 16 «Come molti importanti concetti, il Web 2.0 non ha un confine definito,
ma piuttosto un nucleo fluttuante. E’ possibile visualizzare il Web 2.0
come un insieme di principi e pratiche che tengono insieme un sistema
solare di siti che rispettano alcuni o tutti quei principi». O’Really T., What
Is Web 2.0, Design Patterns and Business Models for the Next Generation
of Software in o’really.com, 30 settembre 2005,
(http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1).
29
Judicibus17, che nel suo articolo World 2.018 partendo da
quanto già circostanziato da O’Reilly cercò di arrivare ad una
definizione più concisa del Web 2.0. Emblematico l’incipit
del suo articolo: De Judicibus, pur essendo italiano, scrisse in
inglese e motivò la sua scelta definendo la lingua
d’oltremanica come una lingua franca del web. Aggiunse che
la maggior parte delle persone che utilizzavano Internet
capivano l’inglese; inoltre, secondo De Judicibus un articolo
in inglese aveva maggiori probabilità di essere letto ed
eventualmente tradotto rispetto ad articoli scritti in altre
lingue (come l’italiano)19. I punti a sfavore di questa
decisione – ad esempio, l’impossibilità di competere con dei
madrelingua sotto diversi punti di vista – non furono
sufficienti a persuadere De Judicibus a scrivere in italiano.
17 Dario de Judicibus è un consulente certificato di direzione aziendale
della IBM Italia. Inoltre è un inventore (con 5 brevetti) e uno scrittore (2
manuali, 3 saggi, un romanzo, due storie brevi oltre a più di 250 articoli
pubblicati su cartaceo).
http://www.lindipendente.eu/wp/it/author/dejudicibus/ 18 De Judicibus D., World 2.0 in lindipendente.eu, 2 gennaio 2008,
(http://www.lindipendente.eu/wp/it/2008/01/02/world-2-0/). 19 «English is not my first language, and even if I am an Italian writer, I
am not so fluent in English as I am in my own language. So, why did I
write this article in English? Because today English is a sort of lingua
franca of the web. Most of people who use Internet are able to read
English, even if it is not their own first idiom. If you write an article in
English, a lot of people will be able to read it and, if the article is a good
one, someone may decide to translate it to other languages too. But if you
write it in another language, especially a language which is not well-
known in the world as Italian, you have little chances it will be translated
to English even if is an excellent text». Ibidem.
30
(figura 3 – “meme map” del Web 2.0, mostra idee e principi che
si irradiano dal nucleo centrale)
Il Web 2.0 veniva visto da De Judicibus come qualcosa in
continuo movimento e per questo motivo riteneva fosse
necessaria una definizione più generale che delineasse i
caratteri distintivi di questa versione della Rete. Venne mossa
un’altra critica ad O’Reilly: il suo articolo era troppo
incentrato su specifici siti e società20. Invece, scriveva De
Judicibus, il Web 2.0 era piuttosto una piattaforma dove i
20 O’Reilly per chiarire il passaggio tra Web 1.0 e 2.0 e sottolineare le
differenze tra le due versioni si ritrovò ad elencare l’evoluzione di alcuni
software o siti. Ad esempio, da Netscape a Google, da mp3.com a Napster,
da Britannica Online a Wikipedia ecc.
31
cosiddetti prosumers21 diventavano sempre più gli attori
principali: «The user is no more external to the system, but
integral part of it22». Con queste premesse si giunse ad una
definizione: «Web 2.0 is a knowledge-oriented environment
where human interactions generate contents that are
published, managed and used through network applications
in a service-oriented architecture23». Ma quali sono queste
applicazioni che consentono lo scambio dei contenuti
prodotti dagli utenti? Ve ne sono di innumerevoli. A partire
dai blog, le chat, i forum, i wiki24, passando per piattaforme
di condivisione di media come Flickr, YouTube o Vimeo fino
a giungere a social network come Facebook, Myspace,
Twitter, Google+, Linkedin o Foursquare. L’editoria
muovendosi in questo scenario non poteva restare a guardare,
una rivoluzione era in atto e richiedeva la capacità da parte
delle testate di compredere il fenomeno e inserirsi come
meglio possibile. Da questo punto di vista si individuano due
correnti opposte nel mondo del giornalismo. Come scrive
Pratellesi i due fronti schierano gli “apocalittici” da una parte
e gli “ingegneri” dall’altra. I primi vedevano il mezzo
21 Prosumer si forma con l’unione di termini inglesi: producer e consumer.
La parola sta ad indicare un utente che, svincolandosi dal classico ruolo
passivo, assume un ruolo più attivo nel processo che coinvolge le fasi di
creazione, produzione, distribuzione e consumo. Fonte: Wikipedia. 22 «L’utente non è una parte esterna al sistema, ma una parte integrante».
Ibidem. 23 «Il Web 2.0 è un ambiente orientato alla conoscenza dove le interazioni
umane generano contenuti che vengono pubblicati, organizzati e usati
attraverso delle applicazioni in Rete in un’architettura orientata al
servizio». Ibidem. 24 Il wiki è un sito web che permette ai propri utenti di aggiungere,
modificare o cancellare contenuti attraverso un browser web. Fonte:
Wikipedia.
32
elettronico come una minacca per la professione: «troppa
velocità nell’elaborazione delle notizie, scarsa affidabilità
delle fonti, nessuna possibilità di verificare e controllare i
contenuti affidati alla Rete25». I secondi invece erano
incuriositi dalle potenzialità del nuovo mezzo e dalle
prospettive che si aprivano per la professione: «un
giornalismo moderno, rapido, interattivo, multimediale e
ipertestuale26». Fu di fondamentale importanza per le testate
capire che il giornale cartaceo e quello online non fossero
concorrenti, bensì complementari, in grado di soddisfare
rispettivamente momenti diversi della stessa domanda di
informazione. L’editoria online dovette quindi in primo
luogo affrancarsi dalla carta stampata creando delle redazioni
autonome capaci di offrire dei modelli di notizie differenti ed
originali. In seguito, l’evoluzione del Web portò con sé
l’esigenza di allinearsi alla nuova veste della Rete e di
attrezzarsi per soddisfare le richieste di un’utenza non più
passiva, ma desiderosa di recitare un ruolo da protagonista.
L’homepage dei diversi siti cominciò ad essere aggiornata
continuamente affiancandola a sezioni di flash news in
costante cambiamento. Accanto alla parola scritta trovarono
sempre più spazio immagini e video, con questi ultimi spesso
delegati a raccontare una notizia con il solo
accompagnamento di poche righe di didascalia. Venne
incrementata l’ipertestualità con l’inserimento di link anche
all’interno degli stessi articoli che rimandavano a vecchi
contenuti o a pagine esterne. Sul modello del blog, ogni
produzione editoriale ebbe presto la possibilità di venire
commentata e giudicata dagli utenti. Tutte le grandi testate si
25 Pratellesi M., New Journalism, cit., p. 24.
26 Ibidem.
33
dotarono di una pagina Facebook o di un profilo Twitter: un
modo più diretto di raggiungere il lettore. Al piede di ogni
articolo fecero la loro comparsa i cosiddetti sharing buttons
(pulsanti di condivisione social), in grado di consentire
all’utente la condivisione del contenuto editoriale tramite i
diversi social networks. Una vera rivoluzione colpì l’universo
dell’editoria online, uno Tsunami che non risparmiò niente:
la notizia, la professione di giornalista, la redazione.
1.3.1 Come cambia la notizia
«Il medium è il messaggio27». Secondo il sociologo
canadese Marshall McLuhan, a cui va ricondotta la citazione
che apre questo paragrafo, non solo il messaggio, ma anche il
mezzo che veicola il messaggio stesso deve essere oggetto di
studio. Il medium, dice McLuhan, porta con sé un certo tipo
di significato al di là del messaggio che trasmette e questo fa
sì che la percezione del destinatario finale sia in qualche
modo influenzata dal tipo di medium utilizzato. Di
conseguenza mezzi diversi (carta stampata e Internet, nel
caso specifico) richiedono messaggi e prodotti diversi, così
come una fruizione differente. L’informazione veicolata
tramite la Rete si è dovuta inevitabilmente adattare al medium
che la ospitava plasmandosi di conseguenza.
Il giornale cartaceo e quello online, pur prefiggendosi lo
stesso obiettivo informativo, perseguono questa meta
27 «The medium is the message», McLuhan M., Understanding Media:
The Extensions of Man, 1966.
34
secondo logiche e modalità completamente diverse. Dopo
aver difficoltosamente imparato a convivere, le due realtà
editoriali si sono ritagliate i rispettivi spazi. In realtà,
l’informazione elettronica è andata avanti per la propria
strada seguendo un’evoluzione costante di pari passo a quella
del mezzo che la ospitava. La carta stampata invece si è
dovuta, volente o nolente, reinventare in base alla voracità
della controparte online. L’onere del lancio della notizia è
diventato così dominio della Rete, in virtù della capacità del
mezzo di essere aggiornato in qualsiasi momento. Al cartaceo
è rimasto l’approfondimento. La tempestività del giornale
online è stata una delle qualità che hanno riscritto le regole
dell’informazione annullando il gap che allontanava la parola
scritta dalla radio o dalla televisione. Collegandosi sul sito
della principale agenzia di stampa italiana, l’Ansa, è possibile
notare come – ad esempio sfogliando le news del 25 ottobre
2013 – la prima notizia, dal titolo “007 Usa, file su operazioni
con alleati”, sia stata pubblicata alle ore 07:58 (escludendo
quelle pubblicate durante la notte). Il sito è stato poi
aggiornato alle 08:36 (“Spread Btp-Bund apre stabile a 239
punti”); e ancora alle 09:07 (“Moto: Giappone, prove
annullate”), alle 09:10 (“F1: India, prime libere, e' sempre
Vettel”), alle 09:11 (“Borsa: Milano apre in calo -0,6%”) e
alle 09:13 (“Calcio: crac Dos Santos, fermo 6 mesi”): quattro
volte in appena sei minuti. Complessivamente durante la sola
giornata del 25 ottobre 2013 il sito dell’Ansa è stato
aggiornato 69 volte. Questo non vale solo per le agenzie di
stampa, allo stesso modo le versioni online delle testate
cartacee vengono aggiornate ogniqualvolta si presenti la
necessità. Il palese e incolmabile gap della carta stampata
rispetto alla tempestività del mezzo elettronico costringe il
“vecchio giornalismo” principalmente a riportare notizie che
35
il pubblico ha già avuto modo di apprendere. L’editoria
offline punta così sull’approfondimento e sul prestigio del
proprio nome o delle proprie firme.
Strettamente collegata alla tempestività dell’informazione
online è la caratteristica dell’interattività. La possibilità data
all’utente di emanciparsi da uno stato passivo è tipica della
Rete e del Web 2.0 in particolare. In questo senso il mondo
editoriale non fa eccezione, tutt’altro. Non è solamente la
pubblicazione delle notizie ad essere in tempo reale, ma
anche le reazioni dei lettori. E’ il processo stesso di
produzione dell’informazione ad essere sottoposto
nell’immediato al controllo dell’utenza. Il pubblico può ora
commentare immediatamente una notizia, condividerla
tramite i diversi social network, esprimere un parere
articolato a riguardo o semplicemente uno stato d’animo. Si
prenda ad esempio un articolo del Corriere della Sera online:
“Caso Berlusconi e incandidabilità, alt dell’Anm”28. Si tratta
di un pezzo pubblicato il 26 ottobre 2013 dalla redazione
online del Corriere. L’occhiello recita: “Il congresso
dell’associazione magistrati”; mentre il sottotitolo è: “La
necessità della norma dimostra la debolezza della politica
Vietti (Csm): «Basta invasioni di campo da parte delle
toghe»”. Continuando a scendere con lo sguardo (figiura 4),
subito dopo il sottotitolo si può leggere un elenco: etica,
processo Mediaset, Silvio Berlusconi e politica. Si tratta dei
quattro topic29 che è possibile astrarre dall’articolo.
28 Caso Berlusconi e incandidabilità, alt dell’Anm in corriere.it, 26
ottobre 2013, (http://www.corriere.it/politica/13_ottobre_26/berlusconi-
anm-incandidabilita-questione-etica-6b4fe710-3e52-11e3-bd5b-
1a8e5e5a5692.shtml). 29 Temi o argomenti.
36
Cliccando sulla stelletta presente accanto a ciascuno dei temi
si segnala il proprio interesse verso quel determinato
argomento (le cifre indicano il numero di utenti che l’ha
fatto). Cliccando invece direttamente sui topic si viene
rimandati ad un elenco comprensivo di tutti gli articoli che in
passato hanno trattato il medesimo argomento30: una sorta di
aggregatore semantico. Sulla destra, invece, campeggia uno
smile con accanto una percentuale – 62% – e uno stato
d’animo. Sotto al piede dell’articolo (figura 5), al lettore
viene data la possibilità di esprimersi riguardo a quanto
appena letto potendo scegliere tra cinque opzioni: indignato,
triste, preoccupato, divertito, soddisfatto. Questo significa
che il 62% degli utenti si è detto soddisfatto di quanto scritto
nell’articolo. Un sistema di feedback31immediato e bilaterale.
Da una parte la testata può sondare l’umore dei suoi lettori;
dall’altra il pubblico viene gratificato dalla possibilità di
esprimersi e dal semplice fatto che il giornale si preoccupi di
conoscere la sua opinione. Scendendo con lo sguardo rispetto
all’indicatore d’umore (figura 4), si trovano prima una
freccia, poi un’icona di una finestra di dialogo. Cliccando
sulla freccia si apre un rettangolo che mostra quattro simboli
diversi. Il primo dà la possibilità di condividere il contenuto
con la community di Corriere.it; il secondo attiva la
condivisione su Facebook; il terzo rimanda a GooglePlus;
l’ultimo invece a Twitter. Si tratta dei cosiddetti sharing
buttons, un ponte tra un determinato link e il mondo dei social
network. Cliccando invece sulla finestra di dialogo si viene
reindirizzati nella stessa pagina, al piede dell’articolo, nella
sezione commenti (figura 5). Poco più sotto (figura 4) viene
30 Si tratta di un esempio dell’ipertestualità di Internet e del giornalismo
online, su cui si tornerà più avanti. 31 Commento od opinione.
37
data la possibilità – se registrati al sito – di salvare l’articolo
in una lista per poi leggerlo in un’altra occasione. Infine, il
lettore può ascoltare il file audio dell’articolo, stamparlo o
inviarlo per posta elettronica. Tornando al piede dell’articolo
(figura 5), è doveroso soffermarsi nuovamente sulla sezione
commenti. Si tratta di un sistema d’espressione articolato che
consente ai lettori di pubblicare la propria opinione e di
discutere con altri utenti. Il giornale offre così uno spazio che
permette al pubblico di uscire dalla ricezione passiva32.
(figura 4 – Il titolo, i topic, l’indicatore d’umore, gli sharing
buttons)
32 Gli utenti possono inoltre votare i commenti degli altri: il contributo più
votato ottiene uno spazio di rilievo al di là dell’ordine cronologico.
38
(figura 5 – l’indicatore d’umore e la sezione commenti)
Altra importante caratteristica della notizia online è
l’ipertestualità. Il termine ipertesto venne coniato nel 1965 da
Ted Nelson33, il quale diede questa definizione: «By
hypertext I simply mean non-sequential writing. Text that
branches and allows choices to the reader, best read at an
interactive screen. As popularly conceived, this is a series of
text chunks connected by links which offer the reader
different pathways34». La prima comparsa dell’ipertesto è nel
33 Theodor Holm Nelson è un sociologo, filosofo e pioniere
dell'informatica statunitense. Oltre alla coniazione del termine
ipertesto,Nelson fondò il progetto Xanadu nel 1960 con l'intento di creare
una rete di computer collegati e dotati di un'interfaccia utente semplice.
Fonte: Wikipedia. 34 «Un tipo di scrittura non sequenziale, un testo che si dirama e concede
delle scelte al lettore, meglio se letto su di uno schermo interattivo. Come
generalmente concepito, si tratta di una serie di pezzi di testo connessi
tramite dei collegamenti che offrono al lettore differenti percorsi». Nelson
T., Literary Machines, Mindful Press, 1980.
39
saggio chiamato A File Structure for the Complex, the
Changing, and the Indeterminate; ««Let me introduce the
word “hypertext” to mean a body of written or pictorial
material interconnected in such a complex way that it could
not conveniently be presented or represented on paper35».
Altro importante contributo nella definizione di ipertesto
viene da George Landow36: «Text composed of blocks of
words (or images) linked electronically by multiple paths,
chains, or trails in an open-ended, perpetually unfinished
textuality described by the terms link, node, network, web,
and path37». Simile alla definizione di Landow e molto
pertinente rispetto all’ipertestualità di Internet è quella che
Jakob Nielsen38 inserisce nel suo lavoro The Art of
Navigating Through Hypertext: «Hypertext is non-sequential
writing: a directed graph, where each node contains some
amount of text or other information[…]. True hypertext
should also make users feel that they can move freely through
the information according to their own needs. This feeling is
hard to define precisely but certainly implies short response
35 «Lasciatemi introdurre il termine “ipertesto” per indicare un corpo di
materiale scritto o visivo interconnesso in un modo così complesso che
non potrebbe venire presentato o rappresentato convenientemente su
carta». Nelson, T., A File Structure for the Complex, the Changing, and
the Indeterminate. 36 Professore della Brown University e tra i principali teorici
dell’ipertestualità. 37 «L’ipertesto è un testo composto da blocchi di parole (o immagini)
connessi elettronicamente secondo percorsi molteplici in una testualità
aperta e perpetuamente incompiuta descritta dai termini collegamento,
nodo, rete, tela, percorso». Landow G., The Definition of Hypertext and
Its History as a Concept. 38 Jakob Nielsen è un informatico danese, autore di Hypertext and
Hypermedia.
40
times and low cognitive load when navigating39». Sono
diversi gli aspetti che distanziano testo e ipertesto. In primo
luogo la non sequenzialità della struttura dell’ipertesto e della
fruizione degli utenti. Questi ultimi possono costruire i propri
percorsi interpretativi originali muovendosi attraverso i
diversi collegamenti ipertestuali (in inglese hyperlink, spesso
abbreviati in link) che consentono di sposarsi da un’unità
informativa ad un’altra. La possibilità di scegliere
consapevolmente come fruire l’ipertesto descrive un’altra
qualità invece assente nel testo tradizionale: l’interattività. Un
ipertesto è inoltre caratterizzato da indefinitezza in quanto
concepito per essere modificato e personalizzato. Bisogna
infine sottolineare come, rispetto al testo, l’ipertesto possa
includere non solo la parola scritta ma anche componenti
sonore (linguaggio verbale orale, musica o qualunque altro
tipo di suono) e visive (statiche come le immagini o dinamici
come i filmati). Per questa sua componente multimediale,
l’ipertesto può essere anche chiamato ipermedia40.
Restringendo l’analisi al campo editoriale, un giornale online
ha qualità ipermediali, così come ogni articolo in esso
contenuto. Si prenda ad esempio un articolo pubblicato su
Corriere.it il 28 ottobre 2013: “«San Giuda» terrorizza Gb,
Olanda e Francia. «Tempesta perfetta»: caos trasporti e black
39 «L’ipertesto è scrittura non sequenziale: un digrafo dove ogni nodo
contiene un certo quantitativo di testo o altro tipo di informazione[…]. Un
vero ipertesto dovrebbe sempre far sentire gli utenti che possono muoversi
liberamente attraverso l’informazione in base ai loro bisogni. Questa
sensazione è difficile da definire precisamente ma certamente implica
tempi di risposta brevi e uno sforzo cognitivo non eccessivo». Nielsen J.,
The Art of Navigating Through Hypertext. 40 Anche questo termine fu coniato da Ted Nelson nel 1965.
41
out”41. L’ipermedialità del contenuto è mostrata in entrambe
le immagini che seguono (figura 6 e figura 7). Nella prima
(figura 6), in basso a destra, si può notare un collegamento
ipertestuale che rimanda ad un articolo del 29 ottobre 2012
(“Due milioni senza luce. Sandy è a New Yotk. Cuomo:
«Almeno cinque morti»42). Si tratta di una notizia correlata:
la tempesta che un anno prima si abbatté su New York.
L’immagine mostra inoltre un contenuto visivo e un link per
uno contenuto audio: cliccando su “Ascolta” è infatti
possibile ascoltare la lettura dell’articolo nella sua interezza.
Nella seconda invece (figura 7) viene mostrata la presenza di
un video nel corpo dell’articolo. Mentre sulla destra si
trovano i collegamenti per la sezione “Multimedia” dove
sono raccolti altri filmati che trattano la stessa notizia.
41 «San Giuda» terrorizza Gb, Olanda e Francia. «Tempesta perfetta»:
caos trasporti e black out in corriere.it, 28 ottobre 2013,
(http://www.corriere.it/esteri/13_ottobre_28/san-giuda-terrorizza-
francia-gran-bretagna-tempesta-perfetta-caos-trasporti-black-out-
80b06d06-3fa5-11e3-9fdc-0e5d4e86bfe5.shtml). 42 Due milioni senza luce. Sandy è a New Yotk. Cuomo: «Almeno cinque
morti» in corriere.it, 29 ottobre 2012,
(http://www.corriere.it/esteri/12_ottobre_29/sandy-raggiunge-new-
york_178c5b50-220f-11e2-867a-35e5030cc1c9.shtml).
42
(figura 6 – contenuti scritti, visivi, sonori e link ipertestuali)
(figura 7 - filmati nel corpo dell’articolo e sezione multimedia)
In Rete la notizia diventa multimediale. Un nodo di un
ipertesto – il giornale – che è a sua volta parte di un altro
ipertesto: il Web. La fruizione da parte dell’utente non è più
rigida come quella offerta dalla carta stampata: il lettore ha il
43
potere di scegliere il proprio percorso interpretativo e di
personalizzare la propria esperienza.
Data la natura sconfinata di Internet e l’ipermedialità che
consente all’utente di costruire il proprio modello di
fruizione, il rischio sarebbe quello di smarrirsi in
quest’universo di dati e di nodi tra loro collegati. Sono i
“motori di ricerca” (search engine in inglese) ad aiutare il
navigatore nel reperimento delle informazioni desiderate
(information retrieval, spesso abbreviato in IR). In primo
luogo un motore di ricerca scandaglia il Web (o una porzione
dello stesso) tramite dei bot43 chiamati crawler (o spider). Il
lavoro dei crawler si basa su una lista di indirizzi fornita dal
motore di ricerca stesso (il search engine sfrutta a sua volta
liste create tramite gli indirizzi suggeriti dagli utenti o liste
stilate dai programmatori stessi). Mentre analizzano un sito, i
crawler acquiscono gli indirizzi di tutti i collegamenti
ipertestuali presenti, i quali vengono a loro volta aggiunti alla
lista di URL44 da visitare. Le pagine analizzate vengono
inseriste nel database e nell’indice del motore di ricerca.
Questi bot acquisiscono inoltre una copia testuale di quanto
visitato, che viene poi utilizzata per fornire risposte alle
ricerche degli utenti. Le fasi di scansione, indicizzazione e
risposta vengono così sintetizzate da Google, il principale
motore di ricerca presente attualmente sul Web:
«Il Web è come una biblioteca pubblica in costante
espansione con miliardi di libri e senza gestione
43 Un programma o script che automatizza delle operazioni 44 Uniform Resource Locator o URL è una sequenza di caratteri che
identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet.
44
centralizzata. Fondamentalmente Google raccoglie le
pagine durante la procedura di scansione, dopodiché
crea un indice per sapere esattamente come cercare le
informazioni. In modo del tutto simile all'indice in
fondo ai libri, l'indice di Google include informazioni
sulle parole e sulle loro posizioni. Quando esegui una
ricerca, i nostri algoritmi, per dirla in modo molto
elementare, cercano i termini di ricerca nell'indice per
trovare le pagine appropriate.
Da questo momento il processo di ricerca diventa
molto più complesso. Se cerchi la parola "cani"
sicuramente non ti interessa trovare una pagina
contenente centinaia di volte la parola "cani". Potresti
voler trovare immagini, video o un elenco di razze. I
sistemi di indicizzazione di Google rilevano tanti
aspetti diversi delle pagine, ad esempio la data di
pubblicazione, se contengono o meno foto e video e
tanti altri fattori. Con il Knowledge Graph45
continuiamo ad andare oltre la corrispondenza delle
parole chiave per comprendere meglio le persone, i
luoghi e gli argomenti che ti interessano46».
Un sito Internet deve essere visitato per sopravvivere. In
questo senso l’indicizzazione e una posizione di rilievo nelle
45 Per Knowledge Graph (in italiano “grafico della
conoscenza”) si intende una funziona introdotta da Google
nel 2012. Grazie a questa funzione, il motore di ricerca di
Google associa alle parole cercate un oggetto e metterà in
relazioni oggetti in modo da avere una ricerca più veloce e
accurata: un primo passo verso la ricerca semantica. 46
http://www.google.it/intl/it/insidesearch/howsearchworks/
crawling-indexing.html
45
ricerche dei search engine assumono una grande importanza.
Se questo discorso può adattarsi alla realtà di grandi testate,
ancor meglio descrive la situazione di siti che non godono
della stessa fama. Il posizionamento nei motori di ricerca può
cambiare radicalmente il destino di un progetto. Non
sorprendono di conseguenza gli sforzi compiuti in tal senso.
Negli ultimi anni è entrato nel linguaggio comune un
acronimo: SEO, search engine optimization. SEO indica una
serie di attività volte ad aumentare il traffico di un sito
attraverso un miglior posizionamento nei motori di ricerca. Si
tratta di una branca della più ampia SEM, search engine
marketing (marketing per i motori di ricerca). SEO è
innanzitutto keyword (parole chiavi):
«L’attività del motore di ricerca è, principalmente,
analizzare le pagine web, assimilarne il contenuto,
separarlo in keyword e assegnare ad ognuna di loro un
punteggio che, complessivamente, sarà il punteggio
della pagina stessa
La prima analisi da effettuare è quindi lo studio di
quale contenuto informativo vogliamo e possiamo
offrire e progettarlo in modo da ottenere la maggior
attenzione possibile dal motore di ricerca47».
47 Le basi della SEO in seosempmi.it, 25 aprile 2011,
(http://seosempmi.it/seo-base/).
46
Altro aspetto cruciale è rappresentato dalle cosiddette
metatag:
«Tutti abbiamo presente come funziona Google.
Inseriamo una keyword, inviamo e ne leggiamo i
risultati. La prima cosa su cui cade la nostra attenzione
è il titolo. Il titolo viene descritto dal metatag TITLE
all’interno dell’HEAD della pagina. E’ fondamentale
avere dei titoli esplicativi, comprensibili, chiari, con
le keyword cercate dall’utente e che siano formattate
secondo un modello che Google possa capire e
restituire al meglio. Stessa cosa per le descrizioni. Il
tag DESCRIPTION, sempre nell’HEAD della pagina,
è un tag che deve contenere dalle 5 alle 15 parole
chiave che voi avete identificato come principali per
quella pagina48».
Esistono altri aspetti SEO altrettanto importanti (la scelta
del dominio o la scrittura del codice HTML, ad esempio), ma
non strettamente correlati a questa ricerca. Keyword, metatag
e il loro corretto impiego invece assumono un ruolo di primo
piano nella stesura di un contenuto editoriale in Rete. Si è
visto in che modo sia cambiata la notizia una volta approdata
online: il medium ospitante ha innanzitutto richiesto diverse
tempistiche; i contenuti si sono fatti più interattivi,
un’apertura al giudizio e all’intervento del pubblico,
precedentemente relegato ad un ruolo passivo; la notizia è
inoltre diventata un nodo di un ipertesto non sequenziale e
dalle proprietà multimediali; infine la necessità dei siti di
48 Ibidem.
47
essere ben pozionati nei motori di ricerca ha fatto sì che
l’informazione si plasmasse anche in accordo all’inserimento
di keyword e metatag. Come hanno modificato il mestiere di
giornalista questi cambiamenti nella struttura e nella stesura
di una notizia? Qual è l’approccio del professionista rispetto
al nuovo medium? Quali le differenze rispetto al lavoro del
collega della carta stampata? Si cercherà di rispondere a
queste ed altre domande nelle prossime pagine, dedicate alla
figura del new journalist.
1.3.2 New journalist
Nel corso della sua storia ultracentenaria, la professione
giornalistica si è dovuta adattare a molteplici situazioni figlie
di nuove scoperte e dell’evoluzione tecnologica.
Dall’invenzione della stampa, passando per l’avvento dei
quotidiani, la rivoluzione industriale, la nascita delle agenzie
di notizie, fino all’invenzione del telegrafo prima, del
telefono poi. La radio, la televisione, infine quella che Marco
Pratellesi chiama “la prima rivoluzione digitale49”. Iniziata
negli anni ottanta con l’introduzione dei videoterminali nelle
redazioni, si trovò suo malgrado ad essere spartiacque tra
“vecchio” e “nuovo”. Molti giornalisti, racconta Pratellesi,
non vollero adattarsi, in particolar modo quelli più anziani.
Troppo affezionati alla macchina da scrivere attraverso cui
avevano raccontato l’Italia del Dopoguerra, voltarono le
spalle all’evoluzione tecnologica. Altri, comunque diffidenti
ma più malleabili, accettarono l’introduzione dei
49 Pratellesi M., New Journalism, cit., p. 27.
48
videoterminali utilizzandoli però né più né meno che come
macchine da scrivere. Le funzionalità più rivoluzionarie dei
pc, in grado di cambiare le regole del mestiere, vennero
sfruttate principalmente dai giovani giornalisti provenienti
dalle università. Negli anni novanta, poco prima
dell’esplosione del mezzo che avrebbe stravolto per sempre
la professione, la digitalizzazione aveva già preso il
sopravvento. L’avvento di Internet poco prima della fine del
millennio viene considerata da Pratellesi la “seconda
rivoluzione digitale”. «Le prospettive di un cambiamento così
radicale e profondo […] spaventarono non poco la categoria.
Tra gli apocalittici si iscrissero anche giornalisti di ampie e
aperte vedute, come Giorgio Bocca, che vedevano nella
nuova dimensione la fine della professione50». La professione
non è certo morta, ma è innegabile che sia cambiata e abbia
dovuto fare i conti con l’avvento del Web. Al giornalista
online è stato richiesto di coltivare capacità e apprendere
nozioni che non erano necessarie per svolgere lo stesso lavoro
sulle testate cartacee. A tal proposito è interessante riportare
quanto pubblicato da Mindy McAdams51 sul suo blog52 il 7
ottobre del 2008. La professoressa ha chiesto ai suoi lettori di
aiutarla nella compilazione di una lista di cose che uno
studente al termine di un corso di giornalismo online
dovrebbe saper fare53. L’articolo è stato ripreso anche da
50 Ibidem. 51 Mindy McAdams è una professoressa dell’Università della Florida,
dove insegna giornalismo online. 52 http://mindymcadams.com/ 53 Mindy McAdams sottolinea come non si parli di semplici abilità,
quanto di un “saper fare”. «Rather than a vague list of skills, we’re trying
to write what we would expect the student to be able to do. You know —
actually DO». http://mindymcadams.com/tojou/2008/stuff-to-teach-the-
next-journalists/
49
Mario Tedeschini Lalli54 nel suo blog55 l’8 ottobre 2013.
Secondo Mindy McAdams uno studente dovrebbe quindi
essere in grado di:
«scrivere un articolo di 40/50 righe in stile
Associated Press56, con titolazione adatta al
web57, sottotoli e link ipertestuali dove utili;
creare un servizio audio di due minuti che
contenga suono naturale (effetti), narrazione
dell’autore e materiale tratto da interviste, che
sia montato digitalmente e compresso in
formato web;
riprendere, montare e comprimere un video di
due minuti e mezzo;
creare e alimentare per almeno otto settimane
un blog su un singolo, specifico argomento
con almeno due post a settimana;
54 Vicedirettore, direzione Innovazione e Sviluppo, Gruppo Editoriale
L’Espresso. Fino all’ottobre 2008 caporedattore Multimedia, Kataweb,
Gruppo Espresso. Da oltre 35 anni in tv, agenzie di stampa, quotidiani e
sul web. Docente di Giornalismo digitale, Istituto per la Formazione al
Giornalismo a Urbino e di Storia del Giornalismo e delle Comunicazioni
di massa all’Università Roma Tre.
http://mariotedeschini.blog.kataweb.it/chi-sono/ 55
http://mariotedeschini.blog.kataweb.it/giornalismodaltri/2008/10/08/gior
nalisti-online-che-cosa-debbono-saper-fare/ 56 Notizia in testa, citazioni delle fonti, astensione da giudizi e
aggettivazioni personali, struttura a piramide rovesciata. 57 Titoli che siano interpretabili facilmente dai motori di ricerca (SEO,
tagging, e che significhino ancora qualcosa quando vengono letti fuori dal
contesto della pagina originaria).
50
creare una presentazione con Soundslides58 di
un minuto e mezzo/due minuti che racconti in
modo coerente una storia di interesse
giornalistico59».
Mario Tedeschini Lalli raccoglie anche alcuni commenti
dei lettori, i quali hanno inoltre proposto:
«Microblogging (Twitter)
Computer assisted research (CAR), uso di
fogli di calcolo e database.
Gestione dei metadati ai fini di ricerca e di
promozione dei propri materiali.
58 Soundslides è un software che consente la creazione di
Slideshows, una combinazione di immagini statiche e
registrazioni audio. Fonte: Wikipedia. 59 Traduzione da
http://mariotedeschini.blog.kataweb.it/giornalismodaltri/2
008/10/08/giornalisti-online-che-cosa-debbono-saper-
fare/. Testo originale: «Write a 12-inch story (400–450
words) in AP print style w/ Web-appropriate head,
subheads and suitable hyperlink(s). Create a 2-minute
audio clip with clear nat sound, narration and interview
material, edited digitally and compressed for the Web.
Shoot, edit and compress a video of 2 min. 30 sec. Create
and maintain a single-subject blog for at least eight weeks
(minimum 16 posts), with at least two posts per week.
Create a 1:30 to 2 min. Soundslides presentation that tells a
coherent journalistic story». McAdams M., Stuff to teach
the next journalists in mindymcadams.com, 7 ottobre 2008,
(http://mindymcadams.com/tojou/2008/stuff-to-teach-the-
next-journalists/).
51
Narrazioni che comprendano materiale
generato dagli utenti (UGC) e mashup, come
sondaggi, mappe cliccabili, grafici e timelines
— se c’è tempo.
Scrivere una notizia tipo ultimora, massimo
di tre frasi, senza errori, in cinque minuti con
il materiale a disposizione60».
E’ sufficiente leggere questo elenco per comprendere
quanto la professione si sia rinnovata nel passaggio dalla
carta stampata alla Rete. Al giornalista che lavora per delle
testate online si richiedono competenze e conoscenze che con
ogni probabilità non sono in possesso di molti professionisti
che operano offline. Emblematiche le parole di Luca De
Biase61:
«In questo contesto, il giornalista deve avere qualità
specifiche da artigiano (saper fare, originalità,
affidabilità), conoscere le tecnologie digitali perché
queste sono il suo nuovo contesto operativo, imparare
a parlare con designer e softwaristi, essere efficiente
60 Tedeschini M., Giornalisti online: che cosa debbono
saper “fare”? in mariotedeschini, 8 ottobre 2008,
(http://mariotedeschini.blog.kataweb.it/giornalismodaltri/2
008/10/08/giornalisti-online-che-cosa-debbono-saper-
fare/).
61 Luca De Biase insegna “Giornalismo e nuovi media” in
diverse università italiane tra cui lo Iulm di Milano. E’
inoltre Editor di innovazione al Sole 24 Ore e Nova24 (del
quale è stato fondatore) ed editor della Vita Nòva, magazine
per tablet.
52
per adeguarsi al sistema di costi limitati che il nuovo
contesto impone, avere una sorta di significato
pubblico (dalla notorietà al carisma), svolgere un
servizio che ne motiva l’adozione e conoscere le
proprie responsabilità civiche. Soprattutto deve
sincronizzarsi con il movimento generato
dall’innovazione e se ci riesce partecipare attivamente
a tale movimento. Una professionalità profondamente
rinnovata, non nuova nelle sue finalità di fondo, ma
aggiornata per avere un posto nella contemporaneità.
Si ha l’impressione che tutto questo sia perfettamente
possibile. Certo, si tratta di un cambiamento che
richiede una profonda umiltà62».
Il giornalista online lavora innanzitutto con tempestiche
completamente diverse rispetto al collega del cartaceo. La
ristrettezza dei tempi e l’esigenza di essere costantemente
aggiornati, oltre alla forsennata ricerca dell’anticipo rispetto
alla concorrenza mettono a serio rischio la possibilità di
revisionare un articolo e di conseguenza la qualità dello
stesso. Il flusso di informazioni è inoltre quantitavamente
imponente. Alle fonti tradizionali si aggiungono quelle del
Web, come possono essere il social network Twitter o
l’enciclopedia libera di Wikipedia. Il rischio di incappare nel
disorientamento e nell’errore è dietro l’angolo. Diviene di
fondamentale importanza la capacità del giornalista di
districarsi nell’universo della Rete, oltre che nella realtà di
tutti i giorni. Il professionista deve fuggire le trappole della
62 De Biase L., Chi vuole fare il giornalista: un mestiere da
innovatori in blog.debiase.com, 3 dicembre 2012,
(http://blog.debiase.com/2012/12/chi-vuole-fare-il-
giornalista-un-mestiere-da-innovatori/).
53
velocità e della copiosità del flusso di informazioni. Come
sostiene Richard Rogers63, intervistato da Lettera43.it64 il 22
ottobre 2013 in occasione dell’Internet Festival di Pisa, «i
reporter devono saper discernere, anziché fare eccessivo
affidamento su fonti sbagliate e dare un'informazione poco
accurata65». Ancor più che in passato il lavoro di verifica
ricopre un ruolo cruciale nella selezione, nell’organizzazione
e nella stesura delle notizie. Gerarchizzare diviene uno dei
compiti principali del giornalista, come sottolinea Emilio
Carelli nel suo Giornali e giornalisti nella rete: «L’overload66
dei flussi informativi, che male si concilia con la scarsa
disponibilità di tempo a disposizione degli utenti per
informarsi, potrebbe rimettere in gioco la centralità del
giornalista nella sua funzione di selezione e creazione di una
gerarchia delle notizie».
Rivoluzionato sotto molteplici aspetti, il ruolo del
giornalista online è caratterizzato da un rapporto con i lettori
completamente stravolto rispetto al passato. L’utente non ha
solamente la possibilità di inserirsi nel processo informativo
“costruendo” un ponte che possa collegarlo alla testata (ad
esempio la sezione commenti); giornalisti e pubblico possono
instaurare un rapporto direttto sfruttando quanto offerto dai
63 Richard Rogers è un epistemologo di Internet, tra i maggiori esperti di
metodi digitali. Rogers è docente di New media dell'Università di
Amsterdam, ex ricercatore di Harvard in Computazione strategica e
autore di Digital Methods. 64 Lettera43.it è un quotidiano online. http://www.lettera43.it 65 Ciolli B., Internet e informazione, come cambia il giornalismo secondo
Richard Rogers in lettera43.it, 22 ottobre 2013,
(http://www.lettera43.it/tecnologia/web/internet-e-informazione-come-
cambia-il-giornalismo-secondo-richard-rogers_43675111299.htm). 66 Letteralmente “sovraccarico”.
54
social network. Tra questi, il più amato dai professionisti è
Twitter67. Il termine deriva dall’inglese to tweet, che significa
cinguettare68 (il sostantivo tweet significa cinguettio) e sta ad
indicare la modalità di funzionamento del sito. Si tratta infatti
di un servizio gratuito di social network e microblogging69
che consente agli utenti registrati di gestire una pagina
personale e di inviare brevi messaggi di testo dalla lunghezza
massima di 140 caratteri (i tweet). Presentato al pubblico il
15 luglio del 2006, ha avuto bisogno di tempo per affermarsi.
L’inizio dell’ascesa è da collocarsi nel 2007, quando in
occasione della South by Southwest Interactive conference70
Twitter riuscì a triplicare il proprio flusso di messaggi
passando da 20.000 a 60.000 tweet giornalieri. Un evento
epocale per il social network inerentemente all’Italia si è
verificato il 29 gennaio 2012, in concomitanza con la morte
dell’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
Come riporta un articolo di Corriere.it, la notizia della
scomparsa è stata data tramite Twitter con largo anticipo
rispetto ad ogni altro mezzo d’informazione: «Il presidente
emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, è morto nella
notte nella sua abitazione di Roma. Aveva 93 anni. La notizia
67 https://twitter.com/ 68 Il simbolo del social network è difatti un uccellino. 69 «Il microblogging (o micro-blogging o micro blogging) è una forma di
pubblicazione costante di piccoli contenuti in Rete, sotto forma di
messaggi di testo (normalmente fino a 140 caratteri), immagini, video,
audio MP3 ma anche segnalibri, citazioni, appunti. Questi contenuti
vengono pubblicati in un servizio di rete sociale, visibili a tutti o soltanto
alle persone della propria comunità». Fonte: Wikipedia. 70 South by Southwest (SXSW) è un festival musicale e cinematografico,
composto anche di un insieme di conferenze e mostre interattive, che ha
luogo ogni primavera ad Austin, la capitale del Texas, dal 1987. Fonte:
Wikipedia.
55
del decesso è stata diffusa inizialmente via Twitter, alle 8.07,
da Alberto Gambino, un giurista, che è stato anche
collaboratore dell'ex capo di Stato71». Con Twitter si assiste
ad uno slittamento in cui la voce informativa non è più quella
delle testate (pur presenti sul social network), bensì quella dei
singoli giornalisti. La personalizzazione dell’informazione è
un fenomeno già piuttosto diffuso e non riconducibile
solamente a Twitter (si pensi ai blog). A tal proposito è
interessante segnalare il panel tenutosi durante il Festival
Internazionale del Giornalismo al Centro Servizi Alessi dal
titolo: “Twitter e Giornalismo personale: lo scenario
italiano”72. Andata in scena durante la prima giornata del
Festival, il 24 aprile 2013, al discussione ha visto come
protagonisti Fabrizio Goria, de Linkiesta73; Andrea Iannuzzi,
direttore AGL74; Dennis Redmont, giornalista e scrittore. A
moderare il dibattito Mauro Turcatti, di Edelman75, il quale
propone un sondaggio: “Twitter ucciderà le agenzie di
stampa?”. L’incontro ha fatto affidamento su di una ricerca
condotta da Edelman che ha aperto il panel presentando dei
dati riguardanti l’utilizzo di Twitter su un campione di 2000
71 È morto l'ex presidente Oscar Luigi Scalfaro in corriere.it, 29 gennaio
2012, (http://www.corriere.it/politica/12_gennaio_29/morto-oscar-luigi-
scalfaro_7d0ca31e-4a55-11e1-bc89-1929970e79ce.shtml). 72 Twitter e giornalismo personale: lo scenario italiano, 24 aprile 2013,
in festivaldelgiornalismo.com
(www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013/twitter-and-
personalised-journalism-the-italian-scenario). 73 Un quotidiano online, testata registrata dal 2010.
http://www.linkiesta.it/ 74 Agenzia Giornali Locali, un’agenzia giornalistica del gruppo Espresso. 75 «Edelman è la più grande azienda di pubbliche relazioni al mondo»
(«Edelman is the world’s largest public relations firm»)
http://www.edelman.com/.
56
giornalisti iscritti. Queste alcune informazioni raccolte76: il
70% dei giornalisti presenti sul social network è di sesso
maschile, solo il restante 30% è invece di sesso femminile; la
grande maggioranza dei professionisti utilizza la lingua
italiana per comunicare (solo 1 su 6 tenta la via dell’inglese);
gli account verificati rappresentano appena lo 0,4% del
campione totale (stessa percentuale per i profili privati
rispetto a quelli pubblici); il 40% degli account non rimanda
a link Url: tra questi il 45% inserisce il link di una pagina
personale; il 24% , meno evoluto nell’attività di personal
branding, rimanda alla rubrica in cui scrive, mentre il restante
5% al profilo su Facebook e il 6% è composto dai direttori
dei giornali; la maggior parte degli iscritti è presente su
Twitter da circa 2 anni; la frequenza per il 75% si attesta a
cinque tweet al giorno. L’incontro ha tracciato virtù e vizi
del social network: Sei sono le virtù: breaking news; fonti; i
fact checking; i testimoni di un evento attraverso twitter e la
facilità con la quale si distribuiscono contenuti. Sette invece
i vizi “capitali” del social: superbia, avarizia, lussuria,
invidia, gola, ira ed infine accidia. Un intervento di grande
interesse è stato quello di Andrea Iannuzzi, che ha parlato
delle diverse tempistiche dei nuovi media, dei rischi e delle
precauzioni da seguire quando si lavora sul Web:
«I singoli giornalisti hanno la libertà di twittare notizie
o presunte notizie non verificate, prima delle agenzie,
perché quest’ultima deve fare verifiche che il singolo
giornalista può non fare, con un basso rischio di brutta
figura. Il concetto di concorrenza, con la rete, deve
cambiare a vantaggio della collaborazione, per avere
76 http://www.slideshare.net/mauro.turcatti/edelman-twitterijf13
57
una informazione migliore. Non c’è motivo per farsi
la guerra, consapevole che non sia un concetto
diffuso. L’utente consulta più fonti. Non si ricorda
nessuno chi ha twittato per primo. Vale di più la
fiducia. Nel metodo di lavoro le notizie mi arrivano su
Twitter e poi guardo le agenzie per trovare
conferme77».
Concretamente, come lavora il giornalsita online? Come
scrive Pratellesi78, nonostante spesso non godano di grande
stima da parte dei colleghi della carta stampata, le redazioni
delle testate presenti sul Web svolgono grossomodo lo stesso
lavoro di quelle offline. Anzi, «le redazioni online sono uno
dei pochi luoghi dove ancora i giornalisti partecipano in
prima persona alla creazione del giornale. Un divertimento
che molti avevano dimenticato, stritolati nei meccanismi da
catena di montaggio che si sono impossessati delle
redazioni79». Allo stesso modo dei giornalisti delle testate
cartacee, quelli online seguono le agenzie di stampa,
navigano sui siti e sui giornali online internazionali in cerca
di spunti e articoli da riportare, fanno interviste, utilizzano il
telefono o si recano sul posto a seconda delle esigenze. E’
cambiato il modo di lavorare, prosegue Pratellesi, non la
professione, che si svolge sostanzialmente seguendo lo stesso
fil rouge: cercare, verificare, dare le notizie. C’è bisogno di
tempo per superare la diffidenza verso il nuovo mezzo, a quel
77 Twitter e giornalismo personale: lo scenario italiano, 24
aprile 2013, in festivaldelgiornalismo.com
(www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013/twitte
r-and-personalised-journalism-the-italian-scenario). 78 Pratellesi M., New Journalism, cit., p. 41 79 Ibidem.
58
punto, sostiene Pratellesi, non ci sarà più bisogno di utilizzare
l’aggettivo “online”. Tutti saranno indistintamente
giornalisti. Tuttavia, come già accennato in precedenza, la
vita delle redazioni online è diversa da quella delle redazioni
cartacee. Sono spesso i caporedattori a guidare le redazioni
online. La differenza principale con le controparti offline è
l’apertura 24 ore su 24: i giornali in Rete non hanno infatti
una versione definitiva ma vengono costantemente aggiornati
in base alle esigenze informative. Altra caratteristica delle
redazioni online, come sottolinea Pratellesi, è la mancanza di
una rigida divisione delle mansioni. Ogni componente del
gruppo deve essere in grado di prendere delle decisioni, per
questo si cerca di avere strutture il più orizzontali possibile.
Pratellesi descrive le due figure professionali che insieme
contribuiscono alla realizzazione dei giornali online:
giornalisti e tecnici-operatori web, i quali si ritrovano a lavoro
fianco a fianco80. I primi devono aggiungere alle fonti
tradizionali (agenzie, fonti dirette, sia ufficiali che
confidenziali) quelle tipiche della Rete (motori di ricerca,
giornali, fonti di informazione ufficiali nazionali e
internazionali). I giornalisti, aggiunge Pratellesi, sono anche
responsabili dell’adattamento della notizia all’ipermedialità
del Web: sono loro a scegliere le immagini ed eventualmente
i filmati da inserire, così come i link ipertestuali. Gli operatori
web invece si occupano della componente tecnica e grafica
lavorando con i vari linguaggi del Web: Html, Xml, Flash,
Javascript. Queste figure professionali realizzano grafici
interattivi, predispongono i sondaggi online suggeriti dalla
redazione, curano il motore di ricerca, l’archivio e gestiscono
80 Sottolinea giustamente Pratellesi (New Journalism, cit., p. 58) come nel
giornale tradizionale la redazione e la tipografia siano rigidamente
separate.
59
in generale tutti gli aspetti inerenti alla fruibilità e alla
leggerezza del sito.
Secondo Pratellesi la divisione tra giornalisti online e della
carta stampata è destinata a scomparire: «sarà la stessa
evoluzione tecnologica ad abbattere divisioni e steccati tra
giornalisti di carta e giornalisti online81». La divisione – dice
Pratellesi – esiste sono nel momento in cui i primi non sanno
usare il sistema che consente di editare i giornali su Internet,
mentre i secondi sì. «Nella sfida dell’aggiornamento in tempo
reale, gli editori hanno sempre più bisogno di contenuti
online. Non per questo vorranno creare redazioni così
numerose da risultare un doppione di quelle che lavorano per
la carta82». La strada – sostiene Pratellesi – è quella di mettere
a punto sistemi editoriali che consentano di editare articoli e
foto tanto per il Web quanto per la carta stampata. Al direttore
resterebbe la scelta del medium su cui pubblicare un pezzo: a
quel punto la distinzione tra online ed offline verrebbe meno.
Tuttavia, ad alcuni anni di distanza dalla pubblicazione di
New Journalism, la situazione non sembra avere ancora
raggiunto lo stato previsto da Pratellesi. La Rete e la carta
stampata si muovono secondo logiche differenti e la
distinzione tra giornalista digitale e professionista
dell’inchiostro permane. Soprattutto, esiste un universo
editoriale intricato in Internet al di fuori delle grandi testate.
Lo individua anche Pratellesi, definendolo come la “terza
via”83. Il dibattito riguardante la dignità del giornalismo
81 Pratellesi M., New Journalism, cit., p. 42 82 Ibidem. 83 «Tra giornalisti di carta e giornalisti online sta nascendo una terza figura
con scarsa o nessuna esperienza giornalistica, ma molto abilità
internettiana. Questa terza via sembra entusiasmare alcuni editori,
60
online appare quindi ancora vivo e per questo verrà affrontato
nelle pagine che seguono.
1.3.3 La dignità del giornalismo digitale
La Rete ha creato nuove figure professionali. Il giornalista
che si trova a lavorare su Internet vede i propri contorni
sbiadirsi, perso tra blog, citizen journalism, social network,
piccole realtà editoriali. E ancora articolisti, web writers,
freelance. La commistione tra professionale ed amatoriale
non aiuta i giornalisti online a rivendicare la propria
legittimità, specie se il lavoro viene svolto per realtà nate in
Rete, prive di qualsivoglia connessione con altri media. La
differenza tra il Web e altri media che si sono imposti nel
passato nei confronti della carta stampata è rappresentata
dall’accessibilità e dalll’interattività che offre agli utenti.
Nello sterminato mare di Internet i navigatori possono
incappare tanto nell’informazione veicolata da giornalisti
professionisti, quanto in quella che affonda le proprie radici
su terreni diversi. Yannick Estienne, un ricercatore francese,
autore di Le journalisme après internet84, parla di
professionalizzazione dei lettori e de-professionalizzazione
soprattutto i più piccoli, che vorrebbero giornali online senza regole, o
quantomeno, fuori dal contratto giornalistico». Ibidem. 84 Il giornalismo dopo Internet.
61
dei giornalisti85 per descrivere questo fenomeno86. La Rete,
dice Estienne, viene vista dai giovani come un veicolo
d’ingresso nel mondo del giornalismo, una rampa di lancio,
un tunnel da attraversare con il solo obiettivo di arrivare
dall’altra parte: la carta stampata. La specializzazione del
giornalista online continua ad incontrare difficoltà
nell’imporsi nel campo del giornalismo tout court. Vengono
definiti come poco numerosi, invisibili e pressoché
sconosciuti al pubblico, privi di una coscienza di gruppo, così
come di rappresentanti, portavoce od organi rappresentativi.
C’è innanzitutto una grande divisione che viene fuori
dall’inchiesta del ricercatore francese: da una parte ci sono i
giornalisti delle aziende Internet (cioè testate nate online e
non collegate ad altri media); dall’altra i giornalisti delle
testate derivate. «Se fra i manager si parla sempre di più di
sviluppare sinergie fra carta e web, fra le redazioni dei
giornali e quelle dei siti le paratie sembrano ancora solide e
la comunicazione fra le persone e i settori resta difficile87». Il
lavoro dei giornalisti online – prosegue Estienne – si articola
principalmente intorno a informazione di seconda mano. Le
tempistiche della Rete obbligano inoltre a reattività e
produttività, esigenze che rendono il processo informativo
più meccanico e assoggettato a dinamiche esterne. Una
85 Estienne Y., Le journalisme après Internet, L’Harmattan, Parigi 2007.
Pino Rea, collaboratore del gruppo di lavoro Lsdi – Libertà di Stampa
Diritto all’Informazione, si è occupato della traduzione di alcune
osservazioni su questo testo francese curate da Guillaume Narvic, blogger
francese. Rea P., Il giornalismo dopo internet: un mestiere “al ribasso”?
in lsdi.it, (http://www.lsdi.it/2008/il-giornalismo-dopo-internet-un-
mestiere-%E2%80%9Cal-ribasso%E2%80%9D/). 86 Estienne si riferisce naturalmente alla situazione francese, ma non
risulta essere esercizio scorretto la trasposizione all’Italia. 87 Ibidem.
62
replica all’articolo pubblicato su Lsdi – e quindi
indirettamente all’inchiesta di Estienne – è poi arrivata da
Vittorio Pasteris, blogger88 e giornalista apparentente alla
redazione de lastampa.it. Scrive Pasteris:
«[…] molte redazioni in rete delle testate dei media
tradizionali sono costituite da giornalisti che vivono
un disagio legato al mancato riconoscimento formale,
spesso forzoso e forzato, della loro effettiva
professionalità. Le ragioni di questo sono da ricercare
ovviamente non nei giornalisti stessi, soggetti passivi
di discriminazione, ma nelle diverse funzioni
manageriali, sindacali e professionali che tentano di
posizionare questi giornalisti in aree grigie spesso
soggette a ricatto89».
L’accusa di Pasteris nei confronti di Estienne è quella di
banalizzare il problema. Il ricercatore francese accusa il
giornalismo online di svolgere principalmente un lavoro di
desk, in cui è assente un impegno reale di scrittura o
produzione di articoli. Ma la replica di Pasteris è decisa,
allargando il cono visivo il giornalista de lastampa.it arriva a
sostenere che il limite dell’informazione sul Web «è una
conseguenza dell’organizzazione aziendale e delle scelte
strategiche delle aziende editoriali, non è una caratteristica
costitutiva dei media digitali90». Il punto focale – dice Pasteris
88 www.pasteris.it/blog/ 89 Pasteris V., Della dignità del giornalismo digitale in lsdi.it, 30 giugno
2008, (http://www.lsdi.it/2008/06/30/della-dignita-del-giornalismo-
digitale/, 30 giugno 2008). 90 Ibidem.
63
– è rappresentato dalle risorse: «con risorse, budget e tempo
a disposizione le redazioni on-line potranno senza problemi
dedicarsi a inchieste, approfondimento, analisi, opinioni91». Il
Web 2.0, tuttavia, ha creato nuove figure nel campo
dell’informazione. Non esiste solamente una
contrapposizione tra giornalisti della carta stampata e
giornalisti online (a loro volta divisi tra quelli appartenenti a
testate interamente digitali e quelli legati a testate derivate).
Il Web 2.0 – scrive Estienne – è il terreno dove prolifera «l’
indifferenziazione crescente fra giornalismo professionale e
giornalismo non-professionale. Giornalista, dilettante,
pubblico: queste categorie si accavallano perdendo a poco a
poco la loro pertinenza92». Autopubblicazione, blogosfera,
citizen journalism, giornalismo “pro-am” (professionale-
amatoriale) – dice Estienne – «tali concetti suggeriscono uno
scivolamento surrettizio verso una concezione del
giornalismo in cui i giornalisti professionisti non sono più
necessari93». Prosegue Estienne: «Di fronte allo sviluppo
dell’autopubblicazione e all’evoluzione dei comportamenti
dei loro lettori, i giornalisti del web possono legittimamente
temere di venire alla fine privati della loro esperienza e di
dover abbandonare il loro ruolo tradizionale di gate keeper»94.
Dello stesso avviso di Estienne era Emilio Carelli, che
qualche anno prima del ricercatore francese si chiedeva se
avesse ancora senso la professione giornalistica data la
perdita dell’esclusività del racconto da parte dei giornalisti a
91 Ibidem. 92 Rea P., Il giornalismo dopo internet: un mestiere “al ribasso”? in
lsdi.it, (cit.). 93 Ibidem. 94 Ibidem.
64
favore del grande pubblico95. Per tracciare una linea tra
giornalismo, giornalismo online e giornalismo partecipativo
in termini di rispettabilità e dignità del lavoro svolto,
dell’informazione trasmessa, bisognerebbe cercare di dare
una definizione il più semplice e chiara possibile di cosa è un
giornalista. Dice Rebecca Blood96, appoggiandosi a una
definizione data da Paul Andrews97, che la quintessenza del
giornalismo è la verificabilità dei fatti. Questa la conditio sine
qua non, questo l’elemento distintivo dell’attività
giornalistica. «So, that word "verifiable", it seems to me, is
crucial to the practice of journalism, whether it be in a
newspaper or in a blog98». Rebecca Blood, partendo da
quanto scritto da Paul Andrews, riesce a proporre una propria
definizione di giornalismo: « Journalism is any third-party
account that adds to the record of verifiable facts99». La
blogger americana propone anche degli esempi chiarificatori
tracciando un parallelismo tra l’attività di un blogger e quella
di un professionista:
95 Carelli E., Giornali e giornalisti nella Rete, cit. 96 Celebre blogger americana. 97 Paul Andrews è un giornalista online e blogger. Egli definisce il
giornalismo come «il far conoscere fatti verificabili ad un pubblico
attraverso un medium». Il testo originale è: «the imparting of verifiable
facts to a general audience through a mass medium». La definizione è data
in Is Blogging Journalism?, Harvard University's Nieman Reports, Fall
2003». 98 « Quindi, quella parola “verificabile”, mi sembra sia cruciale per il
giornalismo, sia in un giornale, sia in un blog ». Blood R., A Few Thoughts
on Journalism and What Can Weblogs Do About It in rebeccablood.net,
15 aprile 2004,
(http://www.rebeccablood.net/essays/what_is_journalism.html). 99 «Qualsiasi resoconto di terzi che contribuisce alla testimonianza di fatti
verificabili». Ibidem.
65
«When a blogger writes up daily accounts of an
international conference […] that is journalism. When
a magazine reporter repurposes a press release
without checking facts or talking to additional
sources, that is not. When a blogger interviews an
author about their new book, that is journalism. When
an opinion columnist manipulates facts in order to
create a false impression, that is not. When a blogger
searches the existing record of fact and discovers that
a public figure's claim is untrue, that is journalism.
When a reporter repeats a politician's assertions
without verifying whether they are true, that is not100».
Una concezione di legittimità e dignità basata sulla
condotta, più che sulla forma o sul riconoscimento di un titolo
che, tra le altre cose, in Italia è legato ad una legge
anacronistica del 1963101 che concentra esclusivamente nelle
mani degli editori il potere di scegliere le sorti degli aspiranti
giornalisti. Si tornerà ad analizzare nel dettaglio quanto
100 «Quando un blogger riporta accuratamente una conferenza
internazionale[…], quello è giornalismo. Quando un reporter di una
rivista ripropone un comunicato stampa senza controllare i fatti o senza
parlare con ulteriori fonti, quello non è giornalismo. Quando un blogger
intervista un autore riguardo il suo nuovo libro, quello è giornalismo.
Quando un opinionista manipola i fatti in modo tale da creare
un’impressione sbagliata, quello non è giornalismo. Quando un blogger
cerca i documenti ufficiali di un evento e scopre che la dichiarazione di
una figura pubblica non è vera, quello è giornalismo. Quando un
giornalista ripete le asserzioni di un politico, senza controllare se quelle
stesse sono vere, quello non è giornalismo». Ibidem. 101 Legge n. 69/1963.
66
appena accennato in altre sezioni di questa tesi. Nelle pagine
che seguono invece si affronteranno le diverse tipologie di
giornalismo online: dalle testate derivate a quelle nate sul
Web, dai blog al diffusissimo fenomeno del citizen
journalism.
67
2 Forme e modelli di giornalismo online
Categorizzare la Rete è esercizio, per la stessa natura del
medium in questione, tutt’altro che semplice. Nello spazio
che segue si tenterà tuttavia di tracciare i confini del campo
d’indagine andando a delineare le diverse tipologie di
giornalismo che è possibile incontrare nel mare magnum del
Web. Si partirà con quei modelli che per primi hanno
incontrato l’universo di Internet: le cosiddette testate
derivate, nate offline e poi approdate online.
2.1 Modelli di testate passate sul Web
Piccoli e grandi gruppi editoriali hanno cercato di sfruttare
le potenzialità della Rete sin dal suo avvento. L’apripista fu
il californiano San Jose Mercury News con il suo Mercury
Center (1993), mentre spettò all’Unione Sarda il ruolo di
antesignano limitatamente alla penisola italiana (1994). Non
furono poche le difficoltà incontrate, specie fino a quando i
gruppi editoriali non compresero la necessità di abbandonare
la strada degli abbonamenti a pagamento e non aprirono alla
fruibilità gratuita dei contenuti presenti online, che nella
maggior parte dei casi si limitavano ad essere riproposizioni
di quanto già pubblicato nei giornali cartacei. Una volta
delegata alla pubblicità ogni fonte di introiti, presto o tardi,
più o meno agevolmente, tutte le grandi testate nazionali ed
estere si dotarono di un proprio sito web seguendo quel
processo di “rimediazione” di cui parlano Jay David Bolter e
68
Richard Grusin102. I due accademici statunitensi, riprendendo
il concetto espresso da Marshall McLuhan secondo cui «il
contenuto di un medium è sempre un altro medium»,
definiscono il processo di rimediazione come quel processo
di reinterpretazione che un medium compie sul contenuto di
un altro medium. Il riferimento è principalmente ai media
digitali e al modo in cui questi ultimi hanno riadattato i
contenuti dei vecchi media. Un punto di partenza per
un’analisi sulle testate passate sul Web può essere
rappresentato da dei dati statistici. Secondo quanto raccolto e
pubblicato da ComScore103 in un’indagine sul traffico nei
giornali online su scala mondiale, limitatamente al mese di
ottobre del 2012 (figura 8), ben 644 milioni di persone hanno
visitato delle testate digitali (il 42,6 % dell’utenza totale di
Internet). Tra questi, una cifra vicina al 10%, ha scelto il Mail
Online104 (poco più di 50 milioni di utenti unici). Al secondo
posto si trova invece il sito di un giornale statunitense: il New
York Times105, con quasi 49 milioni di visitatori. Di nuovo
una testata britannica al terzo posto, occupato dal The
Guardian106, con poco meno di 39 milioni di utenti. Sembra
102 Bolter J. and Grusin R., Remediation: Understanding New Media.
Cambridge, MIT Press, 1999. 103 Most Read Online Newspapers in the World: Mail Online, New York
Times and The Guardian in comscoredatamine.com, 23 dicembre 2012,
(http://www.comscoredatamine.com/2012/12/most-read-online-
newspapers-in-the-world-mail-online-new-york-times-and-the-
guardian/). 104 Versione online del britannico Daily Mail.
http://www.dailymail.co.uk/ 105 http://www.nytimes.com/ 106 http://www.theguardian.com/uk
69
allora doveroso analizzare più nel dettaglio i casi specifici di
questi colossi dell’informazione digitale.
(figura 8 – I dati raccolti da ComScore nell’ottobre del 2012)
Mail Online. Il Daily Mail nasce nel 1896, fondato dal
giornalista ed editore inglese Alfred Harmsworth. La
versione cartacea ha adottato dal 1971 il formato tabloid, che
oltre ad indicare delle dimensioni ridotte rispetto al formato
standard (430 mm x 280 mm rispetto a 749 mm × 597 mm),
si riferisce al taglio della testata, come ad esempio la tendenza
ad enfatizzare le notizie di cronaca nera o quelle di cronaca
rosa legate alla vita delle celebrità. La linea editoriale del sito
non si discosta da quella della versione cartacea, entrambe di
stampo conservatore. Accedendo al Mail Online ciò che
colpisce maggiormente è la predominanza delle immagini
rispetto al testo scritto (figura 9).
70
(figura 9 – Notizia principale della homepage del Mail Online,
07/11/2013, ore 12:31)
Le notizie sono accompagnate da titoli scritti con caratteri
piuttosto grandi e da poche righe di descrizione che
anticipano il contenuto dell’articolo. Sono gli elementi visivi
i protagonisti, tanto della homepage quanto dei singoli link.
Scendendo poco sotto la notizia principale (figura 10), è
possibile ottenere l’immediata conferma. La colonna di
sinistra mostra un altro articolo, anch’esso caratterizzato da
un titolo scritto con un carattere grande e corredato da una
foto. Al centro, le immagini sono protagoniste della
narrazione giornalistica: «Click through today in pictures»,
recita la didascalia posizionata in alto (“scorri le immagini del
giorno”). Si tratta di notizie accompagnati da svariate
immagini in cui il contenuto testuale svolge una funzione
prevalentemente didascalica. Le vicende raccontate
riguardano la vita delle celebrità: ad esempio, la notizia
71
visibile in figura 10 parla del celebre cantante Justin Bieber e
di una sua fan che lo ha fotografato e filmato mentre dormiva
con accanto il suo cappello da baseball. Per confermare
ulteriormente lo spazio dedicato dal Mail Online al gossip
basti scostare lo sguardo sulla colonna di destra. Qui vengono
riportate le notizie accorpate dalla didascalia «Femail
Today». Femail è una sezione del sito107 in cui vengono
raccolte tutte le news che riguardano la cronaca rosa, il
gossip, il benessere ecc.
(figura 10 – un’altra sezione della homepage del Mail Online)
La versione online del Daily Mail e il suo enorme successo
hanno generato diversi dibattiti in giro per la Rete. Scrive
James Robinson: « MailOnline is littered with pictures of
scantily-clad starlets, many of which would never be
107 Il nome Femail è un gioco di parole tra il termine inglese female
(significa sia femmina che femminile) e mail.
72
published in the paper108». Viene quindi tracciata una linea di
demarcazione tra il Daily Mail, il cartaceo e la sua versione
digitale109. L’articolo di Robinson pubblicato sul Guardian
rivela come il 25% del traffico generato dal sito derivi dalla
sezione dedicata allo spettacolo e al gossip: «One advantage
of being a middle-market title is we can stretch our legs either
way110», afferma ironicamente il direttore esecutivo del Mail.
Battuta che potrebbe essere tradotta come: “Vogliamo
soddisfare una fetta più grande possibile di pubblico, quindi
ci adeguiamo di conseguenza”. Un altro articolo meritevole
d’attenzione è firmato da Brian Wheeler per il sito della
BBC111, dove si analizza la fortuna del Mail Online
soprattutto in territorio americano. Vengono individuati
cinque fattori di successo della versione online del celebre
tabloid britannico. Innanzitutto le news legate al patinato
mondo dello spettacolo. « A lot of the gossip blogs and the
gossip websites look to the Daily Mail for how to package
celebrity news. They are just that good at it 112». Un altro
fattore di successo è rintracciabile, secondo Brian Wheeler
108 « Il Mail Online è disseminato di fotografie di celebrità dai vestiti
succinti, molte delle quali non vorrebbero mai pubblicate su carta».
Robinson J., MailOnline: what is the secret of its success? In
theguardian.com, 15 novembre 2010
http://www.theguardian.com/media/2010/nov/15/mailonline-daily-mail-
website 109 «The products are distinct but complementary». Ovvero, «I prodotti
sono diversi ma complementari». Ibidem 110 « Un vantaggio dell’essere una testata generalista è che possiamo
allungare le nostre gambe sia da una parte sia dall’altra». Ibidem 111 Wheeler B., How the Daily Mail stormed the US in bbc.co.uk, 27
gennaio 2012, (http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16746785). 112 « Molti blog e siti di gossip osservano il Daily Mail per capire come
preparare notizie sulle celebrità. Sono semplicemente bravi nel farlo». La
frase è stata detta da Jo Piazza, giornalista americano. Ibidem.
73
nel design non ortodosso del sito («Unorthodox design113»).
La pagina principale, come già evidenziato in precedenza,
presenta decine e decine di notizie, corredate con foto enormi;
ma nonostante ciò il suo utilizzo risulta molto semplice. Sono
proprio le grandi fotografie un altro punto di forza del Mail.
Prosegue Wheeler delineando un quarto fattore di successo: i
titoli lunghi, lunghissimi. Afferma Jakob Nielsen114 a tal
proposito: « But Mail Online has taken Search Engine
Optimisation to a whole different level. Its headlines are so
long they are like mini stories in themselves115». E’ lo stesso
Nielsen ad aggiungere che « One side-effect of this approach
is that readers will probably not feel "disappointed" when
they click on a story, which may help to build loyalty to the
site 116». Il quinto ed ultimo fattore elencato nell’articolo della
BBC è rappresentato dalla separazione tra versione cartacea e
sito Web e dalla cura dedicata a quest’ultimo. Si tratta di
un’entità completamente differente rispetto alla versione
cartacea. «It's an entirely different entity to the print edition.
They created this as a business model for what works online
and they know what's going to get eyeballs and traffic, and
bring in advertisers, and they have created a website around
113 Ibidem. 114 Jakob Nielsen è un consulente della fruibilità di Internet. 115 « Il Mail Online ha portato il SEO ad un livello totalmente differente.
I suoi titoli sono così lunghi che sembrano delle vere e proprie mini-
storie». Ibidem. 116 «Un effetto collaterale di questo approccio è che i lettori con ogni
probabilità non si sentiranno disorientati una volta che avranno cliccato
su una storia, cosa che potrebbe aiutare a costruire un legame di
fidelizzazione». Ibidem.
74
that, not around their print edition117», l’opinione del
giornalista Jo Piazza.
New York Times. L’autorevole giornale statunitense è
arrivato sul Web il 19 gennaio 1996118. Relativamente tardi
rispetto ad altre realtà editoriali meno importanti, il New York
Times scelse un modello di fruizione ibrido. L’accesso alla
homepage era gratuito, ma per visualizzare i vari contenuti,
agli utenti veniva richiesta una registrazione, anch’essa
gratuita. Il giornale americano è riuscito così a creare un
database con i profili di oltre 10 milioni di utenti che
forniscono i dati demografici per la vendita di spazi
pubblicitari mirati119. Nel 2005, tuttavia, la registrazione al
sito cominciò a diventare a pagamento, sino a giungere
all’introduzione del cosiddetto paywall120 nel 2011.
L’annuncio arrivò il 17 marzo tramite una lettera diretta
dall’editore al pubblico: «This week marks a significant
transition for The New York Times as we introduce digital
subscriptions. It’s an important step that we hope you will see
as an investment in The Times, one that will strengthen our
ability to provide high-quality journalism to readers around
117 «Hanno creato il tutto come un business model per quello che funziona
online e sanno cosa attira gli occhi e il traffico, e porta i pubblicitari, e
hanno creato un sito Web intorno a questo, non intorno alla versione
cartacea». Ibidem. 118 Pratellesi M., New Journalism, cit, p. 20 119 Ibidem. 120 «Il paywall è un sistema che impedisce agli utenti di Internet di
accedere a contenuti di pagine web senza pagare una sottoscrizione». Il
testo originale è «A paywall is a system that prevents Internet users from
accessing webpage content without a paid subscription», fonte Wikipedia.
75
the world and on any platform121». Ai lettori sprovvisti di
abbonamento, rimaneva possibile la visualizzazione di 20
articoli al mese gratuitamente, poi diventati 10 nell’aprile del
2012. La politica del Times sembra funzionare, come
conferma un articolo di Margaret Sullivan. «In 2012,
something remarkable happened at The Times. It was the year
that circulation revenue — money made from people buying
the paper or access to its digital edition — surpassed
advertising revenue 122». Il successo del Times scardina una
certezza che ha sempre accompagnato le analisi della Rete:
gli utenti non sono disposti a pagare per accedere a dei
contenuti Web. Accedendo alla homepage del giornale
statunitense, si notano immediatamente le enormi differenze
rispetto ad un sito come quello del Mail Online. Come è
possibile vedere dalla figura 11 è il testo scritto l’indiscusso
protagonista della prima pagina del Times online. I vari
articoli sono presentati da titoli sintetici e dal carattere solo
121 «Questa settimana segna un significativo cambiamento per il New
York Times dal momento che introduciamo la sottoscrizione di un
abbonamento. E’ un passo importante che speriamo vedrete come un
investimento per il Times, che rinforzerà la nostra abilità di fornire
giornalismo di alta qualità a lettori in ogni parte del mondo e tramite ogni
mezzo». Sulzberger A., A Letter to Our Readers About Digital
Subscriptions in nytimes.com, 17 marzo 2011,
(http://www.nytimes.com/2011/03/18/opinion/l18times.html). 122 «Nel 2012, qualcosa di straordinario è successo al Times. E’ stato
l’anno in cui i guadagni derivanti dalla tiratura – soldi che vengono dalle
persone che comprano il giornale o dall’accesso alla versione digitale –
hanno sorpassato quelli provenienti dalla pubblicità». Sullivan M., A
Milestone Behind, a Mountain Ahead in nytimes.com, 19 gennaio 2013,
(http://www.nytimes.com/2013/01/20/public-editor/a-milestone-behind-
a-mountain-ahead.html?ref=opinion&_r=2&).
76
leggermente più grande rispetto alle poche righe di
presentazione del pezzo.
(figura 11 – la homepage del New York Times, l’8 novembre 2013
alle 11:57)
Grande importanza è affidata agli autori dei contenuti, i
cui nomi compaiono anche nella pagina principale. I temi che
hanno precedenza nell’agenda della redazione sono la
politica (sia americana, sia estera) e l’economia. Il sito del
New York Times non trascura le potenzialità del Web 2.0:
contenuti multimediali, link ipertestuali, sharing buttons e
possibilità di inserire commenti. La peculiarità del giornale
statunitense è di carattere gerarchico: il fulcro del processo
informativo è ancora la notizia, il testo scritto. Questo non
significa che vengano sottovalutate le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, tutt’altro; ma queste ultime sono
sempre al servizio del testo. E’ proprio il New York Times tra
i pochi giornali a sfruttare a pieno i nuovi media per offrire
77
un differente tipo di giornalismo, in italiano chiamato di
precisione, in inglese data journalism. Si legge
nell’introduzione di Data Journalism Handbook123: «Data
can be the source of data journalism, or it can be the tool with
which the story is told – or it can be both124». Ovvero, «I dati
possono essere la fonte del data journalism, oppure possono
essere lo strumento attraverso cui la storia viene raccontata –
o può essere entrambe le cose». Nel dicembre del 2012 il New
York Times online si è distinto attraverso una narrazione che
ha stupito il mondo giornalistico, tanto dalla parte dei
professionisti, quanto da quella dei lettori. Bisogna fare un
passo indietro, sino al 19 febbraio 2012. Tre sciatori vengono
uccisi da una valanga a Steven Pass, un passo di montagna
delle Cascade Mountains, non lontano dalla città di Seattle,
nello stato americano di Washington125. Come di consueto,
una notizia di questo tipo esaurisce la propria efficacia
narrativa nel giro di qualche ora, non più di pochi giorni.
Invece, a distanza di quasi un anno, nel dicembre del 2012, il
New York Times ha ripreso in mano l’accaduto costruendo
123 «Il Data Journalism Handbook è un libro gratuito, di pubblico dominio
per chiunque sia interessato al campo emergente del giornalismo di
precisione». «The Data Journalism Handbook is a free, open source
reference book for anyone interested in the emerging field of data
journalism». Nato durante un workshop di 48 ore al MozFest 2011 di
Londra, ha successivamente visto la partecipazione di illustri
professionisti provenienti da testate come la BBC, il Chicago Tribune,
The Guardian, The Financial Times, La Nacion, The Washington Post e
molti altri, compreso il New York Times.
http://datajournalismhandbook.org/ 124 http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_0.html 125 Avalanches kill three in Washington state ski resorts in
theguardian.com, 20 febbraio 2013,
(http://www.theguardian.com/world/2012/feb/19/avalanche-washington-
state-kills-three).
78
attorno ad esso una narrazione rivoluzionaria. Chiamato
Snow Fall126 e realizzato dal reporter John Branch, il progetto
è stato sviluppato in 6 differenti capitoli127. La storia non è
semplicemente corredata da elementi multimediali – video,
grafiche animate, immagini, grafici –, essi sono invece parte
integrante della narrazione, che segue logiche differenti
anche per quanto riguarda il testo scritto, che non si limita a
riportare un fatto di cronaca. I realizzatori hanno cercato –
riuscendovi – di fare immergere il lettore nell’universo
multimediale da loro ideato, ad esempio tramite immagini
della montagna e del punto in cui si trovavano gli sciatori
rimasti uccisi dalla valanga. «It feels like you know the
people and can imagine what they went through. Of course
this can partly be attributed to the personal writing style. But
more than a mere text could achieve the multi-medial
approach creates a feeling of having been there128». Oltre a
regalare al New York Times il premio Pulitzer 2013 per il
feature writing, Snow Fall è stato anche un successo di
pubblico. Soprattutto, l’ambizioso progetto realizzato dal
126 http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-
fall/?_r=0#/?part=tunnel-creek 127 Tunnel Creek (primo capitolo, Tunnel Creek è il nome dell’insenatura
del passo di montagna Steven Pass); To the peak (secondo capitolo, Verso
la cima); Descent begins (terzo capitolo, La discesa inizia); Blur of white
(quarto capitolo, Confusione bianca); Discovery (quinto capitolo, La
scoperta); Word spreads (sesto capitolo, La parola diffonde). Ibidem. 128 «Sembra come di consocere le persone e di potere immagini quello che
hanno vissuto. Naturalmente, questo può essere parzialmente attribuito
allo stile di scrittura personale. Ma più di quanto un semplice testo può
riuscire a fare, l’approccio multimediale crea una sensazione di essere
stati lì». Snow Fall, the future of online journalism? in Masters of Media
11 settembre 2013, (http://mastersofmedia.hum.uva.nl/2013/09/11/snow-
fall-future-of-online-journalism/).
79
giornale statunitense ha aperto un dibattito sul futuro del
giornalismo, sempre più a suo agio nell’universo
multimediale della Rete, in grado di offrire possibilità
narrative prima impensabili. «The New York Times debuted a
new multimedia feature Thursday so beautiful it has a lot of
people wondering — especially those inside the New York
Times — if the mainstream media is about to forget words and
pictures for a whole lot more129». Snow Fall ha rappresentato
fonte di stimuli e ispirazione per il Times, che ha segnato in
agenda diversi progetti legati all’universo digitale: «Una
rivista solo per tablet, l’introduzione di un direttore per i
contenuti digitali a basso prezzo, riuniti sotto il nome di Need
to know e nuova ricetta tutta digital per le notizie
gastronomiche130».
129 «Il New York Times ha esordito con una nuova funzione multimediale
giovedì, così bella che ha portato molte persone a domandarsi –
specialmente persone all’interno del New York Times – se i mass-media
siano in procinto di mettere da parte parole e immagini per molto di più».
Greenfield R., What the New York Times's 'Snow Fall' Means to Online
Journalism's Future in theatlanticwire.com, 20 dicembre 2012.
(http://www.theatlanticwire.com/technology/2012/12/new-york-times-
snow-fall-feature/60219/). 130 Thoman F., L’eredità di Snow Fall: un New York Times sempre più
digitale in corriere.it, 15 luglio 2013,
(http://piazzadigitale.corriere.it/2013/07/15/leredita-di-snow-fall-un-
new-york-times-sempre-piu-digitale/).
80
(figura 12 – La prima pagina di Snow Fall)
The Guardian. Altro caso che offre diversi spunti d’interesse
è quello del Guardian, quotidiano inglese nato a Manchester
nel 1821. Il giornale del Lancashire si è avvicinato a piccoli
passi alla Rete a partire dal 1995. Ad esempio, nel 1996 venne
lanciato un sito dedicato agli Europei di calcio del 1996,
chiamato eurosoccer.com. Il debutto online vero e proprio
arrivò invece tre anni più tardi, nel gennaio del 1999, quando
venne creato il The Guardian Unlimited network of
websites131 (figura 13). Nel settembre dello stesso anno il sito
131 Il network includeva inizialmente quattro sezioni (News Unlimited,
Football Unlimited, Cricket Unlimited and Jobs Unlimited), a cui poi ne
vennero aggiunte altre cinque (Film Unlimited, Education, Books,
Shopping and Money). http://www.theguardian.com/gnm-
archive/guardian-website-timeline
81
può vantare già un milioni di utenti. Un anno più tardi,
nell’aprile del 2000, il Guardian si inserì nelle dinamiche di
un altro fenomeno in grandissima ascesa, la blogosfera, con
uno spazio chiamato Guardian Weblog. Il 2004 vide invece
l’arrivo della versione digitale del giornale cartaceo: gli
articoli dell’edizione stampata erano ora disponibili online
tramite un’interfaccia grafica sviluppata all’interno del
Guardian stesso.
(figura 13 – Il Guardian Unlimited al momento del lancio, nel
gennaio del 1999)
Un anno cruciale per il rapporto tra il quotidiano inglese e
il Web fu il 2006. La sezione Comment Is Free venne aperta
con l’intento di creare uno spazio dedicato al dibattito, alla
discussione, spronando il pubblico a commentare qualunque
cosa venisse da loro letta. Nello stesso anno, il direttore del
82
Guardian, Alan Rusbridger lanciò il motto Web first. Fu un
cambiamento epocale, che stravolse la logica di
pubblicazione delle notizie e i normali rapporti gerarchici tra
i media digitali e quelli offline: «Per la prima volta, uno dei
principali giornali nazionali inglesi ha deciso di pubblicare
gli articoli delle sue firme, inviati e corrispondenti, subito sul
web, senza aspettare di andare in edicola132». A conferma
della posizione di Rusbridger nei confronti della Rete, è
interessante riportare il suo intervento avvenuto in occasione
dell’incontro Esiste il giornalismo? dedicato a Hugh Cudlipp,
ex direttore del Daily Mirror133. Le parole del direttore del
Guardian hanno trattato in particolar modo la diatriba tra
l’accesso gratuito ai contenuti e quello a pagamento.
«As an editor, I worry about how a universal pay wall
would change the way we do our journalism," he
continued. "Journalists have never before been able to
tell stories so effectively, bouncing off each other,
linking to each other (as the most generous and open-
minded do), linking out, citing sources, allowing
response […]. If ever there was a route to building
audience, trust and relevance, it is by embracing all
the capabilities of this new world, not walling yourself
away from them134».
132 Pratellesi M., New Journalism, cit., p. 51 133 L’incontro si è tenuto nel gennaio del 2010. 134 «In qualità di edtore, mi preoccupo di come un paywall univerale
cambierebbe il modo in ci facciamo giornalismo. I giornalisti non sono
mai stati in grado prima di ora di raccontare delle storie in modo così
efficace, appoggiandosi l’un l’altro, facendo riferimento all’altro (come
fanno i più generosi e aperti di mente), creando collegamenti, citando
fonti, permettendo risposte […]. Se mai ci fosse una strada per costruire
83
Nel dicembre del 2010 il Guardian lancia Datastore e
Datablog. « The Data Store is an online directory providing
a selection of datasets on topics of public interest
(government data, education, culture, population) and tools
to explore them135». Il Datablog, invece, raccoglie le analisi
di questi dati. Scrive il creatore e curatore della sezione Data
del Guardian, Simon Rogers: «Dal momento che il web
produce un numero sempre maggiore di dati, i lettori di tutto
il mondo sono più interessati ai meri fatti dietro le notizie di
quanto lo fossero mai stati prima136». Un momento cruciale,
tanto per il data journalism, quanto per quello promosso dal
Guardian, è stato secondo Rogers legato alla prima
un seguito, per costruire fiducia e pertinenza, questa strada
prevede l’apertura a tutte le possibilità di questo nuovo
mondo, non l’isolamento da loro». Guardian's Alan
Rusbridger on why his paper will remain free online in
editorsweblog.org, 26 gennaio 2010,
(http://www.editorsweblog.org/2010/01/26/guardians-
alan-rusbridger-on-why-his-paper-will-remain-free-
online). 135 «Il Datastore è una sezione online che fornisce una
raccolta di set di dati su argomenti di pubblico interesse
(governo, educazione, cultura, popolazione) e strumenti per
esplorarli». The Guardian Data Store in
datadrivenjournalism.net, 30 agosto 2011,
(http://datadrivenjournalism.net/resources/the_guardian_d
ata_store). 136 «As the web pumps out more and more data, readers
from around the world are more interested in the raw facts
behind the news than ever before». Behind the Scenes at the
Guardian Datablog,
(http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/in_the_newsro
om_3.html).
84
pubblicazione di dati da parte di Wikileaks137, che nell’aprile
del 2010 pubblicò del materiale riguardante l’intervento
militare in Afghanistan138. «Before Wikileaks, we were sat on
a different floor, with graphics. Since Wikileaks, we have sat
on the same floor, next to the newsdesk. It means that it’s
easier for us to suggest ideas to the desk, and for reporters
across the newsroom to think of us to help with stories139».
Repubblica.it. La versione online de La Repubblica è,
secondo i dati Audipress140, il giornale italiano più letto su
Internet. La testata nata nel 1976 è approdata sul Web nel
1997. Redazione cartacea e redazione online sono
rigidamente separate141: la prima è diretta da Ezio Mauro, la
seconda da Vittorio Zucconi. La hompage del sito mostra un
buon equilibrio tra testo ed elementi multidimediali.
Vengono meno alcune possibilità di interazione per i lettori:
Repubblica.it non offre un forum di discussione, mentre i
commenti sono abilitati solamente per alcuni articoli. L’altro
lato della medaglia vede invece un grande utilizzo
dell’universo dei social network, in particolar modo di
Twitter. Il servizio Repubblica Domani142 è una delle
rubriche più interessanti presenti nel sito, nonché un ottimo 137 http://wikileaks.org/ 138 Behind the Scenes at the Guardian Datablog, (cit.). 139 «Prima di Wikileaks, noi eravamo seduti in un piano differente, con i
grafici. Dopo Wikileaks, siamo stati seduti sullo stesso piano, accanto alla
redazione che si occupa delle news. Significa che è più facile per noi
suggerire loro delle idee, mentre per i reporter è più facile pensare a noi
per essere aiutati nella costruzione delle loro storie». Ibidem 140 Dati di lettura – Quotidiani – 2013/I in primaonline.it, 27 maggio
2013, (http://www.primaonline.it/2013/05/27/118185/dati-di-lettura-
quotidiani-2013i/). 141 Le redazioni si trovano addirittura in due edifice diversi. 142 http://video.repubblica.it/rubriche/repubblica-domani
85
esempio di integrazione tra sito Web e giornale cartaceo. Le
telecamere di RepubblicaTV entrano all’interno della
redazione della testata per assistere alla riunione della
redazione del mattino. Dall’intervento del direttore Ezio
Mauro, a quelli dei vari responsabili di settore. I vari fatti del
giorno presentati ed analizzati in vista della stesura del nuovo
numero del quotidiano.
Internazionale. Nel panorama editoriale italiano merita di
essere analizzato il caso di Internazionale. Si tratta di una
rivista con uscita settimanale nata nel 1993, diretta da
Giovanni De Mauro. La peculiarità di questo prodotto
giornalistico di Roma sta nel modo in cui utilizza la Rete. Si
proceda con ordine. Internazionale ogni settimana seleziona
un certo numero di articoli provenienti da testate di tutto il
mondo. Una volta scelti vengono tradotti e presentati al
pubblico italiano. La versione online offre dei servizi
aggiuntivi ai lettori del cartaceo, con cui vive un rapporto di
stretta simbiosi. L’homepage del sito accoglie il navigatore
con una slideshow di 10 immagini provenienti da ogni angolo
del globo143. C’è la possibilità di sfogliare il sommario della
versione cartacea ma per accedere ai contenuti è necessaria la
sottoscrizione di un abbonamento. Il sito offre anche dei
contenuti gratuiti: alcune news, la sezione delle “opinioni”,
ovvero dei blog curati dai collaboratori di Internazionale e la
sezione “Paesi”. Quest’ultima è una sorta di grande archivio
che, suddiviso per continenti, oltre a raccogliere contenuti 143 Alle 17:19 dell’11 novembre 2013, ad esempio, le fotografie racconto
nell’ordine: Scontri tra palestinesi e soldati israeliani a Hebron, in
Cisgiordania, per l’anniversario della morte di Yasser Arafat; La fiera
annuale di cammelli a Pushkar, nello stato indiano del Rajasthan; La
fiera annuale di cammelli a Pushkar, nello stato indiano del Rajasthan; e
così via.
86
presenti sul sito della rivista stessa, rimanda a tutti i giornali
di quel determinato paese. Ad esempio, cliccando sull’Italia,
si trovano prima di tutto delle informazioni di carattere
generale (la capitale, l’ora locale, il meteo ecc.). Poco più in
basso c’è spazio per l’ultima ora, delle flash news che
scorrono e a cui è possibile accedere cliccandoci sopra. Si
trovano poi foto, articoli (tanto delle news quanto dei blog),
una mappa dell’Italia, un link alla pagina di Wikipedia e
molto altro. Sul fondo della pagina si trova la sezione “Oggi
in edicola”, dove vengono mostrate le prime pagine dei
maggiori quotidiani nazionali. Poco più in basso, c’è l’elenco
di tutte le testate italiane divise per categorie con i link che
rimandano ai loro rispettivi siti Web. Qual è dunque il punto
di forza di Internazionale? «Quello che noi offriamo al lettore
è la selezione – dice il direttore De Mauro in un’intervista
rilasciata alla rivista Studio144 –. La nostra esistenza è la
dimostrazione di quello che anche Google ha capito, e cioè
che la straordinaria massa di informazioni disponibile è
sostanzialmente inutilizzabile se non è filtrata e selezionata.
Sono convinto che un giornale, più ancora da ciò che
pubblica, derivi la sua identità da ciò che non pubblica, dalla
scrematura145». Il lavoro svolto dalla redazione di
Internazionale si divide fondamentalmente in tre fasi: lettura,
scelta e traduzione. Il successo ottenuto – come ha
pertinentemente sottolineato il direttore della rivista – deriva
144 Studio è una rivista bimestrale di attualità culturale nata nel marzo del
2011. Dentro Internazionale, l’articolo da cui è tratta l’intervista a De
Mauro, è stato pubblicato nel numero 8. Momigliano A., Dentro
Internazionale in rivistastudio.com, 28 giugno 2012,
(http://www.rivistastudio.com/editoriali/media-innovazione/nella-
fabbrica-di-internazionale/). 145 Ibidem.
87
dall’opera di selezione svolta dalla redazione. Internazionale
si inserisce nel mercato online entrando da una porta
secondaria, sfruttando il rovescio della medaglia della grande
quantità d’informazione presente sulla Rete: la difficoltà nel
selezionare e scegliere. Il lavoro svolto dal settimanale
consente all’utente di risparmiare tempo ed energie preziose.
(figura 14 – la homepage di Internazionale, il 5 dicembre 2013
alle 15:55)
2.2 Modelli di testate nate online
Nel paragrafo precedente sono state analizzate delle realtà
editoriali che, forti del loro retroterra cartaceo, hanno messo
piede nel mondo dell’informazione digitale. Pur seguendo
logiche differenti ed ottenendo risultati altrettanto diversi,
88
queste testate sono accomunate da un nome, che in questo
senso può essere inteso come un marchio, che offre nella
dinamica del rapporto tra giornale e pubblico un’opportunità
di riconoscimento e fidelizzazione. Cosa cambia invece per
quegli editori che abbiano deciso o decidano di dare vita a
testate concepite per il Web e nate direttamente nel mare
magnum di Internet? Si cercherà di delineare in questo
paragrafo le dinamiche che caratterizzano queste realtà, le
difficoltà a cui vanno incontro e le diverse vie intraprese.
Il 19 aprile del 2012, l’Università di Oxford, tramite il suo
RISJ, Reuters Institute for the Study of Journalism, ha
pubblicato una ricerca dal titolo Survival Is Success146. I due
ricercatori, il danese Rasmus Klaus Nielsen e l’italiano
Nicola Bruno, hanno lavorato studiando la situazione di nove
realtà del giornalismo indipendente europeo. Tre le
caratteristiche condivise da queste nove imprese editoriali:
dovevano essere vere redazioni giornalistiche con contenuti
che fossero tali, essere nate esclusivamente sul web e per il
web (versioni mobili incluse), infine non dovevano essere in
alcun modo collegate a precedenti edizioni cartacee. La
domanda che si sono posti i ricercatori è stata la seguente:
vsto il lancio di un numero consistente di realtà giornalistiche
sul Web, quali sono i modelli di giornalismo online
sostenibile? Il titolo della ricerca – Survival Is Success,
ovvero La sopravvivenza è un successo – anticipa la
conclusione a cui sono giunti i due ricercatori, che hanno
potuto vedere come al proliferare di nuove testate e
146 Survival is Success: Journalistic Online Start-Ups in Western Europe
in reutersinstitute.politics.ox.ac.uk, 19 aprile 2012,
(https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/about/news/item/article/survival
-is-success-new-risj-chal.html).
89
all’ingenza degli investimenti non corrisponda poi un ritorno
economico: solamente due delle nove realtà prese in esame
hanno raggiunto il cosiddetto break even, ovvero il punto di
pareggio147. Un’altra conclusione tratta dai ricercatori è stata
l’impossibilità di sopravvivere facendo affidamento
esclusivamente sugli introiti pubblicitari148. La ricerca del
RISJ individua due sfide per il lancio di testate su Internet: la
prima è legata all’egemonia delle testate che derivano da altri
media, le quali sfruttano la forza del loro nome per attirare
grandi fette di pubblico149; la seconda invece riguarda gli
investimenti pubblicitari, che da una parte dovrebbero essere
ripartiti tra migliaia e migliaia di siti, dall’altra sono
monopolizzati da colossi come Google, Yahoo, Microsoft e
Facebook150. Le nove realtà analizzate dai ricercatori sono
equamente ripartite tra tre grandi paesi europei: Germania,
Francia e Italia. Al di là delle differenze tra questi stati, due
sono i tratti comuni, d’interesse per la ricerca del RISJ. Il
primo è che i loro mercati nell’ambito mediatico sono
principalmente nazionali: a differenza di testate di lingua
inglese, quelle di lingua tedesca, francese o italiana (così
147 In economia aziendale, il punto di pareggio (break even point o break
even, abbreviato in BEP) è un valore che indica la quantità, espressa in
volumi di produzione o fatturato, di prodotto venduto necessaria a coprire
i costi precedentemente sostenuti, al fine di chiudere il periodo di
riferimento senza profitti né perdite. Fonte: Wikipedia. 148 «Not one of the cases we look at has been able to function on the basis
of online advertising only». Bruno N., Nielsen R., Survival Is Success,
Journalistic Online Start-Ups In Western Europe, RISJ, University of
Oxford, 2012 – p.6
(https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publicatio
ns/Challenges/Survival_is_Success.pdf). 149 Ibidem. 150 Ibidem.
90
come il resto dell’Europa) si orienteranno principalmente su
mercati di scala nazionale151. Il secondo tratto comune
riguarda l’estensione del mercato di riferimento: questi tre
paesi hanno una popolazione tra i 60 e gli 80 milioni e
investono miliardi di euro ogni anno nella pubblicità e nei
media. La logica conseguenza dovrebbe essere l’esistenza di
un buon bacino, quantomeno potenziale, tanto di utenti,
quanto di pubblicitari152. In aggiunta e in conferma di quanto
detto poc’anzi, Germania, Francia ed Italia vedono l’utilizzo
di Internet in grande crescita: oltre metà della loro
popolazione può essere considerata utenza attiva sul Web153.
Costante è anche la crescita degli investimenti pubblicitari su
Internet, in particolar modo per Germania e Francia, dove
circa il 20% degli investimenti è indirizzato online (in Italia
è il 6,5%)154. Partendo da queste basi i ricercatori hanno
analizzato queste nove realtà focalizzandosi su tre aspetti
principali: la loro collocazione nel mercato editoriale, il loro
pubblico di riferimento, il loro modello di business155.
Germania. Il mercato tedesco, il più attivo d’Europa, è
caratterizzato dalla forte egemonia dei media tradizionali e
delle loro controparti online. Una delle figure più autorevoli
della Rete è quella di Spiegel, che oltre a sfruttare il proprio
nome e le proprie risorse economiche, ebbe l’abilità di
muoversi in anticipo nel passaggio sul Web, avvenuto nel
1994, molto prima di gran parte della concorrenza. Spiegel è
stato il punto di riferimento dell’informazione digitale
151 Ivi, p. 9 152 Ibidem. 153 Ibidem. 154 Ivi, p. 10. 155 Ivi, p. 12.
91
tedesca fino al 2009, quando il tabloid Bild l’ha superato156.
La forza dei grandi gruppi editoriali ha rappresentato la
ragione principale che ha vanificato elementi che avrebbero
invece favorito la nascita e il successo di testate online: ad
esempio la capillare diffusione di Internet nel territorio
tedesco e il grande utilizzo della Rete nella ricerca di
notizie157. Netzeitung è la prima realtà trattata dai ricercatori.
Questo sito venne lanciato nel 2000 prendendo a modello uno
dei primi siti di informazione esclusivamente online, il
norvegese Nettavisen, lanciato nel 1996 e in grado di ottenere
un ottimo riscontro di pubblico pubblicando contenuti
disponibili in forma gratuita158. L’obiettivo di Netzeitung era
ambizioso: creare un quotidiano online sul modello di quelli
cartacei in grado di competere apertamente con questi ultimi.
Venne tuttavia commesso un errore strategico: vennero
sottovalutate le differenze tra il mercato norvegese e quello
tedesco, notevolmente più grande e competitivo. Così,
quando tra il 2003 e il 2004 la maggior parte dei media
tradizionali si dotarono di un sito Web, l’identità debole di
Netzeitung e le risorse limitate emersero159. La risposta del
sito tedesco fu quella di abbandonare il modello cartaceo per
costruire una realtà maggiormente orientata verso le
potenzialità della Rete. Venne individuata nella
multimedialità la risposta alla crisi, ma la sopravvivenza del
sito dipese principalmente dai frequenti cambi di proprietà
che consentirono l’innesto di nuovi capitali160. Il fallimento
del progetto Netzeitung arrivò nel 2009, quando il sito venne
156 Ivi, p. 16. 157 Ivi, p. 19. 158 Ivi, p. 20-21. 159 Ivi, p. 22. 160 Ivi, p. 23.
92
convertito a semplice aggregatore di notizie161. La seconda
realtà tedesca analizzata nella ricerca dell’Università di
Oxford è Perlentaucher. Si tratta di un progetto
completamente differente rispetto a quello appena riportato.
Lanciato nel marzo del 2001, questo sito non cercò di
competere con i media già esistenti, bensì di basare la propria
forza sulla ricerca di un’identità alternativa e originale. Il
nome del progetto è emblematico: Perlentaucher in italiano
significa “pescatore di perle”. Il sito si occupa infatti di
selezionare le migliori storie a sfondo culturale provenienti
dai media tedeschi e di ripubblicarle, mettendole a
disposizione dei lettori e concedendo la possibilità di
discuterne162. Il lavoro svolto dalla snella redazione di
Perlentaucher (4 componenti) è simile a quello che compie
l’italiano Internazionale, di cui si è parlato nel paragrafo
precedente. Il sito ha negli anni cercato anche di produrre
contenuti originali, per quanto possibile vista l’esiguità dello
staff. Altri interessanti servizi offerti sono ad esempio la
gestione di un database di recensioni di circa 40.000 libri, che
ha consentito al progetto tedesco di ben posizionarsi nelle
ricerche di Google163. La sopravvivenza di Perlentaucher è
anche garantita dai costi di gestione non altissimi (tra i
200.000 e i 300.000 € l’anno) e da una buona trovata
pubblicitaria: un banner posizionato sulla sinistra di ogni
pagina che pubblicizza un libro di recente uscita,
accompagnato da un piccolo abstract e dal link diretto per il
161 Ivi, p. 24-25. 162 Ivi, p. 27 163 Ivi, p. 28.
93
sito dell’editore e le relative pagine Facebook e Twitter164
(figura 15).
(figura 15 – la homepage di Perlentaucher il 12 novemnbre 2013
alle 14:20, sulla sinistra è possibile vedere il banner
pubblicitario)
Altre fonti di introiti sono le partnership con le librerie
online165, altri banner o servizi extra come la pubblicità
tramite newsletter166. Dopo oltre 10 anni Perlentaucher è
ancora attivo, anche se nel 2011, per fronteggiare la crisi, si è
trovato costretto a lanciare una campagna di raccolta fondi
che ha portato circa 22.000 € di donazioni nell’arco di due
164 Ivi, p. 29. 165 Quando un utente che viene dal database di Perlentaucher acqusita un
libro, il 10% della vendita va ai gestori del sito tedesco. Ivi, p. 30. 166 Ibidem.
94
settimane167. A conferma della fidelizzazione dei suoi lettori.
L’ultimo esempio della realtà tedesca è il giovane The
European, nato nel settembre del 2009. Il sito, fondato da
Alexander Görlach, basa la propria esistenza su una
considerazione: la Rete è invasa dalla sterminata disponibilità
di informazioni, ma manca di analisi in profondità. Questo il
settore dove The European vuole inserirsi: fornire
approfondimenti a notizie di carattere politico e culturale168.
Un altro punto di forza del sito è il prestigio delle firme:
professori universitari, politici, giornalisti, esperti di finanza.
Il target di riferimento della creatura di Görlach è
dichiaratamente una nicchia acculturata, ma non si
possiedono dati del traffico del sito al di fuori di quelli
dichiarati da Görlach stesso (circa 300.000 utenti al mese)169.
Gli introiti di The European derivano in gran parte dalla
pubblcità, composta sia da normali annunci che da
advertorials170, oltre che dall’organizzazione di eventi e dalla
consulenza legata ai social media171. Trattandosi di una realtà
molto giovane, resta da vedere se The European sarà in grado
di attrarre un pubblico più ampio, costruendosi una propria
nicchia al di fuori del sistema mediatico tradizionale, magari
facendo affidamento alle nuove possibilità narrative offerte
dalla Rete.
Francia. Nel 2009 la carta stampata francese ha attraversato
una profonda crisi, dovuta dall’ascesa di Internet da un lato,
167 Ivi, p. 31. 168 Ivi, p. 33. 169 Ivi, p. 35. 170 In italiano si chiama pubbliredazionale, o articolo pubbliredazionale,
ed è un'informazione pubblicitaria impaginata e redatta similarmente ad
un normale articolo della testata giornalistica. Fonte: Wikipedia. 171 Ibidem.
95
dalla crisi economica dall’altro. Le imprese editoriali hanno
richiesto l’aiuto statale, ottenuto dal governo Sarkozy con lo
stanziamento di oltre 200 milioni di euro addizionali ai
normali finanziamenti. Molti giornali, a causa di queste
difficoltà, sono stati costretti a muoversi verso la Rete, non
senza molta diffidenza172. Il fattore che diversifica la
situazione francese da quella tedesca e da quella italiana è che
i siti maggiormente seguiti dagli utenti a caccia di
informazioni non sono quelli dei giornali, ma di emittenti
come TF1 e France Televisions. Il modello più diffuso per
quanto riguarda le testate online prevede una rigida
separazione tra le redazioni della carta stampata e online,
fenomeno che coinvolge colossi come Le Monde.fr o Le
Figaro.fr173. Nonostante le difficoltà incontrate dai media
tradizionali, questi ultimi continuano ad essere anche in
Francia i siti più visitati per ottenere informazioni. Tuttavia,
la distanza tra le nuove realtà nate online e le trasposizioni
digitali di testate cartacee è molto più sottile rispetto a quanto
lo sia in Germania174. Il primo esempio descritto dai
ricercatori dell’Università di Oxford è AgoraVox. Nato nel
marzo del 2005, AgoraVox è uno esempio di citizen
journalism. L’ambizione del suo fondatore Carlo Revelli era
quella di rivoluzionare il comportamento dell’individuo nel
Web portando l’utente ad una modus operandi più attivo e
consapevole, ad esempio trovando dell’informazione non
ancora pubblicata o verificando una voce di corridoio175.
Negli anni AgoraVox è cresciuto arrivando a lanciare delle
172 Ivi, p. 42. 173 Ibidem. 174 Un progetto indipendente come Rue89 vanta poco più di 2 miloni di
utenti rispetto ai 6,3 di Le Figaro e ai 5,8 di Le Monde. Ivi, p. 44-45. 175 Ivi, p. 48.
96
versioni in inglese e in italiano, una piattaforma di
condivisione video (AgoraTV), dei canali tematici (dedicati
all’ambiente, al benessere e alla salute). La creatura di Revelli
concede la possibilità agli utenti, previa registrazione, di
pubblicare autonomamente i contenuti sul sito. Il compito dei
nove gestori di AgoraVox è quello di controllare ed
eventualmente modificare quanto viene reso pubblico sul
sito, seguendo però una logica collaborativa e
partecipativa176. Il grande successo iniziale è stato seguito da
una crisi arrivata sul finire del 2009, che ha ridotto
considerevolmente il traffico degli utenti e costringendo il
team di AgoraVox a fare affidamento a campagne di raccolta
fondi per integrare gli introiti pubblicitari177. Le difficoltà
incontrate dal sito francese vanno comunque viste come parte
di una fase di stallo che vive il citizen journalism nel suo
complesso. Un’altra realtà francese è quella di Rue89, un sito
lanciato nel maggio del 2007 che si proponeva come modello
di integrazione tra giornalismo professionale e citizen
journalism. Sin dagli esordi la creatura dei reporter Pierre
Haski e Pascal Riché si è distinta per la sua apertura, la sua
spinta all’innovazione e la sua indipendenza. Nonostante la
possibilità data ai lettori di inoltrare proposte al management
del sito, il potere decisionale su cosa pubblicare o meno
rimane in mano al vertice della piramide. Accanto ai
commenti degli utenti, trovano spazio quelli accademici,
avvocati o esperti di economia178. Si può dire quindi che pur
incoraggiando la partecipazione del pubblico e pur cercando
di costruire una comunità fidelizzata intorno al sito, Rue89
non verte verso il giornalismo partecipativo, il sito cerca
176 Ivi, p. 49. 177 Ivi, p. 50. 178 Ivi, p. 53.
97
piuttosto di trovare un punto di incontro tra i professionisti e
i lettori. Il riscontro a livello di seguito è stato più che buono,
con una crescita costante fino al 2011 (2 milioni di utenti
unici al mese). Tuttavia, nonostante il successo, la forbice tra
spese e introiti è ampia179. Sono state molte le iniziative
messe in atto da Rue89 per integrare i ricavi derivanti dalle
pubblicità: dall’e-commerce al fundraising, sino ad arrivare
alla versione cartacea della testata180. Nel dicembre del 2011
il sito è stato acquistato dal gruppo di Le Nouvel Observateur,
posseduto da Claude Perdriel, un settimanale nato come
cartaceo e divenuto tra i più letti di Francia anche nella sua
veste digitale181. I prossimi anni diranno come Rue89
affronterà la convivenza con un colosso dell’editoria
tradizionale, quel che la ricerca di Nielsen e Bruno ha
evidenziato è come nonostante questa testata online avesse
dimostrato di poter competere sul mercato dal punto di vista
dell’originalità dei contenuti, del seguito, della
partecipazione degli utenti e dell’uso dei nuovi formati
disponibili sul Web, il modello di business non fosse
sostenibile e come l’attività fosse in perdita. L’ultimo caso
preso in esame per quanto concerne la Francia è quello di
Mediapart. Lanciato nel 2008, Mediapart si distingue dalla
maggior parte delle realtà presenti sul Web per una ragione: i
suoi contenuti sono accessibili solamente previa
sottoscrizione di un abbonamento (figura 16). I costi – escluse
eventuali offerte – sono di 9 € al mese o 90 € per tutto
179 Nel 2010 una spesa pari a circa 2,2 milioni di euro di fronte a dei ricavi
di circa 1,8 milioni di euro. Ivi, p. 56. 180 Ibidem. 181 Ivi, p. 57-58.
98
l’anno182. La linea della testata, diretta da Edwy Panel, si
fonda sulla presa di distanza rispetto a qualsiasi tipo di
influenza politica o economica183, influenza da cui – sostiene
Mediapart – non sono invece esenti gli altri media. Il team di
questa realtà francese si compone di 25 giornalisti, molti di
loro provenienti da altre importanti testate come Le Monde.
Lo stile che caratterizza Mediapart è aggressivo, si cerca di
investigare nel mondo politco ed economico per portare alla
luce verità scottanti. Un caso emblematico si verificò nel
giugno del 2010, quando il giornale francese decise di
pubblicare integralmente delle intercettazioni riguardanti
Liliane Bettencourt, una delle principali azioniste de L’Oreal.
Le registrazioni svelavano che quest’ultima aveva aggirato il
pagamento di tasse tenendo una certa somma di denaro in
conti bancari svizzeri, il tutto favorito dalla complicità del
partito dell’allora Presidente Sarkozy, l’Union pour un
Mouvement Popoulaire184. La pubblicazione da parte di
Mediapart, arricchita di giorno in giorno con costanti
aggiornamenti, creò un dibattito frenetico, oltre allo sdegno
dell’opinione pubblica. Nonostante le reazioni legali del
Partito, lo scandalo era ormai scoppiato185. La ricerca del
RISJ rivela come gli introiti derivanti dalle sottoscrizioni
coprano la maggior parte dei ricavi186, con il resto di questi
182 Il sito offre anche la possibilità di essere testato dall’utente per 15
giorni al costo di 1 € https://www.mediapart.fr/abonnement. 183 Plenel E., Le prix de la liberté in mediapart.fr, 16 marzo 2008,
(http://www.mediapart.fr/journal/france/100308/le-prix-de-la-liberte). 184 Bruno N., Nielsen R., Survival Is Success, Journalistic Online Start-
Ups In Western Europe, cit., p. 60. 185 Ibidem. 186 Dopo lo scandalo Bettencourt, le sottoscrizioni sono raddoppiate. Ivi,
p. 62.
99
affidati alla vendita di e-books o a sussidi statali187. Dopo
anni in perdita, Mediapart ha raggiunto il break even nel 2012
facendo affidamento quasi esclusivamente sui ricavi
provenienti dai propri abbonati188. Tuttavia, non sono poche
le critiche che sono state mosse a questa intrigante realtà
francese. In primo luogo, al di là dei proclami, l’innovazione
non è un carattere predominante nella logica di Mediapart.
La struttura della testata ricorda quella dei formati cartacei,
manca un utilizzo delle nuove tecnologie offerte dalla Rete.
Soprattutto, la sua accessibilità limitata vanifica la
concezione stessa della Rete come scambio libero di
informazioni. Un’altra critica accusa Mediapart di essere
stata troppo apertamente anti-Sarkozy e di essere invece
vicina alla sinistra francese189. Al di là di queste
considerazioni, l’esperimento di Mediapart e la sua scelta del
paywall stanno al momento funzionando. La testata di Plenel
è riuscita a trovare la propria fetta di pubblico, altamente
fidelizzata. Fintanto che i lettori saranno disposti a pagare per
accedere a questi contenuti, Mediapart potrà portare avanti le
investigazioni e le battaglie che lo hanno fino a questo
momento caratterizzato.
187 Ivi, p. 63. 188 Ibidem. 189 Ivi, p. 64.
100
(figura 16 – un articolo di Mediapart del 14 novembre 2013.
L’immagine mostra la scritta “La lecture des articles est réservée
aux abonnés”, che significa “La lettura degli articoli è riservata
agli abbonati”. In basso si nota come l’incipit del pezzo vada via
via sfumando fino a sparire)
Italia. E’ giunto il momento di prendere in esame la realtà
italiana, l’ultima analizzata dalla ricerca dell’Università di
Oxford. Appare un evidente ritardo rispetto agli altri paesi,
fino al 2010 infatti l’unica testata online meritevole di essere
considerata è stata Dagospia. Lanciato nel maggio del 2000,
Dagospia prese a modello l’americano Drudge Report, di cui
si è parlato in precedenza in merito al sexgate. Pettegolezzi e
voci di corridoio, in particolar modo riguardanti il mondo
della politica. Dagospia è stato in grado di ottenere un buon
riscontro di pubblico e di mettere in piedi un modello di
101
business sostenibile fino al 2010, anno in cui il fondatore
Roberto D’Agostino ha deciso di applicare un paywall
all’archivio del sito190. Per quasi un decennio Dagospia è
stata l’unica realtà italiana di un certo rilievo nel campo delle
testate giornalistiche nate online, fenomeno da ricollegarsi al
ritardo con cui, rispetto ai principali paesi europei, l’Italia ha
visto crescere la diffusione e l’utilizzo di Internet nel proprio
territorio. I ricercatori di Oxford hanno individuato un altro
motivo in grado di spiegare il gap che l’Italia si è vista
costretta a colmare. Il sistema mediatico italiano vede degli
intrecci con il mondo politico, così come quello economico o
industriale, che non presentano affinità con nessun’altra
situazione in Europa191. Tuttavia, nel corso degli anni, i
grandi gruppi editoriali si sono mossi con lentezza nel mondo
del Web, ritardo che potrebbe in qualche modo favorire
l’inserimento e la crescita di altre realtà. Ma è presente
un’altra criticità nel sistema italiano: i costi di gestione sono
infinitamente più alti. Questo significa che i siti necessitano
di flussi di traffico particolarmente copiosi. A tal proposito i
ricercatori riportano che un sito come il tedesco
Perlentaucher, in grado di raggiungere il break even in
Germania, avrebbe approssimativamente bisogno in Italia di
un traffico 10 volte superiore a quello che ha attualmente per
sopravvivere192. Nonostante le molte difficoltà, a partire dal
2010 qualcosa si è iniziato a muovere. Il 20 aprile del 2010 è
stato lanciato Il Post. Creato da Luca Sofri, blogger e
giornalista, il modello scelto è stato quello dell’americano
Huffington Post. L’obiettivo di questo sito è di trovare un
equilibrio tra la selezione e la raccolta di notizie di altri media
190 Ivi, p. 69. 191 Ivi, p. 70-71. 192 Ivi, p. 74.
102
e l’analisi, la critica, il tutto condito dalla partecipazione
dell’utenza. Sofri non vuole inserirsi nel mercato come
concorrente dei media tradizionali, si mira piuttosto ad
attirare una nicchia di pubblico in cerca di orientamento nel
sovraccarico informativo della Rete193. La redazione de Il
Post ripropone notizie altrui accompagnadole con una breve
introduzione ed un link alla fonte, ma produce anche
contenuti originali, approfondimenti, soprattutto in materia di
blog194. Tuttavia, la creatura di Sofri non è ancora riuscita a
far crescere la propria nicchia di pubblico, che sembra essere
limitata principalmente alla blogosfera195. Altro interessante
progetto italiano è quello di Lettera43. Nato pochi mesi dopo
Il Post (ottobre 2010), questo sito si propone come un mix tra
notizie di attualità, approfondimenti e gossip. Il fondatore è
Paolo Madron, giornalista che ha a lungo collaborato con
testate di economia e finanza come Il Sole 24 Ore, oltre ad
essere stato vice-direttore del settimanale Panorama e
direttore della rivista Economy. Le conoscenze di Madron nel
mondo finanziario hanno consentito a Lettera43 di partire con
un budget di gran lunga superiore a quello di testate
concorrenti, oltre a garantirgli importanti accordi
pubblicitari196. La redazione è composta da circa 20 persone,
oltre a circa 50 collaboratori esterni. Con oltre 80 notizie
pubblicate giornalmente, il prudente utilizzo di elementi
multimediali e un approccio tradizionale, il sito si propone
come un competitor dei grandi gruppi editoriali. L’obiettivo
è raggiungere un pubblico di massa, non una nicchia.
193 Ivi, p. 76. 194 Il sito ospita infatti una rete composta da circa 50 blogger non
retribuiti. 195 Ivi, p. 77. 196 Ivi, p. 80.
103
Nonostante i buoni risultati ottenuti sia a livello traffico
generato, sia per quanto riguarda gli investimenti dei
pubblicitari, il break even è un obiettivo non facilmente
raggiungibile in virtù del desiderio di Madron di competere
con i colossi del giornalismo italiano197. E’ Linkiesta l’ultimo
caso preso in esame dai due ricercatori del RISJ. Il progetto è
ambizioso, come si può leggere sul sito stesso nella sezione
“chi siamo”:
«Linkiesta.it è un giornale digitale indipendente, pro-
market, libero da ideologie e posizioni precostituite.
Dal punto di vista editoriale Linkiesta.it si posiziona
come organo di approfondimento e inchieste su
politica, economia e finanza, temi sociali. Linkiesta.it
è un’iniziativa innovativa che intende sfruttare
appieno il potenziale delle tecnologie digitali per
superare il concetto tradizionale di giornale,
promuovendo anche in Italia il concetto di citizen
journalism. Per questo motivo intende dare spazio
nella produzione editoriale ad una nuova generazione
di commentatori, provenienti dalla associazioni,
dall’università, dalla scuola e dalle professioni, che
oggi, purtroppo, non hanno spazio sulla stampa
tradizionale198».
A conferma della ricerca di indipendenza del sito, la
Società è divisa tra 84 soci, i quali – ai sensi dello Statuto –
non possono detenere quote superiori al 5% del capitale199.
197 Ivi, p. 82. 198 http://www.linkiesta.it/chi-siamo 199 Ibidem.
104
Linkiesta non si propone, a differenza di Lettera43, come
competitor dei grandi gruppi editoriali, l’obiettivo del
progetto è bensì quello di fornire al pubblico degli
approfondimenti, accompagnati da commenti ed inchieste. I
contenuti sono accessibili gratuitamente, ma Linkiesta chiede
supporto ai propri lettori tramite la sottoscrizione di un
abbonamento200, un’opzione che qualora ricevesse un buon
seguito consentirebbe al sito di integrare gli introiti
pubblicitari con altri, indispensabili ricavi. Quantomeno per
sopravvivere, risultato – dice la ricerca dell’Università di
Oxford – da considerare già come un successo.
Huffington Post. Oltreoceano la situazione sembra essere
differente. Negli Stati Uniti esistono progetti che sono stati in
grado di imporsi sul mercato ben oltre la semplice
sopravvivenza. Il caso più eclatante è quello dell’Huffington
Post201. Definire i confini delle realtà presenti sulla Rete non
è semplice: cos’è l’Huffington Post? Un giornale online? Un
blog? Un aggregatore di notizie? Una piattaforma social?
Come scrive Luca Sofri nel suo blog Wittgenstein202, «sono
soprattutto un grande editore, capace di vendere i suoi
prodotti molto diversi tra loro e di individuare la domanda del
mercato203». L’Huffington Post nasce nel maggio del 2005,
fondato da Arianna Huffington con la collaborazione di
Kenneth Lerer, Andrew Breitbart e Jonah Peretti204. «L’idea
200 Tre opzioni disponibili: 6 mesi a 54 €, 12 mesi a 90 € o 12 mesi a 500
€ in qualità di sostenitore. http://www.linkiesta.it/abbonati-linkiesta 201 http://www.huffingtonpost.com 202 http://www.wittgenstein.it 203 Sofri L., Cosa è lo Huffington Post, davvero in wittgenstein.it. 24
settembre 2012, (http://www.wittgenstein.it/2012/09/24/cosa-e-lo-
huffington-post/). 204 Fonte: Wikipedia.
105
per l’Huffington Post – sostiene la Huffington in un intervista
su Corriere.it – è nata dall’osservazione di come molte delle
discussioni più importanti su politica e società si stavano
spostando sulla Rete, ma tante personalità importanti, con
idee forti, erano tagliate fuori dal mondo di Internet. Così ho
deciso di creare una piattaforma che permettesse anche a
queste voci di partecipare al dialogo online205». La crescita
del sito è stata costante, nel 2008 l’Huffington Post ha iniziato
ad espandersi attraverso delle versioni locali206, mentre nel
2011 la creatura di Arianna Huffington si è spinta oltre i
confini statunitensi207. Nello stesso anno, ma in febbraio,
qualche mese prima della nascita di HuffPost Canada
(maggio), la prima edizione internazionale del sito, il colosso
americano AOL208 decide di investire circa 300 milioni di
dollari per comprare l’Huffington Post, partito con un
investimento iniziale di 1 milione di dollari209. In seguito
all’acquisizione da parte di AOL, Arianna Huffington,
205 Cella F., Arianna Huffington: “Pronta a portare il mio Post anche in
Italia”, in corriere.it, 1 ottobre 2011,
(http://vitadigitale.corriere.it/2011/10/11/arianna-huffington-pronta-a-
portare-il-mio-post-anche-in-italia/). 206 Le prime sono state HuffPost Chicago e HuffPost New York, seguite
da altre come HuffPost Denver o HuffPost Los Angeles. Fonte: Wikipedia. 207 L’Huffington Post è arrivato in Canada, Germania, Spagna, Francia,
Giappone, Maghreb, Regno Unito. Esiste anche una versione italiana in
collaborazione con il Gruppo Espresso, diretta da Lucia Annunziata e
nata nel settembre del 2012. 208 AOL Inc. (in precedenza America Online, Inc. e AOL, LLC) è una
multinazionale mass media che si sviluppa, cresce e investe in marchi e
siti web ed è, dato 2006, il più grande internet service provider del mondo
con i suoi 30 milioni di utenti. Fonte: Wikipedia. 209 Aol, 315 milioni per l'Huffington Post, in corriere.it, 7 febbraio 2011,
(http://www.corriere.it/economia/11_febbraio_07/aol-acquista-
Huffington%20Post_2148d7be-3287-11e0-8ce8-00144f486ba6.shtml).
106
diventa presidente e redattore capo del nuovo gruppo (The
Huffington Post Media Group), che integra i contenuti delle
due aziende210. Alla domanda se l’acquisizione da parte di
AOL possa rappresentare un problema per il carattere
“ribelle” che ha caratterizzato il sito fin dalla sua creazione,
Arianna Huffington risponde: «Stiamo seguendo un percorso
molto simile a quello generale di Internet. Il Web è cresciuto
e con lui i navigatori, non sono più degli adolescenti ma un
pubblico più maturo: non prendono più appuntamenti al buio
con centinaia di siti né si accontentano di mangiare “junk
food”. Tendono a concentrarsi su pochi siti di qualità per
leggere autori e contenuti di valore211». La risposta della
Huffington esprime in maniera puntuale la capacità del sito
di plasmarsi in base alle domande di mercato, uno dei motivi
che spiega il successo straordinario ottenuto da questo
progetto. Un altro importante traguardo viene raggiunto
l’anno successivo, nel 2012, quando il premio Pulitzer, il
massimo riconoscimento in campo giornalistico, viene
assegnato proprio ad un inviato dell’Huffington Post212. A
vincere il prestigioso premio, categoria National Reporting, è
stato David Wood, il quale ha raccontato nel suo lavoro
Beyond the Battlefield (in italiano, Oltre il campo di
battaglia) la vita di alcuni veterani di guerra rimasti ferirti in
Afghanistan e in Iraq e delle loro famiglie. Strutturato in 10
episodi, il premio ricevuto dal reportage di Wood ha suscitato
la reazione entusiasta di Arianna Huffington: «We are
delighted and deeply honored by the award, which recognizes
210 Ibidem. 211 Cella F., Arianna Huffington: “Pronta a portare il mio Post anche in
Italia”, in corriere.it, 1 ottobre 2011, (cit.). 212 Per la prima volta nella storia un Pulitzer viene assegnato ad un
giornalista di un media online.
107
both David’s exemplary piece of purposeful journalism and
HuffPost’s commitment to original reporting that affects both
the national conversation and the lives of real people213». Il
successo non è mai casuale, resta da capire quindi quali sono
state le strategie vincenti messi in atto dalla Huffington e dai
suoi collaboratori. Un’analisi molto accurata è stata
pubblicata da Vittorio Veltroni su Prima Comunicazione.
«Non per tutti è chiaro cosa sia effettivamente la corazzata
Huffington Post214», scrive Veltroni nell’incipit del suo
articolo. In realtà, le domande che ruotano intorno al
fenomeno Huffington Post derivano da un senso di
incomprensione generata dall’apparenza tutt’altro che
rivoluzionaria del sito. Come si spiega allora il suo successo?
Scrive Sofri su Wittgenstein: «Lo Huffington Post non ha
avuto nessuna idea rivoluzionaria: a guardarlo e leggerlo non
è un oggetto diverso, in termini di contenuti e di forma, da
moltissimi siti di news. La sua unica e vincente idea
rivoluzionaria è stata quella di sfruttare […] ogni opportunità
nuova offerta dalla rete: fare tutto, farne tanto, farlo
professionalmente215». Come lo definisce Veltroni,
l’Huffington Post non è un giornale, non è un editore, non è
un produttore di contenuti, bensì una technology company
213 «Siamo felicissimi e profondamente onorati per il premio, che
riconosce sia il valore esemplare degli articoli di David, sia l’impegno
dell’HuffPo verso un’informazione originale che riferisce sia del dibattito
nazionale che della vita delle persone comuni», Calderone M., Huffington
Post Awarded Pulitzer Prize in huffingtonpost.com, 16 aprile 2012,
(http://www.huffingtonpost.com/2012/04/16/huffington-post-pulitzer-
prize-2012_n_1429169.html). 214 Veltroni V., “HuffPost”, un gioiello di piattaforma tecnologica, 1
settembre 2012. Prima Comunicazione. 215 Sofri L., Cosa è lo Huffington Post, davvero in wittgenstein.it. 24
settembre 2012, (cit.).
108
impegnata nel campo del social networking216. «Il cuore
dell’impresa Huffington Post non è tanto nei diversi prodotti
che presenta al consumatore (il sito, il magazine iPad, la
televisione digitale), ma nella piattaforma tecnologica che
permette alle molecole di contenuto di trasformarsi in
elementi di scambio sociale217». L’Huffington Post è una
macchina orientata verso la condivisione social218 che sfrutta
la potenza dell’aggregazione di contenuti altrui e l’attività dei
blogger plasmando il tutto in base all’ottimizzazione per i
motori di ricerca. Il SEO come una bibbia: «Hanno capito la
scienza del SEO (search engine optimization) e ne sono
diventati scienziati: nei titoli, nei testi, nei tag, nella stessa
scelta delle notizie da pubblicare219». In questo senso,
l’informazione non è il fine ultimo del meccanismo creato da
Arianna Huffington, ma lo strumento, da modificare ed
adattare costantemente in base alle necessità, per andare
incontro alla domanda del pubblico. Un’offerta – i contenuti
216 Veltroni V., “HuffPost”, un gioiello di piattaforma tecnologica in
primacomunicasione, 1 settembre 2012,
(http://www.ufficiostampa.rai.it/pdf/2012/2012-09-
01/2012090122696950.pdf). 217 Ibidem. 218 «Le notizie sono diventate “sociali”, nel passato la gente le leggeva
sul divano, oggi gli articoli si ricevono mentre si galoppa a cavallo.
Cambiano i mezzi con cui l’informazione ci raggiunge, ma rimane sempre
giornalismo, buono o cattivo. Chi legge però non si accontenta più di
assorbire le informazioni ma vuole anche commentarle, mettere il “Like”
». Cella F., Arianna Huffington: “Pronta a portare il mio Post anche in
Italia”, in corriere.it, 1 ottobre 2011, (cit.). 219 Sofri L., Cosa è lo Huffington Post, davvero in wittgenstein.it. 24
settembre 2012, (cit.). A tal proposito, nello stesso articolo, Sofri racconta
un episodio emblematico: «quando mi mostrarono la redazione, la prima
volta che andai, mi dissero: “quei venti sono la redazione, gli altri
cinquanta fanno SEO”».
109
– che si plasma in accordo alle richieste degli utenti, recepite
tramite parametri quali la frequenza con cui un termine
compare in un motore di ricerca o i like social ricevuti da un
determinato argomento. Spiega Veltroni: «Ciascun contenuto
– scritto, filmato, fotografato, prodotto, aggregato, linkato o
bloggato che sia – deve essere scomponibile in modo da poter
essere utilizzato più volte, in versioni differenti e infunzione
dei trend di ricerca e di scambio sociali che dominano in quel
preciso momento. Nessun contenuto è dunque compiuto,
finito, cristalizzato in nessun momento220». La piattaforma
che regge l’Huffington Post offre da questo punto di vista
opportunità incredibili. Infatti, come scrive Veltroni nel suo
articolo, la piattaforma è concepita per ottimizzare i singoli
contenuti per i motori di ricerca quanto più meticolosamente
possibile. Vengono mostrati continuamente i termini più
utilizzati nei motori di ricerca, così come i like social che
sono correlati agli argomenti del contenuto che sta per essere
inserito. A quel punto la piattaforma consente due
opportunità all’editor o al blogger che sta per pubblicare
qualcosa: la prima è quella di creare titolo, sottotiolo e
didascalia adattandoli in base alle informazioni messe a
disposizione dalla piattaforma stessa; la seconda prevede
invece la possibilità di affidarsi alla generazione automatica
di titolo, sottotiolo e didascalia, plasmati in modo da ottenere
un eccellente piazzamento nei motori di ricerca e un interesse
alla condivisione social (figura 17).
220 Veltroni V., “HuffPost”, un gioiello di piattaforma tecnologica in
primacomunicasione, 1 settembre 2012, (cit.).
110
(figura 17 – Il titolo principale dell’Huffington Post il 14
novembre 2013 alle 15:57)
Proprio quest’ultimo aspetto è un’altra chiave del successo
dell’Huffington Post.
«Per generare scambio e condivisione, la piattaforma
integra l’elemento sociali al contenuto stesso, così
come il modello editoriali prevede il costante
riferimento ai trend social e di ricerca. Ciascun
articolo, notizia breve, fotogallery o video permette il
commento, la condivisione o il salvataggio per la
lettura ritardata. Ciascun commento è a sua volta
commentabile o segnalabile, con un meccanismo che
evidenzia i commentatori preferiti o più letti e li eleva,
a loro volta, al ruolo di blogger […]221».
221 Ibidem.
111
Viene meno la separazione tra notizia e commento, tra
articolo e opinione. Tutto si fonde in un ambiente polifonico
che annulla qualsiasi tipo di gerarchia e che mischia «voce
editoriale e voce amatoriale, racconto e
commercializzazione222». Lo stesso intreccio tra
professionale e amatoriale è rintracciabile nelle fonti dei
contenuti che vengono postati sul sito. La parole d’ordine in
tal senso è repackaging, ovvero rielaborazione. Tutti i
contenuti pubblicati su Huffington Post, indipendentemente
dalla loro provenienza223, subiscono un processo di
riconfezionamento (che è gran parte del lavoro del team del
sito) in modo tale da renderli appetibili per i motori di ricerca
e per i social network. Vittorio Veltroni porta ad esempio un
caso che vale la pena riproporre integralmente:
«Il caso tipo è quello raccontato da Farhad Manjoo,
un noto blogger tecnologico americano, che racconta
come un suo post su un pessimo telefono sia stato
ripreso da un editor dell’HuffPo che, oltre a linkare
l’articolo originale, ha aggiunto 160 parole di
riassunto (parole scelte per ottimizzare la ricerca e lo
scambio sociale), una fotogallery (taggata per essere
ottimizzata su Pinterest224) di altri pessimi telefoni
222 Ibidem. 223 Siano essi contenuti che nascono dalla riaggregazione di
notizie prese da altri siti o agenzie, oppure contenuti
originali prodotti dai blogger che scrivono per l’Huffington
Post. 224 Pinterest è un social network fondato nel 2010 da Evan
Sharp, Ben Silbermann e Paul Sciarra dedicato alla
condivisione di fotografie, video ed immagini. Pinterest
112
(scelti tra i telefono più odati su Fb) e cambiato il
titolo per scatneere il dibattito social (il titolo era
diventato: “Qual è il peggior telefono in
circolazione”). Questa attività viene svolta in
continuità su ogni pezzo di contenuto e la piattaforma
permette questo livello di flessibilità agli editor che
spesso non hanno preparazione tecnica, ma solo
editoriale. E si consideri un altro dato: questo lavoro
viene ripetuto anche più volte sullo stesso articolo per
riflettere i cambiamenti nelle parole più ricercate o
scambiate socialmente225».
Figura 18 e 19 mostrano rispettivamente l’articolo del
blogger Farhad Manjoo e il contenuto rielaborato
dall’Huffington Post.
permette agli utenti di creare bacheche per gestire la
raccolta di immagini in base a temi predefiniti o da loro
generati. Il nome deriva infatti dall'unione delle parole
inglesi pin (appendere) e interest (interesse). Fonte:
Wikipedia. 225 Ibidem.
113
(figura 18 – l’articolo postato da Farhad Manjoo su Slate)
(figura 19 – il contenuto pubblicato sull’Huffington Post dopo il
lavoro di repackaging)
114
Il pezzo di Farhad Manjoo è una recensione completa e
dettagliata, mentre il sito americano si limita a riportarne
alcuni stralci. E’ sufficiente tuttavia guardare gli sharing
buttons per notare come il primo sia stato condiviso
solamente su Facebook (appena 3 volte); il secondo invece,
oltre a 70 condivisioni sul social network di Mark
Zuckerberg226, ha raggiunto 120 condivisioni su Twitter ed è
stato inoltrato per 17 volte via email. Non manca la
componente interattiva nella rielaborazione degli editor
dell’Huffington Post. In fondo all’articolo si legge: «Now we
want to hear from you: What phone would you pick as the
worst and why? Click “Add a Slide” to submit it below»
(ovvero, «Ora vogliamo sentire la vostra: quale telefono
pensate sia il peggiore e perché? Cliccate su “Aggiungi una
Diapositiva” per inviarlo più in basso»). Agli utenti viene
data la possibilità di partecipare attivamente al dibattito su
quale sia il peggior telefono cellulare al mondo non solo
tramite commenti testuali, ma anche attraverso delle foto.
Non è tutto, le immagini possono essere a loro volta condivise
sui social network. Secondo Veltroni l’Huffington Post non è
tuttavia una macchina perfetta: «i frequenti cambiamenti
degli algoritmi di ricerca, uniti al fatto che sempre più i
motori, nella loro gerarchia, cominciano a includere elementi
di successo social (quindi prediligono risultati che sono stati
condivisi o “liked” a seguito della ricerca), rendono sempre
meno efficaci alcuni dei trucchi seo maggiormente in
voga227». C’è un’altra criticità che potrebbe in futuro mettere
a rischio il meccanismo creato da Arianna Huffington.
Nessuno tra i blogger che producono contenuti per il sito è
226 Fondatore di Facebook. 227 Ibidem.
115
retribuito direttamente dal colosso statunitense. Tanto i
blogger amatoriali, quanto quelli più famosi, non
percepiscono alcun compenso, fatta eccezione per coloro che
vengono pagati da corporation o associazioni che
intervengono nelle discussioni che vertono sui temi che li
riguardano228. Ai blogger viene offerto, in cambio dei loro
post, l’accesso ad un’audience enorme, traducibile in termini
di visibilità. Il problema sottolineato da Veltroni è legato alla
molteplicazione dei contenuti disponibili, unita alla velocità
della loro rielaborazione e alla profondità delle conversazioni
che vengono generate e che si sviluppano intorno a questi
contenuti. «[…] il che comporta che la leggibilità del sito
diminuisce e, quindi, la promessa fatta ai collaboratori
gratuiti di accesso diretto a una audience colossale viene a
mancare a fronte di una crescente difficoltà di esposizione. Il
che produce un […] paradosso: il principale motivo di
reclutamento dell’armata di collaboratori gratuiti viene messa
sotto pressione dal successo stesso del sistema229».
Nell’aprile del 2011 il blogger Jonathan Tasini230 ha lanciato
una battaglia legale nei confronti dell’Huffington Post. Tasini
non ha esitato a definire Arianna Huffington, in una
conferenza stampa, come una schiavista: «The Huffington
bloggers have essentially been turned into modern-day slaves
on Arianna Huffington’s plantation231». La causa iniziata da
228 Ibidem. 229 Ibidem. 230 Per oltre vent'anni ha lavorato negli Stati Uniti come authors' advocate
nel mondo dell'informazione e dell'editoria; ha guidato e vinto la decisiva
battaglia per i diritti digitali contro The New York Times. 231 «I bloggers dell’Huffington Post sono essenzialmente diventati gli
schiavi dei nostri tempi che lavorano nella piantagione di Arianna
Huffington». Peters J., Huffington Post Is Target of Suit on Behalf of
Bloggers, in nytimes.com, 12 aprile 2011,
116
Tasini si è presto trasformata in una vera e propria class
action con oltre 9.000 blogger a chiedere un risarcimento di
circa 100 milioni di dollari. Circa un terzo del ricavato
dall’acquisizione dell’Huffington Post da parte di AOL, una
delle ragioni che hanno spinto i blogger a passare alle vie
legali232. La reazione da parte del giornale online è stata di
totale chiusura rispetto alle rivendicazioni di Tasini e degli
altri blogger: «[…] our bloggers use our platform[…] to
connect and help their work be seen by as many people as
possible233», ha dichiarato un portavoce di Arianna
Huffington, Mario Ruiz. La replica della stessa Arianna
Huffington non si è fatta attendere, arrivata proprio tramite le
pagine dell’Huffington Post. L’incipt del post è emblematico:
«The lawsuit filed Tuesday by Jonathan Tasini is so utterly
without merit, and has been so thoroughly eviscerated in the
media -- including being ridiculed as the "dumbest lawsuit
ever" -- I am hesitant to take any time away from aggregating
adorable kitten videos to respond234». Arianna Huffington
traccia anche una linea di demarcazione tra i blogger e alter
figure facenti parte della redazione del Post. Questi ultimi,
(http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2011/04/12/huffington-post-is-
target-of-suit-on-behalf-of-bloggers/?_r=1). 232 Ibidem. 233 «I nostri blogger usano la nostra piattaforma per connettersi e aiutare
il loro lavoro ad essere visto da più persone possibile». Ibidem. 234 «La causa presentata martedì da Jonathan Tasini è così totalmente
priva di valore, ed è stato così accuratamente sviscerata dai media – così
come è stata ridicolizzata e definita come “l’azione legale più stupida di
sempre” – che mi fa essere titubante nel portar via tempo alla
pubblicazione di video di gattini adorabili per rispondere». Huffington A.,
About That Lawsuit... in huffingtonpost.com, 13 aprile 2011,
(http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/huffington-post-
lawsuit_b_848942.html).
117
retribuiti, hanno però degli incarichi da portare a termine, così
come delle precise scadenze, a differenza dei blogger che
possono postare quando vogliono, scrivendo di qualsiasi cosa
sia di loro interesse, oltre a mantenere i diritti sui loro pezzi,
che consente loro di ripubblicarli dove meglio credono o
riformularli in base ai loro desideri235. «The key point that the
lawsuit completely ignores (or perhaps fails to understand) is
how new media, new technologies, and the linked economy
have changed the game, enabling millions of people to shift
their focus from passive observation to active
participation236». Prosegue Arianna Huffington: «Free
content – shared by people who want to connect, share their
passions, and have their opinions heard – fuels much of what
appears on Facebook, Twitter, Tumblr, Yelp, Foursquare,
TripAdvisor, Flickr, and YouTube237». Viene poi citato un
giornalista del New York Times, John Hrvatska, che in merito
all’azione legale di Tasini scrive: «So, does this mean when
YouTube was sold to Google that all the people who posted
videos on YouTube should have been compensated?238».
Nella conclusione del suo articolo, Arianna Huffington torna
235 Ibidem. 236 «Il punto fondamentale che l’azione legale ignora completamente (o
perlomeno fatica a comprendere) è come i nuovi media, le nuove
tecnologia e la linked economy hanno cambiato il gioco, abilitando
milioni di persone a spostare il loro punto di vista dall’osservazione
passiva alla partecipazione attiva». Ibidem. 237 «Contenuti gratuiti – condivisi da personen che che vogliono
connettersi, condividere le loro passioni e far ascoltare le loro opinioni –
riforniscono la maggior parte di ciò che appare su Facebook, Twitter,
Tumblr, Yelp, Foursquare, TripAdvisor, Flickr, and YouTube». Ibidem. 238 «Questo significa che quando YouTube è stato venduto a Google tutte
le persone che hanno postato video su YouTube sarebbero dovute essere
pagate?». Ibidem.
118
con risentimento sul parallelismo formulato da Tasini tra la
condizione di scrivere per il Post e la schiavitù. «There is a
key difference between "slavery" and "choosing voluntarily
to write for free for one of the country's most popular political
websites”239», afferma Arianna Huffington citando Matt
Welch, direttore di Reason. Dal punto di vista legale la
posizione della giornalista greca, poi naturalizzata
statunitense, è inattaccabile. Non essendo stato firmato alcun
contratto che prevedesse una retribuzione per i contenuti
forniti dai blogger, le rivendicazioni di Tasini e gli altri
perdono qualsiasi tipo di valore. E’ vero che queste persone
hanno scelto liberamente di collaborare a titolo gratuito per
l’Huffington Post, accettando di non essere retribuiti in
cambio della cassa di risonanza offerta dal sito. E’ probabile
che lo straordinario successo del sito, culminato nella vendita
plurimilionaria ad AOL, abbia creato frustrazione nel
constatare come quella cifra, incassata da pochi, abbia in
realtà visto il coinvolgimento di molti, rimasti invece fuori
dal ristretto circolo del guadagno. L’errore di Tasini e di tutti
gli altri blogger è stato quello di accettare di collaborare
gratuitamente, attirati dalla pubblicità garantita dal sito. Nel
momento in cui nessun blogger avesse accettato di offrire i
propri articoli senza un ritorno economico, all’Huffington
Post non sarebbe che rimasta una scelta tra il rinunciare a loro
e l’offrire un compenso. Ma venuta a mancare questa presa di
posizione e accettata la collaborazione a titolo gratuito,
qualsiasi rivendicazione dal punto di vista legale è priva di
fondamento. Così come appurò il giudice John Koeltl circa
un anno dopo, nell’aprile del 2012, respingendo le richieste
239 «C’è una differenza chiave tra la “schiavitù” e “scegliere
volontariamente di scrivere gratuitamente per uno dei siti politici più
popolari del paese” ». Ibidem.
119
di Tasini. I blogger erano, sostiene Koeltl, pienamente
consapevoli che il loro lavoro non sarebbe stato retribuito, per
questo motivo un compenso rappresenterebbe una modifica
retrospettiva degli accordi presi in precedenza240. «The
principles of equity and good conscience do not justify giving
the plaintiffs a piece of the purchase price when they never
expected to be paid, repeatedly agreed to the same bargain,
and went into the arrangement with eyes wide open241», ha
scritto il giudice nella sentenza. Nonostante la sconfitta,
Jonathan Tasini ha immediatamente dichiarato di voler
continuare a battersi contro il lavoro non retribuito di tutti
coloro che forniscono dei contenuti editoriali sul Web. Il
fenomeno dei mancati compensi per coloro che scrivono su
Internet è il fulcro di questa ricerca e si tornerà più avanti,
nella seconda parte della tesi, ad analizzare tutte le
componenti di quello che Tasini definisce un cancro242. Sarà
240 Pilkington E., Huffington Post bloggers lose legal fight for AOL
millions in theguardian.com, 1 aprile 2012,
(http://www.theguardian.com/media/2012/apr/01/huffington-post-
bloggers-aol-millions). 241 «I principi di equità e buona coscienza non giustificano il dare ai
querelanti una parte dei ricavi della vendita dal momento in cui loro non
hanno mai pensato di venire pagati, hanno ripetutamente accettato lo
stesso accordo e hanno raggiunto l’intesa con piena consapevolezza».
Stempel J., Unpaid bloggers' lawsuit versus Huffington Post tossed in
reuters.com, 30 marzo 2012,
(http://www.reuters.com/article/2012/03/30/us-aol-huffingtonpost-
bloggers-idUSBRE82T17L20120330). 242 «[…] this idea that all individual creators should work for free is like
a cancer spreading through every media property on the globe» (ovvero,
«[…] questa idea che tutti gli autori dovrebbero lavorare gratuitamente è
come un cancro che si propaga in ogni media del mondo»). Pilkington E.,
Huffington Post bloggers lose legal fight for AOL millions in
theguardian.com, 1 aprile 2012, (cit.).
120
sufficiente dire in questo frangente che Tasini ha poi
partecipato, il 28 aprile 2012, ad un panel del Festival del
Giornalismo di Perugia dal titolo La sostenibilità economica
del giornalismo digitale: problemi e prospettive, che verteva
sul trovare «un efficace modello di business per valorizzare i
contenuti e retribuire in misura adeguata chi contribuisce al
processo editoriale243». Qualche giorno prima, poco dopo la
sconfitta legale contro l’Huffington Post, Jonathan Tasini
aveva rilasciato una interessante intervista244 per il sito del
festival, di cui si riporteranno alcune parti salienti.
«DOMANDA: Quali sono i problemi principali per
un giornalista digitale oggi?
RISPOSTA: Dipende se si intende un giornalista web
che ha un lavoro a tempo pieno presso una testata o
un giornalista freelance. I giornalisti che lavorano full
time presso una testata hanno visto incrementare
notevolmente la loro mole di lavoro negli ultimi anni,
normalmente senza un compenso aggiuntivo. Le
scadenze quotidiane proprie dell'era della carta
stampata si sono tramutate in una richiesta continua di
nuovi post e di tweet costanti. Ci sono enormi
aspettative: è la nuova versione del giornalista a tutta
velocità in catena di montaggio. Per il giornalista
freelance si riduce tutto più semplicemente a “lavora
per noi gratuitamente”. Se il giornalista freelance poi
lavora per il suo blog personale, allora nasce la
243 http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2012/the-
economic-sustainability-of-digital-journalism-problems-and-prospects 244 Tasini: “Huff Post sta diffondendo la malattia del ‘lavora gratis’ in
tutto il mondo” in festivaldelgiornalismo.com, 18 aprile 2012,
(http://www.festivaldelgiornalismo.com/post/24316/).
121
questione di come monetizzare i contenuti: c'è della
pubblicità da qualche parte là fuori?
D: Cosa ci può dire della sua causa legale con
l'Huffington Post? Come saprà, arriverà presto anche
la versione italiana dell'HuffPo grazie a un accordo
con uno dei maggiori gruppi editoriali italiani, cosa ne
pensa?
R: L'Huffington Post è un cancro che sta diffondendo
la sua malattia del “lavora gratis” in tutto il mondo.
Produce benefici solo per i suoi proprietari. Deve
essere debellato. Vorrei davvero raccomandare a tutti
i giornalisti di boicottare l'Huffington Post ovunque
voglia aprire, inviando un messaggio chiaro anche
agli inserzionisti: perderai parte del tuo business se vai
a fare pubblicità sull'HuffPost finché questo
sfruttatore della manodopera dei giornalisti non
inizierà a retribuire le persone.
D: Cosa ne pensa di “efficaci modelli di business” per
valorizzare adeguatamente i contenuti on line prodotti
dai giornalisti? C'è una soluzione a questo problema?
R: L'espressione “modelli efficaci di business” è un
eufemismo per indicare che è necessario spremere il
più possibile la produttività delle persone per ottenere
profitto. Credo che l'unico modo per compensare i
modelli di business sia quello di formare dei “nuovi
sindacati” per controbilanciare il mercato, grazie a
organizzazioni collettive che possano assicurare a chi
lavora una giusta retribuzione245».
245 Ibidem.
122
Nonostante il monito di Tasini, l’Huffington Post è
sbarcato anche in Italia, il 25 settembre 2012. AOL detiene il
51%, mentre il restante 49% è nelle mani del Gruppo
L’Espresso. La direzione è del giornale è andata a Lucia
Annunziata, che tra le innumerevoli esperienze passate può
vantare la presidenza della RAI, la direzione del TG3, il ruolo
di inviato per Repubblica e quello di corrispondente da
Washington per il Corriere della Sera. Stesso format, stesso
successo. La versione italiana ha seguito le orme di quella
statunitense e dopo il primo anno di vita il Gruppo
L’Espresso ha annunciato che il mese di settembre 2013 ha
registrato un traffico di 3 milioni 232mila utenti unici, 30
milioni di pagine viste e 3mila commenti in media al giorno,
oltre a circa 170mila fan su Faceook e oltre 100mila follower
su Twitter246. «L’Huffington Post Italia ha accompagnato i
lettori italiani in un anno ricco di avvenimenti, raccontati con
tempestività e autorevolezza grazie alla copertura
giornalistica degli eventi in tempo reale della redazione
guidata da Lucia Annunziata, e alle opinioni di 495 blogger
espressione di diverse convinzioni e condizioni politiche,
economiche e religiose247». Ma tutti uniti nella concessione
di lavoro gratuito, si potrebbe aggiungere.
246 L’Huffington Post Italia, compleanno da record, in gruppoespresso.it,
3 ottobre 2013. (http://www.gruppoespresso.it/it/sala-stampa/gruppo-
espresso-informa/documento/lhuffington-post-italia-compleanno-da-
record.html). 247 Ibidem.
123
2.3 La blogosfera
Giuseppe Granieri, autore di Blog Generation, ritiene che
i blog siano, da un punto di vista strumentale, il modello più
semplice di sistema per la gestione dei contenuti248, tanto da
far coincidere il primo blog con il primo sito Web in assoluto.
Del resto, prosegue Granieri, l’idea del creatore di Internet,
Berners-Lee, era di realizzare uno spazio in cui la
pubblicazione dei contenuti fosse facile quanto la loro
consultazione249. Ma cos’è un blog? Bisogna innanzitutto
dire che il termine, abbreviazione di web log, è stato coniato
Jorn Barger, blogger statunitense conosciuto per essere
l’autore di un sito, Robot Wisdom, che ebbe una certa
influenza fin dalla fine degli anni ’90. In Rete è possibile
trovare un numero infinito di definizioni per la realtà del blog,
ma una delle più pertinenti è quella riportata nella pagine
inglese di Wikipedia: «A blog (a truncation of the expression
web log) is a discussion or informational site published on the
World Wide Web and consisting of discrete entries ("posts")
typically displayed in reverse chronological order (the most
recent post appears first)250». Nati inizialmente come forme
di espressione individuale, i blog hanno poi seguito
un’evoluzione che li ha portati ad essere realtà polifoniche.
Scrive Andrew Sullivan, giornalista e blogger statuinitense:
«[…] The key to understanding a blog is to realize that it’s a
248 Granieri G., Blog generation, 2009, Laterza, p. 25. 249 Ivi, p. 26. 250 Un blog (troncamento dell’espressione web log) è un sito di
discussione o informazione pubblicato su Internet e costituito da voci
separate (i post) solitamente esposti in ordine cronologico inverso (il post
più recente appare per primo).
124
broadcast, not a publication. If it stops moving, it dies251». La
diffusione del blog nella Rete ha rappresentato una piccola
rivoluzione inserita nel contesto più ampio della nascita del
Web 2.0: «grazie a questo strumento la Rete è cambiata: la
diffusione dei weblog ha finalmente connesso milioni di
persone, trasformandola da rete di contenuti in infrastruttura
di discussione252». Il blog è stato lo strumento che ha
consentito agli utenti di Internet di passare da una condizione
di passività ad una di più attiva partecipazione nel
modellamento dell’universo del Web. Un altro elemento
fortemente caratterizante è la semplicità di utilizzo, che
spiega il successo e la capillare diffusione del blog. «Il
processo di apprendimento è alla portata dell’utente meno
competente perché non richiede né conoscenze tecniche né
capacità di impaginazione. Il blog, infatti, è già pronto per
l’uso: per cominciare è sufficiente avere qualcosa da scrivere
e da condividere con i propri lettori253». Non richiedendo
competenze, né un impegno particolare, la creazione di un
blog è stata presa in considerazione da un numero sterminato
di persone, che ha usato questa piattaforma anche per
condividere semplicemente i propri pensieri, come una sorta
di diario online. Ma a differenza del diario, «[…] a blog,
unlike a diary, is instantly public. It transforms this most
personal and retrospective of forms into a painfully public
251 «La chiave per comprendere un blog è realizzare che si tratta di una
trasmission, non di una pubblicazione. Se si ferma, muore». Sullivan A.,
Why I Blog in theatlantic.com, 1 novembre 2008
(http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/11/why-i-
blog/307060/). 252 Granieri G., Blog generation, cit., p. 25. 253 Maistrello S., Come si fa un blog, Edizione Tecniche Nuove, 2004, p.
15.
125
and immediate one. It combines the confessional genre with
the log form and exposes the author in a manner no author
has ever been exposed before254». Non è semplice dare una
forma alla blogosfera, tracciarne i confini, perfino quando si
tratta di spazi molto personali. Scrive a tal proposito Di Fraia
nel suo Blog-grafie:
«I confini del diario elettronico risultano
particolarmente labili, sia perché è prevista la
partecipazione dell’altro in qualità anche di redattore,
attraverso il commento, sia perché sono frequenti i
rimandi all’esterno attraverso le tracce che l’autore
lascia sugli altri blog. È l’uso dei link a rappresentare
l’espressione massima di questa connettività che
trasforma il blog in un territorio al contempo
personale e tentacolare che abbraccia più nodi della
Blogosfera255».
La connettività è uno degli elementi fondanti della
blogosfera, oltre che il proprio carattere distintivo rispetto al
mondo mediatico. I due universi sono regolati da logiche
diametralmente opposte. «Per la sua stessa natura il blog è un
atto di generosità: essendo un nodo in un sistema di lettura,
254 «Un blog, a differenza di un diario, è immediatamente pubblico. Esso
trasforma questa forma principalmente personale e retrospettiva in una
dolorosamente pubblica ed immediata. Esso combina il genere
confessionale con la forma del registro ed espone l’autore in una maniera
in cui nessun autore è stato mai esposto in precedenza». Sullivan A., Why
I Blog in theatlantic.com, 1 novembre 2008 (cit.). 255 Di Fraia G. (a cura di), Blog-grafie. Identità narrative in rete, edizioni
Angelo Guerini, Milano 2007, p. 32.
126
sposta l’attenzione (e il lettore) su altre fonti invece di cercare
di trattenerlo sulle sue pagine256». Contro ogni consueta
logica competitiva, è la natura stessa della blogosfera a porsi
su un piano diverso rispetto alle dinamiche di mercato
seguite dai media: «The links not only drive conversation,
they drive readers. The more you link, the more others will
link to you, and the more traffic and readers you will get257».
L’espansione e la crescita costante del modello del blog,
divenuto nel tempo anche mezzo per la divulgazione di
informazione, hanno fatto sì che, nonostante una iniziale
diffidenza258, i giornali online si avvicinassero a questa realtà,
pur tracciando una profonda linea di demarcazione tra
blogging e giornalismo. Come scrive Granieri: «Sebbene i
materiali da costruzione siano gli stessi (ovvero le
informazioni) e alcune procedure di composizione siano
simili, i weblog non sono giornalismo. Informano, ma non
sono giornalismo come lo conosciamo, anche quando a tenere
un blog è un professionista riconosciuto dall’Ordine259». Un
256 Granieri G., Blog generation, cit., p. 38 257 «I link non solo guidano le conversazione, guidano anche i lettori. Più
linki, più verrai linkato e più traffico e lettori otterrai». Sullivan A., Why
I Blog in theatlantic.com, 1 novembre 2008 (cit.). 258 Scrive a tal proposito Jay Rosen: «Alcuni dei sospetti che ho incontrato
sono legati al fatto che dei professionisti si avvicinino ad un’attività che,
molto prima che I professionisti la conoscessero, era non solamente aperta
agli amatory – persone che mettono a disposizione il proprio tempo – ma
era stata inventata, sviluppata e resa popolare da loro». Il messaggio
originale era: «Some of the suspicion I found also has to do with
professionals coming toward an activity that, long before the pros even
knew about it, was not only open to amateurs—people volunteering their
time—but had been invented, developed and first popularized by them».
Rosen J., Brain Food for BloggerCon in pressthink.org,16 aprile 2004,
(http://archive.pressthink.org/2004/04/16/con_prelude.html.). 259 Granieri G., Blog generation, cit., p. 28.
127
blog, rispetto ad un giornale, viene facilmente accomunato
alla pubblicazione di opinione, più che di notizie, ma questo
non è totalmente vero. Forse sarebbe sufficiente, come
puntualizza Rebecca Blood, «chiedere alti standard da coloro
che fanno giornalismo, sia se scrivono per un giornale sia se
scrivono su un blog260». Blog e giornali sono due realtà
diverse sotto molteplici aspetti, ma questo non significa che
da alcuni blog non possa arrivare dell’informazione valida e
verificata quanto quella reperibile sulle testate, cartacee o
digitali che siano. La prima grande differenza di carattere
ontologico è ben sottolineata da Jay Rosen, professore di
giornalismo all’Università di New York, che scrive come il
giornalismo sia una professione chiusa e piena di regole,
mentre il blogging è un’attività aperta a tutti261 e
fondamentalmente priva di regole, soggetta alla discrezione
dell’autore262. Prosegue Rosen: «Blogging is one universe. Its
standard unit is the post, its strengths are the link and the low
costs of entry, which means lots of voices. Journalism is
another universe. Its standard unit is “the story.” Its strengths
are in reporting, verification and access263». Rosen sostiene
260 «[…] demand high standards from those who practice journalism,
whether they write for a newspaper or on a blog» Blood R., A Few
Thoughts on Journalism and What Can Weblogs Do About It in
rebeccablood.net, 15 aprile 2004 (cit.). 261 «Nella blogosfera si nasce tutti uguali e si diventa ciò che si è in grado
di diventare attraverso il proprio concreto fare comunicativo. In teoria
ognuno ottiene ciò che merita, in rapporto alle proprie possibilità
comunicative, intellettuali, creative, relazionali». Di Fraia G. (a cura di),
Blog-grafie. cit, p. 102. 262 Rosen J., Brain Food for BloggerCon in pressthink.org,16 aprile 2004,
(cit). 263 «Il blog è un universo. La sua unità di misura è il post, i suoi punti di
forza sono i link e i bassi costi di ingresso, che significa molte voci. Il
128
come il miglior modo di nobilitare tanto il giornalismo quanto
il blogging, sia separandoli264. Di conseguenza, bisognerebbe
concentrarsi, piuttosto che tentare di inserire la blogosfera
nell’universo giornalistico (o di allontanarla), di capire come
queste due realtà coesistano e collaborino a plasmare
l’informazione online e la Rete tout court. Come sottolinea
Granieri:
«Il weblog, a differenza di modelli a noi più familiari
come il quotidiano o la rivista, non ha nessuna pretesa
di essere esaustivo […] Anzi, al contrario, un weblog
tende per definizione a portare «fuori da sé» il lettore,
dirigendolo verso altre fonti, verso altre voci. Il
risultato è che nessuno legge un solo weblog, poiché
si tratta di un singolo nodo in un’opera collettiva
ipertestuale che tende a configurarsi come un
«sistema di contenuti265».
Le potenzialità della blogosfera sono state, come si è
accennato in precedenza, comprese dagli altri media. Si pensi
all’importanza che i bloggers rivestono in una realtà come
l’Huffington Post, ma anche testate derivate, ad esempio
Corriere.it (figura 20), non hanno tardato a dotarsi di un
insieme di blog266, dove scrivono professionisti di ogni
giornalismo è un altro universo. La sua unità di misura è la storia. I suoi
punti di forza sono il riportare le notizie, la verifica e l’accesso». Ibidem. 264 «Blogging is not journalism. When we separate these two things, we
honor both». Ibidem. 265 Granieri G., Blog generation, cit., p. 36 266 Va sottolineato come tuttavia i blog presenti sulle testate derivate
rispondano meno alle logiche di interconnessione tipiche della blogosfera.
129
genere, da giornalisti a professori universitari, esperti di
politica, economia e quant’altro. E’ in questo senso che la
blogosfera può quindi diventare occasione di spunto ed
approfondimento per il mondo giornalistico, che può
interagire con importanti personalità di settore.
(figura 20 – alcuni dei blog di Corriere.it)
Negli ultimi anni un nuovo fenomeno ha preso piede,
chiamato microblogging. Si tratta di una forma di
pubblicazione costante di piccoli contenuti in Rete, sotto
forma di messaggi di testo (normalmente fino a 140 caratteri),
130
immagini, video o audio MP3. Questi contenuti vengono
pubblicati in un servizio di rete sociale, visibili a tutti o
soltanto alle persone della propria comunità267. Nel prossimo
paragrafo si affronterà questa realtà e in particolar modo i
rapporti tra la forma di microblogging più celebre – Twitter
– e il mondo del giornalismo.
2.4 Microblogging: Twitter e il giornalismo
Affine alla realtà della blogosfera, ma ancor più personale
ed immediato è l’universo del microblogging, di cui Twitter
è esempio più celebre e, giornalisticamente parlando, più
pertinente. Il fenomeno è stato già brevemente descritto, ma
è interesse di questo paragrafo andare ad analizzare il
dibattito che imperversa riguardo alla legittimità
professionale di Twitter, oltre a riportare qualche caso
eclatante in cui questo strumento ha dato prova delle proprie
potenzialità.
Un botta e risposta di grande attualità è quello che è andato
in scena tra il The Australian e il The Guardian. Il 13
novembre 2013 il giornale australiano pubblica un editoriale
sul proprio sito dal titolo Lost in the Twitterverse268. La critica
mossa dal The Australian è forte e diretta: «Hard-core media
values - truth, accuracy, fairness, balance, perspective,
objectivity - are being lost at precisely the wrong time, as the
267 Fonte Wikipedia. 268 Lost in the Twitterverse, 13 novembre 2013, The Australian.
http://www.theaustralian.com.au/opinion/editorials/lost-in-the-
twitterverse/story-e6frg71x-1226758522447
131
news media faces the challenges of falling revenue, distracted
audiences and a loss of skilled practitioners. For newspapers,
the danger is that many are abandoning their core mission in
a democracy, bounding towards meaningless info-tainment
and fleeting fashions269». Pur riconoscendo l’utilità di questi
strumenti limitatamente a certi contesti, il giornale
australiano ritiene che i social media non possano in alcun
modo sostituirsi all’informazione dei media tradizionali:
«Platforms such as Twitter and Facebook are wonderful tools
for journalists and the industry as a whole in terms of
marketing. They can be used to promote stories, maintain
contacts with readers and pass the time on the bus for those
with short attention spans. But social media is neither a
substitute for reporting nor a reflection of what is important
in our democracy270». Le prime critiche all’editoriale sono
state mosse proprio da ex-giornalisti del The Australian. Ad
esempio Amanda Meade risponde con un Tweet, ironizzando
sull’affermazione della testata australiana che definisce i
giornalisti che usano Twitter un “path to ruin”, ovvero “il
sentiero che porta alla rovina” (figura 21).
269 «I valori tradizionali dei media – come la verità, l’accuratezza, la
correttezza, l’equilibrio, l’obiettività – si sono perse esattamente nel
momento sbagliato, mentre i mezzi d’informazioni affrontano le sfide del
calo delle vendite, del pubblico distratto e della perdita di professionisti
capaci. Per i giornali, il pericolo è che molti stiano abbandonando la loro
missione cruciale in una democrazia, affrettandosi verso infotainment
privo di significato e mode passeggere». Ibidem. 270 «Piattaforme come Twitter e Facebook sono magnifici strumenti per i
giornalisti e l’industria nel suo insieme in termini di marketing. Possono
essere usati per promuovere storie, per mantenere contatti con i lettori e
per passare il tempo sull’autobus per coloro con una breve curva
d’attenzione. Ma il social media non è né un sostituto del giornalismo, né
un riflesso di cosa è importante nella nostra democrazia». Ibidem.
132
(figura 21 – il tweet ironico di Amanda Meade, pubblicato il 12
novembre 2013 alle 15:01)
Un’altra reazione decisa è arrivata dalla testata britannica
The Guardian, affidata all’articolo Brownen Clune, So
Twitter is ruining journalism? Really?271. «Twitter is one of
the most powerful journalistic tools available to newsrooms,
and inherent to their survival. That the only national
Australian daily newspaper would publicly fail to understand
that is alarming. We need newsrooms. We need professional
journalists. We need a diverse media landscape. Twitter and
social media play a vital role in that future272». Brownen
271 Clune B., So Twitter is ruining journalism? Really? in
theguardian.com 13 novembre 2013,
(http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/13/so-twitter-is-
ruining-journalism-really). 272 «Twitter è uno degli strumenti giornalistici più potenti che hanno a
disposizione le redazioni, e fondamentale per la loro sopravvivenza. Il
133
Clune porta a sostegno della propria posizione alcuni casi in
cui Twitter ha dato il proprio contributo al giornalismo, nel
duplice senso dell’atto in sé e della professione. Verranno
analizzati in questa sede quattro casi: l’utilizzo di Twitter per
analizzare la polarizzazione politica della società egiziana, le
rivolte di Londra del 2011, la morte di Osama Bin Laden e
l’incidente aereo avvenuto all’aeroporto di San Francisco il 6
luglio 2013.
Twitter e la polarizzazione politica in Egitto. Durante le
rivolte del Nord Africa e del Medio Oriente, che si accesero
a cavallo tra 2010 e 2011, Twitter, così come altri social
network (Facebook su tutti), ricoprì un ruolo di fondamentale
importanza. Da una parte venne usato dagli attivisti come
strumento di organizzazione e di contatto, dall’altra fu una
straordinaria fonte d’informazioni per i giornalisti che erano
altrimenti impossibilitati a recarsi di persona sui luoghi delle
rivolte. Twitter ha continuato a rivestire un ruolo da
protagonista nell’analisi della situazione politica e sociale dei
paesi coinvolti, ad esempio l’Egitto, di cui è stato studiata la
polarizzazione politica proprio partendo da dati e
informazioni raccolte dalla piattaforma di microblogging. La
ricerca è stata svolta da Ingmar Weber e Kiran Garimella con
l’obiettivo di misurare la tensione politica del paese. «We are
interested in gauging political tension through online data to
have a “barometer” that indicates how charged and explosive
the situation is at a given point in time. Our research shows
solo fatto che l’unico quotidiano nazionale australiano possa
pubblicamente non riuscire a capire questo è allarmante. Abbiamo
bisogno di redazioni. Abbiamo bisogno di giornalisti professionali.
Abbiamo bisogno di un diverso senario mediatico. Twitter e i social media
giocano un ruolo vitale in quel futuro». Ibidem.
134
that simply looking at whether Islamists and secularists use
the same hashtags goes a long way towards this goal273». I
due ricercatori hanno in primo luogo identificato circa due
dozzine di attivisti politici vicini sia agli islamisti, sia ai
laici274. In seguito sono stati invece individuati migliaia di
utenti Twitter che avevano pubblicamente retwittato qualsiasi
degli attivisti descritti poc’anzi275. «In the week from June 29
to July 5, 2013 the hashtag #MuslimsForMorsi was used far
more commonly among retweeters of Islamists than seculars
and would be assigned a polarity score of 90 percent Islamist,
whereas #tamarrod, referring to the Egyptian political
movement founded in protest against then-president Morsi
would be almost 100 percent secular on the same axis276».
Questa ricerca, che mira semplicemente ad avere un quadro
273 «Siamo interessati nella misurazione della tensione politica attraverso
i dati reperibili online in modo da avere un “barometro” che indichi
quanto carica ed esplosiva sia la situazione ad un certo momento. La
nostra ricerca mostra che semplicemente osservando se gli islamisti o i
laici utilizzano lo stesso hashtag otteniamo molte informazioni in tal
senso». Ingmar W., Using Twitter to track political polarisation in Egypt
in aljazeera.com 4 ottobre 2013,
(http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/09/utilising-twitter-
track-political-polarisation-egypt-201392714215315617.html). Gli
hashtag sono un tipo di tag utilizzato in alcuni social network per creare
delle etichette. Essi sono formati da parole o combinazioni di parole
concatenate precedute dal simbolo # (cancelletto), inseriti come
commenti alle immagini. Fonte: Wikipedia. 274 Ibidem. 275 Ibidem. 276 «Nella settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2013, l’hashtag
#MuslimForMorsi è stato usato molto più comunemente tra i retweeters
degli islamisti, piuttosto che dei laici e si potrebbe assegnare una
percentuale di popolarità tra gli islamisti del 90%, viceversa #tamarrod,
riferito al movimento politico egiziano fondato in protesta dell’allora
presidente Morsi avrebbe quasi il 100% di popolarità tra i laici». Ibidem.
135
orientativo della situazione politica e sociale dell’Egitto,
rappresenta un eccellente esempio del connubio tra data
journalism e Twitter.
London Riots. Tra il 6 e il 10 agosto del 2011, a Londra prima,
in altre città inglesi poi, si sono verificati dei disordini:
rivolte, atti di vandalismo e saccheggi. Il tutto scatenato
dall’uccisione di Mark Duggan, uno spacciatore di cocaina,
da parte della polizia277. Scrive il Guardian: «For many
people, the England riots began with a flurry of curious
Twitter messages shortly before 9pm on Saturday 6 August.
"There is a photo of a police car burning circulating, claiming
it's outside Tottenham police station #markduggan
#tottenham shooting," one of the messages read. Users were
sharing news of a police car ablaze outside Tottenham police
station278». Questi messaggi vennero rapidamente seguiti da
un’altra foto, quella di un autobus in fiamme nel quartiere di
Tottenham, nel nord di Londra e dalla creazione di un
277 Man dead and police officer hurt in Tottenham shooting in bbc.co.uk,
5 agosto 2011, (http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-
14412752); Bracchi P., Violence, drugs, a fatal stabbing and a most
unlikely martyr in dailymail.co.uk, 8 agosto 2011,
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-2023556/Mark-Duggan-
Violence-drugs-fatal-stabbing-unlikely-martyr.html). 278 «Per molte persone, le rivolte inglesi sono cominciate con un turbinio
di strani messaggi su Twitter poco prima delle 9 di sera di sabato 6 agosto.
“C’è una foto di una macchina della polizia in fiamme che circola, si
sostiene sia fuori la stazione di polizia di Tottenham #markduggan
#tottenham shooting,” uno dei messaggi letti. Gli utenti condividevano
notizie di una macchina della polizia in fiamme fuori dalla stazione di
polizia di Tottenham». Ball J. e Lewis P., Twitter and the riots: how the
news spread in theguardian.com, 7 dicembre 2011,
(http://www.theguardian.com/uk/2011/dec/07/twitter-riots-how-news-
spread).
136
hashtag, #TottenhamRiots, divenuto poi il cuore del
susseguirsi degli eventi su Twitter279. Quel che più conta in
questa sede è che ben prima dei tradizionali mezzi di
diffusione giornalistica, fu da Twitter che arrivarono le prime
notizie e i primi aggiornamenti di quanto stava accadendo a
Tottenham. «The England riots were a seminal moment for
Twitter. With mainstream media organisations often
struggling to keep up with the fast-moving and unpredictable
spread of the unrest, millions of people turned to the social
networking site for information280».
La morte di Osama Bin Laden. L’operazione condotta dalle
forze statunitensi che ha portato all’uccisione del leader di Al-
Qaeda Osama Bin Laden è un altro straordinario esempio
dell’informazione giornalistica veicolata tramite Twitter. La
prima persona a riportare quanto stava accadendo,
inconsapevolmente e in tempo reale, è stata Sohaib Athar
tramite il suo account su Twitter @ReallyVirtual, un
consulente d’informatica che viveva ad Abbottabad, la città
pakistana dove si rifugiava Bin Laden281. Sohaib Athar twittò
il passaggiò di un elicottero poco prima dell’inizio
dell’operazione, senza che in realtà sapesse cosa stesse per
accadere. In seguito arrivarono altri tweet, che man mano
descrivono la presa di coscienza rispetto a quello cui Athar
stava assistendo. Il Post ha raccolto, tradotto e messo a
279 Ibidem. 280 «Le rivolte inglesi furono un momento cruciale per Twitter. Con i
media tradizionali spesso in difficoltà nel tenere il passo del veloce e
imprevidibile propagarsi del malcontento, milioni di persone si affidarono
ai social network per ottenere informazioni». Ibidem. 281 Bin Laden raid was revealed on Twitter in bbc.co.uk, 2 maggio 2011,
(http://www.bbc.co.uk/news/technology-13257940).
137
disposizione molti dei tweet pubblicati da Sohaib Athar
durante l’operazione contro Bin Laden:
«Elicotteri sopra Abbottabad all’una del mattino (è
una cosa piuttosto rara)
Andatevene, elicotteri, prima che prenda il mio
acchiappamosche gigante :-/
Una grossa esplosione qui ad Abbottabad. Spero non
sia l’inizio di qualcosa di brutto :-S
Tutto tace dopo l’esplosione, ma un mio amico dice
di averla sentita a sei chilometri da qui. Anche
l’elicottero è andato.
L’acchiappa mosche gigante ha funzionato!
Dato che i talebani non hanno elicotteri, e dato che
stanno dicendo che non era “loro”, dev’essere una
cosa complicata.
Sembra che l’elicottero sia stato abbattuto vicino
all’area di Bilal Town. La gente dice che forse era un
drone.
Devo scusarmi con il pilota, per le battute
sull’acchiappamosche.
Circolano voci interessanti riguardo l’incidente di
Abbottabad.
Mi sa che Abbottabad sta per diventare incasinata
come la Lahore che mi ero lasciato alle spalle in cerca
di pace e tranquillità. *sigh*
138
Uh oh, ora sono il tizio che ha fatto il liveblogging del
raid contro Osama senza saperlo.
E già arrivano le email dai mainstream media…
*sigh*
La sparatoria è durata 4-5 minuti, per quello che ho
sentito. Ormai sono passate circa dieci ore. Da quel
momento non ho sentito nessun altro colpo.
“Ti sta seguendo su Twitter” era il logico passo
successivo282».
Sfruttando le potenzialità di Twitter Sohaib Athar ha
potuto trasmettere la notizia dell’assalto statunitense contro
Bin Laden, il tweet «ora sono il tizio che ha fatto il
liveblogging del raid contro Osama senza saperlo» è
straordinariamente efficace nel descrivere come questo
strumento dia la possibilità a chiunque di diventare testimoni
di eventi di portata mondiale e storica. Ma Twitter non si è
fermato alla cronaca di Sohaib Athar, infatti anche l’annuncio
dell’uccisione di Bin Laden è stata data tramite la celebre
piattaforma di microblogging. Keith Ubrahn, il capo dello
staff del Segretario della Difesa sotto la presidenza di George
W. Bush, è stata infatti la prima persona a rendere pubblica
la morte del leader di Al-Qaeda. Tramite Twitter, ovviamente
(figura 22).
282 L’uomo che ha twittato la morte di bin Laden (senza
saperlo) in ilpost.it, 2 maggio 2011,
(http://www.ilpost.it/2011/05/02/luomo-che-ha-twittato-
la-morte-di-bin-laden-senza-saperlo/).
139
(figura 22 – Il tweet di Keith Urbahn, il primo annuncio
dell’uccisione di Bin Laden)
«So I'm told by a reputable person they have killed Osama
Bin Laden. Hot damn», il tweet di Keith Urbahn283. Ovvero,
«Ebbene mi è stato detto da una persona affidabile che hanno
ucciso Osama Bin Laden. Incredibile». Come riporta il The
Guardian, il tweet arrivò quando il presidente Obama stava
ancora scrivendo il discorso che avrebbe annunciato agli Stati
Uniti e al mondo intero l’uccisione del nemico numero uno
della Casa Bianca284. Il grande entusiasmo nei confronti di
283 https://twitter.com/keithurbahn/statuses/64877790624886784 284 «At the time President Obama was still writing his speech in which he
would announce the killing of the US's most-sought enemy». Arthur C.,
140
Twitter e dei social media in generale come mezzi capaci di
fare informazioni secondo altre logiche venne frenata dallo
stesso Keith Urbahn, che in un altro tweet scrisse: «As much
as I believe in rise of "citizen journalism," blogs, twitter etc
supplanting traditional media, my tweet isn't great evidence
of it285».
L’incidente aereo di San Francisco. Un ultimo caso, accaduto
il 6 luglio del 2013. «Un Boeing 777 della compagnia
sudcoreana Asiana in arrivo da Seul si è schiantato al suolo
sabato sera all'aeroporto di San Francisco mentre era in fase
di atterraggio e si è incendiato, venendo avvolto in una palla
di fuoco. Il bilancio, reso noto dai vigili del fuoco, è di almeno
2 morti - entrambi d cittadinanza cinese - e 182 feriti, di cui
49 in condizioni critiche286». Questa la cronaca di quanto
accaduto, ma in queste sede è di maggiore interesse riportare
come fu – in un incredibile esempio di citizen journalism –
uno dei passeggeri a dare la notizia dello schianto. David Eun,
manager della Samsung, ebbe la freddezza di affidare al
Twitter first with news of Osama bin Laden's death via ex-Bush staffer in
theguardian.com, 2 maggio 2011,
(http://www.theguardian.com/technology/blog/2011/may/02/twitter-
osama-bin-laden-death-leaked). 285 «Per quanto io stesso creda che l’ascesa di “citizen journalism”, blog,
twitter possa soppiantare i media tradizionali, il mio tweet non dimostra
molto in tal senso». Bin Laden raid was revealed on Twitter in bbc.co.uk,
2 maggio 2011, (cit.). 286 San Francisco, aereo finisce fuori pista Almeno 2 vittime, 182 feriti in
corriere.it, 6 luglio 2013,
(http://www.corriere.it/esteri/13_luglio_06/san-francisco-aereo-si-
schianta-in-pista-passeggeri-intrappolati_411a7170-e670-11e2-ad19-
4496ac8ff7bf.shtml).
141
proprio smartphone il resoconto di quanto era appena
accaduto (figura 23).
(figura 23 – Il tweet di Eun dopo lo schianto)
«Mi sono appena schiantato in atterraggio con
all’aeroporto di San Francisco. La coda si è staccata. La
maggior parte delle persone sembra stare bene. Io sono a
posto. Surreale…». Questo il tweet, corredato da una
fotografia dell’aereo, pubblicato dal manager della Samsung
immediatamente dopo l’incidente. I media non tardarono a
trasmettere a loro volta la notizia data da Eun, che ha poi
alimentato la voracità dei mezzi d’informazione con altri
tweet. Uno straordinario esempio di come i social media
142
possano stravolgere le regole del giornalismo rendendo
semplici cittadini – in questo caso un protagonista
dell’accaduto – dei reporter. Probabilmente il dibattito sulla
legittimità nel definire Twitter come una forma di
giornalismo dovrebbe cambiare la sua prospettiva. Questi
strumenti non devono necessariamente soppiantare
l’industria dell’informazione tradizionale, ma le due realtà
possono convivere, sfruttando ognuna i punti di forza
dell’altra con il solo obiettivo di garantire delle notizie
accurate e fondate.
Questo esempio di citizen journalism anticipa il soggetto
del prossimo paragrafo, ma prima di voltare pagina è il caso
di lasciare spazio ad un’ultima riflessione, che verte sui
motivi che fanno sì che Twitter sia lo strumento preferito dai
giornalisti, ad esempio rispetto ad un altro celebre social
network come Facebook. Uno studio di Shareholic287, basato
su dati raccolti per 13 mesi (da settembre 2012 a settembre
2013) inerenti a 200mila editori che generano un traffico
mensile di oltre 250 milioni di utenti unici, mostra come i
rimandi a Facebook, e quindi il suo traffico, siano di gran
lunga superiori a quelli di Twitter288. Scrive Ezra Klein sul
Washington Post: «Yet journalists -- and, quite often, the
organizations that employ them -- clearly prefer Twitter.
They put enormous effort into building Twitter brands and
coming up with Twitter strategies289». L’articolo del giornale
287 Shareaholic’s Social Media Traffic Report. https://shareaholic.com/ 288 https://blog.shareaholic.com/social-media-traffic-trends-10-2013/ 289 «Tuttavia i giornalisti – e, molto spesso, le aziende che li assumono –
preferiscono chiaramente Twitter. Compiono grandi sforzi per costruire
marchi per Twitter e per programmare strategie per Twitter». Klein E.,
Why do journalists prefer Twitter to Facebook? in washingtonpost.com,
11 novembre 2013,
143
statunitense prova a chiarire anche i motivi di questa
predilezione: «The reason, I think, is that Twitter is simply
more useful for our jobs. For better or worse, it's where news
breaks today. It's also where a lot of real-time reporting
happens. […] As a journalist, if you wanted to stay on top of
much of the best reporting you simply have to be on
Twitter290». Un’altra componente da sottolineare è che la
fama si autoalimenta. Come giustamente afferma Ezra Klein,
il solo fatto che così tanti giornalisti siano presenti su Twitter
dona alla piattaforma un’aura di grande professionalità.
«Tweeting your articles ensures they're seen -- and discussed,
and retweeted -- within a community that includes not just
your friends and peers, but the people who might hire you
someday291».
2.5 Citizen journalism
«When the people formerly known as the audience employ
the press tools they have in their possession to inform one
(http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/11/11/why-
do-journalists-prefer-twitter-to-facebook/). 290 «La ragione, penso, è che Twitter è semplicemente più utile per i nostri
lavori. Giusto o sbagliato, è dove le notizie arrivano oggi. È anche dove
si sviluppa l’informazione in tempo reale. […] Come giornalista, se vuoi
essere aggiornato da un’informazione di qualità devi essere su Twitter».
Ibidem. 291 «Twittando i tuoi articoli ti assicuri che siano visti – e discussi, e
retwittati – all’interno di una comunità che non include solamente i tuoi
amici e i tuoi colleghi, ma persone che potrebbero assumerti un giorno».
Ibidem.
144
another, that’s citizen journalism292». Questa è la definizione
di citizen journalism data da Jay Rosen e già riportata
precedentemente in questa ricerca. Un punto di partenza
imprescindibile per andare ad analizzare nel dettaglio questa
forma di giornalismo che ha, più di altre, scardinato i processi
informativi tradizionali. È interessante notare come il
giornalista Daniel Bennett chieda a Jay Rosen, tramite un post
sul proprio blog Mediating Conflict, di integrare la sua
definizione: «Merely informing one another is not
journalism. This happens all the time. Teachers inform
children in classes all the time, but this isn't journalism is
it?293». Bennett ritiene che vadano fatte due aggiunte: la
prima atta a sottolineare come lo scambio di informazioni
coinvolga un grande numero di persone; la seconda
indirizzata ad evidenzare invece come l’informazione debba
essere comunque degna di nota, meritevole d’essere riportata.
Questa la versione di Bennett della definizione di Rosen:
«When the people formerly known as the audience employ
the press tools they have in their possession to inform many
292 «Quando le persone precedentemente conosciute come pubblico
utilizzano gli strumenti della stampa che hanno in loro possesso per
informarsi l’un l’altro, questo è citizen journalism». Rosen J., A Most
Useful Definition of Citizen Journalism in pressthink.org, 14 luglio 2008
(http://archive.pressthink.org/2008/07/14/a_most_useful_d.html). 293 «Informarsi semplicemente l’un l’altro non è giornalismo. Questo
accade in qualsiasi momento. Gli insegnatni informano I loro alunni nelle
classi in ogni istante, ma questo non è giornalismo, no?». Bennett D., The
definition of citizen journalism considered (ignore my previous post!) in
dsbennett.co.uk, 17 luglio 2008
(http://www.dsbennett.co.uk/2008/07/ignore-that-last-post-defintion-
of.html).
145
others of a newsworthy event, that’s citizen journalism294».
E’ lo stesso Rosen invece a spiegare cosa intende con “le
persone precedentemente conosciute come pubblico”. «The
people formerly known as the audience are those who were
on the receiving end of a media system that ran one way, in a
broadcasting pattern, with high entry fees and a few firms
competing to speak very loudly while the rest of the
population listened in isolation from one another— and who
today are not in a situation like that at all295». Jay Rosen
introduce i suoi lettori di fronte ad una vera e propria
rivoluzione copernicana, che ha però il sapore di una rivalsa
proletaria, giornalisticamente parlando. Il ribaltamento dei
rapporti di dominanza tra un élite che deteneva l’esclusivo
diritto all’informazione e una massa che non poteva che
accettare passivamente. Questa svolta è stata resa possibile
grazie all’avvento dell’era digitale: «What became known as
citizen journalism is the result of the digital era’s
democratization of media — wide access to powerful,
inexpensive tools of media creation; and wide access to what
294 «Quando le persone precedentemente conosciute come pubblico
utilizzano gli strumenti della stampa che hanno in loro possesso per
informare molte altre persone riguardo ad un evento degno di nota, questo
è citizen journalism». Ibidem. 295 «Le persone precedentemente conosciute come pubblico sono quelle
che si trovavano al termine del sistema mediatico unidirezionale in qualità
di riceventi, in un modello di comunicazione di massa, con alte quote
d’ingresso e poche firme abilitate a parlare molto forte mentre il resto
della popolazione ascoltava isolatamente – e che oggi non si trovano
assolutamente in più in una situazione come quella». Rosen J., The People
Formerly Known as the Audience in pressthink.org, 27 giugno 2006
(http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html).
146
people created, via digital networks296». Il pubblico si è
trasformato esso stesso in un media indipendente: «The
audience has now transformed to an independent media. We
have now our printing press – the blog; our own radio station,
the podcasting, our own TV station, the vlog; our own
gallery, the photoblogs; our own alerts, the twitter feeds and
so on297». Anche i rapporti con i media tradizionali, che in
ogni caso sopravvivono, subiscono delle profonde modifiche:
«The users are deciding what the point of their engagement
will be — what application, what device, what time, what
place298». I media tradizionali non si mostrano ciechi di fronte
ai cambiamenti che definiscono il nuovo pubblico come un
pubblico attivo che desidera creare, comunicare, dibattere,
condividere299. Del resto, la svolta è epocale e allerta anche i
296 «Quello che è diventato noto come citizen journalism è il risultato della
democratizzazione dei media dell’era digitale – ampio accesso a strumenti
di creazione mediatica potenti ed economici; e ampio accesso a quello che
le persone creavano, attraverso le reti digitali». Gillmor D., Where Did
"Citizen Journalist" Come From? in citmedia.org, 14 luglio 2008
(http://citmedia.org/blog/2008/07/14/where-did-citizen-journalist-come-
from/). 297 «Il pubblico è ora trasformato in un media indipendente. Abbiamo la
nostra carta stampata – il blog; la nostra stazione radio, i podcast, la nostra
emittente televisiva, il vlog; la nostra galleria fotografica, i photoblog; i
nostri allarmi, i feeds di twitter e così via». Citizen journalism and Rising
Voices in rising.globalvoicesonline.org, 20 luglio 2008
(http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2008/07/20/citizen-journalism-
and-rising-voices/). 298 «Gli utenti decideranno quale sarà il livello del loro coinvolgimento –
quale impegno, quale strumento, quale ora, quale posto». Rosen J., The
People Formerly Known as the Audience in pressthink.org, 27 giugno
2006, (cit). Lla frase appartiene a Tom Curley, amministratore delegato
della Associated Press. 299 Ibidem.
147
più conservatori, come il docente Nicholas Lemann della
Columbia University: «the category that inspires the most
soaring rhetoric about supplanting traditional news
organizations is ‘citizen journalism’, meaning sites that
publish contributions of people who don’t have jobs with
news organizations but are performing a similar function300».
Come accade spesso, scemata l’ondata rivoluzionaria, arriva
il tempo del ripristino dell’ordine, che nel caso del citizen
journalism significa incastonarlo, categorizzarlo, inserirlo nel
linguaggio quotidiano con le sue caratteristiche e sfumature.
A tal proposito il giornalista Tony Rogers su About.com ha
diviso il giornalismo partecipativo (così chiamato in Italia) in
due macro categorie: quello semi-indipendente e quello
indipendente. Il semi-indipendent citizen journalism vede i
cittadini contribuire in diversi modi ai siti di informazione
tradizionale già esistenti: la pubblicazione di commenti
relativi a notizie scritte da giornalisti professionisti,
l’aggiunta di ulteriori informazioni rispetto a quelle inserite
in un pezzo redatto da un reporter, la collaborazione tra
lettore e autore nella stesura della storia (ad esempio un
consulto tecnico) e infine l’incorporazione di blog degli utenti
nei siti dei media tradizionale. L’indipendent citizen
journalism vede i cittadini muoversi in maniera del tutto
indipendente rispetto al mondo del giornalismo
professionista. Rientrano in questo caso blog in cui delle
300 «La categoria che più ispira la retorica che le tradizionali
organizzazioni di news possano essere soppiantate è il citizen journalism.
Con citizen journalism si intendono quei siti che pubblicano i contributi
di quelle persone che non lavorano con le aziende giornalistiche, ma che
ugualmente compiono una funzione simile». Lemann N., Amateur Hour
in newyorker.com, 7 agosto 2006
(http://www.newyorker.com/archive/2006/08/07/060807fa_fact1).
148
persone riportano gli eventi delle loro comunità, siti di notizie
con la medesima funzione o siti ibridi in cui professionisti e
citizen journalist lavorano fianco a fianco301.
Il dibattito sulla dignità del citizen journalism è vivace. E’
interessante la posizione del già citato Nicholas Lemann,
perché – pur scettico – inserisce il giornalismo partecipativo
in una nicchia in cui si muove a proprio agio, molto più di
quello professionista: la testimonianza di eventi inaspettati.
«The best original Internet journalism happens more often by
accident, when smart and curious people with access to
means of communication are at the scene of a sudden disaster.
Any time that big news happens unexpectedly, or in remote
and dangerous places, there is more raw information
available right away on the Internet than through established
news organizations302». Lemann non crede però nel citizen
journalism tout court, sostiene anzi che «as journalism moves
to the Internet, the main project ought to be moving reporters
there, not stripping them away303». I processi informativi
devono rimanere nelle mani dei professionisti, sostiene
Lemann, pur potendo questi ultimi sfruttare delle integrazioni
che vengono dai cittadini e dale nuove tecnologie. La 301 Rogers T., What Is Citizen Journalism? in about.com
(http://journalism.about.com/od/citizenjournalism/a/whatiscitizen.htm) 302 «Il miglior giornalismo di internet avviene quasi sempre per caso,
quando persone curiose e intelligenti, con accesso agli strumenti di
internet, sono sulla scena del disastro. Ogni volta che gli eventi succedono
inaspettatamente, o in posti remoti e pericolosi, c’è più possibilità di avere
informazione immediatamente disponibile su internet che dalle
organizzazioni consolidate». Lemann N., Amateur Hour in The New
Yorker, 7 agosto 2006, cit. 303 «Nel momenti in cui il giornalismo approda su Internet, l’obiettivo
principale dovrebbe essere far arrivare lì anche i reporter, non portarli
via». Ibidem.
149
posizione critica nei confronti del citizen journalism da parte
dei media tradizionali si basa spesso anche sul fatto che i
cittadini coprano il bisogno informativo di piccole comunità:
«Citizen journalists may be activists within the communities
they write about. This has drawn some criticism from
traditional media institutions such as The New York Times,
which have accused proponents of public journalism of
abandoning the traditional goal of “objectivity”304». L’errore
è in questo caso dettato dal timore con cui spesso i media
tradizionali guardano alle novità, sintomatico di una paura di
venire soppiantati che appare infondata. Media tradizionali e
citizen journalism sono due realtà che possono
tranquillamente coesistere ognuna con i proprio punti di forza
e le proprie lacune cercando laddove possibile di integrarsi
vicendevolmente. Del resto, la peculiarità del giornalismo
partecipativo non risiede meramente nella copertura delle
notizie, quanto piuttosto nella portata rivoluzionaria della sua
stessa esistenza: l’appropriazione degli strumenti di
trasmissione dell’informazione. I media tradizionali
dovrebbero considerare il citizen journalism come una fonte
ulteriore a cui attingere, non come una minaccia.
«Vi sono ancora importanti discriminanti che lo
distinguono dal giornalismo mainstream, aldilà
304 «I citizen journalist possono essere attivisti della comunità su cui
scrivono. Questo ha portato ad alcune critiche da parte delle istituzioni del
giornalismo tradizionale, come The New York Times, che hanno accusato
i proponenti del public journalism di perdere di vista lo scopo tradizionale
dell’obbiettività». Rosen J., The Weblog: An Extremely Democratic Form
in Journalism, in PressThink, 8 marzo 2004
(http://archive.pressthink.org/2004/03/08/weblog_demos.html).
150
dell'imitazione di tono e narrazione e dell'adozione del
concetto di newsworthness: il tempo di verificare la
notizia e la gerarchizzazione delle stesse, anzitutto.
Nella stessa scelta terminologica della definizione,
“citizen” c'è l'elemento che aiuta a ricostruire quella
dimensione sociale del racconto giornalistico che
appare il suo tratto più caratterizzante: un mondo
autonomo, creato e gestito dagli utenti stessi, dove i
grandi cataclismi si alternano, senza soluzione di
continuità, ai piccoli accadimenti della
quotidianità305».
A tal proposito è interessante analizzare un articolo
dell’Economist che sottolinea come, piuttosto che mettere a
rischio il futuro del giornalismo professionista, il citizen
journalism abbia l’incredibile capacità di creare nuovi posti
di lavoro. Si tratta di tutte quelle persone preposte allo
scandaglio della Rete in modo tale da trovare, controllare,
autenticare e riproporre materiale pubblicato da normali
utenti. «Far from shunning “shaky footage”, audiences think
users’ videos more intimate and authentic than broadcasters’
slick shots306», sostiene Claire Wardle, di Storyful, una
305 Biasio M., Dal reporter al "citizen journalism": come
cambia il racconto dei fatti, in unipd.it 11 novembre 2013
(http://www.unipd.it/ilbo/content/dal-reporter-al-citizen-
journalism-come-cambia-il-racconto-dei-fatti). 306 «Invece di respingere quelle ‘’riprese mosse’’ dei video
amatoriali o occasionali, tra l’ altro, il pubblico pensa che
le immagini dei cittadini siano più autentiche e ‘’intime’’
di quelle ‘’lucide’’ delle emittenti». Amateur journalists
create jobs for professional ones in economist.com, 1
giugno 2013,
(http://www.economist.com/news/international/21578662-
151
azienda che verifica e pubblica i contenuti generati dagli
utenti. L’articolo dell’Economist sottolinea come le imprese
editoriali si stiano muovendo in due direzioni: da una parte,
superato lo scetticismo iniziale, stanno puntando sull’utilizzo
delle reti sociali come fonti di informazioni; dall’altra si
stanno impegnando nella creazione di piattaforme che
incoraggino i lettori a fornirgli direttamente i loro materiali.
Appartengono a questa categoria iReport di CNN, il
capostipite del genere, che può ora vantare 1,3 milioni di
collaboratori, numero aumentato di ben 6 volte rispetto al
momento del lancio, nel 2008. Di grande originalità il sistema
proposto dal quotidiano svedese Aftonbladet, che chiede ai
propri lettori di fornire il loro indirizzo in modo tale da
avvertirli di eventuali avvenimenti nelle vicinanze della zona
segnalata e chieder loro dei contributi (immagini, video o testi
che siano) in cambio di un piccolo compenso. Anche il
Guardian, sempre attento alle novità offerte dalla Rete, si è
dotato di una piattaforma (Guardian Witness) che consente
agli utenti della versione mobile di pubblicare dei video
d’interesse. Tuttavia, a spaventare le imprese editoriali è la
tendenza dei citizen journalist di postare i propri contenuti
direttamente sui social network, piuttosto che utilizzando le
testate giornalistiche come tramite. «In 2005 nearly all of the
BBC’s user-generated content was submitted directly to the
organisation; now it has to hunt down half of it from social
networks. That means sifting a lot of dross. Every day 7,000
hours of news-related videos are uploaded to YouTube, an
online-video site owned by Google, much of it created by
amateurs. News organisations are hiring ever bigger teams to
amateur-journalists-create-jobs-professional-ones-foreign-
correspondents).
152
scavenge for the best307». Ad esempio la BBC News è tra le
testate meglio attrezzate da questo punto di vista, con circa
20 dipendenti che lavorano a tempo pieno occupandosi della
selezione dei materiali provenienti dagli utenti. Altri
quotidiani importanti si affidano solitamente a gruppi di
lavoro che vanno tra le 5 e le 7 unità. La fase successiva è
rappresentata dalla verifica dell’attendibilità di quanto
trovato sul Web secondo modalità differenti rispetto al
processo che si mette in atto per le fonti tradizionali:
«conscientious reporters will examine users’ past posts to see
if they have obvious political biases and to check that they are
where they claim to be. They use Google’s satellite maps to
certify the location of a photograph or video, and search
image banks to ensure that a photograph is not doctored308».
L’ultimo passaggio, quello della pubblicazione, prevede
l’ottenimento del permesso da parte di chi detiene i diritti sul
materiale in questione. Questa fase non è così immediata
come si potrebbe pensare. Infatti, nella maggior parte dei casi
l’utente chiede alle testate solamente di essere citato, senza
pretendere un compenso economico. Ma proprio rintracciare
307 «Nel 2005 quasi tutti i contenuti prodotti dagli utenti della BBC erano
stati sottoposti alla testata. Ora invece l’ emittente deve dare la caccia ad
almeno la metà di quei contenuti che vanno sui social network. E quindi
significa spulciare un sacco di materiali inutili. Ogni giorno 7.000 ore di
video-notizie vengono caricate su YouTube e varie testate giornalistiche
stanno assumendo sempre più addetti alla ‘’pulizia’’ e al filtraggio delle
reti sociali». Ibidem. 308 «Giornalisti coscienziosi devono esaminare i precedenti post dei
singoli utenti per vedere se hanno dei pregiudizi politici evidenti e
verificare se sono davvero dove dicono di essere. Devono usare delle
mappe satellitari per certificare la posizione di una fotografia o un video,
e scavare nelle banche dati per garantire che una immagine non sia stata
ritoccata». Ibidem.
153
queste persone fa sì che i redattori preposti perdano spesso
moltissimo tempo. «Many journalists want to see simpler
licensing rules. They would like YouTube and Twitter to
make it easier for web users to grant rights to news firms,
perhaps by ticking a box when they first upload their
content309». Offrendo la possibilità di snellire questo
processo macchinoso alcune aziende stanno creando un
nuovo settore di mercato. La già citata Storyful ad esempio
propone un servizio di individuazione e contrattazione dei
diritti sui contenuti prodotti dagli utenti a cui una testata può
accedere pagando un canone di abbonamento mensile tra i
750 e i 15.000 dollari. Esistono inoltre siti come il francese
Citizenside che si pongono come intermediari con l’obiettivo
di aiutare gli utenti a vendere i propri materiali alle testate
giornalistiche.
Non rimane che esaminare più da vicino alcuni esempi di
citizen journalism, sia italiani che internazionali.
OhmyNews. La storia di questo sito koreano comincia con
l’oppresione del regime del paese asiatico. Un articolo del
Guardian firmato da Sarah Hartley spiega come diversi
fattori favorirono la nascita e la fortuna di questa realtà. In
primo luogo si parla della grande crescita economica che
attraversò la Corea a partire dal 1961, che venne tradotta in
grandi investimenti a livello di infrastrutture tecniche. Il
paese si fece trovare preparato di fronte all’evoluzione
tecnologica e ora l’accesso a Internet è altamente pervasivo.
Dall’altro lato, il regime ha calcato pesantemente la mano
309 «Molti giornalisti quindi vorrebbero una semplificazione delle norme
sui diritti. Ad esempio che YouTube e Twitter rendessero più semplice la
procedura per la cessione dei diritti alle testate, per esempio barrando una
casella specifica prima di caricare i propri contenuti». Ibidem.
154
contro la libertà di stampa, al punto che ben 49 dei 64
quotidiani che circolavano nel 1961 sono stati chiusi.
Prosegue l’articolo del Guardian: «But while both factors
were important reasons why so many citizens document their
daily experiences, there was another reason why the news
organisation has grown to its current position. One of the big
pieces of magic isn't digital at all, it's a really good
understanding of their audience, that politically active
audience310». Esaminati i fattori che ne hanno favorito
l’affermazione, è il momento di entrare nel merito della
questione. The Knight Community News Network311 ha
pubblicato una bella intervista fatta a Jean K. Min, direttore
delle comunicazioi di OhmyNews International, di cui è il
caso riportare alcuni stralci312.
310 «Ma mentre entrambi i fattori furono importanti ragioni grazie alle
quali così tanto cittadini ora documentano le loro esperienze
quotidianamente, ci fu un’altra ragione che spiega la crescita
dell’organizzazione di notizie. Uno dei punti di forza non è affatto
digitale, bensì si tratta di una capacità di capire il pubblico, in particolar
modo quello attivo politicamente». Hartley S., Korea's OhmyNews: how
oppression inspired citizen journalism in theguardian.com, 19 gennaio
2011 (http://www.theguardian.com/media/pda/2011/jan/19/ohmynews-
korea-citizen-journalism). 311 «The Knight Community News Network is a self-help portal that
guides both ordinary citizens and traditional journalists in launching and
responsibly operating community news and information sites». («The
Knight Community News Network è un portale fai-da-te che guida tanto I
cittadini quanto I giornalisti professionisti a lanciare e gestire
responsabilmente siti di informazione»).
http://www.kcnn.org/about/about_kcnn/ 312 La versione originale, in inglese, è disponibile all’indirizzo
http://www.kcnn.org/principles/ohmynews. (OhmyNews: ‘Every citizen
can be a reporter’).
155
«DOMANDA: Per favore ci dica qualcosa riguardo a
OhmyNews. Come è partito il sito e quali sono i suoi
obiettivi?
RISPOSTA: In qualità di un ex-giornalista di una
piccola rivista liberale chiamata Mahl dal 1988, Oh-
Yeon-ho, il fondatore e amministratore delegato di
OhmyNews, avevo affrontato innumerevoli rifiuti
mentre cercava di accedere a fonti di informazione più
importanti. Le porte erano chiuse e le domande non
trovavano risposta.
In qualità di persona che paga le tasse, si sentì in
diritto di chiedere alle agenzie governative di
garantiere l’accesso alla vasta riserva di informazione
pubblica. Quello fu il momento in cui gli venne l’idea
dell’”ogni cittadino è un reporter”. L’idea rimase con
lui per diversi anni finché non cominciò i suoi studi di
giornalismo alla Regent University negli Stati Uniti.
Durante i suoi studi alla Regent University, uno dei
professori chiese alla classe di preparare un progetto
di un lancio immaginario di un nuovo media. Preparò
un dettagliato progetto di lancio di un media di
informazione online, costruendo il business model
intorno all’idea che “ogni cittadino è un reporter”.
Dopo essere tornato in Corea nel 1997, ha iniziato a
persuadere alcuni investitori a credere nel suo
progetto e alla fine lasciò il suo lavoro presso Mahl.
Con i fondi iniziali raccolti tramite questi investitori e
una somma addizionale proveniente dalle sue stesse
casse, lanciò OhmyNews nel febbraio del 2000. Il
resto è storia di oggi.
156
D: Cosa rende OhmyNews diverso dai media
tradizionali come ad esempio il South China Morning
Post?
R: Nella sua recente biografia pubblicata in Corea, Oh
ha scritto della sua visione originale e del suo “voler
iniziare una tradizione libera da una informazione
elitaria dove le notizie vengano giudicate in base alla
qualità, senza dare importanza se provengono da un
giornale importante, piuttosto che un reporter locale,
da un giornalista professionista o da una casalinga di
quartiere…così ho deciso di fare un tuffo nel mare di
Internet, anche se temevo che fosse differente rispetto
a quello a cui ero abituato”.
Internet consente alle persone di avere una
comunicazione bilaterale e Oh voleva trarre il meglio
da questo nuovo mezzo. […].
“Ogni cittadino può essere un reporter. I giornalisti
non sono delle strane specie esotiche, sono chiunque
cerchi dei nuovi eventi, li scriva e li condivida con gli
altri”.
E data la natura unica dei suoi partecipanti,
“OhmyNews non riguarda principalmente articoli
puramente infomativi. Articoli che includono sia fatti
che opinioni sono accettabili quando sono ben fatti”.
D: OMN è stato definito il primo sito di citizen
journalism. È vero?
R: Non è certo se siamo il più grande sito di citizen
giornalismo ma siamo il primo sito di citizen
journalism che ha scardinato significativamente il
lucchetto dei media tradizionali sull’agenda setting
nazionale. Dal momento che nessun sito di citizen
157
journalism al mondo fa affidamento su storie originali
fornite da oltre 47mila citizen reporter, potremmo
essere il più grando sito di citizen journalism in
termini di partecipanti. […].
[…]
D: Per favore spieghi come funziona il processo
editoriale di OhmyNews. Come fanno i citizen
journalist a pubblicare gli articoli sul sito? La vostra
redazione lavora con i cittadini per quanto concerne la
realizzazione della storia e dopo vengono pagati se
sono accettati?
R: I citizen journalist scrivono una o due storie per
settimana. Dopo che la inviano, possono controllare il
loro stato. Le storie rimangono come articoli “in
sospeso” finché non vengono accettate dai redattori di
OhmyNews. Una volta accettate, i citizen journalist
possono seguire lo stato delle loro parole in tempo
reale, controllando il numero di visitatori per ognuno
delle loro storie, il numero di commenti o i soldi
raccolti nel “vasetto delle mance”.
[…].
D: Quali sono i principi che formano secondo voi la
base del citizen journalism?
R: OhmyNews apprezza le notizie che sono raccolte e
scritte attraverso la prospettiva dei semplici cittadini.
[…].
OhmyNews inoltre incoreggia i nostril citizen
journalist a selezionare storie di cui hanno una buona
conoscenza e nel riportarle con la loro stessa voce. Li
informiamo che non devono necessariamente seguire
la logica e le regole della professione giornalistica
158
anche se possono esseri utili a volte. In breve, gli
diciamo di essere loro stessi.
Infine, OhmyNews ha a cuore l’accuratezza e la
credibilità delle loro storie. Abbiamo dei redattori che
monitorano, controllano e modificano le storie
mandate dai citizen journalist prima che vengano
pubblicato. Questo è il motivo per cui continuamo a
raccomandare loro una “partecipazione responsabile”.
Per concludere, la politica editoriale di Ohmynews è
la perfetta cooperazione e armonia tra il giornalismo
professionistico e i citizen journalist. […].
[…]».
Il modello proposto da OhmyNews è estremamente
interessante, in particolar modo per quanto concerne la forma
di retribuzione tramite la tip-jar. «The site operates a tipping
system where readers can make donations paid via a mobile
phone for articles they value».313 Un sistema bidirezionale
nella sua interezza, anche per quanto concerne la
retribuzione. Una forma di pagamento democratico basato
sulla qualità percepita e l’apprezzamento degli articoli. Non
uno stipendio fisso, ma qualcosa in più della totale remissione
313 «Il sito funziona tramite un sistema di mance dove i
lettori possono fare delle donazioni tramite telefono
cellulare per gli articoli che apprezzano». Hartley S.,
Korea's OhmyNews: how oppression inspired citizen
journalism in theguardian.com, 19 gennaio 2011 (cit.).
159
alla collaborazione a titolo gratuito. Specie nel momento in
cui «the largest tip ever received was worth US$20,000314».
YouReporter. Nel 2006 Angelo Cimarosti, insieme a Luca
Bauccio e Stefano De Nicolo, inizia a pensare ad una
piattaforma che consenta ai cittadini di pubblicare le proprie
testimonianze di fronte a svariati tipi di eventi tramite foto o
video. Tuttavia l’Italia di quegli anni non possedeva ancora
una capillare diffusione della banda larga, così come non
rappresentavano uno strumento alla portata di tutti gli
smartphone. In partenza YouReporter deve accontentarsi di
ricevere testimonianze fotografiche: «when the earthquake in
l’Aquilia hit in 2008, hundreds of photos were uploaded to
the site; had it been just video based, YouReporter would
have never gotten off the ground315». Il successo grazie alle
piccolo cose, spiega Cimarosti in un’intervista telefonica per
10.000 Words: «The success of YouReporter is about the
small things, especially in a country like Italy, made up of
small towns. People already have an outlet for the big news
events — an earthquake, a cruise ship crash, even a big snow
storm. What YouReporter users share and want to know
about are the small things — suspended trash pick-up, the
traffic sign on the corner that needs to be replaced316». Non
314 «La mancia più generosa mai ricevuta è stata pari a 20.000 $». Ibidem. 315 «Quando ci fu il terremoto a L’Aquila nel 2008, centinaia di foto
vennero caricato sul sito; fosse stato semplicemente basato sui video,
YouReporter non avrebbe mai avuto successo». Fratti K., Dispatch From
Italy: Citizen Journalism and YouReporter Making Waves in
mediabistro.com, 3 ottobre 2013
(http://www.mediabistro.com/10000words/youreporter-citizen-
journalism-abroad_b23092). 316 «Il successo di YouReporter riguarda le piccolo cose, specialmente in
un paese come l’Italia, fatto di piccolo città. Le persone hanno già una
160
solamente le notizie di carattere locale, la diffusione della
banda larga e degli smartphone hanno consentito alla creatura
di Cimarosti di crescere esponenzialmente grazie ai video e
di allargare il proprio raggio d’azioni fino a coprire anche
eventi di portata nazionale, come ad esempio l’alluvione che
ha colpito e devastato la regione Sardegna nel novembre del
2013 (figura 24). La crescita del sito, che in presenza di
notizie di rilievo arriva a caricare fino a 1.000 video al giorno,
è passata anche attraverso la creazione di app per Android e
iOS, così come la nascita di YouReporter NEWS:
«YouReporter NEWS è la testata giornalistica
indipendente di YouReporter.it. Un nuovo progetto
che, dopo un periodo di sperimentazione, entra ora nel
vivo.
Una squadra di giornalisti professionisti è pronta a
coprire ogni giorno i principali eventi italiani ed
internazionali. Le breaking news e i fatti in evoluzione
sono seguiti con particolare attenzione, con vere e
proprie dirette testuali non-stop.
Non solo cronaca, però. Il team giornalistico di
YouReporter NEWS mira ad approfondire le notizie
del momento. La redazione lavora instancabilmente
per proporre mappe, documenti grafici,
approfondimenti interattivi. E ci saranno anche molti
copertura per le notizie importanti – un terremoto, un incidente di una
nave da crociera, perfino una grande tormenta di neve. Quello che gli
utenti di YouReporter condividono e di cui vogliono essere informati è
legato alle piccole cose – la sospensione della raccolta di rifiuti, il
semaforo all’angolo che ha bisogno di essere rimpiazzato». Ibidem.
161
video inediti, che non trovate altrove. Alcuni, per la
prima volta in Italia per l’informazione in Hd317».
(figura 24 – la homepage di YouReporter del 21 novembre 2013
alle 18:52)
Il sito viene mandato avanti tramite algoritmi, non
vengono quindi neppure corretti errori di ortografia. «But if
something is ‘fake’ or very wrong, the users and the
algorithms fix it. It’s like any other networked
community318». I cosiddetti media tradazionali non hanno
tardato a riproporre i contenuti pubblicati su YouReporter.
317 http://www.youreporternews.it/il-progetto/ 318 «Se però viene caricato un video falso o palesemente
artefatto gli algoritmi della piattaforma lo eliminano o gli
utenti possono rimuoverlo, come accade con altri tipi di
comunità sul web». Ibidem.
162
Come riporta lo stesso sito di Cimarosti, molte tra i più
importanti organi di informazione del mondo hanno
ritrasmesso i video dei citizen journalist della piattaforma
italiana: dalla BBC alla CNN passando per Reuters e Al-
Jazeera; senza dimenticare tutti i principali telegiornali
italiani. Infine, per quanto concerne la retribuzione degli
utenti del sito, al momento i video vengono caricati senza
alcun ritorno economico. Nell’intervista rilasciata a 10.000
Words, Cimarosti si è detto pronto ad inserire un sistema
revenue sharing, ovvero un tipo di remunerazione condivisa
tra autore ed editore in base ai ricavi ottenuti dai singoli
contenuti.
Realtà come quelle comprese nella categoria del citizen
journalism, o giornalismo partecipativo, fanno riflettere sulla
situazione legislativa italiana in merito alla formazione delle
figure professionali nel campo dell’informazione. «Did you
know that in Italy, to be a practicing journalist, you take
exams and get certified? That’s what my Roman friend, a
senior digital editor at one of the country’s largest publishing
groups told me over lunch this week during my Italian
holiday. It’s like being a lawyer, or an architect319», scrive
nell’incipit dell’articolo Karen Fratti per 10.000 Words.
Prima di voltare pagine e passare alla seconda parte di questa
ricerca, è forse necessario soffermarsi su questi aspetti. Nelle
pagine che seguono verranno dunque analizzate le
componenti legislative del mondo giornalistico, così come le 319 «Lo sapevate che in Italia, per essere un giornalista che esercita la
professione, bisogna sostenere un esame e prendere un attestato? Questo
è quello che il mio amico romano, redattore digitale per una dei più grandi
gruppi editoriali del paese mi ha detto a pranzo questa settimana durante
la mia vacanza italiana. È come essere un avvocato, o un architetto».
Ibidem.
163
figure professionali che gravitano nel mercato del lavoro,
alcune figlie della rivoluzione digitale.
165
3 Il giornalismo in Italia: la legge e il
mondo del lavoro
3.1 Essere giornalisti in Italia
Nelle pagine che hanno preceduto questa parte della tesi si
sono analizzati gli innumerevoli stravolgimenti che ha dovuto
affrontare la professione giornalistica. Internet, il Web 2.0, la
blogosfera, i social network, il citizen journalism, per citarne
alcuni. L’Italia di fronte al susseguirsi delle spinte
rivoluzionarie risponde con la prontezza tipica delle forze
conservatrci, lasciando che sia una legge del febbraio del
1963 a regolare la formazione dei professionisti. La legge n.
69/1963 sancisce la creazione dell’Ordine dei Giornalisti,
l’organo che gestisce l’iscrizione all’albo professionale. «È
istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i
giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi
elenchi dell'albo. Sono professionisti coloro che esercitano in
modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica
non occasionale e retribuita anche se esercitano altre
professioni o impieghi320».
Organizzazione dell’Ordine. L’Ordine dei Giornalisti è
organizzato territorialmente su base regionale o
interregionale, con ogni Consiglio che detiene il proprio albo
professionale. I consigli sono formati da 6 professionisti e 3
320 Art. 1, Ordinamento della professione di giornalista – Legge 3
febbraio 1963, n. 69. (http://www.odg.it/content/legge-n-691963)
166
pubblicisti con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. I
membri vengono eletti dagli appartenenti all’albo con
scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti. Le cariche
hanno durata di 3 anni con possibilità di rielezione, come
sottolinea l’art. 9 della 69/1963 «ciascun Consiglio elegge nel
proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario
ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei
professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i
pubblicisti, e reciprocamente321». Per quanto concerne invece
il Consiglio nazionale, questo ha sede presso il Ministero
della giustizia ed è composto da due professionisti e un
pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale. Anche
qui le cariche sono triennali e consentono la rielezione, ma
non è possibile far parte contemporaneamente di un Consiglio
regionale o interregionale e del Consiglio nazionale. Oltre a
un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un
tesoriere, il Consiglio nazionale elegge un Comitato
esecutivo composto da sei professionisti e tre pubblicisti (tra
gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il
segretario e il tesoriere).
Funzioni dell’Ordine. Per quanto concerne i Consigli
regionali e interregionali, diverse sono le attribuzioni
esercitate:
«a) cura l'osservanza della legge professionale e di
tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in
qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni
321 Art. 9, Ibidem.
167
attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo
della professione;
c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e
cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede alla amministrazione dei beni di
pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il
bilancio preventivo e il conto consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto
dall'art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli
iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione
nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di
certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla
legge322».
Il Consiglio nazionale invece:
«a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro
della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento
che riguardano la professione di giornalista;
322 Art. 11, ibidem.
168
b) coordina e promuove le attività culturali dei
Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese
al miglioramento ed al perfezionamento
professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali
o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le
deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di
iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e
dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su
quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e
dei Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e
degli affari di sua competenza, da approvarsi dal
Ministro della giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal
Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali
dovute dagli iscritti per le spese del suo
funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da
approvarsi dal Ministro della grazia e giustizia, il
limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli
regionali o interregionali dai rispettivi iscritti323».
L’albo professionale. Ogni Consiglio regionale o
interregionale ha il proprio albo, dove sono iscritti i
giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio
professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del
323 Art. 20, ibidem.
169
Consiglio. Come riporta l’art. 27, ad ogni iscritto viene
rilasciata una tessera. L’albo è ripartito in due elenchi: uno
dei professionisti l'altro dei pubblicisti. Per entrare a far parte
dell’albo dei professionisti ci sono innanzitutto dei requisiti
da soddisfare, in primo luogo l'età, che non deve essere
inferiore ai 21 anni. In secundis l'iscrizione nel registro dei
praticanti, dove a loro volta possono essere iscritti tutti coloro
che intendano avviarsi alla carriera giornalistica e che
abbiano compiuto almeno 18 anni. Per inoltrare la domanda
d’iscrizione al registro dei praticanti bisogna, oltre a fornire
il certificato di nascita e di residenza, presentare attestazione
di versamento della tassa di concessione governativa, nella
misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni
negli albi professionali (requisiti necessari anche per
l’iscrizione all’albo dei professionisti). Bisogna inoltre
presentare una dichiarazione del direttore presso cui viene
svolta la pratica che dia prova dell’effettivo inizio della
pratica stessa324. Il praticantato, secondo l’art. 34, deve essere
svolto «presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico
della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana
di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti
professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a
diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti
redattori ordinari». Al termine di 18 mesi di pratica il
direttore responsabile della pubblicazione può rilasciare la
dichiarazione che descrive e attesta l’attività svolta dal
praticante, necessaria per l’iscrizione all’albo325. Infine è
324 Coloro non in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza
di scuola media superiore devono inoltre sostenere un esame di cultura
generale. Art. 33, ibidem. 325 L’alternativa ai 18 mesi di praticantato è rappresentato dalle scuole di
giornalismo riconosciute dall’Ordine.
170
necessario, come descrive l’art. 32, superare un esame
composto da una parte orale ed una scritta di tecnica e pratica
del giornalismo. «L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi
ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque
dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine
fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni.
Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della
Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di
tribunale e l'altro tra i magistrati di appello326 […]». Per
quanto concerne invece l’iscrizione all’albo dei pubblicisti,
oltre a dover soddisfare i requisiti quali la presentazione dei
certificati di nascita e di residenza e l’attestazione di
versamento della tassa di concessione governativa, bisogna
«presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in
giornali e periodici e i certificati dei direttori delle
pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica
regolarmente retribuita da almeno due anni327». Se per potersi
iscrivere all’albo dei giornalisti professionisti bisogna
svolgere un praticantato di almeno 18 mesi, per entrare a far
parte di quello dei pubblicisti è invece necessario svolgere
attività giornalistica regolarmente retribuita per almeno due
anni. Solamente una volta iscritti all’albo si è giornalisti ed è
possibile esercitare la professione, come spiega l’art. 45 della
legge 69/1963: «Nessuno può assumere il titolo né esercitare
la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo
professionale328».
326 Art. 32, ibidem. 327 http://www.odg.it/content/albo. 328 Art. 45 Ordinamento della professione di giornalista – Legge 3
febbraio 1963, n. 69. (http://www.odg.it/content/legge-n-691963)
171
Sull’esistenza e la legittimità dell’Ordine in Italia. Perché
esiste l’Ordine dei Giornalisti? Come si legge sul sito
dell’Ordine: «l'attività giornalistica è un'attività intellettuale
a carattere professionale, caratterizzata quindi da
quell'elemento di "creatività" che fa del giornalista non un
impiegato o un operatore esecutivo, ma, appunto, un
professionista329». Viene poi sottolineata la rilevanza sociale
dell’attività: «La legge riconosce poi la rilevanza sociale del
giornalismo e impone, a chi lo eserciti in forma professionale,
di iscriversi obbligatoriamente in un Albo dettandone
condizioni e modalità; tutto ciò, soprattutto a garanzia della
pubblica opinione e del lettore che è il destinatario
dell'informazione. La legge, inoltre, prevede l'autogoverno
della categoria […]330». La conditio sine qua non è
rappresentata dalla sentenza n. 11/1968 con cui la Corte
stabilisce che quella dei giornalisti è una professione e non un
mestiere331. Questa posizione trova però una larga schiera di
329 http://www.odg.it/content/la-storia 330 Ibidem. 331 Occhetta F., L’Ordine Nazionale dei Giornalisti in laciviltacattolica.it,
19 settembre 2013
(http://www.laciviltacattolica.it/articoli_download/3216.pdf). Dice la
sentenza n. 11/1968 della Corte Costituzionale: «I giornalisti vengano
associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere
economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto
della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che
supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti di categoria e che perciò
può essere assunto solo da un Ordine a struttura democratica, che, con i
suoi poteri di ente pubblico, vigili, nei confronti di tutti e nell’interesse
della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale
che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di
informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano
comprometterla». Carta di Firenze: approvata a larghissima
maggioranza Fondamentale il ruolo delle rappresentanze sindacali in
172
oppositori. Ad esempio il costituzionalista Paolo Barile
sostiene che «la professione non si presenta come “sapere
specifico” ma come l’esercizio continuativo, esclusivo e
retribuito, della libertà di pensiero a favore di un’impresa
editoriale332». Invece «gli altri Ordini hanno diritto di esistere
in quanto sono ancorati a conoscenze tecniche
imprescindibili e a saperi specifici che vengono accertati
attraverso un titolo universitario e un esame di Stato333». E’
innegabile che il giornalista «vive da sempre di occupazione
subordinata […], non ha rapporti economici diretti con il
cittadino come i medici e gli avvocati obbligati a dare
garanzie […]334». Condivide questo punto Francesco
Occhetta: «I giornalisti stessi dipendono da aziende editoriali
in cui esiste un potere gerarchico che vincola l’attività del
dipendente335». Non è di questo avviso il presidente onorario
dell’Ordine dei Giornalisti, Lorenzo del Boca, intervistato da
i-Italy: «Ci sono delle attività professionali che, avendo un
riverbero sociale molto accentuato, hanno necessità di
garantirsi presso il loro pubblico. Un medico o un avvocato
non possono esercitare le loro professioni senza fornire
fnsi.it, 22 novembre 2011,
(http://www.fnsi.it/esterne/Fvedinews.asp?AKey=13986). 332 Occhetta F., L’Ordine Nazionale dei Giornalisti in laciviltacattolica.it,
19 settembre 2013 (cit). 333 Abruzzo F., La riforma della professione giornalistica in
Impresa&Stato n.46 (http://impresa-
stato.mi.camcom.it/im_46/abruzzo.htm). 334 Bartolini R., Ordine dei giornalisti, un peso morto da pensionare in
europaquotidiano.it, 2 marzo 2012
(http://www.europaquotidiano.it/2012/03/02/ordine-dei-giornalisti-un-
peso-morto-da-pensionare/). 335 Occhetta F., L’Ordine Nazionale dei Giornalisti in civiltacattolica.it,
19 settembre 2013 (cit).
173
garanzie ai propri clienti. Allo stesso modo un giornalista
deve poter dare alla persona alla quale si rivolge […] la
garanzia che quello che gli comunica è la verità […]336».
Appare poco chiaro come il possesso di una tessera possa
tradursi in garanzia di verità, che dovrebbe essere piuttosto
figlia della professionilità del singolo, più che frutto
dell’appartenenza ad un gruppo. Secondo del Boca tuttavia
«occorre un’istituzione che sia in grado di costruire una
deontologia e assicurarsi che venga rispettata337». Prosegue
Del Boca: «L’Ordine non impone niente, stabilisce solamente
quali sono i limiti che il giornalista deve darsi per la propria
professionalità. Questi limiti non sempre vengono rispettati,
però che vengano stabiliti all’interno della stessa categoria è
un elemento di ulteriore miglioramento della libertà del
giornalismo338». Rimanendo nella sfera etica, non si riesce a
capire per quale motivo – come sostiene Occhetta – la
deontologia del giornalista non possa venir giudicata e
regolata dal lettore prima (esprimendo dissenso, cambiando
testata), dal direttore poi (sanzionando o sollevando
dall’incarico) e debba essere sottoposta ad un organo come
l’Ordine. La domanda è stata posta da i-Italy a Marica
Spalletta, docente di Cultura, etica e deontologia della
comunicazione presso l’Università LUISS Guido Carli di
Roma. La posizione della docente si pone al di fuori della
diatriba legata alla legittimità dell’Ordine collocandosi
piuttosto all’interno della necessità di un cambiamento di
mentalità: «Finché l’etica del giornalista non troverà un punto
336 Giuliani F. A cosa serve l'Ordine dei Giornalisti? Professione e
accademia a confronto in i-taly.org (http://www.i-italy.org/18705/cosa-
serve-lordine-dei-giornalisti-professione-e-accademia-confronto). 337 Ibidem. 338 Ibidem.
174
d’incontro e di dialogo con l’etica dell’editore il sistema non
troverà mai il proprio equilibrio […]. Perché le regole siano
applicate non è sufficiente che esse siano fissate in un codice:
occorre che esse siano condivise. Scrivere delle regole è
infatti per molti versi assai semplice, applicarle lo è molto di
meno […]339». C’è chi invece vede nell’abolizione
dell’Ordine un primo passo imprescindibile per risolvere
alcune delle problematiche dell’universo giornalistico
italiano. Infatti, il dibattito tanto sulla necessità quanto sulla
legittimità dell’esistenza di un Ordine dei Giornalisti è
vivace, ma ancorato al piano dialettico, incapace di portare
all’attenzione della politica e dell’opinione pubblica il
bisogno di cambiamento che il tempo impone. Tuttavia, il
processo di liberalizzazione delle professioni
regolamentate340, tra le quali rientra il giornalismo, ha
riacceso l’attualità della questione poiché ha costretto anche
l’Ordine stesso a riformarsi, seppur in minima parte. Il
processo deciso dall’allora Ministro dell’Economia Giulio
Tremonti aveva come «criteri ispirativi […] la formazione
continua, la divisione tra deontologia e attività
amministrativa degli enti, l’assicurazione obbligatoria, le
regole di accesso, la libertà di pubblicità informativa341». Le
ripercussioni per quanto concerne l’Ordine dei Giornalisti
339 Giuliani F. A cosa serve l'Ordine dei Giornalisti? Professione e
accademia a confronto in i-taly.org, (cit.). 340 Confluito nel regolamento delegato emanato con D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137. Grisolia M., Libertà di informazione e ordine dei giornalisti alla
luce della riforma degli ordinamenti professionali in AIC (Associazione
Italiana Costituzionalisti) rivista n. 4/2012, 12 dicembre 2012
(http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Grisoli
a.pdf) 341 Occhetta F., L’Ordine Nazionale dei Giornalisti in civiltacattolica.it,
19 settembre 2013 (cit).
175
furono principalmente due: in primo luogo, «la gestione della
giustizia deontologica non verrà più esercitata dai Consigli
regionali e nazionale, ma da un Collegio territoriale di
disciplina, la cui nomina è definita dal Presidente del
tribunale sulla base di una rosa fornita dal Consiglio regionale
[…]. Finora, invece, il Consiglio giudicante era composto
dall’intero Consiglio nazionale342». Il secondo cambiamento
concerne invece la formazione permanente: «tutti gli iscritti
all’albo, a partire dal 2014, avranno l’obbligo di acquisire in
un triennio 60 crediti […] attraverso attività riconosciute
come aggiornamento dall’Ordine […]. Ci sarà la possibilità
di conoscere nuove modalità lavorative, materia
deontologica, aspetti fiscali, di economia, ma anche aspetti
culturali e tecnologici (nuovi media, internet…) che
richiedono un continuo aggiornamento343». Nonostante
queste modifiche, come sottolinea l’AIC rimane però
«l’irrisolta questione della stessa esistenza dell’ordine e della
sua compatibilità con i principi costituzionali344». Del resto, i
tentativi di abolire l’Ordine dei Giornalisti sono stati diversi.
Come riporta Linkiesta, i primi a battersi contro il sistema
corporativo rappresentato dall’Ordine furono nel 1972 «tre
deputati del Partito repubblicano italiano, Francesco
Compagna, Pasquale Bandiera e Adolfo Battaglia che
presentarono una proposta in sette articoli per chiedere la
soppressione della legge approvata dalle Camere appena
342 Ibidem. 343 Ibidem. 344 Grisolia M., Libertà di informazione e ordine dei giornalisti alla luce
della riforma degli ordinamenti professionali in AIC (Associazione
Italiana Costituzionalisti) rivista n. 4/2012, 12 dicembre 2012 (cit.).
176
nove anni prima345». Negli anni successivi furono diverse
realtà politiche (dal Partito radicale al Movimento sociale
italiano passando per il Partito liberale e l’Ulivo) a tentare,
senza successo, di abolire l’obbligatorietà dell’iscrizione
all’albo, quantomeno sostituendola – un’idea di un gruppo di
deputati del Partito radicale tra cui Marco Pannella e
Francesco Rutelli – con una “carta d’identità professionale”
sul modello francese. Tutte le proposte non riuscirono, per un
motivo o per un altro, a diventare legge. Nel 1997 l’Ordine
dei Gironalisti scongiurò l’attacco più pericoloso, inferto dai
radicali. Il partito di Pannella avanzò la proposta di abolizione
dell’Ordine tramite un referendum il cui quesito era il
seguente: «I sottoscritti cittadini italiani richiedono
referendum popolare abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della
Costituzione della Repubblica e in applicazione della legge
25 maggio 1970 n. 352, sul seguente quesito: “Volete voi che
sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante
‘Ordinamento della professione di giornalista’?”346». I
votanti si espressero favorevolmente all’abolizione con una
percentuale pari al 65,5%347, ma non venne raggiunto il
quorum e di conseguenza la posizione dei cittadini non potè
tramutarsi in azione legislativa. Come sottolinea l’AIC, le
posizioni che si mantengono contrarie all’Ordine basano la
propria tesi sul conflitto tra l’Ordine stesso e l’art. 21 della
Costituzione Italiana (in particolar modo sulla parte che dice
345 De Martino G., Giornalisti, l’ordine che nessuno riesce a cancellare
in linkiesta.it, 15 aprile 2013, (http://www.linkiesta.it/abolizione-odg). 346 Lettera aperta del presidente dell'Ordine dei giornalisti della
Lombardia in radioradicale.it, 6 gennaio 1997
(http://www.radioradicale.it/exagora/lettera-aperta-del-presidente-
dellordine-dei-giornalisti-della-lombardia) 347 http://www.radicali.it/obiettivi/referendum-radicali
177
che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure348»). Recentemente è stato il
Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo a proporre un disegno di
legge per l’abolizione dell’Ordine dei Giornalisti, firmato da
53 senatori. Sono molteplici le ragioni che hanno mosso
all’azione il M5S; si legge: «le criticità relative al sistema di
accesso alla professione, la situazione complessa di quanti
pur non essendo giornalisti professionisti svolgono attività
giornalistica non occasionale e retribuita, la insostenibile
situazione di precariato con cui molte migliaia di giornalisti
sono costretti a convivere ogni giorno, costituiscono nodi
imprescindibili349». Del resto, sostiene il disegno di legge dei
grillini, la Corte costituzionale ha già riconosciuto la
legittimità dell’abolizione dell’Ordine nel momento in cui
definì come ammissibile la richiesta di refrendum del Partito
radicale nel 1997350.
L’Ordine e la Rete. La nascita e l’evoluzione di Internet,
culminata con l’avvento del Web 2.0, hanno rivoluzionato il
mondo giornalistico. In questo contesto è d’interesse
analizzare come la capacità della Rete di fornire sia la
possibilità agli utenti di produrre e pubblicare dei contenuti
con grande facilità, sia l’opportunità alla piccola
imprenditoria di aprire siti web e portali attraverso sforzi
economici accessibili, vadano ad entrare nell’orbita della
348 La Costituzione in senato.it
(http://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=21)
. 349 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703074.pdf 350 Ibidem.
178
legge italiana e dell’Ordine. In primo luogo è necessario
ricordare che in Italia non esiste una definizione legale di
giornalista, ma alcune sentenze della Corte di Cassazione
possono colmare questo vuoto giuridico definendo l’attività
giornalistica come «l'attività, contraddistinta dall'elemento
della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se
non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta,
elaborazione o commento delle notizie destinate a formare
oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi
d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la
conoscenza e la diffusione di esso attraverso un
messaggio351». Dal punto di vista legale esiste invece la
351 Alcune sentenze della Cassazione: A) «La nozione dell'attività
giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge
professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può
che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge
quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività
giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della
creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non
esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o
commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione
interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto
di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un
messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato
dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e
ideologica» (Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007; Riviste: Mass. 1983).
B) «E' di natura giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta
alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare
oggetto di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente
avvenire mediante l'apporto di espressioni letterali, o con l'esplicazione di
espressioni grafiche, o ancora mediante la collocazione del messaggio)
attraverso gli organi di informazione» (Cass. 1/2/96 n. 889, pres. Mollica,
est. De Rosa, in D&L 1996, 687, nota Chiusolo, Il giornalista grafico e
l'iscrizione all'Albo dei giornalisti). C) «Per attività giornalistica deve
intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al
179
distinzione tra giornalista professionista e pubblicista, sancite
nell’articolo 1 della legge 69/1963, che definisce il primo
come colui che esercita la professione in modo esclusivo e
continuativo, il secondo come colui invece che esercita la
professione in modo non occasionale e retribuito, ma
nell’esercizio anche di altre professioni o impieghi. Come è
stato visto in precedenza, l’Ordine riconosce come giornalisti
solamente coloro iscritti all’Albo e in possesso della tessera
professionale. Questo sistema di riconoscimento
condizionato può difficilmente convivere con la realtà della
Rete in cui ogni utente ha la possibilità di pubblicare i propri
contenuti. Internet ha reso i confini della professione più
vaghi: tutti possono produrre informazione giornalistica al di
là della presenza di un titolo di cui fregiarsi o di un tesserino.
Sono addirittura le testate stesse – come è stato visto nei
paragrafi dedicati alla blogosfera, a Twitter e al citizen
journalism – a cercare e riproporre il materiale fornito dai
semplici cittadini. In un contesto come quello appena
descritto ha ancora senso la separazione tra i professionisti e
gli amatori? Chi produce e diffonde informazione può essere
un ottimo o un pessimo giornalista independentemente dal
possesso di una tessera professionale, che dovrebbe però
rendere più pressante il rispetto dei codici deontologici. Quel
commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di
comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il
giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la
diffusione della conoscenza di esso...... differenziandosi la professione
giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una
tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere
conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della
dovuta attenzione e considerazione» (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio
1995, n. 1827). Abruzzo F., I giornalismi in francoabruzzo.it
(http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=99).
180
che appare evidente è la necessità, alla luce dell’accesso
semplificato agli strumenti di diffusione giornalistica, reso
possibile da Internet, di snellire il processo di
professionalizzazione, ad esempio valorizzando il sistema
universitario o conferendo valore e prestigio all’attività
online portata avanti secondo le regole della professione.
L’altro aspetto da analizzare nei rapporti tra l’Ordine e la Rete
è legato all’accessibilità di intraprendere un’avventura
editoriale, sia tramite una testata registrata, sia tramite un
semplice blog. Innanzitutto è necessario chiarire cosa
comporta la registrazione di una testata, in quali circostanze
si è tenuti a farlo e come. Il testo di riferimento è redatto da
Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, il quale dà una lettura della legge 62/2001 alla
luce della delibera n. 236/2001 dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, che sancisce, nell’articolo 1,
l’istituzione del registro degli operatori di comunicazione. In
quest’ultimo sono tenuti a registrarsi «solo gli editori, che
prevedono di conseguire ricavi dalla loro attività e che,
comunque, puntano a ottenere dallo Stato “benefici,
agevolazioni e provvidenze”352». Invece, «le testate
giornalistiche on-line - in quanto "prodotto editoriale" -
devono obbligatoriamente essere registrate nei tribunali e
avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore,
ma solo quando hanno una regolare periodicità (quotidiana,
settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile,
bimestrale, etc)353». Il punto di partenza è l’articolo 1 della
legge 62/2001 che chiarisce come «per “prodotto editoriale”,
ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su
352 Abruzzo F., Registrazione delle testate on-line e R.O.C. in altalex.com,
16 luglio 2001, (http://www.altalex.com/index.php?idnot=3182). 353 Ibidem.
181
supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo,
anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici354». Inoltre, bisogna ricordare come il
comma 3 dell’articolo 1 della 62/2001355 rimandi agli articoli
2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)356 e 5
(Registrazione)357 della legge 47/1948. L’articolo 16 della
354 Legge 7 marzo 2001, n.62, Nuove norme sull’editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001 in camera.it
(http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm). 355 «Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo
2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al
pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli
obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948».
Ibidem. 356 «Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione,
nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I
giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di
qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data
della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome
del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità
delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli
stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari».
Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa, diffamazione,
reati attinenti alla professione e processo penale in odg.it
(http://www.odg.it/content/legge-n-471948). 357 «Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano
depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate
del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale
risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita
182
stessa legge 62/2001 invece sottolinea come «i soggetti tenuti
all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249358, sono esentati dall’osservanza
degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle
l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo
e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso
dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti
l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o
dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del
tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei
documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il
registro è pubblico». Ibidem. 358 «Cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale
si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da
parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese
concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici
o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese
di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le
agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria
elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di
diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione
diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge». Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo in agcom.it,
(http://www2.agcom.it/L_naz/L_249.htm#01-c6).
183
pubblicazioni359». E’ l’articolo 1, comma 2, della delibera
dell’Agicom che spiega come i soggetti obbligati
all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione
siano: i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; le
imprese concessionarie di pubblicità; le imprese di
produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi; le
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste; le
imprese che editano agenzie di stampa di carattere nazionale;
i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale; le imprese
fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici360. Si
può dedurre, come sottolinea Abruzzo, che «le finalità delle
due registrazioni sono divergenti: quella presso i tribunali
serve a individuare le responsabilità (civili, penali,
amministrative) collegate alle pubblicazioni anche
telematiche; quella presso l’Agcom tutela la trasparenza del
settore editoriale tradizionale e digitale361». Tanto la legge
62/2001, quanto la delibera 236/2001, si impegnano a
delineare quindi due tipi di prodotti editoriali. Il primo, senza
periodicità, non è tenuto a rispettare l’articolo 5 della legge
47/1948 inerente alla registrazione in tribunale, ma deve
invece mantenersi fedele all’articolo 2 della stessa legge. Le
testate, comprese quelle online, caratterizzate invece dalla
periodicità della pubblicazione362 devono attenersi sia
359 Legge 7 marzo 2001, n.62, Nuove norme sull’editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001 in camera.it (cit.). 360 Delibera n. 236/01/CONS, Regolamento per l’organizzazione e la
tenuta del registro degli operatori di comunicazione in agcom.it,
(http://www2.agcom.it/provv/d_236_01_cons.htm). 361 Abruzzo F., Registrazione delle testate on-line e R.O.C. in altalex.com,
16 luglio 2001, (cit.). 362 «Le testate (da registrare secondo lo schema della legge 47/1948) sono,
come già sottolineato, quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali,
184
all’articolo 2, sia all’artcolo 5 della legge 47/1948. In merito
all’articolo 2, i giornali online devono mostrare alcuni
elementi identificativi quali il luogo e la data della
pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore; il
nome del proprietario e del direttore o vice direttore
responsabile363. Delineato il quadro di riferimento, è ora
possibile analizzare i rapporti tra le leggi, l’Ordine dei
Giornalisti e la Rete. In tal senso un esempio può essere
chiarificatore. Il protagonista di questa vicenda è Francesco
Vanin, amministratore delegato di una società – Pn Box – che
gestisce una piattaforma, una web tv omonima, che consente
agli utenti di pubblicare video da essi girati in autonomia o
con il supporto di una telecamera messa loro a disposizione
dalla stessa società. Nel 2012 Vanin è stato accusato dal
Tribunale di Pordenone, a seguito di un esposto dell’Ordine
dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, di “esercizio
abusivo della professione”, articolo 348 del codice penale,
punibile con sei mesi di galera. L’Assostampa FVG,
quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate (secondo
l’insegnamento costante della Cassazione): a) dalla raccolta, dal
commento e dall'elaborazione critica di notizie (attuali) destinate a
formare oggetto di comunicazione interpersonale; b) dalla tempestività di
informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e
coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta
attenzione e considerazione». Ibidem. 363 «Il direttore responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell’Albo
tenuto dai Consigli dell’Ordine (norma legittima secondo la sentenza n.
98/1968 della Corte costituzionale). Il tribunale è quello nella cui
circoscrizione la testata on-line ha la redazione. Lo stampatore è il
provider, che "concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio
server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore
di informazioni" (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997)». Ibidem.
185
schieratasi a fianco dell’Ordine, ha rilasciato un comunicato
che chiarisce le motivazioni dell’azione legale:
«L’Assostampa Fvg è al fianco dell’Ordine regionale
dei giornalisti, nella vicenda che riguarda la web tv
pordenonese PnBox, che svolge attività giornalistica
senza aver mai depositato in tribunale una propria
testata, dunque in maniera di fatto illegale. La vicenda
è approdata nelle aule di giustizia dopo un esposto
dell’Ordine dei giornalisti del Fvg.
In ballo non c’è la libertà di informazione, garantita
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. C’è
piuttosto il rispetto della legge sulla stampa, che
prevede l’obbligo di aprire e depositare una propria
testata per chiunque svolga un’attività giornalistica, e
ciò proprio a tutela dell’utenza. Se una piattaforma
web trasmette notizie di politica e attualità con
regolarità, allora si configura come canale
informativo, come conferma il presidente nazionale
dell’Ordine, Enzo Jacopino.
Posizione rafforzata dal commento di Piero Villotta,
presidente regionale dell’Ordine, che ha segnalato il
caso: “Esiste una zona grigia tra l’articolo 21 della
Costituzione e la legge sulla stampa, dentro la quale
rientrano blog e piattaforme online. Anche chi
pubblica i video su YouTube fa divulgazione. Tutto
dipende dalla periodicità. Il nostro esposto è a tutela
dell’utenza, oltre che della categoria. Se viene meno
la garanzia della legge sulla stampa siamo nella
giungla”.
La questione è dunque aperta, in attesa di un
intervento del legislatore, oggi più che mai necessario.
186
Le leggi si possono cambiare, ma fino a che sono in
vigore vanno rispettate. E secondo noi lo deve fare
anche la web tv di Pordenone, attiva da tempo con
attività a tutti gli effetti giornalistica, con servizi di
politica, cronaca, sport e spettacolo. Senza avere una
propria testata giornalistica364».
L’accusa lanciata verso Vanin e la sua web tv è stata
quindi quella di aver svolto attività giornalistica non
occasionale pur non essendo un professionista iscritto
all’Albo dell’Ordine e senza registrare la testata presso il
Tribunale. Ma la replica dell’amministratore delegato di Pn
Box è chiara: «Non vogliamo fare i giornalisti perché non
siamo giornalisti. Io sono un imprenditore, non mi sono mai
definito giornalista. Siamo solo un mezzo per far dire
qualcosa. Il giornalista invece prende un’informazione, la
elabora e media tra fonte e lettore. Noi non diamo una nostra
visione della realtà. Solo chi vede i filmati che postiamo dà
una visione alla realtà365». La questione messa in risalto dalla
disputa tra l’Ordine dei Giornalisti e la web tv friulano che
trascende il caso in sé e va ad abbracciare la modernità della
legislazione italiana rispetto all’editoria digitale. Quanto
imputato a Pn Box «è, esattamente, quanto accade ogni
giorno sulle centinaia di migliaia di blog che popolano – per
fortuna – la blogosfera italiana e sugli oltre 20 milioni di
364
https://www.facebook.com/giornalistifreelancefvg/posts/3
59339054109485 365 Baratta L., Canetta T., L’Ordine dei Giornalisti porta le
web tv in tribunale in linkiesta.it, 4 aprile 2012,
(http://www.linkiesta.it/webtv-ordine-giornalisti).
187
profili facebook. Senza parlare dei tanti italiani che, ormai
[…] nell’era degli smartphone e delle webcam, pubblicano
centinaia di migliaia di contenuti audiovisivi sui canali di
YouTube. Stiamo tutti esercitando abusivamente l’attività di
giornalisti?366». Cosa si cela dietro l’azione legale
dell’Ordine? Tutto questo significa forse che se il sottoscritto,
tramite la propria pagina Facebook, si ritrovasse ogni lunedì
mattina a riportare i risultati del weekend calcistico della
Serie A italiana sarebbe imputabile di “esercizio abusivo
della professione” e rischierebbe fino a 6 mesi di reclusione?
Il fulcro della questione non è la legittimità dell’azione
dell’Ordine dal punto di vista legale, tanto più che Vanin è
stato assolto dal giudice del tribunale di Pordenone, Eugenio
Pergola, dall'accusa di esercizio abusivo della professione
giornalistica367. Quello su cui bisognerebbe soffermarsi è il
rapporto tra la situazione legislativa italiana e la libertà
dell’informazione online. Il citizen journalism, la blogosfera
e i social network sono realtà che, come mostrato in altre
sezioni di questa tesi, non possono più essere ignorate e la cui
portata informativa rappresenta una preziosa risorsa di
integrazione e supporto per i canali tradizionali. In questo
senso, se come sembra, esistono delle zone d’ombra nella
legislazione italiana in rispetto alle novità nel campo
giornalistico legate all’evoluzione tecnologica, piuttosto che
366 Scorza G., Allarme informazione online in ilfattoquotidiano.it, 29
marzo 2012, (http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/29/allarme-
informazione-online/200904/). 367 «Il Pm, Del Tedesco, ha chiesto l'assoluzione ritenendo che l'attività di
Vanin non sia assimilabile al lavoro giornalistico perché non prevede
lavoro intellettuale e mediazione dei contenuti». Assolto Vanin, Pnbox
non è una testata giornalistica in pordenoneoggi.it, 11 luglio 2012,
(http://www.pordenoneoggi.it/notizie/assolto-vanin-pnbox-non-
%C3%A8-una-testata-giornalistica-005799).
188
intestardirsi in un cieco appello alle norme368 - dietro cui forse
si nasconde altro, come la chiusura reazionaria di una casta
rispetto ai cambiamenti -, bisognerebbe impegnarsi affinché
le leggi fossero al passo con i tempi, capaci di rappresentare
lo stato delle cose per come è, non per come fu.
Accedere all’Albo. Come visto in precedenza, l’Albo è
ripartito in due elenchi, quello dei professionisti e quello dei
pubblicisti. Per accedere al primo è condizione
imprescindibile il praticantato di 18 mesi o la frequenza delle
scuole di formazione riconosciute dall’Ordine; mentre per il
secondo è necessario dimostrare l’avvenuta attività
giornalistica continuativa per un minimo di due anni e
regolarmente retribuita. Entrambe le categorie pongono
inoltre come conditio sine qua non il superamento dell’esame
di Stato. Per quanto concerne il praticantato, l’analisi di
Francesco Occhetta sottolinea come «oltre il 70% dei
neogiornalisti professionisti arriva da un praticantato
d’ufficio; il praticantato tradizionale giunge al suo
capolinea369». Questo perché le aziende editoriali hanno tutti
gli interessi a favorire la precarizzazione: basti pensare che
come riporta Occhetta solamente il 10% dei mille giovani che
ogni anno tentano di superare l’esame di Stato proviene da un
contratto di praticantato370. Quello che emerge è un tentativo
di incanalare l’aspirante giornalista verso le scuole
368 «Le leggi si possono cambiare, ma fino a che sono in vigore vanno
rispettate».
https://www.facebook.com/giornalistifreelancefvg/posts/359339054109
485 369 Occhetta F., L’Ordine Nazionale dei Giornalisti in civiltacattolica.it,
19 settembre 2013 (cit). 370 Ibidem..
189
riconosciute dall’Ordine, che hanno però costi esorbitanti371
e sono anch’esse in crisi372. Nascono di conseguenza due
considerazioni. In primo luogo, nel momento in cui le scuole
di formazione richiedono uno sforzo monetario così
importante, si viene a creare una prima selezione tra i giovani
dettata dalle possibilità economiche delle famiglie. Come
dire: chi può investire 7.000 € per iscriversi ad una scuola
riconosciuta dall’Ordine avrà certamente più possibilità di
farsi strada rispetto a chi non dispone di una simile somma di
denaro. Lapalissiano, ma importante da sottolineare perché
strettamente connesso a questo tassello è il ruolo
dell’università pubblica. Al di là della qualità dei singoli corsi
di laurea, quello che emerge è la subalternità degli studi
universitari rispetto alle scuole di giornalismo, la cui
esistenza, potrebbero sostenere i più maligni, sembra legata
principalmente ai guadagni in grado di generare e alle
cattedre che vengono così occupate. Per quanto concerne
l’elenco dei pubblicisti, la situazione è differente. Questi
ultimi non devono infatti affrontare né il praticantato né le
scuole riconosciute dall’Ordine, bensì svolgere un’attività
giornalistica continuativa, documentabile e retribuita per
almeno due anni presso una testata regolarmente registrata e
il cui direttore sia iscritto all’Albo dei giornalisti. In questo
senso il desiderio del giovane aspirante che si trova a cercare
una collaborazione in grado di garantire l’accesso all’esame
371 Da 5.000 a 9.000 €, ibidem. 372 «Quella più gloriosa e antica, l’Ifg di Milano (Carlo de Martino), è
stata incorporata nell’università statale perché non c’erano i soldi per
mantenerla così com’era». Armano A., Un italiano su 550 è giornalista.
Riformiamo l’Ordine? in ilfattoquotidiano.it
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/30/un-italiano-su-550-e-
giornalista-iscritto-allordine-lo-riformiamo/579213/).
190
di Stato può diventare una pericolosa arma a doppio taglio.
L’editore di turno può infatti approfittare della debolezza
contrattuale della controparte sia offrendo retribuzioni non in
linea con il lavoro svolto sia – un’ipotesi ancora peggiore –
proponendo l’emissione di fatture false (che consentirebbero
poi l’accesso all’esame di Stato) in cambio di lavoro gratuito.
A tal proposito sarà sufficiente ricordare l’inchiesta della
Procura di Napoli Onde Rotte. Nel 2008 quattro imprenditori
di alcune tv private campane del gruppo Teleregione-
Italiamia si vedono recapitare delle ordinanze di arresti
domiciliari con l’accusa di truffa e falso per aver falsificato
le fatturazioni e gonfiato gli organici della redazione
giornalistica attraverso assunzioni rivelatesi fittizie, con lo
scopo di beneficiare di contributi pubblici non dovuti373.
L’ordinanza raccoglie le testimonianze di due giornalisti:
«Uno afferma che durante il periodo di assunzione nel gruppo
Teleregione, ha in realtà lavorato per un paio di testate di
Sergio De Gregorio “senza retribuzione, solo per un rimborso
spese simbolico”. Un altro mette a verbale che, nonostante
l’assunzione, in redazione non c’è mai andato. Quel contratto
era, testuale, “un contentino” per aver lavorato gratis per anni
nei giornali di De Gregorio374». L’esame di Stato diventa così
moneta di ricatto nei confronti degli apiranti giornalisti nel
momento in cui le condizioni che ne consentono l’accesso
373 «Fatturato e organico sono infatti i criteri utilizzati dal Corecom, il
comitato regionale per le comunicazioni, per redigere la graduatoria delle
tv campane utilizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico per
erogare le provvidenze pubbliche di sostegno all’editoria televisiva
locale, così come stabilito dalla legge 488 del 1988». Iurillo V.,
Giornalista ti assumo ma solo per finta in ilfattoquotidiano.it, 10
settembre 2010 (http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/09/10/giornalista-
ti-assumo-ma-solo-per-finta/59173/) 374 Ibidem.
191
sono totalmente nelle mani degli editori. L’altro aspetto che
emerge è il circolo vizioso che si viene a creare e che rende i
giovani alla ricerca di affermazioni tanto colpevoli quanto gli
editori che sfruttano illegalmente le legittime aspirazioni di
coloro che sognano di diventare un giorno giornalisti:
«l’inflazione di “professionisti”, molti dei quali lo diventano
solo per curriculum ma in realtà fanno altro, rende i
giornalisti “veri” più deboli di fronte agli editori. E più
esposti al rischio sfruttamento375». Tanto per i professionisti
quanto per i pubblicisti, l’ultimo ostacolo prima
dell’iscrizione all’Albo è rappresentato dall’esame di Stato.
Anche qui, il primo aspetto da segnalare è quello economico,
come scrive Il Fatto Quotidiano: «devi sborsare quasi 500
euro tra tasse e bolli vari, iscriverti obbligatoriamente a un
corso preparatorio – quello online, per esempio, costa 200
euro -, andare a Roma due volte per fare scritto e orale nel
bunker burocratico dell’hotel Ergife. Siamo sui mille euro
come ridere376». In base ad una ricerca condotta da
giornalismoedemocrazia sui risultati degli esami
professionali, si può notare come sia solitamente una
percentuale che si aggira intorno al 25% a fallire la prova377
e a doverla quindi sostenere nuovamente (con l’esborso che
ne consegue). A volte non mancano le polemiche, come
quella generata dalla 115esima sessione d’esame di Stato
tenutasi lo scorso 15 ottobre. L’episodio ha ricevuto
375 Ibidem. 376 Armano A., Un italiano su 550 è giornalista. Riformiamo l’Ordine? in
ilfattoquotidiano.it (cit). 377 Roidi V., Esami di stato: troppi bocciati ma realmente a qualcuno
interessa? in giornalismoedemocrazia.it
(http://www.giornalismoedemocrazia.it/2012/05/15/esami-di-stato-
troppi-bocciatima-realmente-a-qualcuno-interessa/)
192
l’attenzione dei media perché caratterizzata dalla bocciatura
di Giulia Innocenzi, conduttrice di Servizio Pubblico. La
sessione ha visto un numero di non idonei di gran lunga
superiore alla media con il 44% dei partecipanti che non ha
superato lo scoglio della prova orale. Le proteste di coloro
che non ce l’hanno fatta sono nate in virtù di alcune
imprecisioni presenti nella traccia d’esame:
«L'Espresso ha avuto il documento originale
consegnato ai candidati lo scorso 15 ottobre, ossia la
traccia destinata a chi avesse voluto scegliere
l'articolo di cronaca, in genere il più gettonato tra gli
aspiranti professionisti. Una serie di lanci di agenzia
(inventati) da trasformare in un pezzo. Ebbene, se il
pm protagonista della vicenda immaginaria viene
chiamato prima in un modo (Galese) e poi in un altro
(Galesi) - segno di un refuso non corretto - a un certo
punto la traccia indica che è il pubblico ministero
stesso “a decidere se convalidare o meno il fermo” di
alcuni sospetti. Anche i cronisti alle prime armi sanno
che - come indica il codice di procedura penale - è il
giudice per le indagini preliminari a poter ordinare la
convalida del fermo. Il magistrato può solo fare la
richiesta. Strano - e grave - che i commissari
giudicanti di un esame di Stato non conoscano la
differenza tra un gip e un pm.
Accortisi dell'errore, sul sito dell'Ordine dei
giornalisti sono corsi ai ripari, pubblicando la traccia
193
"sbianchettata": la frase incriminata è scomparsa, e a
penna è stata aggiunta la frase “chiederà al gip”378».
La presenza di simili imprecisioni in un’esame di Stato ha
giustamente generato vibranti polemiche, soprattutto da parte
di chi, per poter sostenere nuovamente la prova, deve
affrontare un esborso economico non indifferente. A tal
proposito Il Fatto Quotidiano ha chiesto al presidente
dell’Ordine dei Giornalisti quali spese copre la somma
sborsata dai partecipanti. Interessante la risposta di Iacopino:
«Tutte le quote di iscrizione all’esame servono per sostenere
i costi della commissione e della sala dell’Ergife379. A volte
l’Ordine deve anche integrare le quote con fondi propri. Un
commissario che viene da Milano, ha l’arrogante pretesa di
cenare oltre che di lavorare380».
L’iscrizione all’Ordine e il lavoro. E’ giunto il momento di
occuparsi di quel 75% che in media riesce a superare l’esame
di Stato, ad iscriversi all’Albo e ad ottenere la tessera che
attesta l’appartenza all’Ordine dei Giornalisti. Come vengono
378 Fittipaldi E., Giornalisti, tracce d'esame con errori. E la
gaffe viene "sbianchettata" online, in
espresso.repubblica.it, 1 novembre 2013,
(http://espresso.repubblica.it/attualita/2013/11/01/news/gi
ornalisti-tracce-d-esame-con-errore-il-pm-convalida-gli-
arresti-1.139692). 379 Un hotel a 4 stelle di Roma. 380 Martelli F., Esame giornalisti professionisti, gli errori
nelle tracce e la difesa dell’Ordine in ilfattoquotidiano.it, 2
novembre 2013,
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/02/esame-
giornalisti-professionisti-errori-nelle-tracce-e-difesa-
dellordine/764593/).
194
premiati gli sforzi, economici e non, compiuti? Cosa
comporta la possibilità di fregiarsi del titolo di giornalista e il
diritto ad esercitare la professione? Il Rapporto sulla
professione giornalistica in Italia (anno in esame 2011) a
cura di Pino Rea per Lsdi dice che «i giornalisti iscritti all’
Ordine in Italia sono oltre 112.000 (il triplo di quelli francesi
e il doppio di quelli che lavorano nel Regno Unito) ma solo
il 45% sono attivi ‘’ufficialmente’’. E solo 1 su 5 (il 19,1%
degli iscritti) ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
che gli porta un reddito, in media, 5 volte superiore a quello
di un freelance (e 6,4 volte maggiore nel caso dei
Co.co.co)381». Diversi gli elementi che emergono dalla
ricerca condotta da Pino Rea. In primo luogo il divario nei
redditi tra giornalisti dipendenti, autonomi e parasubordinati,
pur con qualche miglioramento da segnalare per le categorie
con le retribuzioni più basse. Un dato al tempo stesso
interessante ed allarmente è relativo ai 14.800 giornalisti
autonomi (quindi oltre il 10%) che hanno un reddito annuo
inferiore ai 5.000 euro lordi. Un altro dato da evidenziare è
quello relativo alla disoccupazione, che vede coinvolti 1514
giornalisti (un dato stabile), mentre aumenta il ricorso agli
ammortizzatori sociali: la spesa dell’Inpgi, l’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, è aumentata
del 18,9% rispetto all’anno precedente. Un ultimo elemento
che può venire estrapolato dal Rapporto curato da Pino Rea è
legato a quelli che vengono definiti i “giornalisti invisibili”.
Ma di chi si parla esattamente? Si tratta di circa 48.000
giornalisti iscritti all’Ordine che, all’1 ottobre del 2012, non
avevano nessuna posizione Inpgi. Pur non disponendo di
381 La fabbrica dei giornalisti in lsdi.it, 23 novembre 2012,
(www.lsdi.it/2012/la-fabbrica-dei-giornalisti/).
195
ulteriori dati a riguardo, Rea suppone che tra i cosiddetti
“giornalismi invisibili” una buona percentuale sia
rappresentata da precari. Inoltre auspica una riforma
dell’Ordine che in primo luogo «cancelli la distinzione tra
professionisti e pubblicisti, prevedendo che è giornalista chi
fa prevalentemente il giornalista e versa i contributi all’ Inpgi,
imponendo l’ accesso universitario alla professione, ecc.382».
Ma se la vita non è così semplice essendo iscritti all’Albo,
ancora più difficile è la realtà di tutti coloro che si trovano
esclusi dai privilegi dell’Ordine.
«Quel mondo che tracima a cerchi concentrici anche
al di fuori del bacino dell’Ordine, in territori dove si
intuiscono centinaia centinaia e centinaia di aspiranti
giornalisti che sperano in una tessera come viatico al
Giornalismo con la G maiuscola: una miriade di
giovani (e meno giovani) inseriti in qualche modo
nella macchina della produzione e della distribuzione
dell’informazione giornalistica – soprattutto nel
segmento dell’online – che premono verso l’alto nella
speranza di raggiungere almeno il traguardo di uno
sbocco nel pubblicismo383».
Prima di andare ad analizzare nel dettaglio il fenomeno del
precariato nell’universo giornalistico, è necessario affrontare
una breve digressione inerente alle situazioni presenti fuori
382 Rea P., La fabbrica dei giornalisti / Il Rapporto completo in lsdi.it, 30
novembre 2012 (http://www.lsdi.it/2012/la-fabbrica-dei-giornalisti-il-
rapporto-completo/). 383 Ibidem.
196
dall’Italia. L’Ordine dei Giornalisti è un’anomalia tutta
italiana?
3.2 Il giornalismo all’estero
Su Tabloid, la rivista dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, è comparsa una interessante inchiesta384 sul
percorso che gli aspiranti giornalisti devono seguire per
diventare professionisti fuori dall’Italia. La ricerca è stata
condotta da Paolo Pozzi (Tabloid) e Pino Rea (Lsdi) e mira a
riportare, in assenza di un organismo come l’Ordine,
particolarità tutta italiana, le leggi che regolamentano la
natura e l’attività dei giornalisti all’estero.
Francia. Il Codice del Lavoro francese sancisce che «è
giornalista professionale chiunque svolga come attività
principale, regolare e retribuita l’esercizio della sua
professione in una o più aziende editoriali giornalistiche,
pubblicazioni quotidiane e periodiche o agenzie di stampa e
ne ricava la parte principale delle proprie entrate385». In
Francia sono considerati alla stregua dei giornalisti
professionisti anche collaboratori di redazione come
«redattori-traduttori, stenografi-redattori, redattori-revisori,
reporter-disegnatori, fotoreporter, esclusi gli agenti di
pubblicità e tutti coloro che collaborano solo a titolo
occasionale386». Nel paese transalpino esiste una tessera
384 Pozzi, P., Rea P., Ordine dei giornalisti. Dove c’è e dove non c’è, in
Tabloid, luglio 2013, (http://www.lsdi.it/assets/Lsdi-Tabloid-Ordini.pdf). 385 Ibidem. 386 Ibidem.
197
professionale assimilabile a quella italiana, chiamata carte de
presse, la quale viene rilasciata da una commissione statale,
la Commission de la carte d’identité dei giornalisti
professionali, composta da rappresentanti degli editori e dei
giornalisti. I requisiti da soddisfare per poter ottenere la carte
de presse sono in primo luogo l’aver esercitato la professione
giornalistica per almeno tre mesi consecutivi, inoltre più del
50% dei propri redditi deve derivare da questa attività. Il
prerequisito è che il datore di lavoro sia un’azienda
giornalistica di stampa o audiovisiva, o un’agenzia di stampa
accreditata. Le stesse condizioni sono applicabili anche al
giornalista che lavora su Internet. L’accesso alla professione
in Francia è assolutamente libero: non è necessaria una
Laurea, né generica né tantomeno specifica e non è necessario
aver frequentato scuole apposite come quelle che in Italia
sono riconosciute dall’Ordine. Inoltre, la carte de presse, non
è obbligatoria ma il Contratto nazionale di lavoro proibisce
agli editori di tenere per più di tre mesi (il periodo di tempo
necessario per poter inoltrare la richiesta per la tessera
professionale) dei collaboratori sprovvisti della carta. Infine,
«il possesso del tesserino consente di beneficiare più
facilmente di una serie di garanzie sociali associate allo status
di giornalista, come la tredicesima, le ferie pagate o le
indennità di licenziamento387». Riassumendo la situazione
francese è possibile notare come dall’altra parte delle Alpi
non esista un organo assimilabile all’Ordine dei Giornalisti
italiano. La tessera professionale sembra rappresentare uno
strumento di tutela piuttosto che di appartenenza ad una casta.
L’accesso alla professione è molto più snello rispetto al
sistema italiano: tre mesi di praticantato rispetto ai 18 o ai 24
387 Ibidem.
198
richiesti nel nostro Paese e nessuna distinzione tra
professionisti e pubblicisti. Così come in Italia, invece, il
sistema universitario non concede lo status di giornalista, che
viene ottenuto tramite l’esercizio della professione, così come
non costituisce condizione necessaria allo svolgimento
dell’attività. Bisogna però aggiungere che anche in Francia
esistono delle scuole di formazione, che non rappresentano
un requisito per l’accesso alla professione ma un’opportunità
e un ponte con il mondo del lavoro: sono previsti due anni di
corso con frequenza obbligatoria e stages presso aziende
editoriali.
Regno Unito. Il Regno Unito è la patria del liberismo: «non
esiste un contratto collettivo di lavoro per giornalisti, né
l’obbligo di registrazione di una testata, neppure particolari
requisiti per fare il direttore di testata e così via. Prima del
1965 praticamente non esisteva un cursus di studi
giornalistici e i professionisti cominciavano dalla stampa
locale388». Il ruolo del sindacato è stato molto forte fino al
governo della Thatcher, dopo il quale sono venute meno le
battaglie sindacali ma non gli iscritti: la National Union of
Journalists conta 35.000 membri e «raccoglie tutti i
lavoratori del settore giornalistico dai reporter agli editori, dai
fotografi allo staff di redazione, dai membri degli uffici
stampa agli esperti in pubbliche relazioni, come pure chi
lavora su Internet389». La NUJ garantisce assistenza legale
gratuita ai suoi iscritti così come corsi di aggiornamento e
altri privilegi. Ma soprattutto si occupa di tutelare il rispetto
388 I giornalisti nello scenario europeo in Ordine dei Giornalisti della
Sardegna, (http://www.odg.sardegna.it/documenti/censis07.pdf). 389 Ibidem.
199
di alcune condizioni di lavoro imprescindibili390. L’accesso
alla professione è totalmente libero: nel Regno Unito per
esercitare la professione di giornalista è sufficiente
raggiungere un accordo con un editore e lavorare. Tuttavia,
anche nella patria del liberismo esistono dei percorsi di
accesso meno lineari ma che garantiscono l’imbocco di corsie
preferenziali. L’alternativa all’accesso diretto391 è
rappresentata da corsi preliminari392, i cui costi sono variabili
ma esiste la possibilità di richiedere delle borse di studio.
«Perciò nel Regno Unito conviene iscriversi ad un
corso e contemporaneamente chiedere un colloquio
con più editori possibili. Se ti viene offerto un posto,
390 «Qualunque sia il tipo di contratto, comunque il lavoratore, dopo non
più di due mesi dall’inizio del rapporto di lavoro riceva un contratto
scritto, in cui si citino precisamente una serie di elementi: dalle ore di
lavoro, alla malattia, dalla descrizione del tipo di mansione svolta, ai
contributi pensionistici, le ferie, la durata del contratto e così via. Il
minimun rate viene comunque contrattato con il singolo editore e non
sono pochi i casi in cui non viene rispettato, non esistendo alcuna legi
slazione né alcun accordo a livello nazionale. Anche l’orario di lavoro
deve rispettare alcuni accordi sindacali: non più di 48 ore settimanali, 4
settimane di ferie annuali, un riposo di 24 ore settimanali. È tutelata anche
la maternità, con regole dettagliate, la condizione dei giovani lavoratori,
le minoranze. La legislazione tutela anche i diritti delle donne a non essere
discriminate e, in base al Human Right Act, la privacy familiare e le
convinzioni politiche o religiose dell’impiegato». Ibidem. 391 Sarà poi l’editore ad occuparsi della «tua formazione o mandandoti
presso un college o con il programma di insegnamento a distanza, i cui
costi sono in genere sostenuti dal giornale». Ibidem. 392 «La maggioranza dei giornalisti in formazione viene reclutata
dall’industria editoriale dopo aver completato corsi
di formazione per studenti di livello A e laureati (questo percorso è
chiamato “pre-entry”)». Ibidem.
200
probabilmente ti viene proposto un contratto di
formazione di durata biennale, di cui i primi sei mesi
sono di prova per entrambe le parti. Una volta
superata la prova di sei mesi, il giornale ti dovrebbe
registrare presso il National Council per gli esami
preliminari e mettere in moto tutta la procedura di
formazione. Successivamente passerai 12 mesi al
lavoro prima di sostenere il National Certificate
Examination, la qualifica finale del National
Council393».
Irlanda. In Irlanda è presente dal 2007 un Organismo
indipendente di autoregolamentazione della stampa, non
espressamente riconosciuto dalla legislazione, oltre a non
rappresentare una condizione obbligatoria l’iscrizione presso
lo stesso per i giornali. «La normativa prevede l’indipendenza
del consiglio, sia dallo stato che dalle testate giornalistiche,
con una maggioranza di membri indipendenti che
rappresentano l’interesse pubblico394». L’Organismo si
occupa della regolamentazione per quanto concerne: le
norme etiche e pratiche, le regole sull’accuratezza e il rispetto
della reputazione delle persone, le regole tese a garantire la
riservatezza, l’integrità e la dignità delle persone.
Germania. Non esiste una definizione ufficiale per il
giornalista in Germania. L’accesso è fondamentalmente
libero: così come nel Regno Unito, può essere sufficiente un
contatto diretto con l’editore per iniziare a scrivere. Tuttavia,
anche in Germania esistono delle vie alternative che
393 Ibidem. 394 Pozzi, P., Rea P., Ordine dei giornalisti. Dove c’è e dove
non c’è, in Tabloid, luglio 2013, (cit.).
201
costituiscono dei pre-requisiti, nonché delle risorse ulteriori
per gli aspiranti giornalisti. Una di queste è il Volontariat, un
praticantato di due anni regolarmente retribuito in vigore fin
dagl inizi del 1900. L’altra strada è rappresentata da corsi
universitari395 e scuole di giornalismo, le quali possono essere
direttamente di proprietà degli editori o indipendenti. Ad
esempio «presso la Henri-Nannen-Schule, di proprietà
dell’impero editoriale Gruner + Jahr, (editore di Die Zeit) il
praticante riceve un sussidio per la formazione che si aggira
attorno agli 800 euro mensili ed ha ottime possibilità di
trovare un lavoro subito dopo aver completato gli studi396».
Per quanto riguarda invece il sistema universitario è rinomato
il cosiddetto “modello Dortmund”, poiché rappresenta un
ottimo esempio di connessione tra studi accademici e
preparazione al mondo del lavoro397. Mettendo da parte i
percorsi formativi e focalizzando invece l’attenzione
395 In Germania esistono da 25 anni. 396 I giornalisti nello scenario europeo in Ordine dei Giornalisti della
Sardegna, (cit.). 397 «Il programma di studi si articola in tre fasi, la prima delle quali si
conclude dopo i primi due anni e l’acquisizione di un diploma intermedio.
Si comincia con le conoscenze di base per un buon giornalismo
(Grundstudium). La seconda fase prevede dodici mesi di training
professionale, con un internato full-time presso imprese editoriali. In
questo periodo quindi si interrompe la frequenza universitaria. L’istituto
di giornalismo di Dortmund coopera con 30 imprese nel campo dei media
sia a livello regionale (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Bonner
General-Anzeiger ecc.) che nazionale (Deutsche Welle, n-tv, Zdf ecc.). La
fase conclusiva, di studi avanzati (Hauptstudium), prevede due anni di
preparazione della tesi di laurea. Ed è a questo livello che si può scegliere
di specializzarsi in un ambito specifico. Il titolo che si ottiene alla fine –
Diplom – equivale ad un Master’s Degree. L’accesso alla professione per
chi ha seguito un cursus di studi in giornalismo è infine il volontariat (cioè
lo stage), che dura due anni ed è remunerato». Ibidem.
202
sull’accesso alla professione, è possibile notare come
l’aspirante giornalista si trovi di fronte a tre possibilità dal
punto di vista contrattuale. Due di queste sono classiche: una
è rappresentata dal contratto come dipendente fisso398 (tempo
indeterminato), l’altra dal contratto come freelance. La terza
via è caratteristica del sistema tedesco e prende il nome di
fester freier, ovvero “libero-fisso”. Riservato solo al settore
pubblico, al lavoratore viene riconosciuto il carattere di
collaboratore prevalente e vengono garantiti diretti riservati
ai dipendendti (pur non essendolo): dai 31 giorni di ferie
annue alla malattia, la maternità ecc. Il contratto “libero-
fisso” svolge la funzione di garantire al lavoratore precario
un qualche tipo di stabilità399. In Germania esistono
associazioni dei giornalisti e la più famosa è la Deutscher
Journalisten-Verband, o DJV400. Per quanto riguarda invece
il rispetto della deontologia, esso viene assicurato dal
Consiglio tedesco della stampa, «un organo di autocontrollo
che valuta anche le proteste dei cittadini nei confronti degli
organi di informazione e che ha elaborato un codice
deontologico401». Rispetto all’Italia, in Germania non esiste
quindi né un Ordine dei Giornalisti, né una tessera
398 Questo tipo di contratto è sempre più difficile da ottenere. 399 «Questo contratto può comunque essere rescisso senza motivo in
qualunque momento e dà diritto all’assunzione se dura già da dieci anni e
il lavoratore è sotto i 40, quindici anni se il lavoratore ne ha più di 40».
Ibidem. 400 «La DJV è nello stesso tempo un sindacato e un’organizzazione
professionale, fissa gli obiettivi della professione e tratta i contratti
collettivi di lavoro – conta quasi 40.000 associati, tutti giornalisti a tempo
pieno, a cui viene fornita una tessera professionale». Pozzi, P., Rea P.,
Ordine dei giornalisti. Dove c’è e dove non c’è, in Tabloid, luglio 2013,
(cit.). 401 Ibidem.
203
professionale. Non esistendo una definizione legale di
giornalista, quest’ultimo è accomunabile con chiunque scriva
per una testata. L’accesso è libero e diretto, seppure la
frequenza di corsi di formazione o l’università possano
rappresentare delle armi ulteriori per i giovani aspiranti.
Belgio. Così come per quanto riguarda la Germania, anche il
Belgio non dispone di una definizione legale del giornalista.
Tuttavia una legge del 30 dicembre 1963 sancisce che è
“giornalista professionista” «una persona che lavora in un
mezzo di informazione generale (quotidiano, magazine
generalista, radio, televisione, sito Internet di attualità o
agenzia di stampa) e non può occuparsi di pubblicità402». Il
titolo di giornalista professionista viene concesso da una
Commissione di ratifica istituita nel 1965 e composta
paritariamente di giornalisti professionisti e direttori di testate
giornalistiche. La conditio sine qua non è l’aver esercitato la
professione per un periodo non inferiore ai due anni. Così
come in Francia, anche in Belgio viene rilasciata una sorta di
Carte de presse, meglio desrivibile come un lasciapassare
nazionale che ha la funzione di facilitare i rapporti con le
istituzioni politiche, la procura, polizia e le aziende private.
Questo lasciapassare non può essere rilasciato ai giornalisti
della stampa periodica, che possono però ottenere un pass
“stampa periodica” che copre grossomodo le stesse necessità
della tessera che viene consegnata ai giornalisti
professionisti. Per poterla ottenere questi giornalisti devono
aver avorato per almeno due anni in una redazione di un
mezzo di informazione specializzato, firmando almeno sei
402 Ibidem.
204
volte l’anno, e dimostrando di aver scritto almeno 20 articoli
ogni anno.
Norvegia. La Norsk Journalistlag, l’Unione dei giornalisti
norvegesi, si carica dell’onere di assegnare la tessera stampa
ai suoi membri: 9.500, la quasi totalità dei professionisti del
paese scandinavo. I requisiti per il suo ottenimento sono
l’esercizio della professione come attività principale e il
rispetto del Codice etico della stampa.
Svezia. In Svezia esiste una sola organizzazione che ha diritto
a rappresentare la professione e a parlare in suo nome: si tratta
della Svenska Journalistförbundet, l’Unione dei giornalisti
svedesi. I requisti d’accesso variano a seconda della tipologia
di lavoratore in questione. Quello dipendente deve aver
lavorato per un periodo di almeno quattro settimane, mentre
quello autonomo deve certificare un reddito giornalistico
durante almeno quattro mesi. Questa organizzazione
distribuisce le tessere di stampa, ma anche altri organismi
sono legittimati ad assegnarle, pur possedendo minor
prestigio. Dal punto di vista deontologico è presente un
Codice etico dal 2001, che è stato condiviso e accettato dalle
quattro grandi associazioni di editori svedesi.
Svizzera. Nel paese elvetico lo status di giornalista non è
riconosciuto legalmente, di conseguenza ogni persona che
esercita la professione ha diritto a rivendicarne il titolo.
Tuttavia, anche in Svizzera esistono le tessere professionali,
la più diffusa delle quali è la RP, il Registro Professionale dei
giornalisti, essa facilita l’accesso ad un discreto numero di
avvenimenti. I requisiti per il suo ottenimento sono
rappresentati dal riconoscimento della Dichiarazione dei
diritti e dei doveri dei giornalisti (la Dichiarazione di Monaco
205
del 1971) e dalla dimostrazione che almeno il 50% del reddito
del professionista in questione nel corso degli ultimi due anni
provenga da attività giornalistica. La RP può essere rilasciata
solo dai tre sindacati nazionali403, che sono abilitati anche al
rilascio della Carte de presse della Federazione
internazionale dei giornalisti. Il caso svizzero ha la sua
particolarità in quella che nell’inchiesta pubblicata su Tabloid
viene definita la “guerra delle tessere stampa”: «Presse
Suisse, l’organizzazione degli editori della stampa quotidiana
e periodica della Svizzera romanda, ha lanciato (nel 2006)
una sua propria tessera, seguendo l’esempio della Schweizer
Presse, il suo pendant germanofono, che aveva lanciato l’idea
vari anni prima404». La convenienza della carta rilasciata da
Presse Suisse è principalmente di natura economica: «80
franchi svizzeri nel 2010 per la Carte Presse Suisse, contro
355 per Impressum e 150-750, a secondo del salario annuale,
per quella di Comedia405». Questa tessera concede a tutti i
possessori sconti e facilitazioni presso grandi aziende ma
viene contestata dai sindacati per l’assenza di un Codice
deontologico associato alla carta.
Spagna. Nel paese iberico è considerato giornalista chiunque
possegga una laurea in giornalismo. Negli anni settanta, sono
stati gli stessi giornalisti a richiedere una
professionalizzazione del loro mondo e a richiedere la nascita
di specifici corsi di studi. Così, all’interno delle facoltà di
Scienze della comunicazione sono inizati a nascere corsi di
periodismo pressoché in ogni angolo del paese, senza
403 «Impressum, ex FSJ (5.500 membri), Comedia (13.000 membri) e il
Sindacato svizzero dei mass media (3.500 aderenti)». Ibidem. 404 Ibidem. 405 Ibidem.
206
esclusione degli atenei più piccoli406. Nella maggior parte dei
casi questi corso di studi è un biennio universitario (la nostra
Laurea Magistrale) che segue un triennio di preparazione in
materie quali la giurisprudenza, le scienze politiche, la
comunicazione407. Esistono anche dei master per la
formazione in giornalismo, alcuni proposti da grandi editori
e il cui accesso richiede una laurea e il superamento di un
esame di ammissione408. Questi master hanno una durata
variabile che va da uno a due anni e rappresentano un
importante ponte con il mondo del lavoro consentendo a
coloro che portano a termine il percorso una “borsa di
lavoro”, cioè uno stage. L’esercizio della professione è
tuttavia caratterizzato da un’altissima percentuale di
406 «La percentuale di laureati tra i giornalisti è notevole (78%), con una
lieve maggioranza di uomini e un’età media di 37 anni. La stampa
quotidiana assorbe ancora la maggior parte degli occupati, seguita dalla
radio-televisione e dagli uffici stampa. Mentre agenzie e periodi ci sono
più distanziati. Coloro che lavorano su internet (4,8%) sono in numero
maggiore dei freelance (2,3%)». I giornalisti nello scenario europeo in
Ordine dei Giornalisti della Sardegna, (cit.). 407 «C’è anche il caso dell’Università Carlos III di Madrid che, come una
novità, propone ai suoi iscritti un triennio in giurisprudenza o scienze
politiche già specificamente orientati al successivo biennio in
giornalismo, mirando con ciò a formare dei veri professionisti
dell’informazione, un po’ alla maniera francese». Pozzi, P., Rea P.,
Ordine dei giornalisti. Dove c’è e dove non c’è, in Tabloid, luglio 2013,
(cit.). 408 «Tutti i grandi gruppi editoriali spagnoli (il gruppo Prisa, cioè l’editore
di El Pais, Abc, El Mundo, Efe – l’agenzia di stampa nazionale) ne offrono
e il comune denominatore è una forte selezione iniziale. Quello presso il
più grande quotidiano nazionale – El Pais – costa attorno ai 9000 euro per
una durata di un anno e mezzo, per 150 posti e come requisiti d’ingresso
si richiedono una laurea (non strettamente in giornalismo) e due lingue».
I giornalisti nello scenario europeo in Ordine dei Giornalisti della
Sardegna, (cit.).
207
precariato: «anche quando si riesce ad entrare come stagisti
spesso si inizia senza neppure un rimborso spese. Poi
l’editore può offrire di restare come collaboratore part-time,
cioè con un contratto part-time ma che nasconde un impegno
a tempo pieno409». Dal punto di vista legislativo non esiste
uno statuto per la professione di giornalismo. L’articolo 20
della costituzione spagnola del 1978 si limita a contemplare
il diritto fondamentale alla libertà di espressione e
informazione, diritto che si converte nel dovere di informare
correttamente, mentre la legge organica 2/1997 regola la
clausola di coscienza e il principio del segreto professionale.
L’organismo più rappresentativo del giornalismo spagnolo è
la Fape, Federaciòn de asociaciones de la prensa de Espana,
che riunisce 13.000 professionisti di 45 associazioni. Questa
associazione, «vista la situazione di precarietà e l’assenza di
protezione in cui versano molti giornalisti, specialmente i più
giovani, ha approvato un Codice per la contrattazione dei
giovani giornalisti, che contiene le norme di base da rispettare
per tutte le parti interessate: imprese, editoriali, giornalisti,
praticanti o stagisti410».
Australia. Anche in nel paese oceanico non esiste uno statuto
del giornalista, con l’esercizio della professione come unico
requisito per professarsi tale. L’anomalia del modello
australiano è legata al fatto che «la Costituzione australiana
non garantisce esplicitamente la libertà di espressione, cosa
che crea una certa aria di sospetto nei confronti del governo,
dal momento che in teoria la censura sarebbe possibile411».
409 Ibidem. 410 Ibidem. 411 «Le autorità tra l’altro hanno evocato l’ipotesi di una legge che instauri
un filtro obbligatorio per alcuni siti Internet, cosa che è valsa tempo fa
208
Questa assenza rende quindi l’universo giornalistico piuttosto
vulnerabile, solo parzialmente protetta dalla possibilità di
iscriversi al Media, Entertainment & Arts Alliance, un
sindacato che si impegna a garantire e proteggere i diritti dei
giornalisti, che però rimangono scoperti a causa del vuoto
legislativo.
Brasile. La situazione nel paese sudamericano è cambiata
radicalmente negli ultimi anni. Per essere considerato
giornalista prima del 2009 era necessario avere un diploma
superiore in giornalismo e iscriversi al Registro Profissional,
condizioni che consentivano di ottenere una tessera
professionale412. Nel 2009 invece il Tribunale supremo
federale si è espresso a favore dell’incostituzionalità
dell’obbligo del possesso del diploma di giornalista e
dell’iscrizione al ministero del Lavoro come condizioni per l’
esercizio della professione. Ora è la a Fenaj, Federazione
nazionale dei giornalisti brasiliani, a rilasciare una propria
carta.
Stati Uniti. Il 12 settembre 2013 il Senato statunitense, per
approvare una legge che proteggesse i giornalisti dal dover
rivelare le proprie fonti confidenziali, si è trovato costretto a
dare una definizione di “giornalista”: «an employee,
independent contractor or agent of an entity that disseminates
news or information … [who has been] employed for one
year within the last 20 years or three months within the last
all’Australia la presenza nell’elenco dei ‘’Nemici di Internet’’ curato da
Reporters sans frontières». Pozzi, P., Rea P., Ordine dei giornalisti. Dove
c’è e dove non c’è, in Tabloid, luglio 2013, (cit.). 412 «Mentre il giornalista ‘’autodidatta’’ o ‘amatoriale’ era considerato
illegale». Pozzi, P., Rea P., Ordine dei giornalisti. Dove c’è e dove non
c’è, in Tabloid, luglio 2013, (cit.).
209
five years413». Il primo emendamento della Costituzione
americana, oltre a garantire la libertà di stampa, vieta
l’interferenza del governo nell’esercizio della professione.
Questo principio, in virtù della definizione che il Senato si è
visto costretto a fornire, garantisce un alto livello di
protezione per i professionisti. Questo soprattutto in relazione
alle cosiddette shield laws, delle leggi applicate nella maggior
parte degli stati americani che dicono che il giornalista non
può essere costretto a comparire o a testimoniare in relazione
alle informazioni contenute in una notizia o a divulgare le
proprie fonti. Per questo motivo l’azione del Senato ha
provocato tanto reazioni favorevoli quanto apertamente
contrarie. Non esistono tessere professionali ufficiali negli
Stati Uniti, ma ogni datore di lavoro fornisce ai propri
dipendenti una tessera. Esiste la Society of Professional
Journalists, un’organizzazione professionale che conta oltre
10.000 associati e si pone l’obiettivo di incoraggiare la libertà
di stampa e promuovere fra i giornalisti un comportamento
aderente ai principi deontologici. Essa propone un Codice
etico ma non rilascia alcuna tessera professionale e non è
quindi in alcun modo paragonabile all’Ordine dei Giornalisti
italiano. Nonostante la definizione data dal Senato sia
ampiamente inglobante, l’accesso alla professione è tutt’altro
che semplice da un punto di vista strettamente pratico. «As
digital media gave more writers a voice, qualifications for
413 «Un impiegato, un libero professionista o un agente di una entità che
pubblica notizie o informazioni… [che è stato] impiegato per un anno
negli ultimi 20 anni o per tre mesi negli ultimi cinque anni». Kendzior S.,
Who is a 'journalist'? People who can afford to be in aljazeera.com, 17
settembre 2013,
(http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/09/2013917643128064
87.html).
210
journalism jobs became more stringent and dependent on
wealth. This is true worldwide. In 2009, the average cost of
journalism school, often a prerequisite for hire in the US, was
$31,000. Some universities charge over $50,000, along with
living expenses the total bill can be above $80,000 (median
US income is $52,000)414». Inoltre, le posizioni che
consentivano l’accesso iniziale al mondo del lavoro sono
state sostituite da tirocini, la maggior parte dei quali non
pagati: «Today people work for the possibility of working,
waiting to be considered good enough to be hired by the
employers under whom they already labour415». Il risultato è
che l’accesso alla professione diventa ad appannaggio
principalmente di persone con alle spalle una situazione
economica più che solida, in grado di affrontare le spese delle
scuole di formazione o di potersi permettere di portare avanti
tirocini non retribuiti.
414 «Nel momento in cui i media digitali hanno dato voce a più autori, le
qualifiche richieste per i lavori legati al giornalismo sono diventate più
alte e dipendenti dal benessere economico. Questo è vero in tutto il
mondo. Nel 2009, il costo medio di una scuola di giornalismo, spesso un
prerequisito per essere assunto negli Stati Uniti, era di 31.000 $. Alcune
università costano oltre 50.000 $, la spesa complessiva calcolando anche
i costi della vita può essere superiore agli 80.000 $ (il reddito media
statunitensi è di 52.000 $)». Ibidem. 415 «Oggi le persone lavorano per la possibilità di lavorare, aspettando di
essere considerati abbastanza bravi per essere assunti da datori di lavoro
per i quali già lavorano». Ibidem.
211
3.3 Giornalismo e precariato
In Italia ci sono circa 110mila iscritti all’Ordine dei
Giornalisti, questo significa, come fa pertinentemente notare
Il Fatto Quotidiano416, che un italiano su 550 è un giornalista,
professionista o pubblicista che sia. Si tratta di un numero che
stupisce specie in relazione ad altri importanti paesi europei:
nel Regno Unito ci sono circa 40mila giornalisti, quindi uno
ogni 1650 abitanti circa, in Francia invece circa 38mila,
grossomodo uno ogni 1740 abitanti417. Come già analizzato
in precedenza, solo una parte, circa la metà, versa
regolarmente i contributi e può dire di lavorare regolarmente.
Per quanto riguarda gli altri «o non sanno che l’iscrizione alla
previdenza è obbligatoria, o sono evasori contributivi oppure
hanno cambiato mestiere. “Vista la natura dell’industria dei
media in Italia è probabile che nella grande maggioranza dei
casi si tratti di quest’ultima ipotesi”, spiega Guido Besana,
componente della giunta esecutiva della Fnsi, il sindacato
unico dei giornalisti418». Un altro interessantissimo incrocio
di dati è quello tra il numero degli iscritti all’ordine in Italia
e l’estensione del mercato editoriale. «Secondo una ricerca
Ocse419 del 2010 in Germania ogni 100 mila copie di
quotidiani o periodici ci sono 75 giornalisti di carta stampata.
In Francia per vendere lo stesso numero di copie ne bastano
416 Armano A., Un italiano su 550 è giornalista. Riformiamo l’Ordine? in
ilfattoquotidiano.it (cit.). 417 De Luca D., Italia: il paese dei giornalisti invisibili in ifg.uniurb.it 27
gennaio 2012, (http://ifg.uniurb.it/2012/01/27/ducato-online/italia-il-
paese-dei-giornalisti-invisibili/17001). 418 Ibidem. 419 http://www.mondaynote.com/2010/07/11/too-many-journalists/
212
72. In Italia ne occorrono ben 127. […] Anche nella classifica
di diffusione dei periodici l’Italia è il fanalino di coda. In
Germania ogni mille abitanti si vendono 244 giornali al
giorno, in Francia 117. Nell’Italia delle penne solo 88420».
Questo elemento di squilibrio nel mercato del lavoro è
comune anche ad altre professioni, dove gli iscritti all’Ordine
segnano allo stesso modo cifre esorbitanti comparate agli altri
paesi europei. Ad esempio, per quanto riguarda i medici,
secondo dati Istat del 2011421, l’Italia è al terzo posto nel
rapporto tra medici e abitanti, con oltre 410 medici ogni
100mila abitanti (il Regno Unito ne ha circa 260). Per quanto
concerne gli avvocati, invece, se la media europea si attesta
su 127 avvocati ogni 100mila abitanti, quella italiana è di
406422. Tornando all’universo giornalistico, la spiegazione a
quest’ondata di professionisti non è semplice. Il sindacalista
Besana, ad esempio, punta il dito contro l’Ordine, i cui
Consigli regionali non avrebbero interesse a revisionare gli
elenchi cancellando gli iscritti che non esercitano più la
professione: «Dico una cattiveria, per un Ordine regionale
avere tanti iscritti vuol dire avere tante quote. Se non svolgo
attività giornalistica, per l’Ordine non sono un costo, ma una
quota che arriva423». Inoltre secondo Besana, «avere tanti
iscritti significa avere maggior peso nel Consiglio nazionale
420 Ibidem. 421 http://noi-
italia2011.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1[id_pagina]=86&cH
ash=6c8089e674dee3073c9c8cfb3ea1dd6a 422 Avvocati: in Italia sono il triplo della media Ue. E fanno troppe cause
per incidenti in blitzquotidiano.it, 4 luglio 2013,
(http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/avvocati-italia-triplo-
media-ue-cause-incidenti-1610853/). 423 De Luca D., Italia: il paese dei giornalisti invisibili in ifg.uniurb.it 27
gennaio 2012, (cit.).
213
dell’Ordine (Cnog)424». La posizione dell’Ordine è, come
previdibile, diametralmente opposta. Secondo Enzo
Iacopino, il presidente del Consiglio nazionale il problema «è
una legge antica che prevede una procedura per diventare
giornalisti. L’Ordine non ha discrezionalità quando qualcuno
rispetta i parametri per ottenere l’iscrizione425». Per quanto
riguarda le revisioni, invece, Iacopino ammette che «possono
esserci ritardi in alcuni casi. Certe realtà, come Lazio e
Lombardia, possono essere più severe di altre, ma che il
problema degli iscritti sia legato a questo è falso. Dopo
quindici anni di iscrizione all’elenco dei pubblicisti non è
possibile essere cancellati. Fino a che questa norma è nella
legge noi la dobbiamo rispettare426». Al di là della logica tutta
italiana che si esprime nel consueto allontanamento delle
responsabilità, quello che emerge da questi dati è la
saturazione di un mercato che non è in grado di soddisfare
una richiesta di lavoro troppo grande rispetto alle posizioni
disponibili. L’avvento di Internet e la nascita di tante realtà
editoriali anche appartenenti alla piccolissima impresa da un
lato ha garantito maggiori possibilità di trovare un impiego,
dall’altra ha però frammentato il mercato, consentendo
l’ingresso di figure per cui lo scrivere non è visto come un
mestiere che, tra le altre cose, serve anche per arrivare alla
fine del mese e contribuendo di fatto a far scoppiare e
diffondere l’epidemia del precariato. Il Rapporto sulla
professione giornalistica in Italia curato da Pino Rea per
424 «Il Consiglio è eletto su base proporzionale: più iscritti ha un Ordine
regionale, più consiglieri può mandare al Cnog». Ibidem. 425 Ibidem. 426 Ibidem.
214
Lsdi427, stilato su dati del 2012, è in grado di offrire
un’eccellente fotografia della situazione. Le prime
conclusioni sono riportate nell’incipit dell’analisi:
«Si riduce il lavoro dipendente (meno 1,6%), cresce
quello autonomo (+7,1%; 6 attivi su 10, quasi il
doppio di 13 anni fa), e aumenta in modo sempre più
marcato il gap nei redditi fra i due segmenti della
professione. Nel 2012 la media annua delle
retribuzioni dei dipendenti era di 62.459 euro (+0,4%
sul 2011) : 5 volte più di quella degli autonomi e quasi
7 volte superiore a quella dei Co.co.co. La media dei
soli autonomi era infatti di 11.278 euro. E la media
generale (dipendenti + autonomi) era quindi di 33.557
euro428».
Un primo elemento da considerare è che il numero di
giornalisti continua a crescere, sia complessivamente (+1%),
sia limitandosi a quelli attivi (+3,2%), mentre diminuisce il
numero di lavoratori dipendenti (-1,6%). Come facilmente
intuibile, la crescita del numero globale dei giornalisti è
quindi dovuta al lavoro autonomo, che vede aumentare le
proprie fila del 7,1% (da 26.524 a 28.408 unità). Su un
campione di 10 giornalisti iscritti all’Ordine e attivi, 6
svolgono lavoro autonomo. I contratti a tempo indeterminato
coinvolgono un solo professionista su 5 (in realtà meno, visto
che la percentuale è del 18,8%). Rea mostra un
427 Rea P., Il paese dei giornalisti
(http://www.fnsi.it/Download/RAPPORTO_LSDI_2012.pdf). 428 Ibidem.
215
interessantissimo quadro diacronico degli ultimi 13 anni. Dal
2000 a al 2012 (periodo che racchiude perfettamente
l’avvento, l’evoluzione e la diffusione del giornalismo
online), la popolazione attiva è raddoppiata, «da 21.373
giornalisti del 2000, il 26,5% degli iscritti all’ Ordine
(compresi elenco speciale e stranieri), a 47.227 giornalisti del
2012, pari al 43,9% degli iscritti all’Ordine429». Non solo, se
nel 2000 i lavoratori autonomi era circa un terzo della totalità
dei professionisti, nel 2012 hanno abbondantemente superato
la metà430. Gli anni cruciali nei quali è avvenuto il sorpasso
sono il 2008 e il 2009431, quando il numero dei dipendenti
inizia un calo destinato a proseguire e gli autonomi compiono
un importante balzo in avanti passando da 19.486 a 23.213
unità. L’altro dato da prendere in considerazione vede
coinvolti i redditi. Come già riportato in precedenza, ciò che
si evince è innanzitutto l’enorme gap tra i redditi dei
lavoratori dipendenti e quelli degli autonomi. Il salario medio
di un giornalista italiano è di 33.557 euro annui lordi, ma il
dato è risultato di una forbice molto ampia. Se un lavoratore
dipendente guadagna infatti in media 62.459 euro all’anno
(dato in lieve crescita – 0,4% - rispetto al 2011), un autonomo
arriva invece a 11.278 euro lordi. Quest’ultima cifra è a sua
volta la media tra il reddito dei freelance (12.810 euro, una
crescita di 354 euro rispetto al 2011) e quello dei Co.co.co
(9.703 euro, una diminuzione di 730 euro rispetto al 2011).
La differenza tra i lavoratori dipendenti e gli autonomi è
429 Ibidem. 430 Rea lancia il proprio j’accuse: «E a questo punto viene il dubbio che
gli istituti della categoria stiano colpevolmente sottovalutando quello che
è accaduto». Ibidem. 431 Sono gli anni dell’esplosione dei social network e dei blog. La maturità
del Web 2.0.
216
evidente, ancora più marcata se vengono presi in esame i
Co.co.co. Ma Rea riporta dati ancor più allarmanti.
All’interno della fascia dei lavoratori autonomi infatti esiste
un 48,9% (14.042 lavoratori) che hanno redditi annui inferiori
ai 5.000 euro. Addirrittura circa 1 su 5 (18,7%) ha dichiarato
nel 2012 redditi compresi tra 0 e 1.000 euro annui432, dato
sconcertante che fotografa la drammaticità della situazione
per buona parte dei lavoratori autonomi. Anche la situazione
all’interno della categoria dei lavoratori dipendenti mostra un
allargamento della forbice tra “ricchi” e “poveri”. Se le fasce
medio-alte – andamento che si ripercuote in generale su tutto
il gruppo – vedono aumentare il proprio salario, quelle basse
lo vedono invece diminuire. Il risultato, in poche parole, è che
chi godeva di una posizione privilegiata continua a farlo, o
addirittura vede la propria situazione migliorare; chi invece
appartiene alla fascia più povera del lavoro dipendente
compie un ulteriore passo indietro. I problemi legati ai
subordinati sono ben identificabili nelle richieste dei
professionisti nei confronti del Fondo complementare di
previdenza, che viene spesso utilizzato come ammortizzatore
sociale, piuttosto che come strumento di integrazione per la
futura pensione433. «Un altro elemento di cui tener conto è il
fatto che oltre 8.000 dei 19.319 subordinati (8.006, pari al
432 433 euro per 2.096 Co.co.co, 447 euro per 3.231 ‘’liberi
professionisti’’. Ibidem. 433 Spiega Ignazio Ingrao del consiglio d’amministrazione: «I bilanci del
Fondo consente di fare una facile previsione: tra 20 anni si presenterà il
problemacdei giornalisti pensionati con redditi pericolosamente bassi. Per
questo stiamo varando una importante campagna di sensibilizzazione da
per cercare di indurre i colleghi, soprattutto i più giovani, a non
impoverire le proprie posizioni contributive nel Fondo complementare e
anzi a cercare di rafforzarle con versamenti maggiori: altrimenti la loro
prospettiva dopo la pensione sarà davvero difficile». Ibidem.
217
41,4%, nel 2011 era il 40%) hanno anche un reddito da lavoro
autonomo, che non entra nel calcolo della media annua della
sua retribuzione come dipendente, ma che di fatto allarga il
divario con la condizione reddituale del lavoro autonomo e
parasubordinato434». La situazione dei rapporti di lavoro
subordinati mostra un calo, dovuto anche ad un sostanziale
blocco di assunzioni, soprattutto per quanto concerne i
quotidiani (-2,8% di rapporti di lavoro rispetto al 2011), le
agenzie di stampa (-6,6%), l’emittenza locale (-2,8%) e la Rai
(-2,4%). Gli unici settori che mostrano una crescita sono
quello dei periodici (+1,8%), l’emittenza nazionale
commerciale (+3,4%) e altri tipi di aziende private (+1,1%).
La saturazione del mercato viene messa in risalto anche da un
dato che mostra come il lavoro subordinato sia molto
invecchiato negli ultimi anni. Prendendo ancora come base i
13 anni dal 2000 al 2012, è possibile notare come i giornalisti
di età inferiore ai 35 anni siano passati dal 28,9% al 19,9%
(gli ultracinquantenni sono passati dal 17,3% al 29,6%).
Riassumendo la situazione del lavoro dipendente è possibile
quindi segnalare un blocco delle assunzioni che sfocia in un
mancato ricambio generazionale e in un invecchiamento della
categoria. Aumentano le richieste di ammortizzatori sociali
con conseguente impoverimento delle pensioni, se da una
parte le fasce medio-alte vedono rimanere stabili o migliorare
le proprie entrate, quelle basse risentono maggiormente la
crisi. Ma questi anni sono caratterizzati soprattutto
dall’esplosione del lavoro autonomo, tanto i freelance quanto
i parasubordinati (o Co.co.co435). Questa categoria presenta
434 Ibidem. 435 I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti
lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia
fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in
218
alcune caratteristiche affini ai dipendenti, ad esempio
l’invecchiamento: gli autonomi sotto i 30 anni sono passati
dal 12,2% del 2009 al 9,4% del 2012, mentre gli
ultracinquantenni sono passati dal 16,3% al 17,7%. Ma se la
situazione dei freelance mostra un pur lieve miglioramento, è
il lavoro parasubordinato a farsi carico degli elementi
maggiormente allarmanti, dove il 53,4% (5.260 posizioni)
non raggiunge i 5.000 euro annui, dato in crescita rispetto al
2011 (50,7%). La debolezza complessiva dei Co.co.co è
evidenziabile anche riportando un altro dato riguardante i
redditi più alti: solo l’1,8% dei parasubordinati (173) supera
i 50.000 euro annui, a differenza del 5,12 degli autonomi
(765) e del 39,6% dei subordinati (8.189).
Il quadro della situazione mostra come «l’asse della
professione si sta spostando dal giornalismo dipendente,
tutelato dai contratti e dalle leggi, dalla previdenza e
dall’assistenza sanitaria di categoria (Inpgi, Casagit436 e
Fondo di previdenza complementare), al lavoro autonomo,
alle collaborazioni coordinate e continuative, al lavoro dei
freelance437». La mancanza di tutela in cui scivola la
piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma
nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del
lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione
aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del
committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento
dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.
Fonte: Inps
(http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=5654&iMenu=1&iN
odo=5654&p1=2) 436 Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani. 437 Camporese A. (presidente Inpgi), Interventi efficaci e rapidi per
superare una crisi epocale in fnsi.it,
(http://www.fnsi.it/Download/RAPPORTO_LSDI_2012.pdf).
219
professione getta i giovani aspiranti in una giungla intricata
dove spesso vige la legge del ricatto. Sostiene ad esempio
Daniele Cerrato, presidente di Casagit, che «l'editoria italiana
è affollata da mestieranti di varia estrazione, per questo non
sempre possiamo attenderci […] persone dotate di una
professionalità definita. L' utilizzo disinvolto di ogni
spiraglio di risparmio offerto da Contratto e consuetudini fa
sì che cresca, ad esempio, il numero dei pubblicisti assunti
come praticanti e per i quali si realizzano risparmi, da parte
dell'editore, sui contributi da versare anche a Casagit438». Ed
è dello stesso avviso Enzo Jacopino, presidente dell’Ordine
dei Giornalisti: «Gli editori continuano a passare come una
schiacciasassi sopra alla vita di decine di migliaia di giovani
i quali, per di più, debbono periodicamente subire lezioni sul
loro stesso diritto di dirsi, essere o sperare di diventare
giornalisti439». Una volta delineato il contesto, rimane da
vedere cosa è stato fatto concretamente per risollevare le
condizioni di tanti precari e restituire qualche speranza ai
giovani che aspirano a diventare giornalisti. Qualcosa si è
mosso a cavallo tra 2011 e 2012, quando è stata approvata la
cosiddetta Carta di Firenze, entrata in vigore il 1° gennaio del
2012. Questa la premessa del documento redatto di comune
accordo dall’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi:
«Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del
lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale
argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica
attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente
precarizzazione lavorativa di intere fasce della
438 Ibidem. 439 Ibidem.
220
popolazione che, per periodi sempre più lunghi,
vengono costrette ai margini del sistema produttivo e
professionale, con pesanti ricadute economiche,
sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista,
infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per
lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli
effetti un cittadino serie B, che non può costruire il
proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo
del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito
dalla Costituzione440 […]. Un giornalista precarizzato,
poco pagato, con scarse prospettive e tavolta, per
carenza di risorse economiche, anche poco
professionalizzato, è un lavoratore facilmente
ricattabile e condizionabile […]441».
Secondo questa premessa, l’intento della Carta
deontologica di Firenze è quello di vigilare affinché sia
garantito un equo compenso a tutti i giornalisti e affinché
vengano bloccati lo sfruttamento e la precarietà. Per
raggiungere tale obiettivo la Carta di Firenze promuove la
costituzione di un “Osservatorio permanente sulle condizioni
440 «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese». Costituzione della Repubblica Italiana in
quirinale.it,
(http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzi
one.htm). 441 Carta di Firenze in odg.it
(http://www.odg.it/files/carta%20di%20firenze_def_0.pdf
).
221
professionali dei giornalisti” con il compito di vigilare
sull’effettiva applicazione della carta e segnalare condizioni
di sfruttamento professionali (articolo 3). In realtà, come
riporta Il Fatto Quotidiano, non si è andati oltre le buone
intenzioni: «perché, contrariamente al previsto, non è stato
istituito un osservatorio per vigilare sulle violazioni. E perché
l’Ordine non può muoversi d’ufficio. Si deve aspettare che
sia il singolo giornalista, sfruttato e ricattabile, a muoversi.
Alcune realtà regionali si stanno attivando per denunciare le
condizioni di sfruttamento dei collaboratori442». Discorso
simile quello riguardo alla legge sull’equo compenso. «La
schiavitù è abolita per legge443», dice la sezione dedicata al
precariato del sito dell’Ordine dei Giornalisti,
nell’annunciare l’approvazione della legge che potrebbe
contribuire alla fine dello sfruttamento di tanti giornalisti
autonomi: «è stata necessaria una norma, quella sull’equo
compenso, per creare condizioni che consentiranno di porre
fine allo sfruttamento selvaggio dei giornalisti. Giovani di
tante età, compensati con mancette per i loro articoli […].
Cinquanta centesimi per il web, due-tre-cinque euro per la
carta stampata, vessazioni senza fine444». Ma la legge
233/2012, entrata in vigore il 18 gennaio 2013, resta ancora
inapplicata in attesa dell’emanazione delle norme attuative.
Bisogna innanzitutto dire che la legge sull’equo compenso,
fondandosi sull’articolo 36 della Costituzione445, riconosce ai
442 Armano A., Un italiano su 550 è giornalista. Riformiamo l’Ordine? in
ilfattoquotidiano.it (cit.). 443 L’equo compenso è legge in precariato.odg.it, 5 dicembre 2012
(http://precariato.odg.it/lequo-compenso-%C3%A8-legge). 444 Ibidem. 445 «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
222
giornalisti lavoratori autonomi il diritto a un equo
compenso446. L’articolo 1 della 233/2012 definisce l’equo
compenso come «la corresponsione di una remunerazione
proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
tenendo conto della natura, del contenuto e delle
caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i
trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di
lavoro subordinato447». L’articolo 2 della legge invece
istituisce la “Commissione per la valutazione dell'equo
compenso nel lavoro giornalistico448” con il compito di
definire quantitativamente l’equo compenso e di redigere un
elenco di tutte le testate (anche online), le agenzie di stampa,
le emittenti che garantiscono l’equo compenso di cui sopra.
Come pena, invece, la legge nell’articolo 3 prevede per la
mancata iscrizione per un periodo superiore a sei mesi a
decadenza dal contributo pubblico in favore dell’editoria,
nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla
successiva iscrizione. Il proseguio della storia è facilmente
famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Costituzione della Repubblica
Italiana in quirinale.it, (cit.). 446 I dati del Rapporto di Lsdi mostrano come buona parte dei lavoratori
autonomi non godano di quanto garantito dall’articolo 36 della
Costituzione. 447 Legge 31 dicembre 2012, n. 233 in normattiva.it
(http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;233). 448 Composta da: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico; un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
giornalisti comparativamente più rappresentate sul piano nazionale; un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
committenti comparativamente più rappresentate sul piano nazionale nel
settore delle imprese; un rappresentante dell’Inpgi.
223
intuibile. Per entrare veramente in vigore la legge necessita
che venga prima stabilito esattamente l’ammontare dell’equo
compenso, poi che venga redatto l’elenco di cui sopra. Ma
questo non è ancora stato fatto. Come scrive Maurizio Bekar,
freelance, consigliere nazionale della Fnsi, membro e
coordinatore della Commissione nazionale lavoro autonomo
Fnsi, la Commissione «è stata insediata solo a metà giugno, e
i suoi lavori paiono ancora nella fase istruttoria.
L’impressione è che l’iter di questa legge, dopo una
contrastata gestazione parlamentare, preceda con il freno a
mano sempre tirato. Tanto che continuano ad emergere
opposizioni, distinguo e tentativi di sue interpretazioni
restrittive449». Ad oggi, tanto la Carta di Firenze quanto
l’equo compenso sono rimasti allo stato delle buone
intenzioni. Questi due provvedimenti sono tra i temi che sono
stati trattati agli Stati Generali dell’informazione precaria,
che si sono tenuti a Roma l’11 e il 12 luglio 2013, convocati
dalla Fnsi su proposta della Commissione e dall’Assemblea
nazionale lavoro autonomo Fnsi. Convocati con l’obiettivo di
porre fine allo sfruttamento della categoria e restituire dignità
e futuro alla professione, gli Stati Generali si sono svolti con
l’intento di porre le basi per una mobilitazione che coinvolga
tutti gli organismi coinvolti nel mondo giornalistico.
Andando ad esaminare nel dettaglio i temi trattati, oltre a
richiedere l’applicazione della legge sull’equo compenso450 e
449 Bekar M., Che fine ha fatto l’equo compenso per i giornalisti
freelance? in articolo21.org, 12 agosto 2013,
(http://www.articolo21.org/2013/08/che-fine-ha-fatto-lequo-compenso-
per-i-giornalisti-freelance/). 450 «L’applicazione della legge sull’Equo Compenso comporta la
soluzione di tre nodi cruciali: a) definizione dell’Equo Compenso; b)
tracciabilità del lavoro che rende possibile l’individuazione degli editori
224
della Carta di Firenze451, viene ritenuta imprescindibile la
contrattualizzazione delle varie forme di precariato.
«Occorre costruire con la contrattazione collettiva
un’impalcatura di regole e modalità di lavoro corrette
per ampliare il campo dei diritti e delle tutele per chi
non li ha e, allo stesso tempo,contrastare l’abuso
sempre più diffuso di forme di lavoro autonomo o
parasubordinato che dissimulano prestazioni di lavoro
dipendente. Più si rendono forti i processi di tutela e
di rappresentanza collettiva, inoltre, più diventa
esigibile la tutela individuale basata su regole
contrattuali riferite a un corretto utilizzo delle forme
di lavoro autonomo452».
Se è vero che qualcosa si sta muovendo, dall’altra parte
bisogna dire che il tutto è purtroppo ancorato allo stato delle
buone intenzioni, o poco più. L’obiettivo principale per tutte
virtuosi; c) i benefici da cui sono esclusi i soggetti che non rispettano
l’Equo Compenso». Stati generali dell'informazione precaria: i
documenti finali approvati (12 luglio 2013, Roma) in giornalistifreelance,
12 luglio 2013, (https://www.facebook.com/notes/giornalisti-freelance-
httpfreelance20ningcom/stati-generali-dellinformazione-precaria-i-
documenti-finali-approvati-12-luglio-/10151721772224904). 451 «Ferma restando la disponibilità a discutere proposte migliorative per
l’effettiva efficacia di questo strumento, con lo spirito di collaborazione
che deve contraddistinguere l’azione di tutti gli enti di categoria, è
necessario provvedere quanto prima alla formazione dell’Osservatorio
Nazionale previsto dalla Carta con la nomina di tutti i suoi componenti e
si auspica che analoghi osservatori vengano istituiti in ogni realtà
regionale». Ibidem. 452 Ibidem.
225
le parti in causa deve essere innanzitutto restituire dignità al
lavoro, che sembra aver completamente perso il suo valore.
«C’è chi viene pagato 2 euro per una notizia, se questa
però raggiunge almeno duemila visualizzazioni, cioè
viene cliccata sul sito almeno duemila volte. Ma se la
notizia è al di sotto delle 800 battute non viene pagata.
Il compenso scatta dalla 801esima riga in su. Al di
sotto il lavoro viene di fatto regalato all’editore. Se
invece si tratta di un “pezzo” vero e proprio, il
compenso può salire anche a 15 euro, sempre che
raggiunga le duemila visualizzazioni web. Altrimenti
non si vede una lira. Come se andassimo dal medico e
gli dicessimo: ti pago solo se mi guarisci453».
Questo è divenuto possibile come risultato di diverse
componenti. Tra queste c’è la compartecipazione tra il gioco
a ribasso degli editori e l’inquinamento del mercato da parte
di coloro che forniscono prestazioni giornalistiche gratuite.
«Gli editori, si sa, guardano al proprio tornaconto e
hanno capito che affidarsi al lavoro esterno in fondo
paga. Perché sanno di poter contare su degli “schiavi”
che sono per lo più presi dal sacro fuoco di vedere la
propria firma su un pezzo di carta. E l’Ordine dei
453 Ferrigolo A., “Due euro a pezzo”. Un’inchiesta sul
giornalismo precario in reset.it, 4 luglio 2013
(http://www.reset.it/caffe-europa/precari-nei-giornali-
uninchiesta).
226
giornalisti non è riuscito a fermare il fenomeno di quei
colleghi che facendo altri lavori forniscono anche
prestazioni giornalistiche gratuite. Gli editori sanno
che possono sempre contare su un esercito di riserva
di professionisti disposti a tutto e se ne
approfittano454».
Se lo sfruttamento e il precariato si sono trasformati in
consuetudine per chi fa parte dell’Ordine e possiede il
tesserino (professionista o pubblicista che sia), per coloro che
ne sono sprovvisti e aspirano a diventare giornalisti
ufficialmente riconosciuti, la situazione è perfino peggiore.
Trovare un’azienda dove svolgere – regolarmente retribuiti –
i 18 mesi di praticantato (necessari per diventare
professionisti) o i 24 mesi di esercizio dell’attività (necessari
invece per iscriversi nell’Albo dei pubblicisti) è impresa
tutt’altro che agevole. Su Internet esiste una costellazione di
siti che fanno informazione, ma molti di questi non sono
testate registrate essendo sprovvisti dell’elemento della
periodicità, quindi una eventuale collaborazione, anche se
pagata (una chimera), non rientrerebbe nei parametri richiesti
per l’iscrizione all’Albo. Tuttavia, pur imbattendosi in una
testata registrata diretta da un giornalista facente parte
dell’Ordine, la situazione risulterebbe tutt’altro che comoda.
In primo luogo perché trovare una collaborazione retribuita
risulta essere un esercizio paragonabile alla ricerca di un ago
in un pagliaio. Ma anche qualora si ottenesse un compenso
questo sarebbe comunque totalmente inadeguato perfino per
la semplice sopravvivenza mensile. Questo significa che nella
gran maggioranza dei casi i mesi richiesti dall’iter per poter
454 Ibidem.
227
svolgere l’esame di Stato possono essere affrontati – anche in
base al tempo da dedicare all’attività – solamente da persone
coperte economicamente, oppure da coloro che svolgono
contemporaneamente un altro lavoro. L’impervio sentiero
dell’aspirante giornalista è però minacciato da una
condizione intrinseca alla sua stessa situazione: il desiderio
di diventare professionista (o pubblicista che sia),
l’irrefrenabile brama di ottenere il tesserino. Come già
evidenziato quando si è parlato dell’inchiesta della Procura di
Napoli Onde Rotte, il fenomeno dell’emissione di fatture
false da poter poi presentare per sostenere l’esame di Stato
non è una rarità. Nel momento in cui l’editore non può e non
vuole offrire una retribuzione si passa all’offerta indecente.
Ovvero: tu lavori gratis, ma poi puoi diventare pubblicista. I
ricatti di tanti editori disonesti spesso sortiscono i loro effetti
su giovani dalle spalle troppo strette per rispedire la proposta
al mittente. Da una parte c’è la disperazione, dall’altra è ancor
più evidente lo smarrimento della dignità del lavoro. Nel
prossimo paragrafo si analizzerà quindi la realtà degli
aspiranti giornalisti, giovani sprovvisti di tesserino gettati
come carne da macello nel mercato delle collaborazioni, in
particolar modo online.
3.4 Gli aspiranti giornalisti e la Rete
Il tesserino da pubblicista rappresenta una sorta di sacro
Graal per tanti giovani desiderosi di affermarsi e disposti a
passar sopra a qualunque cosa pur di ottenerlo. Lo sanno bene
gli editori, altrettanto pronti a qualsiasi scorciatoia pur di
228
massimizzare le entrate e tagliare i costi. La
compartecipazione di questi due fattori, unita alla
moltiplicazione degli accessi generata da Internet, ha creato
un fenomeno divenuto preoccupantemente diffuso, che vede
il tesserino trasformarsi in arma di ricatto. Il risultato è che il
lavoro finisce con il perdere il proprio valore.
Avventurandosi per la Rete si può trovare di tutto:
collaborazioni a titolo gratuito, retribuzioni legate alle
visualizzazioni dell’articolo, addirittura l’ultima trovata
consiste nello scrivere dei pezzi in cambio di premi455. Il tutto
in bilico tra legalità ed illegalità, con quest’ultima che spesso
avanza nel silenzio generale. «Non sono rari, purtroppo, i casi
di giovani aspiranti giornalisti costretti da aziende truffaldine
a pagarsi da soli i contributi, falsificando documenti e
ricevute fiscali per dimostrare l’esistenza di un’attività
remunerata e poter ottenere così l’ambito tesserino456», scrive
la Repubblica degli Stagisti, che si interroga sulla possibilità
di arginare il fenomeno attraverso un innalzamento del livello
dei controlli. La realtà è che, in assenza di una denuncia
proveniente dalle parti coinvolte, è complicato smascherare
questa pratica. L’azione preventiva è resa vana dal momento
che gli Ordini vengono a conoscenza delle situazioni dei
singoli giovani solo nel momento in cui viene inoltrata la
domanda di iscrizione all’Albo, ma a quel punto pur
disponendo della documentazione fiscale è impossibile
455 www.italianosveglia.com, segue approfondimento nella seconda parte
della ricerca. 456 Curiat A., Disposti a tutto pur di diventare giornalisti pubblicisti:
anche a fingere di essere pagati. Ma gli Ordini non vigilano? In
repubblicadeglistagisti.it, 27 aprile 2010,
(www.repubblicadeglistagisti.it/article/articolo-finti-pubblicisti-
contromisure-ordini).
229
stabilire se la procedura si è svolta o meno nell’ambito della
legalità457. Spiega Gianni Rossetti, presidente dell’Ordine dei
Giornalisti delle Marche alla Repubblica degli Stagisti:
«Per l’iscrizione all’albo elenco pubblicisti bisogna
dimostrare una collaborazione “continuativa” e
“retribuita” relativa agli ultimi due anni. Per quanto
riguarda i compensi non è sufficiente la dichiarazione
del direttore o dell’editore, ma chiediamo una
documentazione certa, cioè il Dpr 600, che sarebbe il
modulo riepilogativo che ogni azienda manda
all’interessato per la denuncia dei redditi, oppure il
versamento della ritenuta d’acconto. Noi chiediamo la
documentazione certa dell’avvenuto pagamento e del
versamento della ritenuta d’acconto. Se poi il
collaboratore restituisce i soldi all’editore e paga lui
stesso la ritenuta d’acconto, noi non abbiamo
strumenti per verificarlo458».
L’Ordine si limita quindi a misure di controllo che paiono
insufficienti per arginare la deriva, come la presentazione da
parte del candidato di ricevute fiscali emesse a cadenza
regolare nel tempo. Nessun Ordine accetta infatti versamenti
sanatori biennali. Ad esempio Sergio Miravalle, presidente
dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, fa affidamento
sull’etica individuale, forse non sufficiente per combattere
457 «Le contromisure potrebbero essere legate all'attribuzione di un potere
ispettivo anche all'Ordine, come già avviene per l'Inpgi, ma questo può
avvenire soltanto con legge dello Stato. E nel progetto di riforma non pare
sia prevista un'eventualità del genere». Ibidem. 458 Ibidem.
230
questo fenomeno: «Invitiamo molti dei ragazzi che
presentano la domanda a parlarci di persona, per conoscerli,
sentire direttamente le loro testimonianze: la verità cartacea è
un conto, quella che emerge da un colloquio diretto è un altro.
E poi, ci auguriamo che l’etica media della categoria sia
migliorata e stia migliorando, e che non ci siano così tanti
direttori disposti a dichiarare il falso nei documenti ufficiali
presentati all’Ordine». Se gli editori sono colpevoli, non
esenti da colpe sono gli aspiranti giornalisti che accettano di
sottostare al ricatto decidendo, a conti fatti, di acquistare di
tasca propria il tesserino professionale. L’avvocato
Gianfranco Garancini, esperto di diritto giornalistico, è
categorico: «Gli aspiranti giornalisti sono correi e, in quanto
tali, teoricamente vanno incontro a pene di tipo economico e
detentivo. In pratica, poi, è difficile che si vada in prigione
per reati del genere, ma si può arrivare a sanzioni pecuniarie
molto elevate […]. Senza contare il fatto che la domanda da
pubblicisti è destinata ad essere respinta e, così, l’aspirante
giornalista vedrà vanificarsi due anni di lavoro non
riconosciuto.459». Al di là delle dinamiche legali, ancora più
mortificante è la disponibilità a svilire il proprio lavoro. E’
vero che la malattia del sistema e le poche soluzioni
alternative rappresentano un’attenuante, ma questa non può
che essere terribilmente parziale. La stessa Repubblica degli
Stagisti riporta due testimonianze interessanti a tal proposito,
che vale la pena riportare. La prima vede come protagonista
459 Curiat A., L'avvocato Gianfranco Garancini: «Chi falsifica la
documentazione pur di entrare nell'albo dei giornalisti pubblicisti
commette reati penali» in repubblicadeglistagisti.it, 27 aprile 2010,
(http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/intervista-avvocato-franco-
garancini-cosa-rischia-chi-falsifica-documentazione-iscrizione-albo-
giornalisti-pubblicisti).
231
Carlo (un nome fittizio), diventato pubblicista presso
l’Ordine regionale del Lazio dopo aver lavorato presso una
testata aziendale, cioè un giornale pubblicato da un’impresa
e incentrato prevalentemente su tematiche aziendali, di cui
non fa il nome. «La mia era di fatto una collaborazione a
distanza: scrivevo gli articoli da casa e non sono mai entrato
direttamente a contatto con l’editore. Diventare pubblicista
era per me il modo più semplice e meno oneroso per
conoscere un mestiere che mi affascinava fin dai tempi del
liceo. Avere il tesserino, poi, non mi avrebbe impedito di
svolgere altri lavori460», rivela Carlo alla Repubblica degli
Stagisti. Il tutto, ovviamente, non retribuito: «pezzi scritti e
non pagati, in barba alla legge, che parla di “attività
regolarmente retribuita”. Retribuzione ovviamente
certificata, dichiarando il falso, dall’editore nell’attestato
richiesto dall’Ordine per l’iscrizione all’albo. A completare
la documentazione, la ritenuta di acconto sui soldi che
teoricamente avrei dovuto ricevere461». Quel che colpisce
maggiormente della testimonianza di Carlo è che, nonostante
tutto, si ritiene un privilegiato. Poteva andare peggio, come
successo a tanti altri: «[…] ho avuto dei privilegi in più
rispetto a tanti colleghi: un rimborso spese per i miei
spostamenti e per alcuni acquisti […], il regolare pagamento
dei contributi. Posso assicurare che non è poco: diversi amici
e conoscenti hanno intrapreso l’attività giornalistica
460 Del Priore C., La testimonianza di Carlo: «Sono diventato pubblicista
scrivendo gratis: ma almeno le ritenute d’acconto me le hanno pagate»
in repubblicadeglistagisti.it, 27 aprile 2010,
(http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/testimonianza-carlo-
diventato-pubblicista-scrivendo-gratis-su-testata-giornalistica-
aziendale). 461 Ibidem.
232
completamente a spese loro. Che tradotto significa non solo
non essere pagati, ma anche versare i contributi di tasca
propria, altrimenti niente tesserino462». Beati monoculi in
terra caecorum463, si potrebbe dire. L’altra storia riportata
dalla Repubblica degli Stagisti vede come protagonista
Franca (altro nome fittizio), che fa parte dei meno fortunati
descritti da Carlo.
«Per diventare pubblicista, ho accettato di pagarmi da
sola i contributi scrivendo per un blog online con
incarichi da freelance ufficialmente retribuiti. In
realtà, il mio direttore mi rilascia le ritenute d’acconto
e io gli restituisco i soldi in contanti. Ovviamente non
ho nessuna retribuzione: di fatto, pago in tasse circa
160 euro ogni sei mesi e in più lavoro gratuitamente
per scrivere gli 80 articoli in 2 anni richiesti
dall’Ordine del Lazio464».
Franca è approdata a questo blog (di cui non viene fatto il
nome) dopo varie esperienze, tutte non retribuite, fatta
eccezione per uno stage per occuparsi della rassegna stampa;
ma anche lì è arrivata la crisi, i tagli del personale e il ritorno
della disoccupazione. Quasi nessun soldo guadagnato, ma
esperienza e contatti, dice Franca. Alla fine, per ottenere il
462 Ibidem. 463 Una locuzione latina traduciile come “Beati i monòcoli nel paese dei
ciechi”. 464 Curiat A., La testimonianza di Franca: «Dopo una serie di stage
logoranti, la scelta di pagarmi da sola i contributi da pubblicista» in
repubblicadeglistagisti.it, 27 aprile 2010,
(http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/testimonianza-pubblicista).
233
tesserino da pubblicista (definito come «un punto saldo,
un’ancora simbolica che voglio raggiungere come obiettivo
personale465»), ha accettato la proposta del direttore del sito:
«Per mantenere l’indipendenza del blog, ha rifiutato di avere
qualsiasi finanziamento e adesso se la deve cavare con le sue
forze. “Quindi, per la pratica da pubblicista non c’è problema,
purtroppo però non posso pagarti. Facciamo così: io ti faccio
le ritenute d’acconto, e tu mi dai i soldi per pagarle”. Cosa
avrei dovuto fare? Ho accettato466».
Al di là della disonestà di alcuni editori e della scarsa
tenacia di qualche aspirante giornalista, per bloccare questa
pericolosa deriva è necessaria una riforma in grado di
restituire dignità al lavoro ed evitare che si creino i
presupposti per il mettersi in moto di questa macchina. In
primo luogo togliendo dalle mani degli editori il potere di
ricattare le nuove leve. Questo può avvenire – escludendo le
costose scuole di giornalismo – solamente puntando
sull’università pubblica. Se non si vuole abolire l’Ordine dei
Giornalisti, quantomeno lo si aggiorni. Devono essere le
facoltà a sfornare i giornalisti, tramite corsi di studio nei quali
teoria e pratica abbiano eguale importanza. Insegnare il
mestiere nelle università, piuttosto che disperdere crediti in
una miriade di materie se non superflue, certo poco attinenti
e creare un collegamento diretto con il mondo del lavoro.
Privando gli editori del privilegio di decidere chi diventerà
giornalista e attraverso quale percorso, questi si troveranno
costretti a svolgere un ruolo di semplici datori di lavoro di
fronte ad un professionista già formato, che non avrebbe più
bisogno di inseguire ad ogni costo il tanto agognato tesserino.
465 Ibidem. 466 Ibidem.
234
Rimarrebbe la non meno gravosa questione della dignità del
lavoro e di un equo compenso che è merce sempre più rara.
Questa è un realtà più complessa, non limitata alla sola Italia.
Le collaborazioni a titolo gratuito rappresentano un
fenomeno sempre più comune, una malattia che Internet ha
senza dubbio aiutato a diffondere e che non riguarda, come si
potrebbe supporre, solamente le piccole realtà
imprenditoriali. Si è già visto che un colosso come
l’Huffington Post non paga neppure un centesimo i blogger
che hanno contribuito a renderlo uno dei portali più famosi al
mondo. Del resto, i siti vivono principalmente di pubblicità;
e gli spazi pubblicitari sono tanto più richiesti e costosi,
quanto più visitato è uno spazio: e i navigatori di Internet si
muovono tra un sito e l’altro alla ricerca di contenuti. Senza
questi non c’è traffico, non c’è pubblicità, non c’è di
conseguenza il sito. Il paradosso è quindi quello che coloro
che producono ricchezza (a seconda delle realtà,
naturalmente) sono gli stessi che non percepiscono nulla.
Rimane da capire perché così tante persone accettino di
scrivere gratuitamente. Buttar giù un articolo che sia ben fatto
e non un semplice “copia e incolla” richiede tempo e fatica,
conoscenza dell’argomento trattato e capacità espositive,
verifiche e organizzazione. In una parola: lavoro. Eppure il
lavoro sembra non valere più nulla. Specie sul Web, dove
richiedere un pagamento rispetto ad una prestazione appare
come una pretesa assurda. Ma al di là dei ricatti, delle
proposte indecenti dei datori di lavoro rimane un punto
cruciale: se nessuno accettasse di scrivere gratis, le aziende
sarebbero inevitabilmente costrette ad offrire qualcosa. E’
vero che questo già avviene, nella maggior parte dei casi con
proposte che insultano in egual maniera di quelle prive di
compenso. Perlomeno, però, non si leggerebbe più di editori
235
a tal punto certi di trovare il collaboratore sfruttato di turno
da offrire in cambio nulla. Zero. Perché così tante persone
accettano di scrivere gratis? Per ottenere illegalmente il
tesserino da pubblicista? Per passione467? Per il narcisimo di
vedere la propria firma in giro per il Web? Per ottenere
visibilità e farsi conoscere? Perché scrivere, per alcuni, non è
un lavoro ma un passatempo?
Oppure perché tutto questo è diventato consuetudine?
Normalità? Del resto, se l’Huffington Post può permettersi di
non pagare i propri collaboratori, perché lo dovrebbero fare
realtà ben più modeste del colosso americano? Ma è
allargando il campo dell’indagine che si può notare come il
fenomeno del lavoro non retribuito non sia esclusiva del solo
giornalismo (professionista o meno che sia, digitale o
cartaceo). Sembra trattarsi piuttosto di una creatura di
quest’epoca che ha precarizzato tanto il presente quanto il
futuro. Un’epoca che ha sradicato troppe fondamenta e che
mette nelle condizioni in cui la speranza di ottenere un
qualcosa domani fa sì che si accetti di avere poco o niente
oggi. Sia che si tratti di 50 centesimi per un articolo, sia che
si tratti di una semplice speranza. Un investimento per il
futuro. Come scrive l’antropologa Sarah Kendzior riferendosi
agli americani che vivono in quella che lei definisce post-
employment economy468, «they compete for the privilege of
467 Il lavoro non retribuito svilisce e toglie valore a qualsiasi passione,
specie se portato avanti per imprese con scopo di lucro. 468 «You live in the post-employment economy, where corporations have
decided not to pay people. Profits are still high. The money is still there.
But not for you». Ovvero, «Tu vivi nell’economia del dopo-impiego, dove
le società hanno deciso di non pagare le persone. I profitti sono ancora
alti. I soldi sono ancora lì. Ma non per te». Kendzior S., Surviving the
post-employment economy in aljazeera.com, 3 novembre 2013,
236
working without pay. They no longer earn money - they earn
the prospect of making money. They are paid in
"connections" and "exposure"469». E’ questo quello che si sta
verificando? Lavorare gratis viene visto come un passaggio
inevitabile nel tentativo di costruirsi una posizione? Nella
coscienza collettiva sembra essersi instillata la convinzione
che la crisi richieda dei grandi sacrifici, come lavorare senza
vedere un soldo. L’idea che bisogna adeguarsi alla situazione
contingente, stringere la cinghia, tirare avanti. Scrive ancora
Sarah Kendzior: «When survival is touted as an aspiration,
sacrifice becomes a virtue. But a hero is not a person who
suffers. A suffering person is a person who suffers. If you
suffer in the proper way - silently, or with proclaimed fealty
to institutions - then you are a hard worker "paying your
dues". If you suffer in a way that shows your pain, that breaks
your silence, then you are a complainer - and you are said to
deserve your fate470». Delineato in ogni suo aspetto il quadro
(http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/surviving-post-
employment-economy-201311373243740811.html). 469 «Loro competono per il privilegio di lavorare senza venire pagati. Non
guadagnano più soldi, guadagnano la prospettiva di fare soldi. Vengono
pagati in “agganci” e “visibilità”». Kendzior S., Managed expectations in
the post-employment economy in aljazeera.com, 12 marzo 2013
(http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/03/2013311164235608
86.html). 470 «Quando la sopravvivenza viene promossa come un’aspirazione, il
sacrificio diviene una virtù. Ma un eroe non è una persona che soffre. Una
persona che soffre è una persona che soffre. Se soffri in maniera adeguata
– silenziosamente, o con aperta fedeltà verso le istutuzioni – allora sei un
grande lavoratore che sta facendo quanto dovuto. Se soffri in modo tale
da mostrare il tuo dolore, questo spezza il tuo silenzio, diventi una persona
che si lamenta, ti viene detto che meriti il tuo destino». Kendzior S.,
Surviving the post-employment economy in aljazeera.com, 3 novembre
2013, (cit.).
237
di riferimento, è giunto il momento di passare alla seconda
parte di questa ricerca, che mira ad indagare il fenomeno
appena descritto.
239
4 Scrivere online: la ricerca
Questa sezione della tesi è frutto di un viaggio nella Rete,
alla ricerca di opportunità lavorative, collaborazioni,
possibilità di scrivere per testate registrate e non. Cosa offre
realmente il mondo del lavoro online? La figura di spicco è
quella dell’articolista. Il dizionario di Corriere.it lo definisce
semplicemente come autore di articoli di giornale471, ma la
realtà è differente. Come scrive Bruno Ugolini su L’Unità, gli
articolisti «sono migliaia di giovani donne e uomini che
vendono il loro lavoro intellettuale sul web per pochi miseri
euro472». Una figura «a metà tra il giornalista e l’operaio alla
catena di montaggio... Non ha sindacato né ordine di
appartenenza e nella scala gerarchica della professione
occupa il posto dopo l’ultimo perché l’ultimo è già troppo
affollato dai collaboratori473». All’articolista viene richiesta
la produzione di un numero di contenuti editoriali più alto
possibile nel minor tempo possibile. Il tutto di fronte ad
offerte economiche estramemente basse, dove spesso si
innesta un gioco a ribasso tra i diversi “pretendenti”. Oppure,
più semplicemente, la posta in palio è la visibilità,
l’oppurtunità di vedere la propria firma online, insomma
niente. Zero. La navigazione della Rete ha portato a scoprire
quattro tipi di offerte per coloro che desiderano scrivere
online: una retribuzione minima, il pagamento in base alle
471 http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/A/articolista.shtml. 472 Ugolini B., Articolisti nella giungla del web in unita.it, 11 ottobre
2010, (http://www.unita.it/commenti/brunougolini/articolisti-nella-
giungla-del-web-1.247709). 473 Ibidem.
240
visualizzazioni del pezzo, il pagamento attraverso premi o la
collaborazione totalmente gratuita.
4.1 Qualche centesimo ad articolo: chi offre di
meno?
Recita l’articolo 36 della Costituzione della Repubblica
Italiana: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa474». Ma non sempre è così; in particolar
modo su Internet. Vediamo cosa si trova inserendo su Google
la chiave di ricerca “articolista retribuito”, esplorando i
portali che raccolgono offerte di lavoro475 o visitando i forum
che si occupano nello specifico di compravendite di servizi
editoriali476. Il primo annuncio in cui mi sono imbattuto
recita: «[CERCO] Copywriter settore Immobiliare con reale
esperienza».
«Salve,
come da oggetto cerco copywriter CON
ESPERIENZA REALE nel settore immobiliare da
474 La Costituzione in senato.it
(http://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=36)
. 475 Kijiji.it, Indeed.com, InfoJobs.it, Bakeca.it, per citarne alcuni. 476 AlVerde.net, GiorgioTave.it.
241
selezionare per collaborazioni durature per la scrittura
di articoli nel settore sopracitato.
Il testo dovrà essere scritto in ottimo italiano e senza
errori. Gli articoli doranno essere discorsivi, con una
corretta impostazione (introduzione, corpo e
chiusura) e di piacevole lettura.
L'impegno potrà variare tra i 5 e i 20 articoli inediti al
mese di minimo 400 parole (numero di massima) e
saranno retribuiti 3 euro LORDO al pezzo.
Gli articoli dovranno essere consegnati in formato
word entro 72 ore dalla richiesta (esclusi festivi). Non
sarà richiesta alcuna formattazione né alcuna
competenza SEO, desideriamo soltanto articoli ben
scritti.
Gli articoli verranno verificati per qualità e per evitare
contenuti duplicati. Garantiamo e pretendiamo
massima professionalità.
La retribuzione verrà corrisposta mediante bonifico
bancario o paypal.
Per chi non fosse in possesso di partita iva la stessa
verrà corrisposta con ritenuta d’acconto o, nel caso di
professionisti con partita iva, richiederà il rilascio di
regolare fattura.
Per inviare la vostra candidatura potete contattarci all
seguente mail: […], indicando nell'oggetto "Risposta
annuncio [CERCO] Copywriter settore Immobiliare
con reale esperienza". Inviare inoltre minimo 3
articoli del settore Immobiliare (in formato word o
pubblicati sul web) e qualsiasi altra informazione si
ritiene utile.
242
Ringrazio per l'attenzione […]».
3 euro lordi ad articolo sono 2,40 euro netti, 60 centesimi
ogni 100 parole, neppure un centesimo a parola. Si supponga
per assurdo che per portare a termine un articolo di circa 400
parole basti un’ora, la retribuzione sarebbe di 2,40 euro l’ora.
In realtà, perlustrando la Rete, si nota piuttosto celermente
come un’offerta di questo tipo sia perfino più generosa della
media. Infatti, raramente la retribuzione di un articolo online
supera l’importo di un 1 euro.
«Ciao a tutti,
cerco articolista per il mio blog che tratta di seo,
wordpress, webmarketing, guadagno, web,
informatica ecc
chi fosse interessato puo contattarmi alla mail […]
il sito è stato aperto da poco, ma ho buone conoscenze
nel campo web e sono molto ottimista, per i compensi
quindi offrirò un minimo di 20 cent per articolo, la
paga crescerà ovviamente, al crescere del sito477».
«Cerco articolisti per le categorie:
- Apple
- Calcio
477 Il titolo dell’annuncio è « [CERCO] Articolista per blog
di tecnologia».
243
- Cinema
- Gossip
Minimo 300 parole. 10 Articoli al giorno per
categoria.
(Gli articolisti saranno valutati per una collaborazione
con maggiore retribuzione a lungo termine)
Retribuzione: 0,50 ( la stessa che prendo io per
scrivere ) Pagamento: Paypal […]478».
«Cerco articolisti esperti di calcio e calciomercato
disponibili a scrivere con continuità.
Si richiedono 3 articoli al giorno di 200/250 parole
ciascuno.
Retribuzione:
0.40€ per 200 parole
0.50€ per 250 parole
Richiesti 3 giorni di prova nei quali verrà valutata
serietà e qualità degli articoli redatti.
Info richieste: Nome, Cognome, Contatto Skype,
precedenti esperienze
[…]479».
478 Il titolo dell’annuncio è «[CERCO] articolisti categoria
Gossip - Cinema – Sport». 479 Il titolo dell’annuncio è «[CERCO] Articolista calcio».
244
«Cerco articolista calciomercato per BREVI NEWS
(100 parole indicativamente come MINIMO). Ho
bisogno di popolare la sezione del mio sito in
wordpress per il calciomercato di gennaio.
Indicativamente 10-15 news al giorno, budget di 100-
110 euro al mese (da vedere bene in privato).
Retribuzione a fine collaborazione (i miei feedback
sono una garanzia solida...).
SOLO GENTE AFFIDABILE E PUNTUALE, IN
GRADO DI SCRIVERE IN ITALIANO
CORRETTO.
Pagamento paypal.
Contatti qui sul forum, gradito contatto skype.
NO COMMENTI, grazie.
[…]480».
Il tenore di questi annunci – scelti casualmente in mezzo
ad una miriade di esempi pressoché identici – è uno dei
leitmotiv della compravendita di servizi editoriali su Internet.
Tuttavia, non tutte le offerte di lavoro presentano una
retribuzione chiara. Non di rado è possibile imbattersi in
annunci che mirano a creare una lotta al ribasso tra i candidati
per accaparrarsi la posizione. Non venendo indicato un
prezzo fisso per articolo – pur variabile in base alla lunghezza
480 Il titolo dell’annuncio è «[CERCO] ARTICOLISTA
CALCIO - Speciale calciomercato, 10 articoli al giorno».
10 news al giorno per 100 euro al mese corrispondono a
circa 30 centesimi ad articolo.
245
dello stesso – si chiede invece agli articolisti stessi di indicare
il proprio tariffario. Una sorta di asta rovesciata dove a
spuntarla è il peggiore offerente (o il migliore, a seconda dei
punti di vista).
«Cerco articolisti retribuiti per la realizzazione di
contenuti su vari argomenti.
Il pagamento avviene settimanalmente tramite paypal
o bonifico.
Gli articoli devono essere semplicemente inviati
tramite mail senza immagini.
Vengono fornite fonti e quindi non sono richieste
conoscenze particolarmente avanzate ma è importante
sapere scrivere bene.
Gli interessanti possono inviarmi una mail
all'indirizzo […] con le seguenti informazioni
-Retribuzione richiesta per articoli rispettivamente di
200 - 300 e 400 parole.
-Argomenti su cui si è scritto in passato e si è disposti
a scrivere.
-Eventuali link a lavori già pubblicati online.
-Informazioni sulla possibilità di fatturare.
Grazie481».
481 Il titolo dell’annuncio è «[CERCO] Articolisti retribuiti
vari argomenti».
246
«Come da titolo cerco un articolista per scrivere brevi
recensioni (auto e accessori), in un primo momento
saranno 10 da 300 parole circa.
Si prega di rispondere specificando il costo x articolo
e inserendo un link con una referenza o confermando
l'intenzione di effettuare un test (in caso negativo) non
retribuito.
Pagamento alla consegna tramite paypal482».
«Ciao a tutti,
stiamo ricercando articolisti che conoscano
perfettamente la lingua italiana e che siano disposti a
consegnare da 1 a 5 articoli al giorno.
E' importante per noi che la qualità sia al primo posto
e per questo vogliamo che siate voi a fare il prezzo per
ciascun articolo.
Chiediamo a tutti gli interessati di inviare una mail a
[…] indicando nel corpo del messaggio i seguenti
dati:
Nome:
Email:
Specizzato in: (inserire le aree in cui siete più esperti
- esempio. sport, musica, turismo, ecc)
Numero Articoli per giorno: (indicare quanti articoli
potete inviare al giorno)
482 «[CERCO] Articolista per settore auto e affini».
247
Prezzo 300 parole:
Prezzo 400 parole:
Prezzo 500 parole:
Link Articoli: (facoltativo - indicare le URL degli
articoli già realizzati o, in alternativa, allegare un
articolo già realizzato)
In relazione al budget che l'articolista ci richiede,
selezioneremo i migliori in ottica
tempistiche/qualità/quantità/prezzo.
Inviate pure le vostre candidature all'indirizzo e-mail
[…] includendo tutte le informazioni richieste483».
L’ultimo annuncio riportato è estremamente interessante.
La mancanza di una retribuzione chiara e la proposta che
viene fatta ai candidati di stabilire loro stessi il proprio
tariffario sono presentati come un mezzo attraverso cui
raggiungere un certo livello qualitativo, piuttosto che come
una mera gara al ribasso («E' importante per noi che la qualità
sia al primo posto e per questo vogliamo che siate voi a fare
il prezzo per ciascun articolo»).
Tra gli annunci che in linea teorica propongono un
compenso per il lavoro svolto, due hanno in particolar modo
attirato la mia curiosità. Il primo è il seguente, intitolato
«Articolisti per The Social Post» e pubblicato su kijiji.it:
483 Il titolo dell’annuncio è «[CERCO] Canditatura
Articolisti per Vari Temi - Fate voi il Prezzo!».
248
«La redazione di The Social Post è alla ricerca di
collaboratori che si occupino di redigere articoli
giornalistici, fotografi e video makers.
Le sezioni per le quali è richiesta la collaborazione
sono Cronaca, Politica, Cultura, Esteri e Sport.
Requisiti fondamentali dei candidati saranno:
- Ottima padronanza della lingua italiana
- Ottime capacità di scrittura
- Affidabilità
- Rispetto delle scadenze
Costituiranno titolo preferenziale nella selezione dei
candidati la conoscenza di tecniche SEO e utilizzo
piattaforma Wordpress.
Il candidato affronterà un periodo di prova di 2
settimane, durante il quale si potranno constatare
impegno e qualità. La collaborazione prevista per gli
articolisti comporterà la stesura di almeno 2 articoli a
settimana per la categoria prescelta. Per i fotografi e
video makers la collaborazione si concorderà in base
alle disponibilità fornite.
The Social Post offre ai candidati la possibilità di
effettuare la pratica giornalistica di 2 anni per
richiedere il tesserino da pubblicista.
Per candidarsi inviare una mail corredata di cv, lettera
di presentazione e autorizzazione al trattamento dei ai
sensi del D. lgs. 196/03 a […]».
249
Il sito in questione è impostato ricalcando il modello del
celebre Huffington Post, già ampiamente trattato in questa
ricerca, come è possibile evincere dalla figura 25.
(figura 25 – La prima pagina di The Social Post, il 21 dicembre
2013 alle 15:00)
Nell’annuncio non viene esplicitato nulla riguardo alla
retribuzione dei collaboratori, ma d’altro canto viene invece
sottolineato come «The Social Post offre ai candidati la
possibilità di effettuare la pratica giornalistica di 2 anni per
richiedere il tesserino da pubblicista». Questo significa, come
si è visto nelle pagine precedenti, che la collaborazione deve
essere necessariamente retribuita. Non è tutto, affinché
l’attività venga riconosciuta dall’Ordine, questa dev’essere
stata svolta presso una testata regolarmente registrata presso
il tribunale. Ma la realtà non è questa. Perlustrando il sito mi
sono infine imbattuto in una pagina chiamata “Staff”, dove è
250
possibile leggere quanto segue: «The Social Post è un blog
(Ha avviato le procedure per la registrazione della testata
giornalistica) e salvo eventuali accordi scritti o contratti di
cessione di copyright, la collaborazione a questo sito è da
considerarsi del tutto gratuita e non retribuita484». E’ evidente
come qualcosa non torni. Nell’annuncio viene esplicitato
come la collaborazione possa consentire all’articolista di
maturare i requisiti necessari all’ottenimento del tesserino da
pubblicista, ma sul sito si sottolinea invece come non sia
prevista una retribuzione. Inoltre, trattandosi di un blog e non
di una testata registrata, anche un eventuale compenso non
garantirebbe la possibilità di sostenere l’esame per diventare
pubblicista. I dubbi che sorgono in maniera legittima non
sono stati chiariti nonostante abbia tentato di mettermi in
contatto con il sito, dal momento che è stato impossibile
ricevere una risposta.
L’altro annuncio a cui si faceva riferimento è il seguente,
intitolato «Articolisti o Blogger da casa - 4/5 Articoli all'ora
140 parole» e anch’esso pubblicato su kijiji.it.
«LEGGERE BENE PER FAVORE ALTRIMENTI
VENITE CESTINATI
Newsgo è un nuovo progetto editoriale che sta
ricevendo un grande successo, attualmente abbiamo
una media accessi di quadi 6000 accessi (il sito è stato
creato il 10 ottobre).
484 http://www.thesocialpost.it/staff/.
251
Il progetto è quello di creare un punto di riferimento
per le aziende della provincia di roma offrendo
visibilità e tanti altri servizi.
Il progetto editoriale è frutto di uno studio e di un
lavoro che va avanti da oltre un anno, non riguarda
solo il sito di notizie ma anche una WEB-RADIO, una
WEB-TV e tanti altri servizi.
Chi cerchiamo:
- Conoscenza avanzata dei social network.
- Conoscenza di wordpress.
- Ottima velocità nel rielaborare gli articoli assegnati.
- Blogger che voglio instaurare una collaborazione
con il sito (scambio gratuito)
Si richiede una velocità di inseriemento di almeno 4/5
notizie all'ora (minimo 140 parole).
Le notizie NON DEVONO ESSERE COPIATE e
incollate, ma devono essere rielaborate.
Le notizie vengono fornite, quindi il candidato deve
andare sul link indicato e rielaborare l'articolo.
Il nostro obbiettivo è di trovare persone che ci
garantiscono 16/20 articoli per il par time e 32/40
articoli per il full time. Con una presenza costante
almeno di 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana
(orari e giorni a scelta).
Il nostro obbiettivo è di avere dalle 9 alle 13 almeno
due persone ogni ora. La nostra redazione ideale è
composta da un numero massimo di 10 elementi.
252
Come candidarsi (leggere bene):
- Inviare una lettera di presentazione mettendo in
evidenza esperienze passate in questo campo.
- Disponibilità durante la giornata e il tempo che
potete dedicare al progetto.
- Indicare una Gmail.
- Avere installato hangout nel vostro pc
I cv selezionati verranno radunati a gruppi di 5
persone dove verrà fatta un pò di formazione. Verrà
effettuata tramite hangout. La formazione consiste
nella linea editoriale e non a conoscenze informatiche.
Dopo una breve formazione online si simulerà quindi
2-3 giornate tipo di lavoro per vedere la bravura del
candidato. Il candidato lavorerà quindi da casa, con la
scelta dei suoi orari ideali
I colloqui inizieranno appena questo annuncio verrà
pubblicato, continuerà anche sabato e domenica (è un
quotidiano e ogni giorni ci sono notizie) a fare
colloqui e formazione. Le persone verranno testate
fino a Venerdì 22 Novembre
Sabato 23 novembre i candidati prescenti verranno
convocati (insieme agli altri componenti della
redazione) per una riunione a Fontenuova.
RETRIBUZIONE
Le persone che parteciperanno al progetto essendo la
testata registrata potranno prendere il tesserino da
giornalista.
253
Per scelta aziendale è stato scelto di non stabilire un
fisso mensile, questo non significa che le persone non
verranno pagate. Molto semplicemente a fine mese si
divide quanto guadagnato dal sito + i vari progetti e si
dividono i ricavi in base a chi ha fatto più articoli.
Quindi non c'è fisso mensile e gli articoli non vengono
pagati a pezzo anche perchè 140 parole non è un
articolo :-) Per me un articolo è almeno 500 parole.
Un altro motivo per cui non è stato scelto il fisso
mensile, perchè vogliamo persone che non si
accontentano di un fisso quando possono guadagnare
molto di più e contribuire alla crescita del Progetto.
Abbiamo preferito scrivere questa cosa nell'annuncio
per maggior chiarezza ed evitare di far perdere tempo
alle persone, capiamo che alcune persone
preferiscono avere una sicurezza sapere che a fine
mese guadagneranno quella cifra, ma questo tipo di
persone non è adatto al nostro progetto.
Sito web: http://newsgo.it».
Il sito richiede un impegno costante, 4 o 5 articoli ogni ora
e un minimo di 20 ore settimanali. Quando l’annuncio entra
nel merito della retribuzione del lavoro da svolgere,
subentrano alcune perplessità. Il primo punto poco chiaro è
legato al fatto che i collaboratori non riceveranno né un fisso
mensile né tantomeno un compenso per ogni singolo articolo.
L’annuncio parla in maniera piuttosto vaga di una divisione
degli introiti del sito in base al numero di pezzi pubblicati. La
motivazione è duplice: da una parte viene sottolineato come
il pagamento ad articolo non venga preso in considerazione
254
poiché la lunghezza minima richiesta dal sito – 140 parole –
non è sufficiente a garantire dignità al pezzo stesso (viene da
chiedersi – seguendo questa logica – perché si propongano
contenuti che per loro stessa natura non sono meritevoli
neppure di venire chiamati “articoli”); dall’altra parte si fa
leva sul desiderio dei collaboratori di non accontentarsi della
sicurezza offerta dal fisso mensile, quanto piuttosto di
aspirare a molto di più. Non si ha ovviamente alcun indizio
riguardo alle cifre in ballo, del resto un altro elemento cardine
del collaboratore ideale dovrebbe essere la sua devozione
verso la crescita del “Progetto”. C’è un altro passaggio
dell’annuncio che merita un approfondimento: «Le persone
che parteciperanno al progetto essendo la testata registrata
potranno prendere il tesserino da giornalista». Abbiamo già
ricordato in questo paragrafo i requisiti necessari per
l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. In primo luogo, la frase
appena riportata parla genericamente di “tesserino da
giornalista”, senza specificare qualora si tratti di quello da
professionista o di quello da pubblicista. Inoltre, una testata
online regolarmente registrata, come si presuppone essere
newsgo.it, dovrebbe, in accordo all’articolo 2 della legge
47/1948, mostrare degli elementi identificvativi quali il luogo
e la data della pubblicazione; il nome e il domicilio dello
stampatore; il nome del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile. Non è stato invece possibile reperire
queste informazioni navigando nel sito che si occupa di
riportare notizie legate al territorio di Roma e Provincia. Di
conseguenza, viene meno anche la certezza che newsgo.it sia
effettivamente una testata registrata, come invece sostiene
l’annuncio. Quel che invece è stato possibile evincere dalla
navigazione di newsgo.it è che il sito offre la possibilità a
chiunque lo desideri di vedere i propri articoli pubblicati
255
tramite la pratica del Guest post485 (figura 26). Il proprio
lavoro offerto in cambio di visibilità, una moneta che sul Web
sembra essere diventata valuta ufficiale.
(figura 26 – Il Guest post di newsgo.it)
485 «Un guest post è un articolo, un contenuto scritto da un blogger o un
copywriter che viene ospitato su un altro sito».
http://www.newsgo.it/collabora-con-noi-guest-post/
256
4.2 Pagamenti a visualizzazioni e Google
AdSense
La retribuzione del lavoro su Internet, seppur minima, non
è tuttavia così scontata. Una delle strategie preferite dagli
editori per diminuire i rischi di perdita è legata a quello che
si potrebbe definire un compenso vincolato. Ovvero,
l’articolo viene pagato solamente nel momento in cui la
pagina raggiunge un certo numero di visualizzazioni da parte
di utenti unici. Altrimenti il lavoro svolto dal collaboratore,
che in ogni caso genera un certo traffico e degli introiti
pubblicitari, non viene retribuito, trasformandosi in gentile
concessione al sito di turno. A tal proposito posso riportare
un’esperienza personale che si colloca perfettamente in
questa tipologia di situazioni. Nel 2011 ho collaborato per
alcuni mesi con una testata online regolarmente registrata
presso il tribunale. Il sito in questione si occupava – e si
occupa tuttora – di sport e mi avrebbe consentito, qualora
avessi lavorato in questa redazione per un periodo non
inferiore ai 24 mesi, di maturare i requisiti necessari per
sostenere l’esame di Stato per ottenere il tesserino da
pubblicista. La collaborazione era infatti regolarmente
retribuita e vincolata da contratto: 4 euro lordi ad articolo.
Una cifra che il sottoscritto riteneva sufficientemente
dignitosa in relazione al lavoro svolto e al tempo che
effettivamente richiedeva. Un giorno, senza alcun preavviso,
ricevetti una email nella quale si faceva presente la necessità
di firmare un nuovo contratto che avrebbe stravolto gli
accordi precedentemente raggiunti in virtù dell’intenzione di
ridurre dei costi gestionali. Secondo il nuovo contratto gli
257
articoli avrebbero previsto un compenso solamente nel
momento in cui avessero raggiunto un certo numero di
visualizzazioni, 300 per l’esattezza. Una cifra non
esorbitante, ma certo non scontata per una piccola realtà come
quella per la quale collaboravo. Posto di fronte ad un bivio,
scelsi di non accettare il nuovo accordo e abbandonai quella
che a distanza di anni rimane la migliore opportunità in
ambito giornalistico che ho avuto modo di trovare. La
motivazione è piuttosto elementare: raggiungere il numero di
visualizzazioni richiesto dal nuovo contratto non sarebbe
stato impossibile, ma la mia ferma opposizione era legata
all’idea di dovere, anche fosse successo una sola volta, cedere
il mio lavoro in forma gratuita.
Un’altra forma di retribuzione simile al compenso
vincolato è quella di Google AdSense, sistema che ha
riscosso e continua a riscuotere un enorme successo tra gli
editori. Di cosa si tratta? «Google AdSense è un programma
gratuito che consente ai publisher online di guadagnare dalla
visualizzazione di annunci pertinenti in una vasta quantità di
contenuti online486». In altre parole, questa funzione dà la
possibilità di pubblicare annunci pubblicitari sul proprio sito
Web e di guadagnare dalle entrate pubblicitarie da essi
generate, derivanti tanto dal numero delle esposizioni
(impression), quanto dal numero di click. «Il rapporto tra
click sui banner/annunci e le impression degli annunci è
espresso in percentuale ed è chiamato CTR della pagina 486 Adsense in google.com,
(https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adsense&rm=hide&
nui=15&alwf=true&emr=1<mpl=adsense&passive=true&continue=htt
ps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fadsense%2Fgaiaauth2%3Fhl%3
Dit&followup=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fadsense%2Fga
iaauth2%3Fhl%3Dit&hl=it).
258
(Click Through Rate). In base al CTR, AdSense calcola l'RPM
della pagina ovvero l'efficacia degli annunci (costo per mille
impression), ossia il ricavo che l'utente ottiene ogni 1000
visite della pagina487». Naturalmente, così come è possibile
pubblicare l’annuncio pubblicitario sul proprio sito, allo
stesso modo il banner può essere posizionato altrove previa
la concessione dello spazio. E’ esattamente questo che viene
offerto da molti editori: viene data la possibilità di inserire il
proprio annuncio pubblicitario sulla pagina dell’articolo e di
guadagnare tramite il Click Through Rate del banner. In altre
parole, qualsiasi ricavo non viene elargito dall’editore, ma da
Google stesso, azzerando in questo modo tanto la percentuale
di rischio quanto i costi della manodopera del sito. Annunci
di lavoro che offrono di guadagnare tramite Google AdSense
sono tra i più comuni su Internet, eccone alcuni esempi.
«Sto cercando degli aspiranti blogger per la creazione
di un sito internet. Gli argomenti trattati verranno
decisi in seguito.
Il candidato dovrà scrivere 1 articolo al giorno (5 a
settimana) di lunghezza variabile (in base
all'argomento) per garantire un numero molto alto di
pubblicazioni sulla piattaforma.
Il sito verrà creato e ottimizzato per i motori di ricerca.
Spiegherò come è meglio scrivere un articolo per
ottenere una maggiore indicizzazione e entrare tra i
migliori risultati di google.
Proponete gli argomenti.
487 AdSense in wikipedia.org, (http://it.wikipedia.org/wiki/AdSense).
259
I pagamenti saranno adeguati al traffico generato dal
sito e direttamente corrisposti da google adsense
(banner pubblicitari).
Sul sito verrà inserito anche un mio banner
Contattatemi per maggiori informazioni488».
«Nota testata giornalistica online ricerca un articolista
dalla conoscenza poliedrica e dalla grande velocità di
lettura e di scrittura di notizie.
NON è necessaria essere laureati MA è indispensabile
soddisfare i requisiti sopracitati.
Il candidato ideale dovrà visitare costantemente le
principali fonti d'informazione (tgcom mediaset,
eurosport yahoo, ansa, adnkronos, games.it, la
repubblica, etc.), leggere velocemente le notizie che
sembrano più interessanti per il grande pubblico, e
riscriverle sotto forma di articoli di una lunghezza di
almeno 500 parole.
Si richiedono almeno 500 articoli al mese, ossia
almeno 100 articoli al mese per ognuna di queste
tematica: sport, spettacolo, economia, informatica,
politica.
Si richiede di NON pubblicare più di 30 articoli al
giorno al fine di non abbassare la qualità.
Non si tratta di copia/incolla di articoli altrui, ma di
scrivere in parole diverse gli stessi concetti.
488 Il titolo dell’annuncio è «Blogger/Articolista».
260
La grande utilità della figura che ricerchiamo è quella
di riscrivere solo le notizie veramente più ricercate dal
grande pubblico e quindi di fare già per i lettori
un'operazione di selezione e rewriting.
Il guadagno dell'articolista che ricerchiamo sarà
direttamente proporzionale all'audience che
riceveranno i suoi articoli.
L'articolista deve avere o un suo blog e/o un account
Adsense attivo.
Non è necessario conoscere i codici informatici, ma
conoscere il linguaggio html costituisce un requisito
preferenziale.
Non vogliamo risposte generaliste e copia/incolla
utilizzati per rispondere a vari annunci o dei "vorrei
più info", ma vogliamo una specifica risposta alla
nostra inserzione.
È previsto un periodo di prova di 7gg non retribuito
ed un immediato inizio collaborazione se gli articoli
in questi giorni inviati saranno pubblicati. Durante il
periodo di prova dovranno essere inviati (usando il
modello html base da noi fornito) almeno 2 articoli al
giorno per ognuno delle 5 sezioni tematiche
sopracitate. Questi verranno attentamente letti e nel
caso pubblicati.
Se la prova verrà superata, l'articolista pubblicherà da
solo i suoi articoli.
Tali articoli non dovranno mai essere pubblicati su
altre fonti d'informazione (di qualunque formato
siano) e dal momento della pubblicazione diverranno
proprietà della nostra testata giornalistica.
261
Non si millantano facili guadagni. Si tratta di un vero
lavoro meritocratico ove chi ha le qualità può
guadagnare davvero bene489».
«Prestigioso Giornale Online (regolarmente iscritto al
Tribunale) ricerca articolisti che scrivano OGNI
giorno per il settore INFORMATICA.
Tale sezione consiste nelle categorie: Cellulari,
Games, Web, Motori di Ricerca, PC e Informatica,
Adsl, etc..
Il lavoro si può svolgere da casa e NON ci sono
vincoli di orario.
Non è necessaria la laurea o essere Giornalisti, ma
richiediamo GRANDE entusiasmo e NO perditempo.
L'offerta è rivolta in particolar modo a giovani ed a
studenti universitari; a blogger che con i loro siti non
hanno abbastanza visibilità; ad amanti della scrittura
e del settore informatico.
Requisiti Indispensabili:
a) essere maggiorenni;
b) ENORME volontà di crescita da piccoli ad elevati
guadagni meritocratici;
c) saper scrivere in italiano corretto.
489 Il titolo dell’annuncio è «Articolista/Rewriter per
Giornale Online».
262
Requisiti Preferenziali (non indispensabili
inizialmente):
a) Avere già un account Google Adsense e
conoscenza del suo regolamento (in mancanza di tale
account, avere un proprio blog/sito);
b) Avere Conoscenza delle keyword e delle tecniche
di indicizzazione degli articoli nei motori di ricerca;
c) Grande velocità ed amore per la scrittura;
d) Ottima conoscenza degli editor Joomla e
Wordpress.
Ricerchiamo articolisti veramente motivati e SERI in
quanto questo non è un annuncio di SPAM ma una
vera opportunità di lavoro da sfruttare in piena
autonomia.
Ai sensi della Legge n. 903/77 e della Legge. n. e
125/91, tale offerta di lavoro si intende estesa ad
entrambi i sessi490».
Internet concede l’opportunità agli utenti di trasformarsi
piuttosto agevolmente in piccola editoria, d’altra parte il
budget a disposizione è spesso molto esiguo, con la
consegenza che l’obiettivo principale diventa quello di
abbattere qualsiasi spesa laddove è possibile farlo. In questo
senso Google AdSense rappresenta l’opzione più fruttuosa
per i gestori di un sito, i quali scaricano sul singolo
490 Il titolo dell’annuncio è «Articolisti di INFORMATICA
per Giornale Online».
263
collaboratore ogni rischio imprenditoriale e su Google
l’onere della retribuzione.
4.3 Vinci un contratto di collaborazione: “il
giornalismo del futuro” secondo Italiano Sveglia
L’ultima idea partorita dalla Rete è quella di Italiano
Sveglia, un sito che fa parte di un network formato da altri 9
blog di informazione491. Come viene chiaramente esplicitato,
non si tratta di una testata registrata, ma di un semplice blog.
La creatura è figlia di Alberto Nardella, responsabile della
ProgrammaWeb di San Marco in Lamis (Foggia), l’azienda
che gestisce il network di 10 blog. La novità proposta dal sito
è rappresentata dal sistema di retribuzione concepito: gli
articolisti non ricevono alcun compenso, ma possono
accumulare dei punti scrivendo dei pezzi per il blog. Una
volta raggiunti 20000 punti si ottiene un contratto di
collaborazione a progetto. Recita quello che potrebbe essere
definito il “manifesto” di Italiano Sveglia:
«Sei un appassionato di scrittura e ti piacerebbe
approfondire temi di attualità ma non trovi spazio per
le tue idee? Oppure sei semplicemente interessato a
ciò che ti succede intorno e vorresti cimentarti nella
redazione di un articolo? Questo è il posto giusto per
te, ItalianoSveglia.com ti offre la straordinaria
491 Blog Italiano, Blog Notizie, Giornale di Oggi, Informarsi, Italia Blog,
Leggendo, Notiziario Italiano, Notizie Blog, Notizie di oggi.
264
possibilità di mettere a disposizione
dell’informazione sul web la tua capacità critica e di
scrittura.
Su ItalianoSveglia.com, dopo esserti registrato, potrai
attingere ad un bacino di news da cui potrai prendere
spunto per sviluppare un testo originale e inedito. In
questo modo potrai così fornire il tuo punto di vista
sul tema in questione e ripercorrere le vicende di
attualità con spirito di analisi e in modo totalmente
libero.
Saranno accettati solo articoli conformi a quanto
previsto da Termini e condizioni.
Grazie ad Italiano Sveglia, potrai sia avere la
possibilità di scrivere e pubblicare articoli sul web, sia
guadagnare crediti per ogni pezzo pubblicato. Una
volta raggiunti i 20000 punti potrai ottenere un
contratto di collaborazione a progetto per la redazione
di articoli sul network Italiano Sveglia. Insomma,
potrai dare sfogo alla tua passione per la scrittura e
allo stesso tempo guadagnare, dando al mondo
dell’informazione il tuo contributo personale.
Cosa aspetti, registrati e inizia subito a scrivere!492».
Qual è il meccanismo del blog? Semplice: ogni articolo –
minimo 500 parole – inviato dagli utenti, in seguito
all’approvazione dell’amministrazione del sito, fa
492 Premiati Scrivendo in italianosveglia.com,
(http://www.italianosveglia.com/Premiati+Scrivendo-a-
5.html).
265
guadagnare 10 punti493, si ottiene inoltre 1 punto per ogni
commento ricevuto. Di conseguenza, 2000 articoli al netto
dei commenti consentono di sottoscrivere un contratto con
Italiano Sveglia. In realtà, il blog era nato seguendo altre
logiche, come testimoniano alcuni articoli reperiti online.
Esisteva un vero e proprio catalogo di premi494 dove
figuravano spazzolini elettrici, spremiagrumi, macchine
fotografiche, smartphone, console, televisori e molto altro.
Tutti questi premi sono stati soppressi, fatta eccezione per il
contratto di collaborazione, che ha però visto raddoppiare la
propria soglia di punti passando da 10000 a 20000. Un
articolo de Linkiesta495 del 25 luglio 2013 calcolava come un
articolo pubblicato su Italiano Sveglia valesse grossomodo 2
euro: uno spazzolino elettrico, il premio più modesto, valeva
100 punti, quindi 10 articoli ed il suo costo online era di 19,15
euro, spedizione inclusa. «Di fatto noi premiamo chi scrive
mentre tantissimi giornali ti fanno scrivere e non pagano.
Anzi, me lo dica lei se c’è qualcuno che paga, che gli mando
un po’ di gente!496», sosteneva il responsabile Alberto
Nardella nel luglio del 2013. Aggiungendo: «Finora i nostri
utenti sono arrivati a vincere degli spazzolini, ma se vanno
avanti così farò fatica a dare tutti i premi. Insomma, a partire
da settembre potrei aver bisogno di sponsor, perché brutte
493 «L’articolo verrà pubblicato su tutti i 10 blog informativi appartenenti
al network ItalianoSveglia.com, ma verranno riconosciuti all’utente 10
crediti complessivi», ibidem. 494 La pagina esiste ancora
(http://www.italianosveglia.com/catalogo_premi.html), ma non è
presente un collegamento diretto all’interno del sito, né alcuna menzione
nel regolamento o in qualsiasi altra pagina del blog. 495 Trevisani A., “Se scrivi tanti articoli ti regaliamo uno spazzolino” in
linkiesta.it, 25 luglio 2013 (http://www.linkiesta.it/italiano-sveglia). 496 Ibidem.
266
figure non ne voglio fare…497». Tuttavia, proprio l’intervista
rilasciata da Nardella a Linkiesta ha costretto il sito a rivedere
i propri piani. Alessandro Trevisani, autore del pezzo, aveva
infatti avvisato il numero uno di Italiano Sveglia che il
presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Enzo
Iacopino, aveva iniziato a vigilare sull’attività del blog498. La
reazione di Nardella, arrivata tramite un post del 3 settembre
2013, è stata la sospensione della raccolta punti: «Carissimi
utenti, la redazione di Italiano Sveglia comunica con
rammarico che, da questo momento, non potremo più
accettare articoli e commenti da parte di utenti registrati e, di
conseguenza, assegnare punti e premi499». Meglio arrendersi,
piuttosto che iniziare una guerra contro l’Ordine dei
Giornalisti, l’opinione del blog: «il progetto Italiano Sveglia
ha deciso di tutelarsi e di tutelare soprattutto il titolare
dell'azienda che lo gestisce per evitare ripercussioni sulla sua
persona fisica e la sua attività imprenditoriale. Entrare in
meccanismi che portano a scontri con realtà come quella
dell'Ordine dei Giornalisti, casta che esiste solo in Italia e
sappiamo tutti perché, non conviene perché significherebbe
497 Ibidem. 498 «Il lavoro va retribuito. Inoltre la materia dei concorsi a premi è
disciplinata da una legge specifica (per creare un concorso ne va data
notizia ai ministeri dell’Economia e delle attività produttive, ndr), mi
auguro per lui che lo abbia fatto… Infine sarei curioso di capire se nella
vicenda sono coinvolti dei giornalisti», Ibidem. 499 Comunicato a tutti gli utenti di Italiano Sveglia: sospensione della
redazione di articoli e raccolta punti in italianosveglia.com, 3 settembre
2013,
(http://www.italianosveglia.com/comunicato_a_tutti_gli_utenti_di_italia
no_sveglia__sospensione_della_redazione_di_articoli_e_raccolta_punti-
b-29616.html).
267
andare oltre le nostra capacità500». La chiosa, invece, lasciava
dubbi sul proseguimento del progetto: «valuteremo come
riproporre la possibilità a tutti voi di partecipare con i vostri
contributi, per realizzare un'informazione libera.
Diversamente, come spesso succede in Italia, saremo costretti
a riproporre la nostra idea altrove, fuori dalle frontiere italiane
chiuse e bigotte501». Ipotesi, quella estera, che era già stata
avanzata nell’intervista per Linkiesta502. Invece, piuttosto che
chiudere i battenti, salutare l’Italia e provare l’avventura fuori
dai confini nazionali, Italiano Sveglia ha modificato il
proprio modello riproponendelo in una versione più asciutta:
niente più premi, ma solamente la possibilità di ottenere un
contratto a progetto. Ma prima di raggiungere l’agognata
soglia dei 20000 punti, tanti articoli non retribuiti, come da
prassi dell’editoria online. E’ forse lecito domandarsi se la
data del comunicato in cui è stata annunciata la sospensione
del sistema dei premi (3 settembre 2013), sia solamente una
coincidenza rispetto all’affermazione di Nardella
nell’intervista per Linkiesta: «Finora i nostri utenti sono
arrivati a vincere degli spazzolini, ma se vanno avanti così
farò fatica a dare tutti i premi. Insomma, a partire da
settembre potrei aver bisogno di sponsor, perché brutte figure
non ne voglio fare…503». Nessuna brutta figura, invece: il sito
è ancora attivo e un utente, pubblicando un paio di articoli al
500 Ibidem. 501 Ibidem. 502 «Da quanto capisco, le innovazioni in Italia sono viste male, perciò è
logico che poi la gente se ne va all’estero… Ed è quello che farò anch’io:
al primo attacco che subisco me ne vado all’estero con la mia famiglia,
poi voi vi riempite di immigrati…». Trevisani A., “Se scrivi tanti articoli
ti regaliamo uno spazzolino” in linkiesta.it, 25 luglio 2013 (cit.) 503 Ibidem.
268
giorno per due anni, può ancora ottenere un contratto di
collaborazione a progetto di 6 mesi per la redazione di articoli
sul network Italiano Sveglia. Premiarsi scrivendo è ancora
possibile (figura 27).
(figura 27 – il banner di Italiano Sveglia)
269
4.4 Scrivere gratis: il giornalismo online non
retribuito
Esiste infine un’ultima forma di collaborazione che non
prevede alcun tipo di compenso. Scrivere gratuitamente su
Internet è un fenomeno in continua espansione che coinvolge
tanto la piccola quanto la grande editoria online504, tanto i
blog quanto le testate regolarmente registrate. Inoltre, al
contrario di come si potrebbe credere, non si tratta – lo si
vedrà più avanti – di una situazione unicamente italiana, ma
di un virus diffuso su scala internazionale. La navigazione
della Rete ha consentito di trovare diversi annunci di lavoro
che condividono caratteristiche comuni sia per quanto
concerne le richieste, sia per quanto riguarda invece ciò che
viene proposto in cambio. Per giustificare la mancanza di una
retribuzione, le aziende molto spesso enfatizzano la natura
primordiale del blog o della testata di turno, promettendo un
eventuale compenso futuro vincolato alla crescita del sito.
«Blog emergente attivo a livello nazionale da oltre 4
anni, con un buon numero di visite cerca
collaborazione per la stesura degli articoli da
pubblicare.
Il candidato ideale dovrà visitare costantemente le
principali fonti d'informazione (tgcom mediaset,
eurosport yahoo, ansa, adnkronos, games.it, la
repubblica, etc.), leggere velocemente le notizie che
sembrano più interessanti per il grande pubblico, e
504 Si pensi al caso citato dell’Huffington Post.
270
riscriverle sotto forma di articoli di una lunghezza di
almeno 300 parole
Al momento sono particolarmente interessanti le
seguenti tematiche:
sport (calcio e altri sport)
spettacolo
videogiochi
Moda
Salute e bellezza
Non si tratta di copia/incolla di articoli altrui, ma di
scrivere i testi in modo originale mantenendo gli stessi
concetti.
Inizialmente NON è prevista retribuzione. In base alla
crescita del blog con conseguenti introiti, all'impegno
dell'articolista sarà valutato un futuro compenso fisso.
Proprio per questo non si richiede impegno costante
(circa 4/5 articoli a settimana se possibile) ma è
richiesta la massima serietà.
Se interessati, dovrete inviare un articolo di prova ed
effettuare periodo di valutazione di sette giorni per di
entrare a far parte dello staff505».
«Un Ambizioso progetto per giovani che vogliono
dare voce alla propria "mano".
505 Il titolo dell’annuncio è «Articolisti e collaboratori per
blog di notizie».
271
L'offerta consiste nell'offrire a giovani aspiranti
giornalisti anche senza esperienza, l'opportunità di
cimentarsi nel ruolo di redattore, con la massima
flessibilità.
Il nostro network si occupa di:
-Mondo Mobile ( Android, Tablet, ecc)
-Apple (iPhone,iPad, Mac ..)
-Calcio
Inizialmente il lavoro non sarà retribuito, ma se
riusciamo a trovare un buon numero di collaboratori
che ci permettono di andare avanti riusciremo presto
a retribuire tutti i collaboratori506».
In questi casi la promessa di un compenso futuro assume
caratteri aleatori. Non vengono mai esplicitate chiaramente
né la condizione che deve essere raggiunta affinché la
collaborazione muti da gratuita a retribuita, né l’ammontare
dell’ipotetico compenso di cui sopra. In questi termini la
strategia delle aziende sembra principalmente atta a non
scoraggiare eccessivamente quei collaboratori meno propensi
a lavorare senza venire retribuiti. Altre offerte di lavoro non
prevedono neppure quest’orizzonte di speranza. La moneta
con cui gli editori intendono pagare il lavoro svolto dal
blogger, l’articolista, l’aspirante giornalista di turno si chiama
visibilità. Scrivere per farsi conoscere, per far circolare il
506 Il titolo dell’annuncio è «Redattore, blogger , aspirante
giornalista, articolista».
272
proprio nome nei circuiti della Rete e riuscire in un futuro a
migliorare qualitativamente la propria posizione.
«TGC, nuovo portale che tratta di Street Style, Urban
Fashion e Made in Italy cerca collaboratori articolisti
capaci di scrivere articoli sul tema "sneakers".
Al momento non è prevista retribuzione, ma offriamo
visibilità ed esperienza.
Contattateci per ulteriori informazioni507».
«Ciao, se ti piace scrivere ma non hai la possibilità di
pubblicare i tuoi articoli potresti collaborare con noi
inserendo i tuoi articoli nel blog del nostro portale di
prenotazione turistica in Puglia.
Non abbiamo la possibilità di riconoscerti un
compenso, avrai comunque la visibilità dei tuoi
articoli firmati sul blog del portale.
Gli argomenti sono vari: la Puglia, il Salento, un
evento o manifestazione, ecc. quello che ti viene in
mente!
Grazie in anticipo per l'interesse508».
507 Il titolo dell’annuncio è «Articolista blog Urban
Fashion». 508 Il titolo dell’annuncio è «Articolista collaborazione
gratuita».
273
«Cercasi Articolista per blog di Grafica avviato da
poco. Vi porterà via poco tempo (1/2 articoli a
settimana) e in più avrete la possibilità di farvi
conoscere (ogni articolo avrà la vostra firma).
Il blog in questione è: GraficAzzardo.it.
Per qualsiasi altra informazione non esitate a
contattarmi!
[…]509».
«Ciao a tutti.
Cerchiamo articolisti per Prima Pagina on line,
giornale gratuito con un'unica pagina, la prima
appunto. Il giornale esce dal lunedì al venerdì tranne i
weekend. Gli articoli sono sintetici ma essenziali. Le
comunicazioni con la redazione avvengono tramite
mail e social network. Al momento non sono previsti
compensi poiché non ci sono rientri economici. La
testata è iscritta al tribunale di Bologna. Vi offriamo
la possibilità di fare un'esperienza costante nonché la
possibilità di essere letti da circa 700 persone al
giorno.
Le sezioni del nostro giornale sono: attualità, cultura
e spettacolo, moda, sport, cinema, scienza e
tecnologia.
Per altre informazioni, non esitate a contattarci
[…]510».
509 Il titolo dell’annuncio è «Articolista Blog Grafica». 510 Il titolo dell’annuncio è «Articolisti per Prima Pagina on
line».
274
Come è stato precedentemente visto esaminando il caso
dei blogger dell’Huffington Post, la visibilità è considerata un
compenso di valore non solo nell’ambito della piccola
editoria, ma anche per quanto concerne colossi come il sito
americano. Potrebbe risultare un esercizio banale sottolineare
come la visibilità non consenta né di pagare un affitto, né
tantomeno di fare la spesa in un supermercato. A fronte di
offerte non irrinunciabili, le richieste degli editori risultano
spesso tutt’altro che modeste. Serietà, puntualità, esperienza,
conoscenza di una lingua straniera, conoscenze delle
tematiche trattate, titoli di studio, disponibilità in determinate
fasce orarie e garanzia di un certo numero di articoli tra i vari
requisiti che le aziende richiedono.
«Stage gratuito e volontario:
L'offerta è indirizzata ad operatori culturali o grandi
appassionati della Canzone italiana d'autore, Jazz,
Blues, R&B.
Profilo della candidata/o ideale:
1) Articolista
2) Videoreporter al femminile
* Curiosità Intellettuale
* Residente a Roma
* Età superiore ai 23 anni
* Ottima capacità espositive
275
* Corretto uso dei sistemi informatici
* Cultura musicale e generale.
* Minima esperienza come articolista.
* Telegenia e dizione italiana corretta (prof.2)
* Conoscenza video/foto
* Gradita fotovideocamera (prof.2)
Verranno valutati soltanto i Cv inviati attraverso la
sezione WORK del nostro sito vivalaradio.fm
Le candidature provenienti dalle altri comuni e prive
dei requisiti richiesti verranno cestinate.
Astenersi soliti perditempo, assoluta serietà511».
«Social Media Life, magazine online specializzato su
tematiche legate ai Social Network, è alla ricerca di
nuovi collaboratori. Nello specifico stiamo valutando
profili di Web Copywriter e Blogger per la redazione
di articoli relativi ai Social Media. Ci rivolgiamo a
persone appassionate di Web, Marketing e
Comunicazione che abbiano competenze redazionali
e una particolare inclinazione verso il mondo dei
Social Network.
L’attività potrà essere svolta in remoto e in totale
autonomia.
511 Il titolo dell’annuncio è «Viva La Radio! Network 2014
redazione Roma».
276
Non è prevista alcuna forma di Retribuzione al
momento.
Requisiti obbligatori:
- Ottime capacità scritturali
- Conoscenza approfondita dei principali Social
Media
- Tempestività nella pubblicazione delle ultime news
Requisiti preferenziali:
- Conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza di Social Media nuovi o poco conosciuti
(Pinterest, Ning, QQ, Picotea) […]512».
La navigazione della Rete ha consentito di appurare come,
in ambito editoriale, le offerte non retribuite rappresentino
una prassi consolidata. La ricerca ha inoltre evidenziato come
spesso le richieste delle aziende siano tutt’altro che
uniformate al compenso proposto. Si cercherà ora di
delineare le ragioni che spingono molte persone, soprattutto
giovani, ad accettare queste condizioni e a scrivere gratis.
Non solo, scrivere gratis per aziende che traggono profitti
anche grazie a quel lavoro non retribuito.
512 Il titolo dell’annuncio è «Blogger Articolista per
magazine online».
277
4.4.1 L’analisi del fenomeno: per quali ragioni si scrive
gratis
«Se ti senti una ostetrica che partorisce un nuovo
giornalismo, sappi che sei solo il becchino che sta scavando
la fossa a quello vecchio513». Con queste parole lo scrittore e
giornalista Carlo Gubitosa sintetizza il proprio appello rivolto
a tutte quelle persone che accettano di scrivere gratuitamente
sul Web contribuendo nella maggior parte dei casi ai
guadagni di terzi. Il dibattito a riguardo è vivace e di
straordinaria attualità. In queste pagine si cercherà di
delineare le ragioni che possono spingere blogger, articolisti
o aspiranti giornalisti ad offrire i propri contributi
gratuitamente.
Un idraulico riparerebbe un tubo senza essere pagato? In
un ristorante, un cameriere ci servirebbe gratuitamente? Uno
chef preparerebbe i diversi piatti se non fosse retribuito? Se
portassi la mia macchina da un meccanico e mi rifiutassi di
pagare, quale sarebbe la sua reazione? E’ evidente come
queste domande siano puramente retoriche: nessuno tra
questi lavoratori offrirebbe i propri servizi senza percepire un
compenso. L’idea di lavorare gratis verrebbe non solo
respinta con sdegno, ma tacciata di sfruttamento, se non
addirittura di schiavismo. In questo quadro il giornalismo, ma
più in generale la prestazione intellettuale, sembra vivere
secondo logiche proprie, del tutto slegate da quelle
appartenenti alle altre professioni. Affinché un accordo si
513 Gubitosa C., Appello a chi scrive gratis tanto per farsi leggere: e' il
momento di smetterla in giornalismi.info, 26 settembre 2012
(http://web.giornalismi.info/gubi/articoli/art_9600.html).
278
concretizzi è evidente come siano necessarie due condizioni:
deve esserci qualcuno che lo propone da una parte e qualcuno
che lo accetta e sottoscrive dall’altra. Nello specifico, se
esiste il fenomeno della scrittura non retribuita, si presuppone
che esistano delle realtà editoriali che propongono di lavorare
gratuitamente e dei collaboratori che accettano quest’offerta.
In assenza di una di queste due precondizioni, il fenomeno
non può divenire reale514. Di fronte ad una realtà che appare
bizzarra, specie in relazione alle logiche che regolano le altre
professioni, nascono due domande. Rispondere al primo
interrogativo non è complicato. Perché le aziende non offrono
una retribuzione? Ritengo che anche coloro completamente
all’oscuro delle logiche editoriali online possano trovare una
risposta sfruttando la logica. L’obiettivo di tutte le aziende
con scopo di lucro è quello di massimizzare le entrate. Per
poter perseguire questo scopo la strategia primaria è quella di
ridurre quanto più possibile le spese e tra le voci in cui è
possibile effettuare il maggior numero di tagli spicca il
comparto umano. Tuttavia, affinché questa strategia si
concretizzi, ad esempio tramite un’offerta di lavoro che non
preveda una retribuzione, è necessario – come già evidenziato
– che ci siano delle persone disposte a lavorare (è importante
utililizzare questo verbo) gratis. Sintetizzando: perché le
aziende editoriali non offrono una retribuzione? Perché il loro
obiettivo è massimizzare le entrate riducendo i costi e perché
possono sfruttare una manodopera che non viene retribuita.
Rispondere alla seconda domanda risulta invece molto più
complesso. Perché molti tra blogger, articolisti, giornalisti
(aspiranti e non) scrivono gratis? Quali sono le ragioni che
514 Un’altra precondizione potrebbe essere l’assenza di una legislazione
che proibisca il lavoro non retribuito.
279
spingono queste persone a dedicare il proprio tempo e le
proprie energie verso un’occupazione che non produce alcun
guadagno? Ritengo che le ragioni siano molteplici e che a
volte più di una concorra nel rendere questo fenomeno una
realtà tangibile. Nell’elencare e analizzare le diverse ragioni
che possono partecipare al consolidamento di questo
processo si seguirà un ordine che muoverà dall’ambito
professionale verso un contesto e un orizzonte di attese
sempre più amatoriale.
La prima ragione è rappresentata dal sempre agognato
tesserino professionale, nello specifico quello da pubblicista.
Si è già visto come affinché la collaborazione svolta venga
riconosciuta dall’Ordine dei Giornalisti sia necessario – tra le
altre cose – che il lavoro sia retribuito. L’apparente
contraddizione viene risolta dall’illegalità in cui si muove
questo aspetto dello scrivere gratuitamente su Internet.
Esistono due scenari in questo senso. Da una parte la proposta
che mira all’inganno totale: gli articoli non vengono retribuiti
e non si potrà mai ottenere il tesserino. Dall’altra parte la
collaborazione consente, nonostante i pezzi non vengano
pagati, di presentare la necessaria documentazione all’Ordine
tramite l’emissione di fatture false. Un esempio di quanto
appena descritto può essere un annuncio di questo tipo
pubblicato su kijiji.it:
«Testata online femminile cerca in tutta Italia
aspiranti redattori/articolisti AMBOSESSI.
La risorsa si occuperà di redigere articoli 1/2 volte a
settimana (mattina o pomeriggio secondo
280
disponibilità) e lavorerà in sinergia con un team di
esperti e professionisti del settore.
REQUISITI INDISPENSABILI:
-voglia di cimentarsi con una realtà dinamica, in
costante crescita;
-ottima padronanza della lingua italiana;
-disponibilità (eventuale) a seguire direttamente
eventi e convegni;
-preferibile conoscenza tecniche SEO per
implementazione testi su Internet e motori di ricerca
(inserimento banner, iperlink, ecc).
La collaborazione è da intendersi a TITOLO
GRATUITO. Possibilità di conseguire il tesserino
dopo periodo di prova515».
Un’altra ragione che persuade molti aspiranti giornalisti ad
accettare proposte di collaborazione gratuita è rappresentata
dalla speranza di vedere la propria situazione come
temporanea. In quest’ottica il lavoro non retribuito è visto
come un investimento per il futuro, un sacrificio necessario
per una fortuna da ottenere un domani. Delle fatiche che
verranno un giorno ricompensate. Sono stati esaminati nel
paragrafo precedente alcuni annunci che promettono una
retribuzione futura a fronte di una mancanza momentanea. In
realtà è stato analizzato come queste prospettive siano
piuttosto nebulose, prive di un carattere definito e di un
qualsiasi punto fermo. In tal senso il leitmotiv è: “quando il
515 Il titolo dell’annuncio è «Giornalisti/articolisti».
281
sito crescerà, i collaboratori verranno retribuiti”. Proposta che
riesce in ogni caso ad esercitare un certo fascino su diverse
persone516. Fare esperienza e arricchire il proprio curriculum
vitae è un altro motivo che spinge verso il lavoro non pagato.
Della serie: “tanto la disoccupazione quanto l’occupazione
non fruttano denaro, ma nel secondo caso perlomeno viene
impreziosito il curriculum”. Un ottimo biglietto da visita per
tutti quegli editori che sono poco interessati alla qualità e
molto attenti ai costi: l’aver lavorato gratis sarà senza dubbio
presente tra i requisiti preferenziali. Tra le ragioni principali
che possono essere delineate per spiegare il fenomeno del
giornalismo non retribuito è il valore inestimabile che è stato
assegnato alla visibilità sul Web. Nel paragrafo precedente è
stato visto come molte realtà editoriali sottolineino come la
mancanza di un riitorno economico venga compensata dalla
visibilità offerta dal blog o la testata di turno. Richiamando
ancora una volta il celebre caso dell’Huffington Post, è stato
visto come la visibilità fosse considerata la moneta attraverso
cui venivano pagati i numerosissimi blogger che offrono i
loro contributi gratuitamente. Naturalmente, con il crescere
dell’importanza e della fama di un sito, cresce il valore della
moneta stessa – la visibilità – offerta dall’editore. Avere una
vetrina dove mettere in mostra il proprio operato viene vista
come una grande opportunità per ottenere guadagni futuri, sia
inerentemente all’ambito giornalistico – farsi conoscere,
ottenere incarichi -, sia per sponsorizzare attività esterne
come ad esempio la pubblicazione di un libro. Sin qui si è
rimasti nell’ambito della professionalità, situazioni che
vedono coinvolte persone che per differenti ragioni vedono la
516 A tal proposito è sufficiente sfogliare alcuni annunci presenti su siti
come AlVerde.net o GiorgioTave.it e notare quanti utenti si propongano
per collaborazioni improntate sulla prospettiva di una retribuzione futura.
282
collaborazione gratuita come necessaria per il
raggiungimento di altri obiettivi (il tesserino da pubblicista,
una retribuzione futura, l’esperienza, la visibilità). Esistono
tuttavia realtà che poggiano le proprie radici in terreni
maggiormenti amatoriali, dove la scrittura è considerata non
un lavoro ma un hobby, o piuttosto una passione da coltivare
ad ogni costo. In questi casi una componente essenziale, oltre
a quella del desiderio di condividere le proprie opinioni e
idee, è rappresentata dal narcisismo. Il fascino di vedere la
propria firma in calce ad un articolo pubblicato su un blog o
una testata, la soddisfazione di ricevere commenti, essere
condivisi sui social network, fare collezione di “mi piace” su
Facebook sono motivi che contribuiscono a ingolosire quella
fetta di collaboratori meno interessati all’aspetto
professionale della scrittura giornalistica. Come sostiene
Carlo Gubitosa:
«Il profilo che mi viene in mente non è quello del
Narciso che si compiace di sé stesso, ma della persona
con un ego talmente smisurato da avere bisogno di
continue conferme. Cioè, se io sono una persona
osannata e celebrata, se io sono continuamente
dopato, se la mia autostima è continuamente
alimentata da stimoli che mi arrivano dall’esterno; nel
momento in cui passa una settimana senza che mi
arrivi un complimento, ma anche un insulto di un
avversario politico, nel momento in cui passa una
settimana senza che io mi senta al centro della scena,
purtroppo – siccome siamo essere umani – crolla
anche la fiducia che ho di me stesso, l’autostima e
vado di nuovo in ricerca di quella visibilità che mi
283
permette di mantenere i normali livelli di attenzione
su di me517».
Per chiarire ulteriormente le ragioni che spingono blogger
e articolisti ad offrire il proprio lavoro gratuitamente, sarà
interessante riportare alcune testimonianze trovate in Rete.
Scrive Vincenzo Iurillo su IlFattoQuotidiano.it:
«C’è chi scrive gratis o quasi perché in fondo in fondo
pensa che il giornalismo sia una missione sacra che
non può essere sporcata con una cosa vile come il
denaro. Senza capire che senza le spalle larghe di una
tranquillità economica non si possono intraprendere
sacrosante campagne stampa, qualsiasi esse siano.
C’è chi scrive gratis perché si sente sufficientemente
gratificato dal sentirsi dire quanto è bravo, senza farsi
sfiorare dal dubbio che forse gli dicono che sei bravo
solo per farlo continuare a lavorare gratis.
C’è infine chi scrive gratis solo perché gli piace dire
in giro che è un giornalista. E’ il peggiore, non c’è
verso di guarirlo. Forse può riuscirci soltanto
qualcuno davvero bravo518».
517 Questo è un estratto di un’intervista che ho fatto a Carlo
Gubitosa. 518 Iurillo V., I ‘giornalisti’ a cui piace (o conviene)
scrivere gratis in ilfattoquotidiano.it, 30 marzo 2012
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/30/troppi-
giornalisti-piace-conviene-scrivere-gratis/).
284
In risposta al post di Carlo Gubitosa citato in precedenza e
che verrà ripreso più avanti, Valentina Orsini, una giovane
blogger romana, ha pubblicato una replica sul suo blog
Criticissimamente. Il pezzo sottolinea come ai blogger sia
negata la possibilità di scegliere e come coloro che
desiderano scrivere siano costretti ad accettare di sottostare
ad accordi non retribuiti.
«Se io avessi davvero la possibilità di fare una
scelta, di certo non farei quella della povera blogger
che scrive per passione e non scenderei a
collaborazioni misere e vergognose con testate o siti
bombardate da annunci pubblicitari. Gli stessi che
sappiamo benissimo, "finanziano". L'appello che lei
fa non ha ragione. Proverei a invertire le parti. Date a
noi l'opportunità di lanciare un appello, dateci la
possibilità di scegliere. Me lo trovi lei un sito o una
testata che paghi i miei pezzi...io sono qui. Il mio
nome e cognome ce l'ha. Nel frattempo, sà com'è, IO
VOGLIO SCRIVERE. E non smetto certo perché
qualcuno dall'alto trovi vergognoso e immorale
questo mio bisogno e questa mia ambizione con cui
vado avanti, nonostante tutto, nonostante
"NIENTE"519».
519 Orsini V., Caro Gubitosa, il tuo appello a chi scrive
gratis, non mi sta bene. Ti spiego perché in
criticissimamente.blogspot.it, 27 settembre 2012
(http://criticissimamente.blogspot.it/2012/09/caro-
gubitosa-il-tuo-appello-chi-scrive.html).
285
Questo esempio mostra come spesso sia il semplice
desiderio di scrivere a guidare alcuni blogger verso la
collaborazione gratuita. Il problema in tal senso non è
scrivere gratuitamente, ma scrivere gratuitamente per realtà
che traggono un profitto da quel lavoro non retribuito. La
testimonianza appena riportata si inserisce anche nel solco del
giornalismo visto come il “lavoro dei sogni”. «La storia dei
sogni, il lavoro dei sogni è una stronzata. Io faccio il mio
lavoro ed alle volte faccio delle cose assolutamente pallose,
ma io ci devo campare, il lavoro non è un hobby. Non credo
che per inseguire il lavoro dei tuoi sogni puoi ritrovarti a 40
anni ancora a scrivere gratis520». Un’altra testimonianza
interessante è quella della blogger Sara Rocutto che affida ad
un post dall’emblematico titolo «Ho scritto un nuovo post:
gratis» la sua posizione riguardo allla scrittura non retribuita
sul Web. «Ebbene si ho scritto un nuovo post sul blog che ho
su Linkiesta. L’ho scritto gratis e l’ho corredato pure di foto,
scattata da me521», sentenzia nell’incipit la blogger italiana.
Sara Rocutto ritiene che non ci sia differenza tra la
pubblicazione dei suoi articoli sul suo stesso blog e la
pubblicazione su altre piattaforme, ma sottolinea come la
scrittura non sia la sua fonte di sostentamento522. Di
520 Questo è un estratto di una intervista che ho fatto a Silvia Bencivelli. 521 Rocutto S., Ho scritto un nuovo post: gratis in
dopolapioggia.wordpress.com, 3 ottobre 2012
(http://dopolapioggia.wordpress.com/2012/10/03/ho-scritto-un-nuovo-
post-gratis/). 522 «E certo qualcuno potrà obbiettare che posso benissimo farlo sul mio
solito blog: cosa cambia? Oppure mi si potrebbe ribattere che beh, perché
non mi dovrebbero pagare per i miei pensieri? Posso capire se questi
discorsi li fanno gli “esperti di comunicazione” i “giornalisti
professionisti”, i web expert per i quali anche scrivere un tweet è un
286
conseguenza, non è il guadagno ad interessare la blogger:
«scrivo per fare si che una storia trovi il suo spazio, abbia vita,
scrivo perché una mia opinione trovi confronto con altre,
scrivo come esercizio di stile (anche) […]. Scrivo per far sì
che qualcosa che interessa a me trovi spazio anche nel mondo
di altri. E proprio non capisco come così facendo si svilisca
una professione523». Ma in realtà, Sara Rocutto non svolge la
professione giornalistica in modo continuativo, ma saltuario,
senza scadenze di alcun tipo524. La situazione cambia
drasticamente nel momento in cui il lavoro viene svolto
secondo logiche diverse, come sottolinea la testimonianza
della blogger LaStancaSylvie sul suo blog Downshifting
Baby:
«Niente soldi ma mille scadenze da rispettare. C’è
stata la neve e non l’ho vista perché stavo scrivendo
gratis per qualcuno che pensa che quello che stavo
facendo ha valore pari a zero.
Bene, con le occhiaie blu, il fidanzato triste e io per
nulla felice sebbene scrivessi, ieri ho inviato tre mail:
Ciao,
lavoro, ma io che nella vita guadagno da altre cose, beh, ho un altro punto
di vista». Ibidem. 523 Ibidem. 524 «Certo, ci spendo tempo, ore a volte a scrivere e cercare, ma proprio
per questo scrivo quando voglio (una volta al mese) e finora quello che
voglio. Mi si ponessero delle regole diverse, dei paletti, beh riterrei la cosa
meno interessante. Avessi la percezione che grazie a me altri diventano
ricchi cambierei idea. Ma finché le cose stanno come stanno non capisco
dove stia il problema». Ibidem.
287
sono troppo vecchia e troppo poco ricca per scrivere
gratis, se devo farlo lo faccio per me, sul mio blog
[…]525».
Un altro contributo interessante proviene da una
discussione nata su un forum, quello della nota webzine
musicale OndaRock. Il sito diretto da Claudio Fabretti è
aperto a collaborazioni esterne alla propria redazione: questo
qualora vengano soddisfatti alcuni requisiti e si accetti di
scrivere senza alcuna retribuzione.
Il topic in questione è intitolato «Perchè Scrivere
Recensioni Gratis?526» e secondo le intenzioni dell’autore la
discussione al suo interno verte verso i motivi che spingono
gli utenti a scrivere recensioni musicali senza ricevere un
compenso. I due punti su cui si basa la posizione dell’utente
che ha dato il via al dibattito sono i seguenti: in primo luogo
egli ritiene che «se un collaboratore si facesse pagare, si
rischierebbe di parlare solo di certe etichette/uffici stampa e
magari parlare bene anche se non lo meritano527». Secondo
l’utente la non retribuzione garantirebbe quindi l’integrità di
quanto viene scritto, ribaltando l’idea che la ricattabilità e la
corruttibilità siano invece minacciate – oltre che dall’etica e
dalla morale individuale – dalla solidità economica. Inoltre,
525 Scrivere Gratis o della Capacità di Incasinarsi Sempre
la Vita in downshiftingbaby.wordpress.com, 28 febbraio
2012
(http://downshiftingbaby.wordpress.com/2012/02/28/scriv
ere-gratis-o-della-capacita-di-incasinarsi-sempre-la-vita/). 526 http://forum.ondarock.it/index.php?/topic/18057-
perche-scrivere-recensioni-gratis/ 527 Ibidem.
288
l’autore del topic sostiene che la retribuzione andrebbe contro
lo spirito polifonico della Rete e delle webzine, che mira a
dare voce a tutti coloro che solitamente sono tagliati fuori dai
cosiddetti canali ufficiali. Altri utenti sottolineano invece il
carattere narcisistico della decisione528. L’intervento del
direttore del sito merita di essere menzionato: «Secondo me
la differenza sostanziale, finora, è che chi dirige riviste
cartacee spesso qualcosa ci guadagna […] e sfrutta la
manodopera a basso costo (o a zero costo) dei recensori; chi
dirige riviste online, come nel nostro caso, non percepisce
guadagni e quindi lavora gratis come gli altri. Non è tanto, ma
non è neanche poco, come differenza529». In realtà, pur non
disponendo dei dati di traffico, è possibile sostenere come
OndaRock sia un sito che ha scopo di lucro e che ha introiti
pubblicitari quantomeno derivanti dai banner che compaiono
tanto nella pagina principale, quanto in quelle secondarie e
che sponsorizzano importanti aziende. Ma secondo il
direttore del sito la webzine «è un misto di passione,
masochismo, narcisismo e genuino desiderio di informare in
modo libero530».
Come è stato visto, passione, narcisismo e desiderio di
partecipare all’informazione sul Web sono tra i motivi che
spingono – in particolar modo coloro meno attratti dalla
prospettiva professionale del giornalismo – a scrivere
528 «Boh forse perchè in molti lo vedono più come un hobby, un piacere...
conte di più la narcisistica condivisione delle proprie idee su un disco che
non il possibile guadagno che potrebbe esserci dietro. E chissà magari nel
momento in cui diventasse un lavoro commissionato forse verrebbe meno
anche il piacere». O ancora: «Quello che mi spinge è un'esigenza quasi
fisica di condividere ciò che mi piace». Ibidem. 529 Ibidem. 530 Ibidem.
289
gratuitamente online, favoriti dalle potenzialità della Rete. Il
masochismo, tuttavia, non è elemento di minore impatto nel
momento in cui la collaborazione gratuita viene svolta presso
un editore che ha come scopo ultimo il guadagno e che sfrutta
quella manodopera per i propri interessi.
4.4.2 Perché scrivere gratis danneggia la professione e
inquina il mercato
«Dopo il dubbio, ecco l’inganno: la favola della passione-
per-il-lavoro a volte conduce a una falsa morale, quella per
cui si può anche lavorare gratis. E ci si casca, oh se ci si casca.
Perché si pensa: il mio lavoro è così bello che lo farei gratis.
Ennò! Fermo, fermo e non ti muovere. Tu non devi fare niente
gratis! È difficile, lo so, ma gratis niente. Niente531». Apre
così il suo articolo pubblicato su Linkiesta Silvia
Bencivelli532, intitolato emblematicamente «La generazione
“lavoro gratis per avere una vetrina”». Il proliferare del
fenomeno del lavoro non retribuito ha mosso alcuni esponenti
– non troppi, a dire il vero – dell’universo giornalistico a
531 Bencivelli S., La generazione “lavoro gratis per avere una vetrina” in
linkiesta.it, 10 giugno 2013 (http://www.linkiesta.it/lavorare-gratis). 532 L’articolo raccoglie degli estratti del libro Cosa intendi per domenica?
– La mia (in)dipendenza dal lavoro, edito da LiberAria editrice. Silvia
Bencivelli è nata nel 1977. È laureata in medicina: giornalista scientifica
freelance, conduttrice radiofonica e saggista. Ha collaborato con la
trasmissione di Rai 3 Presa diretta e con altri programmi Rai ed è membro
del board di SWIM (Science writers in Italy). Ha pubblicato Perché ci
piace la musica (Sironi 2007, 2012) e Il sesso a test (Alpha test editore
2008). Fonte: Linkiesta.
290
parlare apertamente contro questa pericolosa deriva. Silvia
Bencivelli fa parte di questo gruppo piuttosto ristretto, in cui
entra a pieno merito anche Carlo Gubitosa, già citato in
apertura del precedente paragrafo. Il suo post intitolato
«Appello a chi scrive gratis tanto per farsi leggere: e' il
momento di smetterla» e pubblicato sul suo sito
giornalismi.info ha rappresentato una dura presa di posizione
contro tutti coloro che scrivono in Rete gratuitamente533.
Entrambi i pezzi appena citati muovono dall’assunto che il
problema non sia semplicemente scrivere online senza essere
retribuiti, ma farlo per aziende che generano un profitto da
quel lavoro non pagato. Il punto, che potrebbe apparire come
dato per scontato, è di cruciale importanza. In tal senso il caso
dell’azione legale dei blogger guidati da Jonathan Tasini
contro l’Huffington Post è emblematica. Queste persone
avevano deciso liberamente di offrire i propri contributi
gratuitamente al colosso americano, ma una volta resisi conto
del profitto che il loro lavoro non retribuito aveva partecipato
a generare – la vendita per oltre 300 milioni di dollari ad AOL
-, hanno compreso che la visibilità offerta dal sito non poteva
più essere una moneta sufficiente. In questo senso, le ragioni
analizzate nel paragrafo precedente che spingono blogger,
articolisti o giornalisti a concedere i propri contributi senza
ricevere un compenso passano in secondo piano; qualsiasi sia
la ragione, è necessario focalizzarsi sulle conseguenze
generate da questo comportamento534. Tanto Carlo Gubitosa
quanto Silvia Bencivelli inquadrano alla perfezione il
problema nei loro scritti, sottolineando come il danno per
533 Come si è già visto non sono mancate le reazioni polemiche in risposta
a quanto scritto da Gubitosa. 534 Questo tralasciando per un momento l’inalienabile dignità del lavoro
che inevitabilmente risulta svilita da questo fenomeno.
291
ogni scelta individuale sia poi collettivo. «Anche a me –
scrive Gubitosa – e' capitato di scrivere gratis per questo
maledetto prurito alle mani che mi perseguita da una ventina
d'anni, e perche' il piacere di pubblicare un editoriale su un
quotidiano nazionale puo' mettere in ombra il compenso che
ne corrisponde. Ma poi ho cominciato a interrogarmi sulla
responsabilita' sociale delle mie azioni535». La responsabilità
di aver contribuito al crollo del valore della professione che
si è verificato negli ultimi anni, a cui hanno compartecipato
diversi fattori. Da un sistema d’accesso alla professione che
andrebbe riformato passando per lo sviluppo del Web, sino
ad arrivare a editori interessati principalmente (se non
esclusivamente) alla riduzione dei costi e a concludere con
tutte le persone che per svariate ragioni hanno accettato di
lavorare gratis. Affermazioni quali «me ne frego se non mi
pagano. finché posso esprimere ciò che penso senza vincoli,
e finché qualcuno mi legge e magari apprezza quello che
scrivo536», non sono eticamente e socialmente accettabili. Il
perché si cela dietro ad una semplice legge di mercato che
Silvia Bencivelli descrive in maniera magistrale nel suo
articolo pubblicato su Linkiesta.
«Se accettassi, farei molto male al mio investimento
numero uno, cioè al mio lavoro. E farei un danno
importante al mercato. Perché lavorando gratis è quasi
certo che si venga scelti senza una valutazione della
professionalità, ma solo per il prezzo. In questo modo
si innesca un meccanismo viziato di ribasso continuo
535 Gubitosa C., Appello a chi scrive gratis tanto per farsi leggere: e' il
momento di smetterla in giornalismi.info, 26 settembre 2012 (cit.). 536 Ibidem.
292
e implacabile della qualità del lavoro, a detrimento di
chi quel lavoro lo fa e di chi dovrebbe goderne i frutti.
Mi spiego.
Un editore poco interessato alla qualità di quel che
pubblica, tra un lavoratore bravo che costa X e uno
medio che costa X/2, preferirà quest’ultimo. E il costo
di quel servizio sarà fissato a X/2, così come,
probabilmente, la sua qualità. Se l’editore deciderà di
abbassarlo a X/3, il lavoratore medio potrà fare due
cose: accettare e quindi essere complice
dell’abbassamento del valore di quella prestazione. O
rifiutare, lottando per il mantenimento del valore a
X/2, che peraltro è comunque bassino visto che
eravamo partiti da X.
Se poi ci sarà uno stagista con esperienza (figura
professionale sempre più diffusa, corrispondente a un
lavoratore intorno ai 28 anni plurititolato e ricco di
famiglia) che accetterà di farlo gratis, il valore di
quella roba diventerà zero. Il primo lavoratore e il
secondo si troveranno disoccupati e soprattutto
vedranno il loro lavoro svalutarsi fino allo zero: quel
patrimonio di competenze e credibilità non varrà più
niente, nessuno pagherà più per le loro prestazioni. E
il pubblico avrà un servizio di qualità più bassa537».
Gubitosa pur non ritenendo coloro che hanno accettato o
accettano di scrivere gratis come i principali colpevoli della
537 Bencivelli S., La generazione “lavoro gratis per avere
una vetrina” in linkiesta.it, 10 giugno 2013 (cit.).
293
situazione538, non li assolve. «Persone che amano
considerarsi "scrittori puri" amanti dell'arte per l'arte e lontani
dalla preoccupazione della vil pecunia, mentre in realtà sono
solo pedine di un nuovo tecnocapitalismo che monetizza sugli
aggregatori la tua voglia di farti leggere […]539». Ma c’è chi
respinge ogni accusa, come Francesco Sellari, che nel suo
blog Postille risponde a Gubitosa: «Ho scritto gratis e non mi
sento di consigliare a nessuno di farlo. Ma non mi va di
sparare a zero, con sprezzo e sarcasmo, su chi oggi, per le
motivazioni più disparate (ego, passione, gratificazione,
competenze inespresse, volontà di trattare temi di nicchia e
poco seguiti, desiderio di fare informazione libera e
indipendente), accetta collaborazioni gratuite. Per me il
nemico sta da un’altra parte540». Il “nemico” secondo Sellari
è il datore di lavoro, l’editore: «Nessuno mi venga a dire che
anche per colpa mia, per il fatto di aver accettato di scrivere
gratis, oggi i “colleghi” se la passino male. Io non mi sento d
aver affossato i precari, né di essere stato un crumiro541».
538 «Non credo che la responsabilita' piu' grave sia quella di chi ragiona
come fai tu e come facevo anch'io in passato con responsabilita' che
all'epoca non percepivo: le omissioni piu' pesanti sono quelle di un
sindacato che ha accettato un contratto di lavoro dove i freelance del web
semplicemente non esistono, lo stesso sindacato che dovrebbe denunciare
per esercizio abusivo della professione i portali registrati come testate
giornalistiche che fanno profitti pubblicitari o di altra natura sfruttando il
lavoro gratuito di anime belle». Gubitosa C., Appello a chi scrive gratis
tanto per farsi leggere: e' il momento di smetterla in giornalismi.info, 26
settembre 2012 (cit.). 539 Ibidem. 540 Sellari F., Dello scrivere gratis e dei miei nemici in
postille.wordpress.com, 29 settembre 2012
(http://postille.wordpress.com/2012/09/29/dello-scrivere-gratis-e-dei-
miei-nemici/). 541 Ibidem.
294
Eppure, senza per questo motivo decolpevolizzare chi sfrutta,
come minuziosamente spiegato da Silvia Bencivelli, i
lavoratori hanno contribuito ad inquinare il mercato e di
conseguenza a dequalificare la professione542. Secondo
Sellari non è così e lascia spazio ad un’ipotesi differente:
«Non posso neanche escludere che gli editori potrebbero
scegliere di continuare a risparmiare sul costo delle risorse
umane, aumentando il carico di lavoro sui giornalisti in
organico, pregiudicando ulteriormente la qualità
dell'informazione543». La domanda posta da Sellari in
conclusione del suo post è legittima ed è il punto cruciale
intorno a cui ruota la questione, il nodo che andrebbe sciolto:
«come far si che chi vuole fare questo mestiere non sia
costretto ad accettare di lavorare gratis?544». Una risposta
secca e risolutrice con ogni probabilità non esiste, poiché
molte sono le azioni che andrebbero portate avanti. In primo
luogo una riforma del sistema di accesso alla professione,
accompagnata da un controllo rigido del sindacato sul
fenomeno. Tuttavia, ritengo che qualcosa possa essere fatto
anche partendo dal basso; utilizzando le parole di Carlo
Gubitosa, «non mi illudo che si possa rispolverare la "lotta di
542 «Ragionamenti come quello che fai tu, e che purtroppo ho fatto anche
io in passato, hanno fatto crollare il valore della professione giornalistica
negli ultimi 5 anni da 100 euro a pezzo (quanto prendevo io nel 2003 per
scrivere articoli da freelance sul sito di un grande gruppo editoriale) a
zero», scrive Carlo Gubitosa rivolgendosi ad un blogger che scrive senza
essere retribuito. Gubitosa C., Appello a chi scrive gratis tanto per farsi
leggere: e' il momento di smetterla in giornalismi.info, 26 settembre 2012
(cit.). 543 Questa affermazione è tratta dall’intervista che ho realizzato a
Francesco Sellari. 544 Sellari F., Dello scrivere gratis e dei miei nemici in
postille.wordpress.com, 29 settembre 2012 (cit.).
295
classe" per farsi valere come categoria professionale, ma
almeno si potrebbe concordare sul fatto che il lavoro gratuito
che genera profitto per altri è cosa negativa che non
danneggia solamente chi lo pratica545». Ad esempio, mi sono
imbattuto in una campagna di sensibilizzazione per il rispetto
dei lavori creativi chiamata #coglioneNo, portata avanti dal
collettivo Zero, un gruppo formato da tre ragazzi italiani che
attraverso il proprio manifesto si presenta così: «Zero perché
il mondo è finito e non ce ne siamo accorti. Perché è finita la
nostra fiducia nei confronti di qualsiasi istituzione, di
qualsiasi forma di rappresentazione[…]. Zero perché i soldi
sono finiti. Da un pezzo. E noi di soldi nostri non ne abbiamo
mai avuti. Zero perché quando sono cadute le maschere delle
mille opportunità che doveva darci il terzo millennio, ci
siamo ritrovati senza scelta546». Il collettivo ha prodotto tre
brevi video intitolati «Lo diresti al tuo idraulico?», «Lo diresti
al tuo giardiniere?», «Lo diresti al tuo antennista?», in cui, al
termine di una prestazione lavorativa, colui che riceve il
servizio si mostra restio al pagamento. «Per questo progetto
non c’è budget – viene ad esempio detto all’idraulico – però
mi è venuta un’idea: appena tu vai via mi faccio una foto
mentre sto cagando sulla tazza che tu hai appena sistemato e
poi te la metto su Facebook, più Twitter, Instagram e
Pinterest! E poi ti taggo547». L’ironia fotografa e denuncia la
situazione vissuta da tanti lavoratori creativi, alla difesa dei
quali si rivolge la campagna #coglioneNo.
545 Gubitosa C., Appello a chi scrive gratis tanto per farsi leggere: e' il
momento di smetterla in giornalismi.info, 26 settembre 2012 (cit.). 546 http://zerovideo.net/manifesto/ 547 Il video è disponibile all’indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=sd5mHHg1ons#t=123.
296
«#coglioneNo è la reazione di una generazione di
creativi alle mail non lette, a quelle lette e non risposte
e a quelle risposte da stronzi.
È la reazione alla svalutazione di queste
professionalità anche per colpa di chi accetta di
fornire servizi creativi in cambio di visibilità o per
inseguire uno status symbol.
È la reazione a offerte di lavoro gratis perché ci
dobbiamo fare il portfolio, perché tanto siamo
giovani, perché tanto non è un lavoro, è un
divertimento.
Questo gennaio ZERO vuole unire le voci dei tanti
che se lo sentono dire ogni volta. Vogliamo ricordare
a tutti che siamo giovani, siamo freelance, siamo
creativi ma siamo lavoratori, mica coglioni548».
Come si vedrà in seguito, il fenomeno non è limitato alla
realtà italiana e non coinvolge solamente l’universo
giornalistico. Quanto descritto in queste pagine è anche figlio
di cambiamenti sociali ed economici, di un capitalismo che
ha trovato nella crisi un parafulmini e nella Rete un alleato
dal doppio volto. In questo senso, una presa di coscienza
collettiva potrebbe davvero essere un passo imprescindibile
per la guarigione di questa malattia piuttosto propensa al
contagio, ma «se era difficile creare una coscienza di classe
all’interno di una fabbrica FIAT […] figuriamoci quanto oggi
è difficile creare questa coscienza di appartenere ad una
548 http://zerovideo.net/coglioneno
297
stessa categoria professionale tra gente che non lavora nello
stesso posto, non si è mai vista in faccia, si percepisce in
competizione reciproca perché siamo entrati nella cultura
dove non c’è più la solidarietà tra lavoratori549». Inoltre, come
sottolinea ancora una volta Carlo Gubitosa, l’inquinamento
del mercato editoriale, la trasformazione della professione in
un hobby partorisce una selezione classista della professione:
«se il giornalismo diventa un hobby per chi campa d’altro, si
sta già facendo una selezione classista della classe
giornalistica, nel senso che i giornalisti che […] hanno poche
risorse economiche […] li perderemo perché non ci potrà
essere più spazio […] per chi cerca un giusto compenso dalla
scrittura. Ci sarà solo posto per le classi medio-alte dove non
fa problema dare contenuti gratuiti perché tanto il reddito
arriva altrove550».
Prima di analizzare la situazione fuori dai confini italiani,
si riserverà il prossimo paragrafo ad alcune interviste che ho
realizzato e che contribuiranno a delineare ancor più
accuratamente il quadro della situazione.
4.5 Approfondimento: interviste
Questo paragrafo è dedicato ad alcune interviste fatte a
professionisti e aspiranti giornalisti, da cui sono già stati
estratti alcuni stralci nei precedenti paragrafi. Ringrazio tutte
549 Questo è un estratto di un’intervista che ho fatto a Carlo Gubitosa. 550 Questo è un estratto di un’intervista che ho fatto a Carlo Gubitosa.
298
le persone che hanno accettato di collaborare nella
realizzazione di questa ricerca.
4.5.1 Carlo Gubitosa
La prima serie di domande che viene proposta è quella che
ho presentato a Carlo Gubitosa, citato già numerose volte
nelle pagine precedenti. Ripropongo testualmente la
narrazione che Gubitosa propone di sé sul suo sito
giornalismi.info: «Ingegnere delle Telecomunicazioni,
giornalista freelance e saggista, dal 1995 collabora con i
principali periodici italiani di informazione indipendente,
fino a ricoprire nel 2003 il ruolo di caposervizio per la sede
di corrispondenza di Milano dell'agenzia di stampa
"Redattore Sociale". Dal settembre 2009 e' direttore
responsabile di "Mamma!" (www.mamma.am) la prima
rivista italiana di giornalismo a fumetti. A partire dal 2003
realizza seminari e attivita' didattiche sul giornalismo e le
nuove tecnologie dell’informazione presso il corso di laurea
in Scienze della comunicazione dell’Università di Bologna,
all'interno dei corsi di Teoria e tecniche del linguaggio
giornalistico e Comunicazione giornalistica. Ha al suo attivo
numerose pubblicazioni, tra cui "Telematica per la Pace".
(Apogeo, 1996); "L’informazione alternativa" (EMI, 2002);
"Viaggio in Cecenia" (Nuova Iniziativa Editoriale 2004):
"Elogio della pirateria". (Terre di Mezzo, 2005); "Carovane.
Esperienze di strada contro le guerre e le mafie", (EMI,
2006); "Ricettario della pace". (Meravigli, 2009);
"Propaganda d'autore. Guerra, razzismo, P2 e marchette: un
299
atto d'accusa ai giornalisti VIP", (Stampa Alternativa,
2011)551».
Emanuele Mastrangeli: Perché per un periodo hai scritto
anche senza venire retribuito? Quando e per quale motivo hai
smesso di farlo?
Carlo Gubitosa: Ho scritto gratis in due periodi. All’inizio
facevo circolare i miei articoli che poi qualcuno pescava su
Internet e li ripubblicava. Io all’epoca non avevo l’istinto di
adeesso di andare da quello che li pubblicava, tirargli le
orecchie e dirgli “sì, sono contento che lo hai pubblicato, però
adesso mettiamoci d’accordo sul compenso”. Ero contento
che ciò che seminavo in Rete venisse utilizzato. Dopodiché
c’è stato un lungo periodo di scrittura giornalistica
professionale dove sembrava normale sia a me che alla
controparte il fatto che alla prestazione corrispondesse un
compenso. Poi c’è stato un periodo in cui sembrava assodato
che se un editore pubblicava qualcosa di una persona, quella
persona doveva avere un compenso. Indipendentemente dal
fatto che lo scrittore fosse giornalista o blogger, poi in quegli
anni, agli inizi del 2000, non c’era neppure questa definizione
di blogger. Ci sono stati dei periodi in cui il giornalismo
freelance dava delle possibilità. Io all’epoca ero ancora uno
studente universitario e avevo un reddito tutto sommato
dignitoso, se pensiamo che il Corriere della Sera poteva
pagare all’epoca un articolo per le sue testate online anche
sulle 200.000 lire, ovvero 100 euro di oggi, cifre che
sembrano incredibili. Dopodiché, col passare degli anni, è
successo che la scrittura, il suo valore professionale, per la 551 http://web.giornalismi.info/gubi/indici/ind_373.html.
300
legge della domanda e dell’offerta è crollato al punto che
ormai il valore di un articolo è praticamente nullo. Anche le
persone che venivano retribuite, stipendiate nei grandi gruppi
editoriali non esprimono un valore professionale
necessariamente diverso da chi scrive online, i cosiddetti
blogger. Magari ci sono dei blogger che fanno articoli più
approfonditi di persone che stanno stabilmente in redazione.
L’unica cosa che definisce lo spartiacque tra una categoria
professionale e l’altra non è più il fatto di avere un mestiere,
di avere delle tecniche, di rispettare una determinata
deontologia, di usare più o meno rigore nella verifica delle
cose. Prima erano questi gli spartiacque tra il giornalismo
professionale retribuito oppure no. Adesso lo spartiacque è
semplicemente essere interno o esterno alla struttura
redazionale. Se sei interno vieni stipendiato anche se passi la
giornata a fare tweet rilanciando cose altrui, se sei esterno non
sei stipendiato anche se scrivi articoli da premio Pulitzer.
Questo andazzo è arrivato al culmine quando si è chiusa una
stagione di collaborazione retribuita con il quotidiano
Liberazione. Ho scritto degli articoli per questo quotidiano
come collaborazione militante, ho scritto anche degli
editoriali, che sono il genere più prestigioso e autorevole del
giornalismo, uno spazio che richiede un certo impegno anche
da parte della testata nel sostenere il giornalista. Quando ho
visto che perfino gli editoriali su una testata nazionale
conosciuta in tutta Italia, sovvenzionata sia da un Partito, sia
dallo Stato, non avevano valore di mercato mi sono convinto
di aver valutato male il problema. Ovvero, il problema non
era tanto dell’editore o del padrone di riferimento che gestiva
quella testata, ma che anche io con quegli articoli gratuiti, con
quella coppia di editoriali avevo contribuito ad affermare
l’idea che nel mercato del giornalismo perfino un editoriale è
301
un prodotto, un servizio, una prestazione, un’opera che può
essere ottenuta con pochi soldi o addirittura gratis. Quindi nel
momento in cui tu scopri di essere in un certo senso un
collaborazionista di un sistema di sfruttamento decidi di
tirarti fuori. Io ho poi voluto con degli scritti, con delle
riflessioni pubbliche chiamare chi scrive alla presa di
coscienza del valore del proprio lavoro. I casi sono due: o
quello che scrivi non vale niente e quindi non serve, oppure
vale e quindi merita di essere retribuito. Inoltre, anche se
rinunci a degli spazi, anche se rinunci a quella moneta
intangibile che oggi si chiama visibilità, anche se pensi
avendo pochi lettori sul tuo sito individuale di avere meno
possibilità di carriera rispetto alla grande vetrina del grande
blog, cerca di capire quale è la responsabilità sociale del tuo
mestiere di scrivere. Perché magari stai scrivendo delle cose
bellissime però il modo in cui le scrivi, per come consenti ad
altri di fare profitti anche tramite la pubblicità online anche
grazie al tuo contributo di volontariato stai alimentando un
male oscuro che rischia di ridurre la professione giornalistica
ad un hobby. Un hobby che si può permettere solo chi vive di
altro. Questo vuol dire che se il giornalismo diventa un hobby
per chi campa d’altro, si sta già facendo una selezione
classista della classe giornalistica, nel senso che i giornalisti
che vengono dalla strada, che hanno poche risorse
economiche, che potrebbero dare al giornalismo la
prospettiva delle classi meno agiate li perderemo perché non
ci potrà essere più spazio per chi vive, per chi cerca un salario,
per chi cerca un giusto compenso dalla scrittura. Ci sarà solo
posto per le classi medio-alte dove non fa problema dare
contenuti gratuiti perché tanto il reddito arriva altrove.
Dunque questa è stata la mia parabola: gli esordi in cui
disseminare i propri scritti, la parte della professionalità
302
matura e il crollo del mercato con il valore delle prestazioni
giornalistiche che è crollato a zero, anche in funzione alle
relazioni che uno ha. Perché se si è così fortunati da avere un
contratto di praticantato o di entrare nelle grazie di qualche
testata o editore, poi una volta assunti si entra in quel sistema
di posizioni blindate che ormai riguarda un numero sempre
più sparuto di professionisti.
EM: Tralasciando le ragioni maggiormente legate all'ambito
professionale come possono essere la speranza di ottenere
una retribuzione in futuro, il desiderio di fare esperienza o di
ottenere visibilità, credi che il narcisismo giochi un ruolo
importante nel processo decisionale di coloro che scrivono e
non vengono pagati?
CG: Il narcisismo è compiacersi di sé stessi: c’è Narcisio che
si guarda specchiato nel fiume e rimane ipnotizzato da quanto
è bello. Credo che i meccanismi siano altri. Nel senso che,
pensando ai giornalisti – volendo tracciare un profilo
psicologico –, il profilo che mi viene in mente non è quello
del Narciso che si compiace di sé stesso, ma della persona
con un ego talmente smisurato da avere bisogno di continue
conferme. Cioè, se io sono una persona osannata e celebrata,
se io sono continuamente dopato, se la mia autostima è
continuamente alimentata da stimoli che mi arrivano
dall’esterno; nel momento in cui passa una settimana senza
che mi arrivi un complimento, ma anche un insulto di un
avversario politico, nel momento in cui passa una settimana
senza che io mi senta al centro della scena, purtroppo –
siccome siamo essere umani – crolla anche la fiducia che ho
di me stesso, l’autostima e vado di nuovo in ricerca di quella
visibilità che mi permette di mantenere i normali livelli di
attenzione su di me. Invece il problema non è tanto di questi
303
normali meccanismi che sono nel carattere dell’uomo, nel
senso che tutti noi siamo tentati dalle lusinghe e spaventati
dall’essere insignificanti; il problema sta proprio nella cultura
italiana dove la persona è sempre predominante rispetto al
contenuto. Cioè, se un tempo si parlava di lotta di classe da
una parte, di capitalismo dall’altra, di destra da una parte, di
sinistra dall’altra. Adesso si parla di Travaglio da una parte,
di Sallusti dall’altra. Non ci sono più scontri tra idee, ci sono
scontri tra persone che degenerano in scontri tra personaggi.
La colpa è di una cultura dilagante in Italia tale per cui si cerca
come isola rassicurante un personaggio di riferimento, poi
tutto quello che dirà per noi sarà verità di fede: le grandi
rivelazioni come le bufale, le leggerezze come le grandi
inchieste. Noi non ci schiereremo dalla parte della verità,
dalla parte di un ideale, dalla parte di un pensiero ma dalla
parte di una firma. Questa è una degenerazione sociale, una
malattia sociale che ha molto a che fare con quel culto del
capo, quel culto della personalità, la ricerca dell’uomo forte,
la ricerca del leader, la ricerca del pastore che ti guida come
una pecorella smarrita, che è proprio quella debolezza
caratteriale delle popolazioni su cui si riversano i regimi
autoritari, non solo militari o politici, ma anche regimi
culturali. Regimi per i quali abbiamo 3 o 4 grandi gruppi
editoriali in Italia, ovvero RCS, Gruppo L’Espresso
Repubblica, Gruppo Mondadori Mediaset e Gruppo Il Sole
24 Ore. Questo è un regime editoriale, tale per cui a noi fa
anche piacere che siano pochi, perché se ci fossero tante firme
coraggiose, se ci fossero tanti giornalisti che seguono
ciascuno delle idee forti, noi ci sentiremmo spaesati e sperduti
e ci chiederemmo: chi è che dice la verità? Chi è il mio
oracolo? Chi la mia guida, il mio riferimento umano,
spirituale e politico? Quindi, sicuramente c’è anche una
304
componente narcisistica di autocompiacimento del
giornalista, c’è anche l’altro fattore che dicevo, cioè degli ego
che vengono alimentati dal pubblico e cercano sempre
continue conferme.
EM: Molte persone sembrano non capire una semplice legge
di mercato: le aziende possono permettersi di offrire "zero"
perché ci sono persone che accettano di lavorare pur non
venendo retribuite. Ovvero, in altri termini, se nessuno
accettasse di scrivere gratis, gli editori sarebbero costretti ad
offrire un compenso. Perché quest'argomento spesso non
viene recepito?
CG: Perché c’è, peggio di come c’era prima, il conflitto tra il
particolare e l’individuale. Se io riesco ad ottenere una bella
vetrina su un blog famoso, che poi magari mi permette di
avere i contatti giusti tali per cui ottengo anche una rubrica
pagata, a me che cazzo ne frega della solidarietà con la mia
categoria di lavoratori? Allora, se era difficile creare una
coscienza di classe all’interno di una fabbrica FIAT, dove
c’erano persone tutti i giorni gomito a gomito che laovravano
per lo stesso padrone, che avevano grossomodo delle
lamentele comuni, delle aspirazioni comuni; figuriamoci
quanto oggi è difficile creare questa coscienza di appartenere
ad una stessa categoria professionale tra gente che non lavora
nello stesso posto, non si è mai vista in faccia, si percepisce
in competizione reciproca perché siamo entrati nella cultura
dove non c’è più la solidarietà tra lavoratori. Ognuno lavora
da casa sua, i rapporti con le redazioni sono legati alla
contrattazione individuale, i sindacati dei giornalisti
compaiono solo a difesa dei contrattualizzati, strappandosi gli
occhi sui freelance, sui liberi professionisti che oggi
rappresentano la maggior parte della prestazione giornalistica
305
in Italia. Se non c’è neanche solidarietà sul contratto
nazionale, se perfino il contratto di lavoro nazionale non
contempla la figura del freelance, ma riconosce solo i diritti
di chi è sotto contratto, quindi con un rapporto di lavoro
dipendente e subordinato, che solidarietà ci possiamo
aspettare tra i lavoratori? Questo però non significa che
questa coscienza e questa solidarietà non si possa ricercare,
anzi. Uno dei motivi per cui mi hai telefonato è il mio appello
scritto nell’intenzione di creare consapevolezza. Ovvero, tu
puoi continuare a scrivere gratis, ma devi essere consapevole
che se lo stai facendo stai danneggiando in maniera anche
indiretta la tua categoria di lavoratori e di conseguenza anche
te stesso.
EM: A mio modo di vedere editori e collaboratori sono
entrambi colpevoli, pur in maniera differente. Se l'operato dei
primi potrebbe essere controllato dalla Legge, per i secondi
può bastare una presa di coscienza collettiva?
CG: La presa di coscienza collettiva non l’abbiamo avuta
quando perfino l’ultimo degli operai andava in giro con i libri
sotto il braccio, figuriamoci se ce l’abbiamo adesso dopo
vent’anni di stordimento televisivo o con i social network che
si stanno sostituendo alla televisione come armi di distrazione
di massa. Io penso che la soluzione debba arrivare nei canali
tradizionali, cioè in una normativa che impedisca anche a
tutela del lettori di utilizzare lavoro non retribuito in una
testata registrata che fa anche peraltro profitti. Questo
dovrebbe essere chiaro per legge: io domani non posso
mettere su un’impresa edile con il muratore che mi viene a
lavorare gratis perché così fa esperienza, si fa notare, cerca la
visibilità. No, in tal caso arriva l’ispettorato del lavoro e mi
denuncia, perché quello è lavoro nero. Così, analogamente, il
306
percorso legale in un paese che ha partorito lo statuto dei
lavoratori, in un paese che ha avuto tra i sindacati più forti
d’Europa, quando ancora erano sindacati dei lavoratori e non
erano sindacati interlocutori dei gioverni, io mi auguro che
esista una normativa e che possa esistere una trattazione
sindacale tale per cui certe forme di sfruttamento da una parte
diventano illegali e dall’altra certi diritti vengono affermati in
contratti collettivi e nazionali. Credo che oggi le speranze
siano poche di arrivare a questo risultato, ma io non vedo altre
strade. I diritti della categoria si devono affermare su due
binari: nel rispetto di alcuni principi di Legge che vanno
stabiliti in Parlamento e nel riconoscimento di alcuni diritti
che va stabilito nel rapporto tra editori e lavoratori mediato
dai sindacati. Il problema è che nello stato dell’arte di questo
rapporto tra editori e lavoratori mediato dai sindacati, la
figura del giornalista freelance non esiste, non è menzionata,
nonostante produca gran parte della produzione giornalistica.
Il problema quindi è che ci sono dei professionisti individui
che restano ognuno per i cazzi suoi, pensando al loro privato,
al loro meschino interesse personale e che non hanno tempo,
voglia, possibilità o visione strategia per organizzarsi in
maniera più efficace.
EM: Nella raccolta delle fonti in Rete, mi sono imbattuto in
posizioni antitetiche rispetto alla tua. Ovvero a difesa della
scrittura non retribuita. Tra le diverse interpretazioni date,
una mi ha colpito in particolare. Il giornalismo viene spesso
rappresentato come un lavoro non equiparabile agli altri,
dotato di caratteristiche tali che lo rendono soggetto al lavoro
non retribuito. Perché secondo te?
CG: Questo ce lo dovrebbero spiegare loro. Io non credo che
il mio tempo, il valore della mia esperienza professionale,
307
delle tecniche che ho imparato, del mestiere che ho
accumulato in questi vent’anni che scrivo sia inferiore al
valore professionale dell’avvocato che accumula esperienza
in vent’anni che scrive cause, arringhe, memorie difensive.
Ognuno di noi sviluppa un tipo diverso di scrittura, la sua è
una scrittura tecnica, la mia è una scrittura giornalistica, però
non vedo perché debba esserci questo divario nel compenso
di un avvocato e quello di un giornalista. Altrimenti ci
dovrebbero dire che quello che era un lavoro retribuito è
diventato un hobby. Le conseguenze sarebbero che
l’informazione, cioè la fotografia del paese non verrà più fatta
da rappresentanti di tutte le classi sociali, ma dai
rappresentanti delle classi agiate che possono permettersi di
scrivere gratis. È un futuro quello del giornalismo
profondamente classista se diventa un hobby, cioè se si
legittima l’idea che chi campa di giornalismo è solamente
colui che ha incarichi di responsabilità, che ha dei giornalisti
sotto di sé, mentre quello che scrive un articolo non lavora
realmente. Io vorrei chiamare l’idraulico e dirgli: “che hai
fatto? Un’ora, mi hai cambiato un tubo; ti do i soldi dei pezzi
e ringraziami pure”. Ma invece io devo pagare il suo lavoro.
Ed è giusto. Io sono stato culturalmente abituato a riconoscere
la professionalità dell’idraulico, quella dell’ingegnere, devo
abituarmi a riconoscere la professionalità del giornalista.
Anche qui è una questione di cultura. Oggi siamo talmente
ignoranti che il giornalismo non vale più niente, anche perché
c’è sempre meno gente in grado di distinguere la differenza
tra un giornalismo fatto con mestiere e le cazzate copiate e
incollate, piene di bufale, di complottismi e di fuffa raccattata
dalla Rete.
308
EM: Ritieni che lo sviluppo di Internet e del Web 2.0 abbiano
avuto un ruolo importante nel proliferare del fenomeno
avendo garantito l'accesso alla produzione dei contenuti ad un
pubblico precedentemente tagliato fuori?
CG: Questa è un’ottima domanda. Secondo me c’è il fattore
tecnologico e il fattore sociologico. Il fattore tecnologico è
l’avvento dei blog, la diffusione sempre più massiccia delle
tecnologie Internet, il fatto che chiunque può scrivere
eccetera. Ma c’è anche il fattore sociologico. Ovvero,
impregnati di un ventennio di ignoranza televisiva,
lobotomizzati dalla subcultura che ha circolato e dilagato, il
dato sociologico ci impedisce di distinguere il buon
giornalismo, la buona inchiesta, il buon lavoro investigativo,
anche semplicemente l’articolo scritto in un buon italiano
dalla monnezza fatta tanto per riempire una colonna, dalla
propaganda politica, dalla disinformazione, dal complettismo
o dalle bufale varie che hanno trovato spazio anche sui
quotidiani senza che nessuno dicesse niente, senza che
nessuno perdesse il posto per questo.
EM: Navigando in Internet ho notato come il dibattito
riguardo a questo fenomeno sia molto più intenso all'estero,
specie negli Stati Uniti, di quanto non lo sia in Italia. Perché
non viene dato il giusto risalto a questa situazione?
CG: Perché in Italia i primi a difendere il padrone sono i servi.
Perché i più accaniti nel dirmi “tu mi stai imbavagliando, tu
mi stai limitando nella mia espressione”, sono stati dei
blogger che lavorano gratis e rivendicano il diritto di farlo. In
Italia forse c’è meno sensibilità riguardo a questo tema perché
ci piace essere servi ben riconosciuti, non economicante, ma
con una bella vetrina su un blog di grido. Piuttosto che essere
309
padroni di noi stessi e di quello che scriviamo. Ogni volta mi
sembrava assurdo dovere ripetere che ognuno era libero di
scrivere dove e come meglio credeva, ma che se c’è qualcun
altro che si mette dei soldi in tasca bisognerebbe porsi delle
domande. Perché questo crea un problema anche agli altri,
non solo a chi decide di scrivere gratis. Io dico: se ti piace il
mestiere della scrittura devi capire che lo stai rovinando con
questo atteggiamento, non solo per te, non solo per i tuoi
colleghi ma anche per gli anni e per i decenni a venire, se
veramente diventeremo un hobby per borghesi con la pancia
piena. Il giornalismo è un mestiere, ci devo dedicare le mie 8
ore e mi devono dare il mio stipendio.
EM: La situazione complica la vita agli aspiranti giornalisti?
CG: No, perché noi paghiamo per essere giullari a casa
d’altri, per essere in vetrina sul blog dell’Annunziata o di
Luca Sofri o di altri, ma non siamo capaci di farci noi degli
spazi. L’accessibilità del Web viene sfruttata nel senso che
tutti possono scrivere, ma poi tutti lo fanno a casa d’altri. Il
“tutti possono scrivere” lo interpreto in maniera diversa,
ovvero nel senso che tutti possono fondare una testata con le
tecnologie del Web. Tutti possono fondare una rivista con le
tecnologie di microeditoria che oggi ti consentono anche
bassissime tirature: stampatevi la vostra rivista, fatevi il
vostro gruppo redazionale, perché non sarà la testata a dare il
valore alla vostra firma, sarete voi stessi e come saprete
costruire un giornalismo a vostra misura; non adattarvi voi ad
un contenitore su un piano editoriale esterno. Quindi è vera
la frase che è più difficile scrivere, ma bisogna aggiungere la
postilla: è più difficile scrivere se si vuole farlo all’interno di
grandi gruppi editoriali che garantiscono la pappa pronta di
una buona visibilità. Ma allora togliti il pannolino, createlo tu
310
un pubblico, createla tu una testata. Sii originale, sii diverso.
Il tuo futuro professionale deriva da ciò che di nuovo avrai tu
da dire rispetto a quello che è stato detto prima, non solo
rispetto al contenuto ma anche rispetto alla forma. Meglio
essere padroni a casa nostra, pur con le pezze al culo, che
servi a casa d’altri comunque con le stesse pezze al culo.
Perché se andando da un’altra parte facessi i milioni ti capirei,
ma gratis per gratis almeno scrivi gratis per te stesso.
4.5.2 Silvia Bencivelli
La seconda intervista che propongo è quella realizzata
grazie alla gentile collaborazione di Silvia Bencivelli. Anche
in questo frangente, affido la narrazione biografica alle parole
pubblicate sul sito omonimo silviabencivelli.it: «Sono nata il
20 luglio del 1977 e sono cresciuta a Pisa. Nel luglio del 2002
mi sono laureata in medicina e chirurgia all’Università di Pisa
e nel novembre del 2004 ho conseguito il Master in
comunicazione della scienza alla Sissa di Trieste. Oggi vivo
a Roma. Ho cominciato a fare la giornalista scientifica
lavorando nella sede romana dell’agenzia Zadig, per cui ho
scritto lanci di agenzia e articoli per quotidiani e riviste e dove
ho avuto modo di seguire alcuni progetti editoriali, in
particolar modo di editoria scolastica. Dal 2005 al 2011 ho
lavorato nella redazione di Radio3 Scienza, il quotidiano
scientifico di Radio3 Rai, e saltuariamente sono ancora tra i
conduttori del programma. Sono stata inviata della prima
serie di Cosmo, trasmissione scientifica di Rai3 ideata da
Gregorio Paolini e da Hangar e condotta da Barbara Serra,
che è andata in onda la domenica in seconda serata nella
311
primavera del 2011. Da novembre 2011 a giugno 2013 ho
collaborato con Rai3 per Presa Diretta, di Riccardo Iacona e
Francesca Barzini. Collaboro anche con giornali e riviste (Le
Scienze, La Stampa nel canale Tuttogreen, Mente e Cervello,
a volte con Panorama e Focus, e ho collaborato con il
manifesto, per cui, per qualche anno, ho scritto la pagina di
Chips and Salsa dedicata alla scienza nell’inserto culturale
Alias), con scuole di comunicazione e master (Master SGP
dell’Università La Sapienza di Roma, Master in
comunicazione della scienza della Sissa di Trieste, Istituto
per la formazione al giornalismo di Urbino), case editrici (Il
Saggiatore, Sironi, De Agostini scuola), agenzie di
comunicazione (La Fabbrica, effecinque). E partecipo come
relatore e come moderatore a eventi culturali per il grande
pubblico e per le scuole. Ho pubblicato un po’ di libri: Perché
ci piace la musica (Sironi editore, febbraio 2007, e in seconda
edizione marzo 2012) e Il sesso a test (Alpha test editore,
maggio 2008), entrambi tradotti in francese dalla casa editrice
Belin. Il libro sulla musica è stato anche tradotto in inglese
(Music World Media) e in spagnolo (Rocaeditorial). Si
trovano anche Tosse e altre catastrofi e Pappa che passione,
libri del bimestrale Un Pediatra per Amico, che ho curato
insieme a Sonia Bozzi. A maggio è uscito Cosa intendi per
domenica – La mia (in)dipendenza dal lavoro, per LiberAria
edizioni. E a settembre Comunicare la scienza, con Francesco
Paolo de Ceglia, per Carocci editore nella collana Bussole.
Sono stata selezionata per la fellowship Giovanni Armenise
– Harvard Medical School Foundation, in collaborazione con
l’Ugis (Unione giornalisti italiani scientifici) nel maggio
2008, e per la fellowship Eicos (European Initiative for
Communicators of Science) al Max Planck Institute di
Göttingen nel giugno 2009. A novembre 2010 ho vinto il
312
Premio speciale per la divulgazione scientifica e sociale
sull’Hiv/Aids del Premio giornalistico Riccardo Tomassetti.
Ho vinto il primo premio del concorso Short on Work,
concorso internazionale di documentari brevi e videoricerca
sul lavoro promosso dalla Fondazione Marco Biagi, nel
settembre 2012, con 2033, girato insieme a Chiara Tarfano.
Nel novembre 2012 mi è stato assegnato il premio Piazzano
per il giornalismo scientifico. Il 19 gennaio 2013 ho
partecipato allo spettacolo della Sora Cesira all’auditorium di
Roma: Felicità, all’interno del Festival delle Scienze di
Roma, con i miei monologhi su scienza e felicità. Sono
autrice del documentario Segna con me, per la regia di Chiara
Tarfano, che ha appena ricevuto il premio Miglior Film
dell’Ens (Ente nazionale sordi) al Cinedeaf (Festival
internazionale di cinema sordo), seconda edizione (2013).
Sono nel board di Swim – Science Writers in Italy,
associazione di giornalisti scientifici italiani che aderisce alla
European Union of Science Journalists’ Associations
(EUSJA) e alla World Federation of Science Journalists
(WFSJ)552».
Emanuele Mastrangeli: Hai mai scritto senza essere
retribuita? Se sì, perché lo hai fatto?
Silvia Bencivelli: Sì, certo che mi è successo. Alle volte per
errore, nel senso che non sapevo che non sarei stata retribuita.
Ad esempio giornali che poi non hanno pagato i collaboratori
o che avevano il vizio di dimenticarsene. A me è successo
diverse volte anche con testate nazionali. Non di recente,
devo dire, anche perché una volta che mi è successo e non 552 http://silviabencivelli.it/curriculum/.
313
sono riuscita a farmi pagare ho smesso di collaborare. Se io
continuassi a collaborare anche gratis potrei dire che scrivo
per 3 o 4 testate nazionali e ci farei una figura migliore,
mentre al momento dico di collaborare con un unico
quotidiano nazionale con testate mensili nazionali sempre
dello stesso gruppo anche perché sono in buoni rapporti e so
che non ci sono rischi.
EM: Quindi non hai mai accettato volontariamente di
lavorare pur non venendo pagata, è una situazione che è
subentrata poi nel momento in cui determinati pagamenti non
sono arrivati?
SB: Ultimamente non ho fatto lavori gratis a meno che non
ritenga che possa avere un risvolto sociale o morale. Capita a
tutti di fare un regalo e quindi ogni tanto regalo la mia
prestazione, lo posso fare con mio padre, con un amico vero
o di fronte ad una questione sociale che mi preme o in
situazioni di confine come può essere la promozione di un
libro. Ad esempio, se mi chiedono di scrivere un pezzo su un
tema che ho affrontato in un libro e in calce viene scritto che
è un estratto del mio libro diventa un sistema promozionale
per vendere copie. E’ come quando fai le presentazioni dei
libri, non ti fai pagare. Mi è capitato poi di scrivere contributi
gratis per dei libri, me ne vengono in mente almeno due di
recente. Ti viene detto che si tratta di un’operazione culturale
che ti costa poco perché hai già scritto a riguardo, hai già tutto
il materiale ecc. Probabilmente è anche vero però il confine è
sempre molto sottile. Ma io vivo di scrittura e devo
ovviamente cercare di farmi pagare quello che faccio per il
tempo che investo nelle cose che produco per il semplice
motivo che vivo di quello. C’è poi una motivazione di tipo
etico che è quella di preservare il mercato. Questo non accade
314
in nessun altro tipo di mercato lavorativo, perché per il
mercato della penna lo dovresti fare? Il mercato intellettuale
è un mercato come gli altri e lo difendi come difendi gli altri.
EM: Tralasciando le ragioni maggiormente legate all'ambito
professionale come possono essere la speranza di ottenere
una retribuzione in futuro, il desiderio di fare esperienza o di
ottenere visibilità, credi che il narcisismo giochi un ruolo
importante nel processo decisionale di coloro che scrivono e
non vengono pagati?
SB: Può darsi che ci sia anche una motivazione di questo tipo.
Io tutte le volte che ho avuto a che fare con colleghi che
scrivono gratis ho visto anche una lagna terrificante, molto
inconsapevole, che vede nella loro narrazione loro descritti
come povere vittime e dall’altra parte la figura del direttore
che non paga promettendo e non mantenendo. Loro non lo
ammettono però sicuramente questo aspetto del narcisismo
c’è, oltre a questo vittimismo che è un po’ stucchevole.
EM: Molte persone sembrano non capire una semplice legge
di mercato: le aziende possono permettersi di offrire "zero"
perché ci sono persone che accettano di lavorare pur non
venendo retribuite. Ovvero, in altri termini, se nessuno
accettasse di scrivere gratis, gli editori sarebbero costretti ad
offrire un compenso. Perché quest'argomento spesso non
viene recepito?
SB: In primo luogo perché noi collaboratori esterni siamo
tanti. Quindi è abbastanza facile tra di noi trovare qualcuno
che accetta dei compensi infimi per motivazioni sciocche e
con l’unica reale motivazione di poterselo permettere, cioè di
avere una famiglia alle spalle. Quindi significa che il direttore
del giornale invece di avere a disposizione 3 collaboratori, ne
315
ha 100 di cui 80 disposti a scrivere gratis, e ne sceglierà 1 tra
questi 80. Magari non con grossa attenzione alla qualità. Io
mi occupo di scienza ed è molto facile trovare online o sui
giornali di carta cose di scienza scritte veramente male. Però
evidentemente ai “nostri” direttori dei giornali questa qualità
non interessa molto, in fondo l’articolo lo paghi zero euro…E
per questo motivo secondo me questo sistema rovina il
mercato. Tutto ciò è anche profondamente disonesto nei
confronti del lettore perché il lettore sul momento non ha gli
strumenti per capire cosa è stato pagato zero e cosa no, cosa
vale zero e cosa no. Noi dovremmo scrivere sempre tendendo
alla qualità migliore possibile ma la qualità si paga, perché
vuol dire tempo, studio, ricerche, non un articolo scritto così
perché tanto è gratis.
EM: Credi che il fenomeno sia anche figlio di Internet, del
Web 2.0, del fatto che l’accesso alla produzione dei contenuti
editoriali si sia ampliato enormemente?
SB: Sì, hai perfettamente ragione. C’è un malinteso sulla
parola democrazia. Oggi per democrazia si intende che
ognuno può parlare e io sono d’accordo sul fatto che ognuno
può parlare e sulla posizione di non censurare la Rete. Però
per altre cose c’è chi ha l’autorità per parlare e chi non ce l’ha.
Come ad esempio se parliamo di ricerca e sperimentazione,
l’opinione di uno scienziato dovrebbe valere di più di quella
di un religioso, di un mistico o di un umanista, gente insomma
che si occupa di tutt’altro. Invece oggi si tende a confondere
le cose e il Web contribuisce in tal senso. Del resto un mio
articolo che finisce sulla pagina di un quotidiano nazionale tu
lo leggi gratis, come leggi gratis pagine di complotti che
dicono che le scie chimiche vengono buttate nel cielo per
farci morire tutti. Perché il giornale dovrebbe pagarmi più di
316
zero? Il sostenitore del complotto lo fa per zero, il lettore per
zero legge entrambi e magari ritiene che abbiano lo stesso
valore. La differenza dovrebbe essere che il quotidiano
dovrebbe essere interessato a considerarsi fonte autorevole.
Ma tu considera che ci sono quotidiani online che accettano i
blog di chiunque lo richieda perché tanto non paga e quindi ti
trovi blog con il bollino di un quotidiano che dicono una cosa
ma anche l’esatto opposto.
EM: Questo anche perché alla fine ai giornali online interessa
principalmente il numero di click che ricevono piuttosto che
la qualità?
SB: Certo, nel momento in cui tu mi porti traffico io giornale
online ti pubblico, senza curarmi di ciò che scrivi. Inoltre i
blog dei quotidiani non si distinguono tanto bene dagli
articoli dei quotidiani. E se un blogger scrive gratis, un
giornalista non può ambire a grandi cifre. E’ un momento in
cui sembra che tutti possano parlare di tutto. Peraltro questo
è molto pericoloso perché se ci pensi Internet esiste da una
decina d’anni con questa diffusione così aperta, però non
abbiamo ancora sviluppato un modello di business, quindi
non sappiamo ancora come far fruttare l’editoria in Rete,
tranne che per la pubblicità, che però rende molto di meno
della pubblicità su tv. Ed è un problema internazionale, non
solo italiano. A quanto ho capito per un giornale ci vogliono
più o meno 20.000 click al giorno per essere redditizi sul
lungo termine. Ad esempio Repubblica.it fa un sacco di soldi,
un giornale molto più piccolo fa molta più fatica. Tra l’altro
le cose non sono così chiare nemmeno per noi che ci
scriviamo sopra, tutto è ancora molto fumoso. Io intravedo in
tutto ciò l’inizio della fine del giornalismo vecchio stile. Se
io scrivo un articolo sul mio blog ci metto lo stesso tempo che
317
ci metto per un giornale online, forse anche di più perché poi
c’è davvero il mio nome e quindi il mio tempo comincia ad
essere diviso tra lavoro retribuito e hobby. E’ abbastanza
complicato pensare a come andrà avanti. Nel mio settore,
quello scientifico, prima o poi dovrà esserci un grande
investimento da parte delle istituzioni, che saranno le uniche
forse a mantenere un bollino di autorevolezza. Anche se devi
considerare che le istituzioni scientifiche in Italia oggi non le
considera quasi nessuno autorevoli, vedi il caso Stamina. C’è
un problema di credibilità e di indipendenza: cioè, se io vengo
pagata soltanto dalle istituzioni scientifiche, poi come faccio
a dire che quello che dicono non sia corretto? Quindi
bisognerà trovare una soluzione, ma intanto il mercato va a
puttane. Anche se ci sono problemi ancora più gravi come
quelli legati all’indipendenza del giornalista,
sull’autorevolezza di quel che scrive, sulla competizione tra
una cosa verificata e una cazzata scritta da chiunque.
EM: Navigando in Internet ho notato come il dibattito
riguardo a questo fenomeno sia molto più intenso all'estero,
specie negli Stati Uniti, di quanto non lo sia in Italia. Perché
non viene dato il giusto risalto a questa situazione?
SB: Sì, è vero. In Italia il dibattito è un po’ più timido.
Quando abbiamo cominciato a discuterne tra collaboratori in
RAI – e in RAI a volte le condizioni per i collaboratori esterni
sono terribili, frustranti, umilianti – i miei colleghi della RAI
avevano molta paura di parlarne. Perché tutto sommato poter
dire di lavorare per la RAI è una cosa ancora prestigiosa e
quindi era difficile partecipare ad una manifestazione
pubblica o fare interviste per un giornale. Ero sempre io
quella che si esponeva. E’ anche vero che questa cosa poi mi
ha portato un po’ di onore, mi hanno fatto scrivere un libro,
318
ne ho parlato in trasmissioni televisive importanti, questo
anche a dimostrazione che alle volte l’onestà viene premiata.
Purché non sia ovviamente incoscienza: io non mi metto a
parlar male della mia azienda anche perché alla RAI devo
molto per la mia crescita professionale. Però per come
funziona il sistema dei collaboratori onestamente no; lavorare
per 9 mesi sottopagato, poi stare 3 mesi ad aspettare che ti
rifacciano il contratto non è il massimo della vita. Anzi, è una
condizione umiliante a cui tu ti sottoponi solo se duranti quei
3 mesi hai modo di mantenerti in qualche altra maniera. O
facendoti un gran mazzo lavorando per chissà chi o avendo
alle spalle la solita famiglia generosa, che però ad una certa
età dovresti anche salutare e ringraziare. Ad ogni modo sì, in
Italia il dibattito non è così importante. In Italia passi anche
per rompicoglioni. Ad esempio se guardi sul mio blog, su
silviabencivelli.it, e apri il secondo articolo più cliccato, «Il
colpevole siamo noi», ci sono più di 100 commenti e la gente
quasi mi insulta dicendomi che non mi posso permettere di
dire certe cose perché questa cosa del mancato pagamento è
una garrota alla quale la gente non si diverte a sottoportsi ma
che è necessaria per realizzare i propri sogni. E poi la storia
dei sogni, il lavoro dei sogni è una stronzata. Io faccio il mio
lavoro ed alle volte faccio delle cose assolutamente pallose,
ma io ci devo campare, il lavoro non è un hobby. Non credo
che per inseguire il lavoro dei tuoi sogni puoi ritrovarti a 40
anni ancora a scrivere gratis. Anche se hai una famiglia
facoltosa alle spalle, ci sono altre persone che non se lo
possono permettere e magari sono molto più brave di te.
Allora tu non vieni scelto sulla base della tua bravura, ma
sulla base del fatto che tuo padre è generoso. Non mi pare un
sistema molto gratificante per diventare adulti.
319
EM: Un'ultima domanda. La ricercatrice e giornalista
americana Sarah Kendzior, che ho avuto il piacere di
intervistare, ritiene che questo fenomeno si collochi
all'interno di un quadro più ampio da lei definito "post-
employment economy", ovvero: lavori sottopagati o non
retribuiti diventati prassi in una società dove il continuo
richiamo alla crisi fa credere che tutto ciò sia un passaggio
inevitabile. Lo sfruttamento divenuto normalità. Credi che
l'antropologa americana abbia ragione e che questo sia ciò
che sta accadendo anche in Italia?
SB: Sì, mi sembra un buon punto. Aggiungo soltanto una
cosa, anche per lasciarti con un messaggio d’ottimismo. Io
vedo una grossa differenza tra la precarietà del mondo
intellettuale e il libero professionismo del mondo
intellettuale. La precarietà nel mondo intellettuale è una cosa
abbastanza rara e ha tutto un altro percorso. Ma per quelli
come me è tutto sommato normale e anche positivo che
lavorino da liberi professionisti con partita iva. Perché io
lavoro con partita iva per un sacco di soggetti diversi,
ciascuno di questi soggetti mi chiede aggiornamenti riguardo
a temi diversi e io cresco professionalmente avendone tanti.
Conviene a tutto il sistema. Quando la RAI mi fa lavorare a
partita iva, purché mi paghi decentemente senza far ricadere
su di me tutto il rischio professionale, mi permette di
ritagliarmi dell’altro tempo per studiare, per viaggiare, per
l’università, per cose che arricchiscono la mia cultura. E
siccome io vivo con la cultura, non posso pensare che il mio
futuro sia quello di dipendente in un unico posto. Voglio dire,
se un giorno una casa editrice mi assumerà io sarò felice, ma
al momento a me va benissimo avere la partita iva, purché sia
pagata in una maniera decente, perché ci vedo l’opportunità
320
di fare un percorso professionale che sia solo mio, che mi
arricchisca dal punto di vista culturale, che sia molto
personale e che crei una fisionomia professionale sul mio
mercato vincente e gratificante.
4.5.3 Francesco Sellari
Ho inoltre intervistato Francesco Sellari, un blogger e
freelance, che ha scritto per un periodo senza venire retribuito
decidendo poi di smettere.
Emanuele Mastrangeli: Perché per un periodo hai scritto
anche senza venire retribuito? Quando e per quale motivo hai
smesso di farlo?
Francesco Sellari: Ho scritto gratis per differenti realtà di tipo
editoriale: associazioni, siti internet più o meno importanti,
un quotidiano locale, in un paio di occasioni anche per un
cartaceo nazionale. Le motivazioni erano diverse: per la
necessità che sentivo di "fare la gavetta" di migliorarmi, di
scrivere meglio, più velocemente, imparando a seguire i
criteri più importanti del racconto giornalistico; per poter
entrare in contatto con dei professionisti; per la speranza di
poter entrare a far parte di progetti editoriali dai quali trarre
anche un beneficio di tipo economico. Ho smesso
innanzitutto perché la mia occupazione (lavoro da alcuni anni
in uffici stampa e comunicazione) e altri impegni non mi
hanno più consentito di farlo. E poi, nel momento in cui ho
visto riconosciuta la mia professionalità da realtà editoriali di
321
livello nazionale, la mia capacità di fare il mestiere del
giornalista, di saper riconoscere e trattare una notizia, ho
deciso di dare priorità a quei progetti che avrebbero potuto
assicurarmi un ritorno economico perlomeno dignitoso.
EM: Tralasciando le ragioni maggiormente legate all'ambito
professionale come possono essere la speranza di ottenere
una retribuzione in futuro, il desiderio di fare esperienza o di
ottenere visibilità, credi che il narcisismo possa giocare un
ruolo importante nel processo decisionale di coloro che
scrivono e non vengono pagati?
FS: Cos'è il narcisismo in questo ambito? Il desiderio di veder
pubblicata la propria firma su un quotidiano nazionale o su di
un importante sito internet? La ricerca del successo? La
volontà di diventare famosi? Sicuramente può influire un
certo desiderio di visibilità, più che altro figlio della necessità
di accumulare un "capitale reputazionale" da sfruttare nella
ricerca di lavoro e collaborazioni retribuite. Probabilmente ci
sono persone che pensano in questo modo di ottenere il loro
"quarto d'ora di notorietà" su internet ma credo che siano una
piccola minoranza. Oggi il narcisismo trova una valvola di
sfogo e più immediate gratificazioni nei meccanismi dei
social network.
EM: Non pensi che le aziende possano permettersi di offrire
"zero" anche perché ci sono persone che accettano di lavorare
non venendo retribuite? Ovvero, in altri termini, non credi
che se nessuno accettasse di scrivere gratis, gli editori
sarebbero costretti ad offrire un compenso?
FS: Mi sembra improbabile la concreta possibilità che non ci
sia più nessuno disposto a scrivere gratis, soprattutto on line.
E’, tra l'altro, l'ipotesi prospettata da quei giornalisti, più o
322
meno affermati, che quando hanno potuto hanno scritto
gratis, magari con le più nobili motivazioni, e che oggi
criticano i giovani, ingenui ma appassionati, che provano a
farsi strada nel giornalismo e vengono accusati di contribuire
a svalutare la professione.
Certo, se tale scenario si avverasse qualche editore potrebbe
essere costretto ad attivare qualche altra collaborazione
retribuita. Non posso escluderlo del tutto. Ma nell'attuale
contesto di difficoltà crescenti per gli editori, dovute
all'aumentata concorrenza e al crollo degli investimenti
pubblicitari, non posso neanche escludere che gli editori
potrebbero scegliere di continuare a risparmiare sul costo
delle risorse umane, aumentando il carico di lavoro sui
giornalisti in organico, pregiudicando ulteriormente la qualità
dell'informazione.
Poi bisognerebbe anche capire cosa si intende per "scrivere
gratis" oggi che l'informazione si fa sempre più on line.
Pubblicare su internet materiali a carattere informativo
significa quasi sempre contribuire ad aumentare il profitto di
un'azienda. I contenuti del più insignificante blog su una
qualsiasi piattaforma gratuita generano, indirettamente o
direttamente, profitti per l'azienda che tale piattaforma offre.
Questo non è forse scrivere gratis?
EM: Navigando in Internet ho notato come il dibattito
riguardo a questo fenomeno sia molto più intenso all'estero,
specie negli Stati Uniti, di quanto lo sia in Italia. Perché non
viene dato il giusto risalto a questa situazione?
FS: Una ragione potrebbe essere il fatto che ngli Stati Uniti
l'informazione on line - l'ambito nel quale è più diffuso il
lavoro non retribuito - è nata prima e prima ha raggiuto una
323
sua importanza e una sua rilevanza nel dibattito pubblico. Più
in generale, nel mondo anglosassone il giornalismo ha da
sempre un'autorevolezza che gli organi di informazione
italiana non hanno saputo guadagnarsi. Forse è anche per
questo motivo che lì il fatto che un giornalista scriva gratis,
eserciti cioè una professione fondamentale per una società
democratica, faccia più notizia che da noi dove i giornalisti
godono di pessima fama e per alcuni sono ancora dei
privilegiati.
EM: Ti rigiro la domanda che poni alla fine del tuo post: come
pensi si possa consentire a chi vuole fare questo mestiere di
non essere costretto a lavorare gratis?
FS: Il problema del lavoro non retribuito è un problema
comune alla stragrande maggioranza dei giovani, ovvero di
coloro che sono agli inizi della loro carriera professionale.
Faccio questa premessa per dire che, secondo me, alcune
misure necessarie a contrastare il ricorso al lavoro gratuito e
sottopagato nel giornalismo in realtà hanno una portata
generale e riguardano tutto il mercato del lavoro.
Bisognerebbe ad esempio fare in modo che gli stage, di
qualsiasi natura essi siano, prevedano sempre un rimborso
minimo, meglio se con standard fissati in sede europea.
Quindi questo dovrebbe valere anche per tutte le scuole di
giornalismo e soprattuto per quelle poche e costosissime
riconosciute dall'ordine. Se poi l'Ordine riconoscesse un
maggior numero di scuole, i costi da sostenere per
frequentarle sarebbero più accessibili. Questo invoglierebbe
più persone a tentare questa strada per accedere alla
professione, una strada la cui efficacia è tutta da verificare,
ma che perlomeno consentirebbe di fare esperienza nelle
redazioni e di arricchire il proprio portfolio di contatti
324
professionali, piuttusto che provare a scrivere gratis nella
speranza di essere notato.
Andrebbero poi sanzionate quelle realtà editoriali che hanno
fatto e continuano a fare un ricorso massivo al lavoro gratuito
promettendo in cambio la maturazione dei requisiti per
l'iscrizione nell'albo dei pubblicisti. Sono realtà note ai vari
Ordini dei Giornalisti regionali. Questo potrà significare
meno opportunità per potere ottenere il tesserino (e magari
contribuirà ad aprire una discussione sulla sua utilià e più in
generale sulle distinzioni tra i diversi albi) ma sicuramente si
potrà lanciare un segnale contro la vulgata che purtroppo per
poter coltivare la speranza di fare questo lavoro bisogna
accettare qualsiasi compromesso al ribasso.
Poi sarebbe da affrontare tutto il discorso sul sostegno
all'occupazione giovanile in questo settore. Per quelle poche
realtà che ancora ricevono contributi diretti per l'editoria se
ne potrebbe vincolare parte dell'erogazione alla stipula di
convenzioni per nuove collaborazioni retribuite o per percorsi
di inserimento professionale per i giovani. Se ci fosse la
volontà politica si potrebbero recuperare risorse per sostenere
nuovi progetti di giornalismo cooperativo destinate
principalmente ai giovani.
Se poi si volesse dare un segnale, visto che ormai il dibattito
è aperto, le testate e gli editori potrebbero impegnarsi con un
sorta di "carta di intenti" a non sfruttare collaborazioni
gratuite o sottopagate.
325
4.5.4 Valentina Orsini
Un’altra intervista è stata realizzata grazie alla gentile
collaborazione di Valentina Orsini, blogger di
CriticissimaMente. La giovane scrittrice, dopo un periodo in
cui ha accettato di collaborare anche gratuitamente pur di
provare ad avere successo nell’universo giornalistico, ha poi
deciso di aprire un blog personale. Così come Francesco
Sellari, Valentina Orsini respinge le accuse che vengono
rivolte alla manodopera, incolpando invece un sistema che
non offre opportunità al di fuori dello sfruttamento.
Emanuele Mastrangeli: Presentati: chi sei? cosa hai studiato?
quando hai iniziato a scrivere online? scrivere rappresenta la
tua fonte di sostentamento primaria?
Valentina Orsini: Presentarsi è sempre difficile, non sai mai
se quello che stai per raccontare di te possa davvero bastare a
far capire chi sei. Oppure semplicemente a convincere chi
legge che, fermarsi due minuti davanti alla tua storia, possa
valere la pena. Dico sempre che la mia storia non ha nulla di
particolare, anzi. E' solo lo specchio di una situazione che
mette tutti sullo stesso piano, e ci si riflette l'uno nell'altro. Mi
chiamo Valentina Orsini, sono una blogger, critico
cinematografico e speaker web radiofonica. Come si fa ad
essere tante cose insieme e nulla in sostanza? Questa è la
domanda che pongo a me stessa da un po' di tempo. Certo
quando mi iscrissi a Lettere, scegliendo con gli occhi gonfi di
gioia e speranze, il corso in Letteratura, musica e spettacolo,
non avevo in serbo domande. Mi sono laureata nel 2011, e ho
326
iniziato a scivere per una testata cartacea sportiva. Ero una
giornalista a tutti gli effetti, o meglio, quella sarebbe stata la
mia cosiddetta gavetta per arrivare lontano. O almeno
arrivare. Mi occupavo di calcio giovanile fino alla Serie D,
seguendo dalle tre alle sei partite ogni week end. Ovviamente
tutto a mie spese, a me la sola gloria di imparare ( a detta loro)
la professione e, ottenere il tanto ambito tesserino da
pubblicista. Così è stato per otto mesi, poi qualcosa mi ha
dato un motivo per fermarmi e pensare, valutare ciò che stavo
facendo. E capii che non era così che doveva essere. Non era
giusto. I miei articoli, così come quelli degli altri
collaboratori, riempivano le pagine di un giornale venduto
tutti i giorni a 1 euro. E a noi quale merito? Nel frattempo
diventavo madre. Ho abbandonato questa strada ed ho
iniziato a mandare curriculum in ogni dove, per fare però
quello che realmente sognavo di fare, scrivere di cinema. Chi
risponde e chi no. Finché qualcuno non inizia a dimostrare un
certo interesse, mi scrive proponendomi una collaborazione e
tutte, dico TUTTE le loro mail recitavano così: "La
collaborazione è da intendersi a titolo gratuito. Ma andrete al
cinema gratis". (Pensa...) Quale fortuna sotto i miei occhi
senza mai essermene accorta!
EM: Scrivi o hai mai scritto per altri siti al di fuori del tuo
blog? Se sì, sei o sei stata retribuita?
VO: C'ho provato, ho scritto per un paio di siti e un mensile
on line di critica cinematografica, poi ho lasciato tutto.
Durante un corso di Giornalismo culturale ho messo a fuoco
una possibilità diversa. Quella di investire su un progetto che
sarebbe stato solamente mio. Un blog. CriticissimaMente
nasce così, come uno spiraglio di luce nuova, un'opportunità
libera da vincoli dannosi e umilianti. Scrivere non è mai stata
327
la mia fonte di sostentamento primaria. No. Almeno non in
termini economici. Sono stata pagata per scrivere qualche
volta, le conto sul palmo di una mano. Mi hanno pagato 80
euro per recensire un determinato film, questo è accaduto tre
volte. Poi una volta, una nota tv mi ha chiesto di pubblicizzare
un servizio, e anche lì, previsto compenso. Scrivere mi
sostiene e mi salva la vita. Non mi fa campare, ma mi aiuta a
vivere. E' come un paradosso micidiale, dal quale non puoi
venir fuori. Forse è questo che mi ha spinto per un po' a farlo
senza pretese alcune. Ripenso a tutte le volte in cui la gente
mi ha riso in faccia: "Ah perché tu vuoi fare il critico
cinematografico come professione? Ahahah.". Sì, io
immaginavo una cosa del genere.
Con CriticissimaMente qualcosa è cambiato. Alla fine impari
ad andare avanti e ad alimentare le tue speranze, con l'affetto
dei lettori. Riesci a fare degli apprezzamenti, delle mail piene
di dimostrazione di stima e tante piccole cose, il compenso
più grande. Ma questo non basta per fare del tuo sogno la tua
professione. Io oggi ho 28 anni e sono madre di due bambini.
Una volta un amico giornalista mi ha detto che non avevo da
lamentarmi perché alla fine io avevo fatto la mia scelta.
Avevo scelto di diventare madre. Assurdo. Come se
realizzarsi nella vita fosse l'alternativa al diventare genitori.
Come se una cosa escludesse l'altra. Certo se ancora oggi
esistono persone che vedono questo nel futuro dei giovani, è
dura. Io non credo sia giusto alimentare e contribuire ad
allargare questo sistema. Perché saremmo non solo vittime,
ma anche carnefici di questa uccisione di massa ai danni della
cultura nel nostro paese.
EM: Nella tua risposta al post di Carlo Gubitosa scrivi: "noi
che scriviamo si, per passione, ma anche perché crediamo che
328
prima o poi, qualcuno, qualcosa, si smuova". Come credi che
le cose possano cambiare?
VO: Quando parlai con Gubitosa ero ancora piena di rabbia e
coraggio. Convinta che avrei cambiato il mondo. A distanza
di un anno non è che io non condivida più quanto detto
nell'articolo. Ammetto che scrivere gratis sia sbagliato, ma
continuo a non tollerare quell'atteggiamento che condanna le
vittime di questo sistema, senza cercare una soluzione. Perché
non aiuta, non cambia le cose. Un giovane aspirante
giornalista o critico che sia, oggi, in Italia, ha due possibilità:
accettare lo sfruttamento che duri due anni e sentirsi pure
colpevole della morte della professione, oppure rinunciare.
Fare in modo che in quella tanto sospirata casta di
professionisti nessuno entri, nessuno esca. Perché l'Italia è
così. Un circolo vizioso e asfissiante. Una stanza buia e
senz'aria. La scelta è la nostra salvezza, ma scegliere non è
mai semplice. Io oggi non mi vergogno di dire che scrivo per
passione. E' stata una mia scelta. Una di quelle che fai, ed è
qui il vero male, quando davanti non hai alternative. (Scrivo
per passione, ma non dimentico mai di ricordare a me stessa
quali siano, da sempre, le mie vere ambizioni).
Le cose possono cambiare eccome. Ma finché si continua a
cercare la colpa (sbagliando) e non il rimedio, la vedo dura.
Il lavoro è lavoro. Tutti i giovani che stanno scrivendo ora, e
sognano di farne una professione, non devono buttarsi e
cedere a baratti ignobili. "Tu scrivi per me però vai al cinema
gratis". Non esiste! Il mio consiglio e la mia speranza è che
nessuno più faccia del proprio talento, la propria passione.
("Non si accontenti di sopravvivere. Lei deve pretendere di
vivere in un mondo migliore, non soltanto sognarlo". Penso a
329
un film di Ozpetek, regista che tra l'altro neanche amo.
La finestra di fronte).
4.5.5 Emanuele De Vito
Ho ritenuto fosse interessante proporre anche delle
interviste realizzate con degli aspiranti giornalisti. I due
ragazzi a cui ho posto le mie domande hanno portato la loro
testimonianza evidenziando le difficoltà che incontrano
coloro che desiderano avvicinarsi alla professione. Il primo
ragazzo intervistato, Emanuele De Vito, laureando presso
l’Università degli Studi di Roma Tre, sottolinea la propria
disillusione prodotta dalla conoscenza ravvicinata dei sistemi
di accesso alla professione.
Emanule Mastrangeli: Presentati: chi sei? cosa hai studiato?
Emanuele De Vito: Ciao, sono Emanuele, ho 23 anni e sto
studiando Scienze della Comunicazione presso l’Università
degli Studi di Roma Tre, a breve conseguirò la laurea con una
tesi in Filosofia Politica sulla Crisi della Democrazia.
EM: Come e perché hai iniziato a scrivere? Per chi lo fai o lo
hai fatto?
EDV: Ho iniziato a scrivere perché, come molti che hanno
deciso di intraprendere questo corso di studi, avevo il sogno
di diventare giornalista. La conoscenza un po' più ravvicinata
di questo mondo, insieme a una serie di eventi esterni, mi ha
fatto però cambiare idea. Ho scritto per un periodo di circa un
330
anno per due giornali. Il primo era uno dei quotidiani locali
della mia città, Salerno, dove mio cugino in passato, lui poi
diventato in seguito giornalista professionista, aveva iniziato
a praticare la professione. E' stato un mio familiare dunque a
presentarmi al direttore. Il secondo era un magazine a tiratura
nazionale riguardante il fenomeno ultras, a cadenza
quattordicinale. In questo caso, andai io a presentarmi dal
direttore. Per quanto ne ricordi, alcuni miei articoli sono stati
pubblicati anche su alcuni siti, ma senza alcuna regolarità.
EM: Sei o sei mai stato retribuito per il tuo lavoro? Se non lo
sei, perché hai accettato?
EDV: No, ed aggiungo ovviamente no. In quel giornale e in
altri nella mia citta tutto il lavoro fatto prima del
conseguimento del titolo di pubblicista era quasi sempre non
retribuito, o pagato somme ridicole che però ti legavano
giorno e notte alla redazione. Il capitolo retribuzione non è
mai stato neanche sfiorato da nessuno dei miei “datori di
lavoro”, anche se neanche mi sento di chiamarli cosi' data la
precarietà del “rapporto lavorativo”. Pur trattandosi di un
lavoro a tempo pieno a tutti gli effetti, ho cercato di vivere
l'esperienza più come uno stage dove imparare il mestiere.
Dovendo io conseguire il tesserino di giornalista pubblcista,
la mia “paga” era la possibilita' di scrivere per questa testata
e di avere cosi la possibilita di conseguire il titolo di
giornalista. Ovviamente poi dopo due anni il direttore
avrebbe dovuto firmare un foglio dichiarando che la mia paga
era stata di tot, come la procedura per conseguire il titolo
prevede. Non sono mai arrivato a quel punto, ma questa era
la pratica standard. Condizioni simli per tutti coloro che
dovevano iniziare. Il lavoro era comunque abbastanza duro,
a volte anche 7 giorni a settimana, ed ero spesso in redazione
331
a svolgere a volte anche il lavoro dei redattori: impaginare,
titolare e correggere strafalcioni altrui. A volte per motivi
giornalistici mi recai anche con mezzi personali in luoghi
della provincia distanti piu di 80 km dal capoluogo nonché
mio luogo di residenza: ovviamente nessun rimborso venne
mai dato. Accettai perché, essendo già a conoscenza del
funzionamento, non avevo alcuna aspettativa riguardante
l'aspetto retributivo.
EM: Ritieni sia giusto scrivere gratis per blog o testate for-
profit?
EDV: Domanda retorica: lavorare gratis non e' mai giusto.
Tuttavia, il settore è in crisi dato che le entrate sono sempre
meno (carta stampata) e su Internet non si è ancora riusciti a
trovare un modo remunerativo di scrivere se non tramite
marketing e pubblcità.
EM: Non credi che questo fenomeno inquini il mercato?
EDV: E' ovvio che questo fenomeno inquina il mercato. E'
chiaro che, essendo quella da me descrita la situazione
(almeno nella mia città e nella mia regione), solo chi ha una
famiglia dietro che mantiene può permetttersi di
intraprendere questa via. E’ chiaro che se solo chi appartiene
alla classe benestante e dominante svolge questo mestiere,
centrale per la salute della democrazia stessa, il modo in cui
lui o lei vede il mondo o lo riporta rispecchierebbe la visione
del mondo della classe dominante stessa, andando poi quindi
il giornalista a perdere quella funzione di critica sociale, di
cane da guardia della democrazia, che dovrebbe svolgere. La
situazione e' un po' meno tragica di come la descrivo,
fortunatamente. Ma questa, ahimé, e un po’ la situazione
italiana qualcunque mestiere uno prenda in considerazione,
332
ovvero il non essere pagati per i primi anni quando si
comincia a lavorare.
4.5.6 Lorenzo Fusco
L’altro ragazzo intervistato, laureato presso l’Università
degli Studi di Roma Tre, sottolinea invece come l’amore per
la professione l’abbia spinto a cercare di trovare la propria
strada anche senza essere pagato.
Emanuele Mastrangeli: Presentati: chi sei? Cosa hai studiato?
Lorenzo Fusco: Mi chiamo Lorenzo Fusco e sono dottore in
Lettere Primarie ed Italianistica presso l'Università degli
Studi di Roma Tre.
EM: Perché hai iniziato a scrivere?
LF: Ho iniziato a scrivere per la grande passione che mi ha
sempre spinto verso la letteratura, la linguistica e il
giornalismo, soprattutto quello su carta stampata.
EM: Come hai iniziato a scrivere?
LF: Ho cominciato con il sito di informazione sportiva
calcioweb.com. Si trattava di una agenzia di stampa che, a
cavallo degli anni '90 e 2000, era tra le prime nel campo
dell'informazione sportiva in Italia. Poi, l'assenza di fondi ha
costretto l'agenzia a cessare la propria attività. Il sito, però,
non ha mai smesso di esistere. E' rimasto nelle mani di un
unico proprietario che, coincidenza ha voluto, è stato anche il
333
mio insegnante di giornalismo in un corso privato tenuto
presso i locali di una nota emittente radiofonica.
EM: Sei mai stato retribuito per il tuo lavoro?
LF: Ovviamente no. Inizialmente il lavoro sul portale era
finalizzato ad esercitare la scrittura per l'agenzia di stampa.
Successivamente, però, abbiamo deciso di avviare un serio
progetto di riqualifica del sito per farlo ritornare ad essere
quello di un tempo. In questa seconda fase, ho assunto non
solo il ruolo di articolista ma anche di caporedattore.
Nonostante la nuova qualifica assunta, però, anche in questo
caso, non si è mai parlato di paga.
EM: Allora perché hai accettato?
LF: Perché il progetto era nato all'interno di un corso di
formazione di un anno e dunque in un clima familiare. Non
mi sembrava il caso di rifiutare. Le intenzioni e le ambizioni,
poi, mi sembravano serie e importanti e il mio amore per la
professione giornalistica mi ha convinto ancora di più.
Inoltre, se dovevo scrivere gratuitamente, tanto valeva farlo
per una persona che conoscevo e di cui mi fidavo, che mi
avrebbe sicuramente aiutato a diventare pubblicista.
EM: Ritieni sia giusto scrivere gratis per blog o testate no
profit?
LF: A mio giudizio, dipende dalle situazioni. Nel mio caso,
non posso certo dire di essermi sentito “sfruttato”. Stesso
discorso nel caso di chi considera la scrittura su blog o testate
giornalistiche, principalmente come un passatempo. Per tutti
gli altri casi, certo, non lo ritengo assolutamente giusto.
EM: Non credi che questo fenomeno inquini il mercato?
334
LF: Assolutamente si, perché si produce una corsa al ribasso
che sminuisce il giornalismo sia dal punto di vista economico
che dal punto di vista professionale, ed è un peccato. Perché
questa è la base su cui si fonda il sistema giornalistico
italiano. Se la base è corrotta, poi non ci si può lamentare se
esistono pochi e troppo osannati giornalisti veri in Italia.
335
5 L’estero e la situazione economica e
sociale
«We unfortunately can’t pay you for it, but we do reach 13
million readers a month553». Potere in qualche modo riportare
l’espressione facciale di Nate Thayer, giornalista freelance,
di fronte all’offerta ricevuta dalla global editor di Atlantic,
Olga Khazan, sarebbe maggiormente significativo di tante
righe d’inchiostro. Il freelance, così come spiega un post
pubblicato sul suo blog NateThayer che riporta passo dopo
passo lo scambio di email tra lui e Olga Khazan, ha rispedito
l’offerta al mittente554.
«Thanks Olga:
I am a professional journalist who has made my living
by writing for 25 years and am not in the habit of
giving my services for free to for profit media outlets
so they can make money by using my work and efforts
by removing my ability to pay my bills and feed my
children. I know several people who write for the
Atlantic who of course get paid. I appreciate your
553 «Purtroppo non ti possiamo pagare, ma raggiungiamo 13 milioni di
lettori al mese». Thayer N., A Day in the Life of a Freelance Journalist—
2013 in natethayer.wordpress.com, 4 marzo 2013
(http://natethayer.wordpress.com/2013/03/04/a-day-in-the-life-of-a-
freelance-journalist-2013/). 554 Atlantic ha chiesto a Nate Thayer di riadattare un suo pezzo («25 Years
of Slam Dunk Diplomacy: Rodman trip comes after 25 years of basketball
diplomacy between U.S. and North Korea») pubblicato su NKNews.org.
336
interest, but, while I respect the Atlantic, and have
several friends who write for it, I have bills to pay and
cannot expect to do so by giving my work away for
free to a for profit company so they can make money
off of my efforts. 1200 words by the end of the week
would be fine, and I can assure you it would be well
received, but not for free. Frankly, I will refrain from
being insulted and am perplexed how one can expect
to try to retain quality professional services without
compensating for them. Let me know if you have
perhaps mispoken555».
Con estrema tranquillità Olga Khazan ha sottolineato
come il giornale non disponesse di fondi da dedicare ai
freelance. Tuttavia, molti giornalisti secondo la global editor
555 «Grazie Olga: sono un giornalista professionista che ha
avuto come sostentamento primario la scrittura per 25 anni
e non è mia abitudine concedere i miei servizi
gratuitamente a gruppi mediatici for-profit in modo che
loro possano fare soldi utilizzando il mio lavoro e i miei
sforzi eliminando invece la mia capacità di pagare le mie
bollette e sfamare i miei figli. Conosco diverse persone che
scrivono per Atlantic e che vengono naturalmente pagate.
Apprezzo il vostro interessse, ma, anche se rispetto
Atlantic, e nonostante abbia molti amici che scrivono per
esso, ho bollette da pagare e non posso pensare di farlo
concedendo il mio lavoro gratis ad un’azienda for-profit per
consentire loro di fare soldi grazie ai miei sforzi. 1200
parole entro la fine della settimana andrebbero bene, e
posso assicurarti che le riceveresti, ma non gratis.
Francamente, mi asterrò dall’essere insultato e sono
perplesso riguardo a come qualcuno possa aspettarsi di
provare a ottenere servizi professionali di qualità senza
pagare. Fammi sapere se ti sei spiegata male». Ibidem.
337
di Atlantic utilizzano il sito come cassa di risonanza per
godere di visibilità e per questo motivo riteneva che Nate
Thayer sarebbe potuto essere interessato alla proposta556. Ma
così non è stato:
«I am sure you are aware of the changing,
deteriorating condition of our profession and the
difficulty for serious journalists to make a living
through their work resulting in the decline of the
quality of news in general. Ironically, a few years
back I was offered a staff job with the Atlantic to write
6 articles a year for a retainer of $125,000, with the
right to publish elsewhere in addition […]. I am sure
you can do what is the common practice these days
and just have one of your interns rewrite the story as
it was published elsewhere, but hopefully stating that
is how the information was acquired. If you ever are
556 «I completely understand your position, but our rate even for original,
reported stories is $100. I am out of freelance money right now, I enjoyed
your post, and I thought you’d be willing to summarize it for posting for
a wider audience without doing any additional legwork. Some journalists
use our platform as a way to gain more exposure for whatever professional
goals they might have, but that’s not right for everyone and it’s of course
perfectly reasonable to decline». Ovvero: «Capisco perfettamente la tua
posizione, ma la nostra tariffa persino per storie originali è di 100 $. Non
dispongo di fondi per i freelance al momento, mi è piaciuto il tuo pezzo e
ho pensato che avresti accettato di riassumerlo per pubblicarlo per un
pubblico più ampio senza dover fare nessun lavoro aggiuntivo. Alcuni
giornalisti utilizzano la nostra piattaforma per guadagnare visibilità per
qualsiasi interesse professionale loro possano avere, ma questo non è
giusto per tutti ed è perfettamente ragionevole rifiutare». Ibidem.
338
interested in a quality story on North Korea and wiling
to pay for it, please do give me a shout557».
Nate Thayer ha deciso di pubblicare lo scambio di email
per offrire una testimonianza delle condizioni in cui versa il
lavoro giornalistico nei nostri giorni. La situazione all’estero,
al contrario di quanto si potrebbe credere, non è affatto
migliore di quella italiana; ma il dibattito, specie negli Stati
Uniti è molto più intenso, con giornalisti e antropologi che si
interrogano riguardo al fenomeno e si schierano contro o a
favore di quest’ultimo.
557 «Sono certo che tu sia consapevole delle diverse e
deteriorate condizioni in cui versa la nostra professione e
della difficoltà dei giornalisti seri di vivere del proprio
lavoro e del risultato dell’abbassamento qualitativo
dell’informazione. Ironicamente, alcuni anni fa, mi venne
offerto un lavoro da Atlantic per scrivere 6 articoli in un
anno per un compenso di 125.000 $ […]. Sono certo che tu
possa fare quella che è la pratica più comune al giorno
d’oggi e chiedere ad uno dei tuoi redattori interni di
riscrivere la storia così come è stata pubblicata altrove, ma
possibilmente esplicitando come l’informazione è stata
ottenuta. Se mai dovessi essere interessata ad una storia di
qualità sulla Corea del Nord e volessi pagare per essa,
contattami pure». Ibidem.
339
5.1 Who pays writers? Il dibattito fuori
dall’Italia
Quasi nessuno, si potrebbe rispondere. La domanda che dà
il nome al paragrafo è così attuale che un sito di
crowdsourcing558 si occupa – tramite i vari contributi dei
partecipanti – di fotografare la situazione riportando il
tariffario di siti e riviste. Il sito, gestito da una blogger
chiamata Manjula Martin, esprime la propria missione con
queste parole: «A place to list whether, and how much,
magazines and websites pay their writers. We'll post 'em as
you report 'em. Intended to be informational, not
judgmental559». Who pays writers? è un infinito elenco dove
ogni post riporta la retribuzione offerta da un dato sito o una
data rivista. Ecco alcuni esempi:
558 Il crowdsourcing (da crowd, "folla", e outsourcing, "esternalizzazione
di una parte delle proprie attività") è un modello di business nel quale
un’azienda o un’istituzione affida la progettazione, la realizzazione o lo
sviluppo di un progetto, oggetto o idea ad un insieme indefinito di persone
non organizzate precedentemente. Questo processo viene favorito dagli
strumenti che mette a disposizione il web. Il crowdsourcing inizialmente
si basava sul lavoro di volontari ed appassionati che dedicavano il loro
tempo libero a creare contenuti e risolvere problemi. La community open
source è stata la prima a trovarne beneficio. L'enciclopedia Wikipedia
viene considerata da molti un esempio di crowdsourcing volontario.
Fonte: Wikipedia. 559 «Un posto dove riportare se, e quanto, riviste e siti pagano i loro
scrittori. Li pubblicheremo così come li riportate. Questo spazio vuole
esssere informativo, non giudicante». Who pays writers? in
whopays.tumblr.com, (http://whopays.tumblr.com/).
340
«Vintage Life Magazine
Report: “Doesn’t Pay—will give you an
advertisement” in exchange for an 800-word feature
in 2013.
RELEVANT Magazine
Report: 10 cents/word for print, nothing for web
“unless it’s commissioned/short deadline/urgent.”
VICE
Report: $75 for a 1200-word feature. “Thoughtful
edits, which is nice.”
Vanity Fair, circa 1992
Blast from the past: A writer reports recurring
assignments for pieces on pop culture/ “hip new
things” at $2 a word for 150-300 words. “Aahhh, the
good ole days”560».
560 «Vintage Life Magazine – Reseconto: “Non paga – ti
offrei uno spazio pubblicitario” in cambio di un pezzo di
800 parole nel 2013. Relevant Magazine – Resoconto: 10
centesimi a parola per la carta stampata, niente per il web
“a meno che non sia commissionato/a breve
scadenza/urgente”. VICE – Resconto: 75 $ per un pezzo di
1200 parole. “Modifiche ponderate, che è apprezzabile”.
Vanity Fair, 1992 – Tuffo nel passato: uno scrittore riporta
incarichi ricorrenti per pezzi sulla cultura pop/nuove cose
341
Who pays writers? può rappresentare un ottimo strumento
per entrare nel merito della questione. All’estero, in particolar
modo negli Stati Uniti, il fenomeno ha una rilevanza di gran
lunga maggiore nell’agenda mediatica rispetto all’Italia.
Sono stati già riportati ed analizzati casi eclatanti come quello
di Nate Thayer o l’azione legale dei blogger guidati da
Jonathan Tasini nei confronti dell’Huffington Post. Il
dibattito va in scena su testate di primissimo piano come
possono essere Atlantic o The New York Times. Dalle pagine
online del giornale newyorkese è arrivata una denuncia molto
forte, firmata da Tim Kreider. Il suo articolo «Slaves of the
Internet, Unite!561» ha dato il via ad un dibattito intenso
ospitato dal palcoscenico di Twitter, oltre ad aver generato
repliche illustri su altre testate. «I received, in a single week,
three (3) invitations to write an original piece for publication
or give a prepared speech in exchange for no ($0.00)
money562». Kreider sottolinea immediatamente come sia
diventata una prassi la pretesa di ottenere un lavoro senza un
esborso economico nel momento in cui si parla di
giornalismo. Il canovaccio, poi, è sempre lo stesso: «They
often start by telling you how much they admire your work,
alla moda” a 2 $ a parola per 150-300 parole. “Aahhh, i
vecchi tempi”», ibidem. 561 «Schiavi di Internet, Unitevi!». Krieder T., Slaves of the
Internet, Unite! In nytimes.com, 26 ottobre 2013
(http://www.nytimes.com/2013/10/27/opinion/sunday/slav
es-of-the-internet-unite.html?_r=1&). 562 «Ho ricevuto, in una sola settimana, tre (3) inviti a
scrivere un pezzo originale per la pubblicazione o a
concedere un discorso in cambio di nessun soldo (0.00 $)».
Ibidem.
342
although not enough, evidently, to pay one cent for it.
“Unfortunately we don’t have the budget to offer
compensation to our contributors...” is how the pertinent line
usually starts. But just as often, they simply omit any mention
of payment563». Così come pertinentemente sottolineato da
Silvia Bencivelli, anche Kreider evidenzia come la moneta
più utilizzata sul Web sia la visibilità, dal giornalista chiamata
exposure. E pur non nascondendo il fatto che spesso le
richieste di esecuzione di un lavoro non retribuito provengano
da persone che realmente non dispongono di un budget
adeguato564, Krieder attacca tanto gli editori senza scrupoli
sempre pronti a risparmiare laddove possibile, quanto chi a
suo modo partecipa a rendere tutto ciò possibile: coloro che
accetano di lavorare gratis565. In questo senso il pensiero di
563 «Spesso iniziano dicendoti quanto ammirano il tuo lavoro, sebbene
non abbastanza, evidentemente, da pagare un centesimo.
“Sfortunatamente non disponiamo di un budget per offrire un compenso
ai nostri collaboratori…” è la formula utilizzata solitamente. Ma molto
spesso, semplicemente non viene menzionato nulla riguardo al
pagamento». Ibidem. 564 «In fairness, most of the people who ask me to write things for free,
with the exception of Arianna Huffington, aren’t the Man; they’re editors
of struggling magazines or sites, or school administrators who are
probably telling me the truth about their budgets». Ovvero, «In tutta
onestà, la maggior parte delle persone che mi chiede di scrivere cose
gratuitamente, con l’eccezione di Arianna Huffington, non sono l’Uomo;
sono editori di riviste o siti in difficoltà, oppure amministratori scolastici
che stanno probabilmente dicendo la verità riguardo ai loro fondi».
Ibidem. 565 «I know there’s no point in demanding that businesspeople pay artists
for their work, any more than there is in politely asking stink bugs or
rhinoviruses to quit it already. It’s their job to be rapacious and shameless.
But they can get away with paying nothing only for the same reason so
many sleazy guys keep trying to pick up women by insulting them:
because it keeps working on someone. There is a bottomless supply of
343
Krieder si colloca sul solco di quanto scritto da Carlo
Gubitosa e l’appello che il giornalista americano lancia alla
fine del suo pezzo ricorda quello pubblicato dallo stesso
Gubitosa sul suo sito:
«So I’m writing this not only in the hope that everyone
will cross me off the list of writers to hit up for free
content but, more important, to make a plea to my
younger colleagues. As an older, more accomplished,
equally unsuccessful artist, I beseech you, don’t give
it away. As a matter of principle. Do it for your
colleagues, your fellow artists, because if we all
consistently say no they might, eventually, take the
hint. It shouldn’t be professionally or socially
acceptable — it isn’t right — for people to tell us, over
and over, that our vocation is worthless566».
ambitious young artists in all media who believe the line about exposure,
or who are simply so thrilled at the prospect of publication that they’re
happy to do it free of charge». Ovvero, «So che non ha senso domandare
a uomini d’affare di pagare gli artisti per il loro lavoro, non più di quanto
ne abbia chiedere cortesemente alle cimici o al rhinovirus di andarsene. Il
loro lavoro richiede di essere rapaci e senza vergogna. Ma loro possono
andarsene senza aver pagato nulla solamente per la stessa ragione per cui
così tanti ragazzi malfamati continuano a provare di abbordare donne
insultandole: perché continua a funzionare su qualcuno. C’è un
rifornimento senza fondo di giovani artisti ambiziosi in tutti i media che
credono nella visibilità, o che sono semplicemente così eccitati dall’idea
di essere pubblicati che sono felici di farlo gratuitamente». Ibidem. 566 «Sto scrivendo tutto questo non solamente nella speranza che tutti mi
cancellino dalla lista di scrittori da contattare per contenuti gratuity ma,
più importante, per lanciare un appello ai miei giovani colleghi. In qualità
di artista più anziano, più esperto e ugualmente fallito, vi imploro, non
darlo via. Per una questione di principio. Fallo per i tuoi colleghi, per i
344
Tuttavia, i professionisti del settore non sono unanimi
nell’accogliere e condividere appelli di questo tenore567. C’è
chi crede che l’esposizione garantita dalla vetrina dei siti sia
una moneta di valore (Dan Lewis), chi ritiene che scrivere
tuoi compagni artisti, perché se noi dovessimo tutti insieme
dire di no loro potrebbero, eventualmente, recepire il
messaggio. Non dovrebbe essere né provfessionalmente né
socialmente accettabile – non è giusto – che delle persone
ci dicano, ancora e ancora, che la nostra vocazione non ha
valore». Ibidem. 567 Altra importante presa di posizione sulla falsariga di
Krieder è quella di Kathleen Geier che dalle pagine online
di Washington Monthly scrive: «The reason I insist on
being paid for my writing is not only because my time and
services are valuable and doing unpaid work for someone
else is insulting. There’s also a principle of solidarity at
work. Every time a writer agrees to work for free, she drives
down writers’ wages and makes it harder for other writers
to make an adequate living from their craft». Ovvero, «La
ragione per cui insisto nell’essere pagata per I miei lavori
non è solamente che il mio tempo e miei servizi hanno
valore lavorare gratuitamente per qualcun altro è offensive.
C’è anche un principio di solidarietà al lavoro. Ogni volta
che uno scrittore accetta di lavorare gratis, abbassa gli
stipendi degli altri scrittori e rende più difficile per gli altri
scrittori vivere del proprio lavoro». Geier K., Op-ed of the
day: Tim Kreider in the New York Times, “Slaves of the
Internet, Unite!” in washingtonmonthly.com, 27 ottobre
2013 (http://www.washingtonmonthly.com/political-
animal-
a/2013_10/oped_of_the_day_tim_kreider_in047523.php).
345
gratis in determinate circostanze possa rivelarsi molto utile
(Daniel D’Addario), chi pur deprecando il lavoro non
retribuito pensa che pretendere che nessuno accetti più di
collaborare gratuitamente sia utopico (Derek Thompson). E
ancora, all’estremo opposto rispetto a un Gubitosa o un
Krieder, si trova chi crede che i cambiamenti tecnologici,
economici e sociali rendano il fenomeno inevitabile,
irreversibile e al contempo tutt’altro che dannoso (Mathew
Ingram), o chi ritiene che la scrittura gratuita sia un enorme
benificio per la società (Matthew Yglesias).
Dan Lewis dalle pagine di Medium fa sapere che
l’esposizione, la visibilità offerta da alcune piattaforme può
portare – percorrendo vie secondarie – dei guadagni. E’
quanto è successo a lui e al suo progetto, decollato grazie alla
cassa di risonanza ottenuta tramite la scrittura di pezzi non
retribuiti. «The goal of “exposure” isn’t “experience” or to
add to the “I’ve written at X, Y, and Z” line on your resume.
It’s to convert some of the publisher’s audience to your own.
That’s it568». Esistono due regole imprescindibili secondo
Lewis per perseguire quest’obiettivo: in primo luogo l’editore
deve dimostrare che la sua piattaforma verrà utilizzata per
deviare parte del pubblico verso lo spazio gestito dal
collaboratore; dall’altra parte quest’ultimo deve fare in modo
di sfruttare l’esposizione ottenendo un beneficio a lungo
termine. Lewis, alla fine del suo post, sottolinea come grazie
alla visibilità sia diventato uno scrittore in grado di 568 «L’obiettivo della visibilità non è l’esperienza o il poter aggiungere
“Ho scritto su X, Y e Z” sul vostro curriculum vitae. L’obiettivo è far
diventare parte del pubblico dell’editore il vostro pubblico. Tutto qui».
Lewis D., It’s Totally Okay to Write Stuff for Free to Get Exposure…if
that’s what you’re actually doing in medium.com, 28 ottobre 2013
(https://medium.com/i-m-h-o/1b361d512b5).
346
guadagnare dalla propria attività: ha pubblicato un libro, ha
qualche cliente pagante, gestisce una pubblicazione
all’interno della quale può piazzare degli annunci
pubblicitari. Quello che Lewis sembra però non considerare
è che quanto ha vissuto in prima persona non può essere
trasformato in una legge universale. Nessuno nega che
l’esposizione possa portare dei benefici, ma nella maggior
parte dei casi questi hanno effetti trascurabili, se non
inesistenti. In primo luogo perché affinché la visibilità offerta
da un sito sortisca un effetto, il traffico dello stesso dev’essere
importante. In altri termini, quali risultati si possono ottenere
accettando un’offerta di lavoro non retribuita da parte di una
realtà online frequentata da qualche decina di utenti? Esiste
una contraddizione difficilmente risolvibile a tal proposito:
l’esposizione ha valore569 solamente nel momento in cui il
blog o la testata generino un traffico di un certo spessore, ma
traffici intensi accumulano guadagni altrettanto importanti,
quindi per quale motivo si dovrebbe concedere il proprio
lavoro gratuitamente in favore di imprese che producono dei
capitali sostanziosi? Secondo Daniel D’Addario, giornalista
di Salon, il quale si schiera contro l’appello lanciato da
Krieder su The New York Times, dal momento che la
situazione della professione è radicalmente cambiata e le
opportunità si sono ridotte e impoverite, in alcuni casi diviene
inevitabile scrivere senza ricevere un compenso. Quando un
giovane scrittore dovrebbe scrivere gratis?570 Si chiede
569 Manca in ogni caso la certezza di ricevere in cambio qualche beneficio.
Si tratta comunque di un investimento con alto coefficiente di rischio, al
contrario di un pagamento sicuro e prestabilito. 570 D’Addario D., When should a young writer write for free? In
salon.com, 29 ottobre 2013
347
D’Addario nel suo post. La risposta è che a volte non può non
farlo. Se il sistema funziona secondo queste logiche, i giovani
non possono che attraversare il lavoro non retribuito come
una tappa che non è possibile aggirare. Dalle righe di Salon,
D’Addario attacca Krieder e il suo j’accuse nei confronti di
coloro che accettano di scrivere gratuitamente. La colpa,
spiega D’Addario, è degli editori, non di coloro che vivono
una situazione di sfruttamento, sottopagati e condannati al
precariato. Anche Derek Thompson dalle pagine online di
Atlantic cerca di confutare alcune delle posizioni esposte da
Krieder. In primo luogo, a Thompson preme sottolineare
come scrivere non sia equiparabile ad altri lavori,
semplicemente perché in fondo tutti scrivono gratis. Della
stessa idea è anche Farhad Manjoo, un giornalista americano
che lavora per il Wall Street Journal (figura 28).
«You might not think you do, but you almost certainly
do. Maybe you publish opinions and thoughts on
Facebook and Twitter. Maybe you have diary, a
Tumblr, or a personal blog, to share ideas and work
out theories. Maybe you write long letters or emails or
talks to colleagues, students, newspapers, mentors,
and mentees. This is all free writing. Sometimes, it is
done on sites with paid advertising, sometimes with
sites with editors, sometimes in private windows and
notebooks, and while writing is never "easy," it is
easier than ever, and so it is done, often free of charge,
all over the place. The Web is awash with words, and
if everybody insisted on publishing only those words
(http://www.salon.com/2013/10/29/when_should_a_young_writer_write
_for_free/).
348
agreed upon by paid contract, the Internet and the
world of letters would be considerably more
empty571».
(figura 28 – Il tweet di Farhad Manjoo572)
571 «Potresti non credere di farlo, ma quasi certamente lo
fai. Forse pubblici opinioni e pensieri su Facebook e
Twitter. Forse hai un diario, un Tumblr, o un blog
personale, dove condividi idee e sviluppi teorie. Forse
scrivi lunghe lettere o email o chiacchiere a colleghi,
student, giornali, mentori e allievi. Tutto ciò è scrittura
gratuita. A volte, questo viene fatto su siti che hanno
annunci pubblicitari a pagamento, a volte su siti che hanno
degli editori, a volte su finestre private e mentre scrivere
non è mai “facile”, è comunque più facile di quanto lo sia
mai stato e per questo viene fatto, spesso gratuitamente,
ovunque. Il Web è inondato da parole e se tutti insistessero
nel pubblicare solamente quelle parole concordate tramite
un contratto retribuito, Internet e il mondo delle lettere
sarebbe considerabilmente più vuoto». Thompson D.,
Writing for Free in theatlantic.com, 28 ottobre 2013
(http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/10/wri
ting-for-free/280918/). 572 «Le persone scrivono gratis. Succede in ogni momento.
Perciò se gestisci una rivista e non stai chiedendo alle
persone di scrivere gratis, stai sbgliando».
349
Leggendo le parole di Derek Thompson risulta inevitabile
collegare questo articolo con il caso di Nate Thayer, al quale
– come descritto in precedenza – è stato proposto di adattare
un pezzo per Atlantic senza ricevere un compenso; infatti, il
pezzo firmato da Thompson è pubblicato sullo stesso giornale
statunitense. Al di là di questa considerazione, la posizione
del giornalista di Atlantic mostra più di una falla, o quanto
meno più di una omissione. Thompson inserisce senza
criterio nello stesso calderone un post su Facebook, una email
inviata ad un amico e il lavoro non retribuito, condito da
commissioni, scadenze, regolamentazioni, direttive. Il
giornalista ricorda più avanti che scrivere è anche una
professione e in quanto tale la sua natura possa scontrarsi con
l’idea di un lavoro svolto senza un compenso economico.
Tuttavia, nonostante egli ritenga che gli scrittori andrebbero
pagati, Thompson rifiuta l’idea che scrivere gratis sia un
problema tout court. «So, do websites that accept free writing
foreclose our industry to people who can't afford to write for
free, or open our industry to anybody who wants to write for
free? Maybe both573». Il giornalista di Atlantic omette un
passaggio: nessuna posizione critica, come ad esempio quella
di Krieder, afferma che scrivere gratuitamente sia sbagliato
in ogni sua accezione, dalla scrittura su un blog privato alla
concessione di articoli verso siti no-profit; bensì, si cerca di
esprimere il dissenso etico, morale e professionale nei
573 «Quindi, i siti che accettano la scrittura non retribuita
precludono l’accesso alla nostra industria alle persone che
non possono permettersi di scrivere gratis, oppure aprono
la nostra industria a chiunque voglia scrivere
gratuitamente? Forse entrambe le cose». Ibidem.
350
confronti del lavoro non retribuito svolto a favore di imprese
for-profit. Secondo Thompson nel momento in cui scrivere
gratis sul Web aumenta il numero di contenuti disponibili –
al di là del livello qualitativo –, il fenomeno non può essere
considerato negativo. Mentre sotto tutt’altra luce vengono
visti i tirocinii non retribuiti:
«The fact that so many people write for free, all the
time, sits uncomfortably with the fact that writing is
also, occasionally, a profession. And we have, in this
country, a fairly clear sense that work deserves
compensation. This is, for example, why I consider
unpaid internships morally repugnant, since we're
essentially asking that entry-level jobs, for which
there is a minimum wage, be performed for free
because somebody replaced the word "job" with
"internship”574».
Quello che Thompson non riesce a spiegare con
sufficiente convinzione– volontariamente o meno – è la
natura della differenza tra il giornalismo e la scrittura in un
senso più generale e le altre professioni. Il fatto che chiunque
574 «Il fatto che così tante persone scrivano gratuitamente, in ogni
momento, non si concilia con il fatto che scrivere sia anche,
occasionalmente, una professione. E noi abbiamo, in questo paese,
un’idea sufficientemente chiara che il lavoro debba essere retribuito.
Questo è il motivo per cui, ad esempio, io considero i tirocinii non pagati
moralmente disdicevoli dal momento che stiamo essenzialmente
chiedendo che lavori che consentono l’accesso, per i quali esiste una paga
minima, vengano svolti gratuitamente per il solo motivo che qualcuno ha
rimpiazzato la parola “lavoro” con la parola “tirocinio”». Ibidem.
351
abbia scritto e scriva qualcosa gratuitamente in determinati
contesti è un argomento fuorviante a sostegno della tesi che
il giornalista di Atlantic cerca di proporre. Anche Carlo
Gubitosa respinge l’idea di un giornalismo qualitativamente
differente dalle altre professioni: «Io non credo che il mio
tempo, il valore della mia esperienza professionale, delle
tecniche che ho imparato, del mestiere che ho accumulato in
questi vent’anni che scrivo sia inferiore al valore
professionale dell’avvocato[…]. Ognuno di noi sviluppa un
tipo diverso di scrittura […] però non vedo perché debba
esserci questo divario nel compenso di un avvocato e quello
di un giornalista575». Un esempio chiarirà meglio questa presa
di posizione. Si pensi alla cucina. Internet, tra le tante
rivoluzioni messe in atto, ha consentito di accedere ad un
database di ricette sterminato. Ogni piatto che si vuole
riproporre viene accompagnato da descrizioni testuali,
fotografie e video, oltre a collegamenti ipertestuali che
rimandano ad altre capacità eventualmente richieste dalla
ricetta576. Diventare dei buoni cuochi richiede solamente un
pizzico di impegno e laddove manchino le abilità manuali e
la predisposizione, si potrebbe comunque compensare con la
conoscenza. Molte persone cucinano in casa propria per la
famiglia o gli amici senza ricevere un compenso, ma questo
non implica che un cuoco in un ristorante debba o possa
lavorare senza venire retribuito. Il ristorante è un’impresa for-
profit che offre dei servizi dietro un pagamento e dove parte
del totale dei guadagni viene speso per il costo della
manodopera. La pretesa di un datore di lavoro di far lavorare
575 Estratto dall’intervista fatta a Carlo Gubitosa. 576 Ad esempio, se un utente volesse cimentarsi nella preparazione di una
quiche, potrebbe volere utilizzare una pasta brisé fatta in casa, piuttosto
che comprarla già pronta.
352
gratis un proprio dipendente perché esistono migliaia di
persone che cucinano in casa senza venire pagate sarebbe
etichettata come follia. Ma se questo stesso datore di lavoro
potesse contare su delle persone disposte a lavorare nel suo
ristorante senza venire retribuite, la proposta del principale
assumerebbe un’altra prospettiva: pur continuando ad essere
eticamente e moralmente inaccettabile, si approprierebbe di
una valenza pratica differente. Ne consegue che la differenza
tra il giornalismo e gli altri lavori non è qualitativa, non è
intrinsica, ma figlia di uno stato di cose a sua volta derivante
da processi che verranno più avanti analizzati. Il ricatto
dell’editore è possibile nel momento in cui esiste una
disponibilità di produttori di contenuti che non comportano
alcun esborso, che è stata generata da fattori che ne hanno
favorito l’esplosione. Ma né Derek Thompson, né nessun
altro, ha spiegato per quale motivo il giornalista sia diverso
dal cuoco, se non per il fatto che esistono persone disposte,
per svariate ragioni, a svolgere questa professione
gratuitamente; anche e soprattutto perché hanno l’opportunità
e il modo di farlo. E allora il tutto si riduce ad una legge di
mercato, come quella descritta da Silvia Bencivelli nel suo
articolo pubblicato su Linkiesta. «Why do people write for
nothing? – si chiede Mathew Ingram sulle pagine di
PaidContent – Is it because some capitalistic conspiracy has
decided that their work is of no value, as many of Kreider’s
supporters seem to think? No. In some cases it’s because they
like to do it, and don’t need the money. In other cases it’s
because writing helps publicize other things that make money
[…]577». Le cose sono cambiate, sottolinea Ingram, e se da
577 «Perché lo fanno? È forse perché qualche complotto capitalista ha
deciso che il loro lavoro non ha alcun valore, come molti dei sostenitori
di Kreider sembrano pensare? No. In alcuni casi è perché gli piace farlo ,
353
una parte il fenomeno crea problemi ad alcune persone,
dall’altra molte altre stanno avendo la possibilità di fare
qualcosa che amano raggiungendo un pubblico di una certa
portata o interagendo con altri autori578: And that’s not a bad
thing at all. Non è affatto male, sostiene Ingram. Soprattutto
perché non sembra esserci grande differenza qualitativa tra i
contenuti prodotti dietro pagamento e quelli gratuiti, come
sostiene Hunter Walk, un ex membro dello staff di YouTube
in uno scambio di Tweet con lo stesso Ingram (figura 29).
e non hanno bisogno di soldi. In altri casi è perché la scrittura aiuta a
pubblicizzare altre cose che invece fanno fare soldi». Ingram M., No,
writing for free isn’t slavery, and other misconceptions about the
economics of online media in paidcontent.org, 28 ottobre 2013
(http://paidcontent.org/2013/10/28/no-writing-for-free-isnt-slavery-and-
other-misconceptions-about-the-economics-of-online-media/). 578 «Is this a bad state of affairs for many people? Sure it is, just as the
amateurization of photography and other fields is difficult for some
professionals in those fields. But it’s arguably good for many others —
some of whom can now create a life that includes doing something they
love, reaching an audience or connecting with other artists, and maybe
even getting paid for it». Ovvero, «E ‘una brutta situazione per molte
persone? Certo che lo è, proprio come la amatorizzazione della fotografia
(ad esempio) crea forti difficoltà per molti professionisti del settore. Ma è
senza dubbio un bene per molti altri – alcuni dei quali possono ora crearsi
una vita in cui c’ è anche la possibilità di fare qualcosa che si ama,
raggiungendo un pubblico o collegandosi con altri artisti , e che forse
potranno anche essere pagati per questo». Ibidem.
354
(figura 29 – Il tweet di Hunter Walk rivolto a Mathew
Ingram579)
Tuttavia, anche il giornalista di PaidContent aggira il
punto cruciale attorno a cui ruota la tesi di Krieder – così
come quella di Gubitosa e di altri –, ovvero che la scrittura
gratuita e il giornalismo professionale potrebbero
tranquillamente convivere e perfino alimentarsi a vicenda.
Quel che si cerca di combattere è il lavoro non retribuito
svolto a favore di imprese for-profit, non la scrittura online
tout court. «If you do enjoy writing and you don't have a
money-making writing opportunity, you should definitely be
writing for free. The tough choice is whether you want to
write for free for some other publications or just under your
own header580». Rispondendo alla constatazione di Matthew
579 «Ma come mai l’apparente differenza di qualità tra coloro che scrivono
per soldi e coloro che scrivono gratis è così sottile?». 580 «Se ti piace scrivere e non hai un’opportunità di lavoro che possa farti
guadagnare, dovresti assolutamente scrivere gratis. La scelta difficile è se
vuoi farlo gratis per altre pubblicazioni o solamente sotto la tua stessa
355
Yglesias apparsa sulle pagine di Slate, se la scelta ricadesse
sul rifiuto della concessione di contenuti gratuiti in favore di
imprese for-profit, ne gioverebbero tutti (figura 30): i
giornalisti professionisti, che non vedrebbero il proprio
lavoro dequalificato e sottopagato (o non pagato affatto); i
freelance, i blogger, gli appassionati e quant’altro, che
otterrebbero qualcosa dai propri sforzi oltre all’esposizione e
a qualche complimento; i lettori, che disporrebbero forse di
un minor numero di contenuti, ma di maggiore qualità581; gli
editori, per la stessa ragione legata alla qualità media dei
contenuti. Perché, dopotutto, l’obiettivo primario delle
imprese resta quello di offrire un servizio qualitativamente
alto. Oppure no?
guida». Yglesias M., People Writing for Free on the Internet Is an
Enormous Boon to Society in slate.com, 5 marzo 2013
(http://www.slate.com/blogs/moneybox/2013/03/05/writing_for_free_on
_the_internet_it_s_a_huge_boon_to_society.html). 581 In un mercato non inquinato in cui i contenuti sono pagati, quei lavori
che non spingono all’esborso forse non spiccano per qualità. E in ogni
modo potrebbero essere pubblicati gratuitamente su piattaforme personali
o no-profit.
356
(figura 30 – Un tweet di Ted Weinstein582, un autore e agente
letterario americano)
5.2 A new economy: cosa è cambiato
Si è fatto riferimento, disseminando in più occasioni delle
tracce, a dei cambiamenti strutturali, di carattere tecnologico,
economico e sociale, che hanno favorito e consentito
l’emergere del fenomeno del lavoro non retribuito, in
particolar modo quello giornalistico, di interesse primario in
questa sede. La prima parte di questa ricerca ha analizzato in
maniera approfondita le modifiche che la professione ha
dovuto metabolizzare a causa dell’evoluzione tecnologica di
Internet, strumento che ha ridefinito le regole giornalistiche e
ridisegnato le competenze del singolo professionista. Ma la
Rete ha fatto molto di più, contribuendo per sua stessa natura
582 «Se ogni scrittore smettesse di scrivere gratis, gli editori dovrebbero
pagare o non pubblicare più».
357
all’esplosione del fenomeno che è oggetto di studio di questo
lavoro. Quando sono state analizzate le diverse vesti del
giornalismo online, è stato evidenziato come il Web abbia
ospitato forme di comunicazione, ancora prima che forme
giornalistiche, rivoluzionarie. Internet ha messo nelle mani di
ogni singolo utente una chiave che per un’infinità di anni era
stata in possesso di un’oligarchia inarrivabile, una chiave che
ha consentito ad un pubblico precedentemente relegato ad un
ruolo passivo di interagire prima, di creare poi. Bisogna
riconoscere che la professione giornalistica, o la scrittura in
un’accezione più generale, ha sempre esercitato un grande
fascino, forse anche perché alimentata nel tempo da una serie
di mitologie non esattamente corrispondenti alla realtà. E’
questo il punto che a molti critici preme sottolineare, come
mostrato nel paragrafo precedente: ci sarà sempre qualcuno
disposto a scrivere gratuitamente, per svariati motivi. C’è di
più: ci sono sempre state persone che avrebbero voluto
scrivere pur non venendo retribuite. La differenza è che negli
ultimi anni tutto ciò è diventato possibile grazie a Internet,
che ha letteralmente aperto le porte del paradiso. «I suppose
people who aren’t artists assume that being one must be fun
since, after all, we do choose to do it despite the fact that no
one pays us. They figure we must be flattered to have
someone ask us to do our little thing we already do. I will
freely admit that writing beats baling hay or going door-to-
door for a living, but it’s still shockingly unenjoyable
work583», scrive Tim Krieder nel suo articolo per The New
583 «Immagino che le persone che non sono artisti pension che esserlo
debba essere divertente dal momento che, dopotutto, noi scegliamo di
farlo nonostante nessuno ci paghi. Immaginano che noi dobbiamo essere
lusingati di avere qualcuno che ci chieda di fare questa cosa insignificante
che già facciamo. Ammetto candidamente che scrivere sia meglio di
358
York Times. Rimane semplicemente un lavoro, si potrebbe
aggiungere, soprattutto nel momento in cui esistono delle
direttive, delle commissioni, delle scadenze, degli orari e
quant’altro. Ma ciò che si para dinnanzi ai sostenitori delle
idee di Jonathan Tasini, Carlo Gubitosa, Silvia Bencivelli,
Tim Krieder – per citarne alcuni – è una new economy, una
serie di cambiamenti strutturali che hanno trasformato il
mercato nell’arena del ribasso. «There will always be people
who want to write for free – scrive Mathew Ingram –, and
that’s not necessarily a bad thing. Unless, of course, you are
one of those writers who used to profit from the lack of
marketplace competition584». La morte di una professione,
secondo Ingram, is not necessarily a bad thing. E potrebbe
aver ragione, se il mercato editoriale fosse completamente
avulso da logiche economiche, se la sepoltura della
professione e la nascita di uno spazio corale non
contribuissero al consueto arricchimento di pochi. In tal caso,
coloro che cercano di combattere questo fenomeno
accetterebbero il cambiamento figlio dell’evoluzione
tecnologica e cesserebbero di gridare all’ingiustizia. Ma la
new economy, in questo senso, indossa solamente un vestito
nuovo, mantenendo intatte le vecchie abitudini di un
raccogliere il fieno o fare porta-a-porta per campare, ma rimane
comunque un lavoro assolutamente non divertente». Krieder T., Slaves of
the Internet, Unite! In nytimes.com, 26 ottobre 2013 (cit.). 584 «Ci saranno sempre persone che vorranno scrivere gratis, e questa non
è necessariamente una brutta cosa. A meno che, ovviamente, tu non sia
uno di quegli scrittori che guadagnava grazie alla mancanza di
competizione sul mercato». Ingram M., The new economics of media: If
you want free content, there’s an almost infinite supply in
paidcontent.org, 6 marzo 2013 (http://paidcontent.org/2013/03/06/the-
new-economics-of-media-if-you-want-free-content-theres-an-almost-
infinite-supply/).
359
capitalismo che trattiene per i suoi vertici la quasi totalità
della ricchezza.
La veste della new economy è caratterizzata da un dominio
della domanda, come la definisce Ingram. «The reality is that
media or content broadly speaking has gone from being
primarily supply-driven to almost totally demand-driven, and
that has changed the economics in some fundamental
ways585». L’abbondanza, per utilizzare le parole del teorico
dei media Clay Shirky, pesa nel cambiamento molto più della
scarsità. Questo perché, come scrive Ann Michael su The
Scholarly Kitchen, «we know how to ration, save, and
preserve when we need to do so. It’s much harder to set
priorities and find our path when information abounds. We
may drown. We may get side-tracked. We may shut down.
But, in any case, abundance confuses and distracts us more
than scarcity does586». La new economy si è quindi plasmata
in un contesto di abbondanza in cui il valore dell’offerta è
crollato: «Writing hasn’t become free or cheap because no
585 «La realtà è che i media o il contenuto in senso lato sono passati da
una situazione di monopolio dell’ offerta a una situazione, opposta, di
dominio della domanda, che ha radicalmente cambiato i dati economici
essenziali del settore». Ingram M., No, writing for free isn’t slavery, and
other misconceptions about the economics of online media in
paidcontent.org, 28 ottobre 2013 (cit.). 586 «Sappiamo come razionare, risparmiare e preservare quando
dobbiamo farlo. È molto più complicata scegliere delle priorità e trovare
il nostro percorso quando l’informazione abbonda. Potremmo affogare.
Potremmo essere depistati. Potremmo arrestarci. Ma, in ogni caso,
l’abbondanza ci confonde e distrae molto di più di quanto faccia la
scarsità». Michael A., Shirky at NFAIS: How Abundance Breaks
Everything in scholarlykitchen.sspnt.org, 2 marzo 2010
(http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/03/02/shirky-at-nfais-how-
abundance-breaks-everything/).
360
one wants it any more, it has become free or cheap because
there is so much of it that its intrinsic value has eroded — and
the advertising content that used to help pay the freight for
that writing has eroded just as quickly587». Un’abbondanza
che ha privato l’offerta non solamente di un valore
economico, ma anche di un valore che si potrebbe definire
intellettuale, estetico, artistico. Internet è diventato infatti
anche palcoscenico della trasformazione delle opere
artistiche, tutte raccolte sotto la fredda etichetta di
“contenuti”.
«The first time I ever heard the word “content” used
in its current context, I understood that all my artist
friends and I — henceforth, “content providers” —
were essentially extinct. This contemptuous coinage
is predicated on the assumption that it’s the delivery
system that matters, relegating what used to be called
“art” — writing, music, film, photography,
illustration — to the status of filler, stuff to stick
between banner ads588».
587 «La narrazione non è diventata gratuita o poco costosa perché nessuno
la vuole più ma perché ce n’ è così tanta in circolazione che il suo valore
intrinseco è stato eroso – e il contenuto pubblicitario che serviva per
sostenere la diffusione della scrittura ha perso valore altrettanto
rapidamente». Ingram M., No, writing for free isn’t slavery, and other
misconceptions about the economics of online media in paidcontent.org,
28 ottobre 2013 (cit.). 588 «La prima volta che ho sentito la parola “contenuto” utilizzato nel suo
senso corrente, ho capito che io e tutti i miei amici artisti – poi divenuti
“fornitori di contenuti” – eravamo essenzialmente estinti. Questo
srezzante neologismo si basa sul presupposto che è il sistema di consegna
che conta, relegando quello veniva definita “arte” – scrittura, musica,
361
Il fenomeno della scrittura non retribuita affonda le sue
radici in un terreno che trascende la professione giornalistica
e cui si è fatto cenno sul finire della prima parte di questa
lavoro. La realtà descritta in queste pagine si colloca nel più
ampio contesto di quella che l’antropologa, ricercatrice e
scrittrice americana Sarah Kendzior definisce post-
employment economy. Ho avuto il piacere e l’onore di porle
qualche domanda via email e utilizzerò stralci delle risposte
per arricchire il comparto informativo della realtà che si cerca
di descrivere, infine riporterò l’intervista integrale.
5.3 The post-employment economy
«From every institution in the United States, there is a
message broadcast on all channels to America’s educated
youth that hopes to enter active economic life, ‘Dude, why
are you all hung up on money? RELAAAAAAAX!”. Take a
step back, take a deep breath and consider this message in the
context of the rest of American life. Are you breathing?
WOW, WHAT AN AMAZING LOAD OF BULLSHIT589».
film, fotografia, illustrazione – allo stato di riempitivo, roba
da attaccare in mezzo a degli annunci pubblicitari». Krieder
T., Slaves of the Internet, Unite! In nytimes.com, 26 ottobre
2013 (cit.). 589 «Da ogni istituzione degli Stati Uniti, arruva un
messaggio diffuso in tutti i canali rivolto alla gioventù
americana istruita che spera di entrare a far parte della vita
economica, “Ehi, perché siete tutti ossessionati dai soldi?
362
Eric Garland, autore americano e direttore di Transitionistas,
non utilizza mezzi termini nel suo post intitolato «Sexy dirty
money». Il riferimento è alla realtà degli Stati Uniti, ma le
affinità con le condizioni economiche e sociali
dell’Occidente, Italia compresa, sono tali che il suo
messaggio può facilmente travalicare i confini americani.
«Money matters in America590». I soldi sono importanti in
America. Non solamente lì, si potrebbe aggiungere. Sarebbe
bello se così non fosse, ma questo slancio idealistico non
cambia la realtà dei fatti. I soldi contano, chi lo nega mente
oppure ha le spalle economicamente ben coperte. Eppure, c’è
chi – le istituzioni, chi detiene il potere economico, le imprese
– vuole convincere del contrario. «They are looking at
America’s young people and honestly asking with a straight
face - hey, what do you need money for, anyway? YOU
SHOULD BE FULFILLED JUST TO BE WORKING
HERE! YOU’RE LUCKY TO HAVE A CHANCE…591».
Per gran parte dei giovani laureati – americani e non –
l’accesso al mondo del lavoro è stato rimpiazzato da un
susseguirsi di tirocinii non retribuiti. Questo sistema è
diventato nel tempo consuetudine: «In one generation,
working for free for people who can pay you went from
something laughable, to something wealthy people were
Calma!”. Fate un passo indietro, prendete un respire profondo e
considerate questo messaggio in relazione al resto della vita americana.
State respirando? Wow, che incredibile cazzata!». Garland E., Sexy dirty
money in transitionistas.com, 6 marzo 2013
(http://www.transitionistas.com/2013/03/06/sexy-dirty-money/). 590 Ibidem. 591 «Guardano ai giovani americani e gli chiedono onestamente e
sinceramente – hey, a cosa ti servono i soldi, in ogni caso? Dovresti
sentirti appagato solo per il fatto di lavorare qui! Sei fortunato ad avere
un’opportunità…». Ibidem.
363
doing in a few fields, to something everyone was
recommended to do, to something almost everyone has to do.
Entry-level jobs were replaced with unpaid internship592».
Sarah Kendzior ha descritto il fenomeno definendolo scam,
ovvero un imbroglio, su Twitter. Questi i 10 tweet pubblicati
dalla studiosa americana che hanno attirato grande attenzione
e alimentato un interessante dibattito:
«Here is how the internship scam works. It’s not about
a “skills” gap. It’s about a morality gap.
1) Make higher education worthless by redefining
“skill” as a specific corporate contribution. Tell young
people they have no skills.
2) With “skill” irrelevant, require experience. Make
internship sole path to experience. Make internships
unpaid, locking out all but rich.
3) End on the job training for entry level jobs.
Educated told skills are irrelevant. Uneducated told
they have no way to obtain skills.
4) As wealthy progress on professional career path,
middle and lower class youth take service jobs to pay
off massive educational debt.
592 «In una sola generazione lavorare gratis per persone che possono
permettersi di pagare si è trasformato da qualcosa di divertente, in
qualcosa che persone benestanti facevano in qualche campo, poi in
qualcosa che veniva raccomandato di fare, infine in qualcosa che quasi
tutti devono fare». Bakkila S., Why You Should Never Have Taken That
Prestigious Internship in polycimic.com, 14 giugno 2013
(http://www.policymic.com/articles/48829/why-you-should-never-have-
taken-that-prestigious-internship).
364
5) Make these part-time jobs not “count” on resume.
Hire on prestige, not skill or education. Punish those
who need to work to survive.
6) Punish young people who never found any kind of
work the hardest. Make them untouchables —
unhireable.
7) Tell wealthy people they are “privileged” to be
working 40 hrs/week for free. Don’t tell them what
kind of “privileged” it is.
8) Make status quo commentary written by unpaid
interns or people hiring unpaid interns. They will tell
you it’s your fault.
9) Young people, it is not your fault. Speak out. Fight
back. Bankrupt the prestige economy593».
593 «Così funziona l’imbroglio dei tirocinii. Non è un
problema di mancanza di capacità. È un problema di
moralità. 1) rendere l’istruzione di alto livello inutile
ridefinendo la capacità come uno specificio contributo
aziendale. Dire ai giovani che non hanno capacità. 2) Una
volta rese unitili le capacità, richiedere l’esperienza.
Rendere i tirocinii l’unica strada per fare esperienza.
Rendere i tirocinii non retribuiti, escludendo tutti al di fuori
dei ricchi. 3) Porre fine all’apprendistato per le posizioni
d’ingresso. Agli istruiti viene detto che le capacità non
contano nulla. Ai non istruiti viene detto che non hanno
possibilità di maturare quelle capacità. 4) Mentre i
benestanti fanno strada, i giovani delle classi medie e
povere fanno lavori umili per saldare gli ingenti debiti
maturati per la loro istruzione. 5) Rendere questi lavori
part-time inutili sui curricula. Assumere sulla base del
prestigio, non per le abilità o l’istruzione. Punire coloro che
hanno bisogno di lavorare per sopravvivere. 6) Punire il più
severamente possibili i giovani che non hanno mai trovato
365
Il fenomeno del giornalismo online non retribuito si
muove anche in questo scenario più ampio, che coinvolge
altre professioni, legate o meno all’utilizzo della Rete. Lo
sottolinea Francesco Sellari nell’intervista che ho realizzato
con lui: «Il problema del lavoro non retribuito è un problema
comune alla stragrande maggioranza dei giovani, ovvero di
coloro che sono agli inizi della loro carriera professionale.
Faccio questa premessa per dire che, secondo me, alcune
misure necessarie a contrastare il ricorso al lavoro gratuito e
sottopagato nel giornalismo in realtà hanno una portata
generale e riguardano tutto il mercato del lavoro». Si tratta
del post-employment economy che Sarah Kendzior definisce
come: «[…]the replacement of steady jobs that pay a living
wage with contingent and poorly paid or unpaid labor – and
the expectation that this is normal, and that these positions are
a required stepping stone to a “real job”. People no longer
work for pay, they pay to work594». Il risultato prodotto da
lavoro. Renderli intoccabili – non assumibili. 7) Dire alle
persone benestanti che sono dei priveligati siccome
lavorano 40 ore settimanali gratuitamente. Non dire loro
che tipo di privilegio esso sia. 8) Fare il modo che il
commento della situazione sia scritto dai tirocinanti non
pagati o dalle persone che assumano tirocinanti non pagati.
Ti diranno che è colpa vostra. 9) Giovani non è colpa
vostra. Ditelo. Reagite. Fate fallire l’economia del
prestigio». Kendzior S., The moral bankruptcy of the
internship economy in sarahkendzior.com, 9 giugno 2013
(http://sarahkendzior.com/2013/06/09/the-moral-
bankruptcy-of-the-internship-economy/). 594 «E’ il rimpiazzo di lavori sicuri che permettono il
sostentamento con altri temporanei sottopagati o non pagati
affatto – e l’idea che questo sia normale e che queste
366
questa situazione, come giustamente sottolinea l’antropologa
americana, non è semplicemente la svalutazione
dell’istruzione o delle capacità, ma quella delle persone595.
Un elemento cruciale utilizzato per sostenere questo sistema
è il continuo richiamo alla crisi. La contingenza che richiede
dei sacrifici, delle rinunce inevitabili. Ma la situazione è
realmente questa? Where is all the money going? Dove vanno
i soldi? Chiede Sarah Kendzior in un suo articolo pubblicato
su Al Jazeera596. L’Huffington Post – dopo essere stato
ceduto per oltre 300 milioni di dollari ad AOL – non può
permettersi di sborsare una cifra superiore allo zero per i
contributi dei suoi blogger? L’Atlantic, con i suoi 13 milioni
di lettori, non poteva offrire un compenso a Nate Thayer per
il riadattamento del suo pezzo sulla Corea del Nord? Eppure,
Sarah Kendzior scrive: «The Atlantic is two things every
legacy publishing company would like to be: profitable and
more reliant on digital advertising revenues than on print [...].
2012 brought the Atlantic a record profit, beating out the
record profit of 2011, with 59 percent of earnings coming
from digital revenues597». La sperequazione economica, pur
posizioni siano un passaggio inevitabile per raggiungere un “vero lavoro”.
Le persone non lavorano più per guadagnare, ma pagano per lavorare».
Questa risposta è presa dall’intervista che ho fatto a Sarah Kendzior. 595 «It is not skills or majors that are being devalued. It is people». Ovvero,
«Non sono le capacità o le università che vengono svalutate. Sono le
persone». Kendzior S., Surviving the post-employment economy in
aljazeera.com, 3 novembre 2013, (cit.). 596 Kendzior S., Managed expectations in the post-employment economy
in aljazeera.com, 12 marzo 2013 (cit.). 597 «L’Atlantic può suscitare l’invidia di ogni impero mediatico per due
motivi: produce dei guadagni e i suoi introiti derivanti dalla pubblicità
online superano quelli del cartaceo […]. Il 2012 ha portato ad Atlantic un
367
venendo considerate ingiusta, perde la sua efficacia
argomentativa nel momento in cui il continuo richiamo alla
crisi ha convinto dell’assolutà normalità della situazione. E’
per questo che Sarah Kendzior definisce la crisi economica
come una crisi che ha manipolato le aspettative delle
persone598; in questo contesto lavorare senza venire pagati
diviene normalità. O, per utilizzare il pungente sarcasmo di
Eric Garland, si potrebbe dire:
«You’re only 28. Or 33. You have a long career ahead
of you. You can get paid later! After all, we don’t have
budget for interns this year. We used that money to
increase executive pay at a rate five times greater than
the cost of living. Because the economy is terrible
right now! And we’re at all time record highs of
corporate cash reserves and profits. But it’s terrible!
Hey – why are you getting angry? YOU KIDS
TODAY EXPECT SO MUCH!599».
guadagno record, battendo quello precedente del 2011, con il 59% delle
entrate derivanti dalla versione digitale». Ibidem. 598 «The economic crisis is a crisis of managed expectations. Americans
are being conditioned to accept their own exploitation as normal».
Ovvero, «La crisi economica è una crisi di aspettative manipulate. Gli
americani sono stati convinti a considerare il loro stesso sfruttamento
come normale». Ibidem. 599 «Hai solo 28 anni. O 33. Hai una lunga carriera davanti a te. Puoi essere
pagato più avanti! Del resto, non abbiamo un budget per i tirocinanti
quest’anno. Abbiamo utilizzato quei soldi per aumentare le paghe dei
dirigenti fino a cinque volte tanto il costo della vita. Perché l’economia è
terribile in questo periodo! E noi abbiamo profitti record! Ma è terribile!
Hey – perché vi state arrabbiando? Voi ragazzi al giorno d’oggi vi
aspettate troppo!». Garland E., Sexy dirty money in transitionistas.com, 6
marzo 2013 (cit.).
368
Di fronte a questa situazione, ho chiesto a Sarah Kendzior
cosa potrebbe essere fatto concretamente. Secondo la
ricercatrice americana:
«People are already organizing and working for
change […]. We need to realize that almost everyone
is suffering from the same economic plight – it is only
a matter of degrees. People need to stand up for each
other and form broader coalitions. We also need to
address problems without shame. Exploiters should
feel ashamed, not the exploited. Feelings of shame,
humiliation keep people from discussing their
personal situation, but it helps people to know they are
not alone600».
Secondo Sarah Kendzior per quanto concerne l’universo
della scrittura online, il risveglio collettivo si trova ad un
livello più avanzato rispetto ad altri campi lavorativi, anche
600 «Le persone si stanno già organizzando e stanno già
lavorando per il cambiamento […]. Dobbiamo realzzare
che quasi tutti stiamo soffrendo la stessa situazione
economica – è solo una questione di livelli. Le persone
lottare anche per gli altri e formare delle coalizioni.
Dobbiamo anche nominare il problema senza vergogna. Gli
sfruttatori dovrebbero vergognarsi, non gli sfruttati.
Sentimenti di vergogna, umiliazione impediscono alle
persone di discutere la loro situazione personale, ma le
persone vengono aiutate dal fatto di sapere che non sono
sole». Questa risposta è presa dall’intervista che ho fatto a
Sarah Kendzior.
369
grazie a prese di posizione pubbliche come quelle contro
l’Huffington Post o l’Atlantic.
«Media is an interesting field, because you are finally
seeing some pushback in terms of unpaid and
exploited labor, which you are not yet seeing in policy
and other fields. You can also track the erosion in
quality in online publications that do not pay their
writers.
The idea that a journalist should not be paid anything
for their work — that “exposure” is an acceptable
currency — is very recent and is a product of the
recession. It stemmed both from a loss of revenue for
media companies throughout the 2000s, peaking in
2008, and from the desperation of young writers who
could not find jobs in media but wanted their names
in print […].
What I am seeing now is the rejection of prestige for
money. I see writers who used to work for the
Atlantic, HuffPost or other non-paying publications
move to lesser-known publications that do pay. The
quality of the paying publications is going up, while
the quality of the non-paying publications is going
down, because you get what you pay for. There are
exceptions to this on both ends, but basically it is
true601».
601 «Quello mediatico è un campo interessante, perché
finalmente si vede qualche ribellione per quanto riguardo il
lavoro non pagato e sfruttato, cosa che non si vede in altri
campi professionali. È possibile inoltre notare un crollo
qualitativo nelle pubblicazioni online che non pagano i loro
370
Si conceda spazio ad un ultimo caso che ritengo sia
meritevole di essere visionato602. La protagonista
dell’accaduto è Danielle Lee, una ricercatrice della Oklahoma
State University che, tra le altre cose, gestisce un blog
chiamato The Urban Scientist603. Venerdì 11 ottobre 2013, la
biologa riceve una email da un redattore di un blog chiamato
biology-online.com, descritto come tra i più seguiti nel campo
scientifico grazie ai suoi visitatori mensili pari a circa 1,6
milioni di utenti unici. Ofek – così si presenta il redattore del
blog – si dichiara affascinato dal blog gestito da Danielle e
chiede alla ricercatrice di entrare a far parte della schiera di
guest blogger di Biology Online tramite qualche piccolo
contributo mensile. In prima istanza la biologa della
scrittori. L’idea che un giornalista non dovrebbe essere
pagato per il proprio lavoro – che la visibilità sia una
moneta accettabile – è molto recente ed è il prodotto di una
recessione. Deriva sia dal calo degli introiti dei media
durante gli anni 2000, in particolar modo nel 2008, sia dalla
disperazione dei giovani scrittori che non potevano trovare
un lavoro ma volevano il loro nome sulla stampa […].
Quello che vedo ora è il rifiuto del prestigio e la richiesta di
soldi. Vedo scrittori che lavoravano per l’Atlantic, per
l’Huffington Post o per altre compagnie che non pagano i
propri dipendenti andare a lavorare per pubblicazioni meno
famose ma che pagano. La qualità dei pezzi pagati sale,
mentre quella dei lavori non pagati sta scendendo, perché
alla fine ottieni quello che paghi. Ci sono eccezioni da
ambo le parti, ma grossomodo è vero». Bakkila S., Why You
Should Never Have Taken That Prestigious Internship in
polycimic.com, 14 giugno 2013 (cit.). 602 Ringrazio la gentilissima Silvia Bencivelli per la
segnalazione. 603 http://blogs.scientificamerican.com/urban-scientist/.
371
Oklahoma State University si dichiara interessata, decidendo
così di chiedere ad Ofek l’ammontare della retribuzione. La
replica del redattore del blog scientifico è molto chiara: i
guest blogger non vengono pagati, ma possono godere di
grande visibilità e aumentare il proprio traffico personale
ottenendo poi di riflesso un accrescimento degli introiti
pubblicitari. La replica della dott.ssa Lee è molto civile:
«Thank you very much for your reply. But I will have to
decline your offer. Have a great day. DnLee604». La reazione
del redattore di Biology Online non è stata invece altrettanto
civile (figura 31).
(figura 31 – La risposta di Ofek e la successiva reazione della
dott.ssa Lee)
604 «Grazie per la sua risposta. Ma devo declinare la sua offerta. Buona
giornata. DnLee». Lee D., Responding to No name Life Science Blog
Editor who called me out of my name in scientificamerican.com, 11
ottobre 2013 (http://blogs.scientificamerican.com/urban-
scientist/2013/10/11/give-trouble-to-others-but-not-me/).
372
Danielle Lee, dopo essere stata etichettata come “puttana”,
ha deciso di pubblicare lo scambio di email online, così come
delle foto e un video605 che mostrano la sua reazione.
«Seriously, all anger aside…this rationalization of working
for free and you’ll get exposure is wrong-headed. This is
work. I am a professional. Professionals get paid. End of
story. Even if I decide to do it pro bono (because I support
your mission or I know you, whatevs) – it is still worth
something606». La storia si è conclusa con le scuse del team
di Biology Online607 e il licenziamento di Ofek. Reagire non
è inutile, specie nel momento in cui tutto può essere condiviso
online come ha brillantemente fatto la ricercatrice americana.
O, per utilizzare le parole di Sarah Kendzior: «Exploiters
should feel ashamed, not the exploited». Gli sfruttattori
dovrebbero vergognarsi, non gli sfruttati.
5.3.1 Intervista a Sarah Kendzior
Affido la chiusura di questa parte alle domande che ho
rivolto a Sarah Kendzior, che ringrazio ancora una volta per
605 http://www.youtube.com/watch?v=Q9kTZx1vq7c. 606 «Seriamente, rabbia a parte…questa giustificazione del lavoro gratuito
in cambio di visibilità è ridicola. Questo è lavoro. Sono una professionista.
I professionisti vengono pagati. Fine della storia. Anche se decido di farlo
pro bono (perché supporto le tue idee o perché ti conosco, o per qualsiasi
motivo) – vale comunque qualcosa». Lee D., Responding to No name Life
Science Blog Editor who called me out of my name in
scientificamerican.com, 11 ottobre 2013 (cit). 607 http://www.biology-online.org/biology-forum/about34647.html.
373
la sua grande disponibilità. Dopo lo scambio originale,
troverà posto una traduzione in italiano.
Emanuele Mastrangeli: Briefly: what is the post-employment
economy?
Sarah Kendzior: The post-employment economy is the
replacement of steady jobs that pay a living wage with
contingent and poorly paid or unpaid labor – and the
expectation that this is normal, and that these positions are a
required stepping stone to a “real job”. People no longer work
for pay, they pay to work.
EM: In your article "Managed expectations in the post-
employment economy", you wrote that «Americans are being
conditioned to accept their own exploitation as normal».
According to you, how did this happen?
SK: I explain this in some detail in this interview:
http://www.policymic.com/articles/48829/why-you-should-
never-have-taken-that-prestigious-internship
EM: In your article "Surviving the post-employment
economy" you wrote that «choices of today’s workers are
increasingly limited». But you also wrote that people «can
organise and push for collective change». What do you think
people should do?
SK: People are already organizing and working for change.
The fast food strikes last week are a good example of this. We
need to realize that almost everyone is suffering from the
same economic plight – it is only a matter of degrees. People
need to stand up for each other and form broader coalitions.
374
We also need to address problems without shame. Exploiters
should feel ashamed, not the exploited. Feelings of shame,
humiliation keep people from discussing their personal
situation, but it helps people to know they are not alone, that
contrary to media mantras, this is not their fault.
EM: Talking about journalism, you wrote that the problem is
that people are writing for free for companies that are making
a profit. Jonathan Tasini led a lawsuit against The Huffington
Post on behalf for unpaid bloggers. Nate Thayer refused to
give his article for free to the Atlantic. Is something
changing? Can these actions increase people's awareness?
SK: Yes, and they have. There have been similar campaigns
regarding unpaid internships in journalism. Under pressure,
publications began paying interns and/or increased wages.
Once unpaid labor is seen as a source of embarrassment –
instead of something sanctioned and normal – policies begin
to change.
EM: If nobody accepted to write for free, companies should
offer a compensation. Why do this still happen? Is it because
nobody wants to be the first?
SK: Things have already started changing, both in terms of
people demanding compensation and companies getting it.
We still have a long way to go though.
EM: Do you think Internet had an active role in the
phenomenon of unpaid writing?
SK: Yes. And I’m not opposed to people writing for free on
their own volition, like on a personal blog. I’m opposed to
people writing for free for large corporations that profit off
their work and refuse to pay them.
375
EM: I'm getting my degree in Journalism. In Italy, to be a
practicing journalist, you take exams and get certified. In
order to do that, you must write for a newspaper - either
offline or online - for 2 years being regularly paid. I spent one
year living in Edinburgh, Scotland, where I found a job in a
delicatessen. I had a decent wage, I lived on my own. I came
back in Italy in september 2013 in order to get my degree. I'm
jobless and I came back living with my mother. Did I make
mistake?
SK: That’s a personal question that I can’t answer, but it
seems to me like you did everything right and then re-entered
a terrible economy with little opportunity for young people.
Your situation is typical and does not reflect your talents and
abilities. Don’t think of it as a matter of whether you made a
mistake. Think of it as a situation in which most people are
denied opportunity and need to push for structural change.
You’re not alone.
EM: Brevemente: cos’è la post-employment economy?
SK: E’ la sostituzione di lavori sicuri che permettono il
sostentamento con altri temporanei sottopagati o non pagati
affatto – e l’idea che questo sia normale e che queste posizioni
siano un passaggio inevitabile per raggiungere un “vero
lavoro”. Le persone non lavorano più per guadagnare, ma
pagano per lavorare.
EM: Nel tuo articolo "Managed expectations in the post-
employment economy", scrivi che «Gli americani sono stati
convinti ad accettare il loro sfruttamento come normale».
Secondo te, come è successo tutto ciò?
376
SK: Lo spiego in questa intervista:
http://www.policymic.com/articles/48829/why-you-should-
never-have-taken-that-prestigious-internship
EM: Nel tuo articolo "Surviving the post-employment
economy" scrivi che «le scelte dei lavoratori sono limitate».
Ma aggiungi che le persone «possono organizzarsi e premere
per dei cambiamenti». Cosa pensi che dovrebbe essere fatto?
SK: Le persone si stanno già organizzando e stanno già
lavorando per il cambiamento. Gli scioperi nei fast food della
scorsa settimana608 sono un buon esempio. Dobbiamo
realizzare che quasi tutti stiamo soffrendo la stessa situazione
economica – è solo una questione di livelli. Le persone
devono lottare anche per gli altri e formare delle coalizioni.
Dobbiamo anche nominare il problema senza vergogna. Gli
sfruttatori dovrebbero vergognarsi, non gli sfruttati.
Sentimenti di vergogna, umiliazione impediscono alle
persone di discutere la loro situazione personale, ma le
persone vengono aiutate dal fatto di sapere che non sono sole.
EM: Parlando di giornalismo, hai scritto che il problema è che
le persone scrivono gratis per imprerse for-profit. Jonathan
Tasini ha condotto un’azione legale contro l’Huffington Post
in nome dei blogger non retribuiti. Nate Thayer ha rifiutato di
concedere il suo articolo gratuitamente all’Atlantic. Qualcosa
sta cambiando? Queste azioni possono accrescere la
consapevolezza collettiva?
608 http://www.usatoday.com/story/money/business/2013/12/05/fast-
food-strike-wages/3877023/
377
SK: Sì e lo stanno facendo. Ci sono state campagne simili
riguardanti i tirocinii non pagati nel mondo giornalistico. Una
volta sotto pressione, le pubblicazioni hanno cominciato a
pagare i tirocinanti e/o ad aumentare i salari. Una volta che il
lavoro non retribuito viene visto come qualcosa di
imbarazzante – piuttosto che come qualcosa di normale – le
abitudini cominciano a cambiare.
EM: Se nessuno accettasse di scrivere gratis, le imprese
dovrebbero offrire un compenso. Perché questo ancora
succede? Dipende dal fatto che nessuno vuole fare il primo
passo?
SK: Le cose stanno già cambiando, sia in termini di persone
che richiedono una retribuzione, sia per quanto concerne le
aziende che iniziano a pagare. C’è ancora molto da fare
tuttavia.
EM: Credi che Internet abbia avuto un ruolo importante nel
proliferare del fenomeno della scrittura non retribuita?
SK: Sì. E non sono contro le persone che scrivono gratis per
loro stessi, come su un blog personale. Sono contro le persone
che scrivono gratis per grandi imprese che guadagnano sul
loro lavoro e si rifiutano di pagare.
EM: Sto per prendere una laurea in Giornalismo. In Italia, per
diventare un giornalista, devi sostenere un’esame ed avere
una certificazione. Per farlo, devi scrivere per un giornale –
sia offline che online – per 2 anni venendo regolarmente
retribuito. Ho vissuto per un anno a Edimburgo, in Scozia,
dove avevo un lavoro in un negozio. Avevo uno stipendio
dignitoso e vivevo per conto mio. Sono tornato in Italia nel
settembre del 2013 per finire l’università. Sono senza lavoro
378
e sono tornato a vivere con mia madre. Ho commesso un
errore?
SK: Questa è una domanda personale a cui non posso
rispondere. Mi sembra che non hai commesso degli errori,
ma semplicemente sei rientrato in un’economia terribile che
concede poche opportunità ai giovani. La tua situazione è
tipica e non riflette le tue capacità. Non credere che il punto
sia se hai commesso o meno un errore. Pensa che si tratta di
una situazione che nega alla maggior parte delle persone delle
opportunità e necessità di essere cambiata. Non sei solo.
379
Conclusione
Recita un famoso proverbio italiano: i giornalisti lodano
chi li paga, e mordono chi li disprezza. Gli editori meno
propensi ad aprire il portafogli possono stare tranquilli: non è
così. Non lo è più, perlomeno. Certo non vale per ogni
giornalista. Volendo peccare di malizia si potrebbe arrivare a
dire che le le lodi sono garantite a priori, soldi o non soldi.
Ma non è il momento di esultare, i difensori della libertà di
stampa possono smorzare il proprio entusiasmo. Se il
proverbio denunciava infatti una particolare sensibilità al
denaro della categoria, il venir meno di questa peculiarità non
garantisce affatto la trasparenza o la qualità dell’esercizio
della professione. Bisogna tuttavia riconoscere che i
giornalisti continuano a mordere chi li disprezza; ma anche
qui qualcosa è cambiato. Il disprezzo, ma sarebbe meglio dire
la critica, non arriva più dall’universo editoriale, dai vertici
della piramide, bensì dalla base, da quei pochi colleghi che
lanciano il proprio j’accuse. Pur cambiando il mittente, il
destinatario reagisce alla stessa maniera: mordendo.
Difendendo il proprio territorio, il proprio orticello fatto di
sogni, speraze ed egocentrismo. E, perché no, servilismo.
Si faccia un passo indietro, alla domanda cardine da cui è
sbocciato questo lavoro. Perché si è arrivati alla non
retribuzione della prestazione intellettuale, in particolar modo
quella giornalistica sulla Rete609? Il processo di risposta a
questo quesito è stato – come si è visto – lungo e ha richiesto
609 Riguardo all’esistenza del fenomeno credo che ogni dubbio sia stato
ampiamente fugato.
380
un avanzamento graduale. In primo luogo si è resa necessaria
una descrizione dettagliata del contesto di riferimento, da un
duplice punto di vista diacronico e sincronico. Era
impossibile non riportare, pur brevemente, l’intrecciarsi
dell’evoluzione tecnologica di Internet con l’universo
giornalistico. La vera rivoluzione – al di là dei cambiamenti
che hanno riguardato la notizia, la professione o i formati – è
stata quella dell’accesso. Il fenomeno descritto è in primo
luogo figlio del Web 2.0 e della sua liberalizzazione degli
accessi. Il risultato è stato la sconfinata abbondanza
dell’offerta di cui si è parlato trattando la cosiddetta new
economy, che ha portato ad una situazione di mercato in cui
la domanda si è ritrovata a simulare un m’ama, non m’ama
nel bel mezzo di un prato infinito. Un’ulteriore conseguenza,
molto più sottile, è stata quella della sottrazione di dignità. Il
mescolarsi torbido di amatoriale e professionale, falso e
veriterio, attendibile e non attendibile, tipico della Rete, ha
generato l’idea che il lavoro online fosse meno nobile di
quello classico. Non solo, è stato – forse anche scientemente
– insinuato il dubbio che forse di lavoro non fosse neppure
lecito parlare. In fondo, spesso e volentieri lo si fa da casa,
senza orari fissi, senza mai incontrare di persona i propri
colleghi o superiori. E non manca la concorrenza; molte
persone premono per accapararsi questo lavoro/non lavoro,
addirittura gratis.
Già, gratis. Dopo aver vissuto il fenomeno in prima
persona, dopo averlo ricercato, dibattutto, raccontato, la
parola “gratis” ancora suscita un non so che di inesplicabile
in relazione al mio concetto di lavoro. Una parte
fondamentale di questa tesi ha riguardato l’indagine delle
ragioni che hanno spinto e spingono tanti giovani e non ad
381
offrire il proprio tempo, la propria disponibilità, le proprie
energie, il proprio impegno, la propria conoscenza, le proprie
abilità senza venire retribuiti610. Ciò che è emerso,
naturalmente, è stata una molteplicità di ragioni, una
compartecipazione di più fattori che insieme hanno
contribuito e contribuiscono, con maggiore o minore peso
specifico, alla proliferazione del fenomeno in questione.
Senza ripetere in maniera didascalica quanto già
dettagliatamente riportato nell’ultima parte di questo lavoro,
è possibile aggiungere che il fenomeno risulta essere il
prodotto tra delle condizioni preesistenti611 e l’opportunità
che queste si concretizzassero, di cui è principale artefice la
Rete. In altri termini, lontani dal voler demonizzare
Internet612, il Web si è limitato a consentire l’espressione di
spinte già esistenti, che hanno trovato nell’universo digitale
il terreno della propria realizzazione. Il fenomeno non può
essere spiegato in assenza di una di queste due componenti,
610 Dato per assodato, come già ampiamente sviscerato nelle pagine
precedenti, che la visibilità non sia una moneta degna di essere
considerata tale. Questo è perlomeno il pensiero di diverse personalità che
hanno prestato la propria voce nella coralità di questo lavoro, pensiero
affine a quello del sottoscritto. 611 Ho suddiviso le ragioni delle persone che decidono di scrivere gratis
in due categorie. Una prima, maggiormente inserita nell’ambito della
professionalità, raccoglie le motivazioni di coloro che vedono la
collaborazione gratuita come necessaria per il raggiungimento di altri
obiettivi (il tesserino da pubblicista, una retribuzione futura, l’esperienza,
la visibilità). La seconda categoria invece racchiude in sé realtà legate
maggiormente all’universo amatoriale, dove la scrittura è considerata non
un lavoro ma un hobby, o piuttosto una passione da coltivare ad ogni
costo. In questo contesto entrano in gioco dinamiche differenti, come ad
esempio il narcisismo o la gratificazione egocentrica. 612 Credo fermamente nell’assoluta neutralità degli strumenti, i cui effetti
sono quasi esclusivamente il risultato dell’utilizzo che ne viene fatto.
382
entrambe parimenti essenziali. L’assenza di una delle due, fa
cadere la logica che sostiene il discorso.
Una volta delineate le ragioni, il passo successivo è quello
dell’attribuzione di responsabilità613. Anche in questo caso la
soluzione non è univoca. Ritengo che il ragionamento debba
procedere analizzando tre piani differenti. In primo luogo c’è
il piano legislativo e istituzionale. In particolar modo per
quanto concerne l’aspetto meno trasparente del fenomeno,
quello legato alla trasformazione del tesserino da pubblicista
in merce di scambio, si evidenziano le colpe di un sistema
caratterizzato da lacune, contraddizioni e un generale
anacronismo. Questioni come la legittimità dell’Ordine dei
Giornalisti, la sua modernità rispetto alla dirompenza
dell’evoluzione tecnologica, la selezione economica e
classista prodotta dalla sua articolazione, si propongono come
centrali ed incredibilmente attuali di fronte al fenomeno del
lavoro non retribuito. Da parte delle istutizioni emerge invece
un generale disinteresse nei confronti del problema, che è
possibile evincere in primo luogo constatando l’assenza quasi
totale di un dibattito a riguardo nelle arene pubbliche. Un
altro piano di riferimento è quello degli editori, secondo
alcuni gli unici meritevoli di essere additati come colpevoli.
La questione va scissa. Da una parte ci sono gli editori
disonesti tout court, che si muovono nel campo dell’illegalità:
si sta parlando di coloro che attraverso l’emissione di fatture
false consentono ai loro collaboratori di presentare la
documentazione richiesta per essere ammessi all’Esame di
Stato per l’ottenimento del tesserino da pubblicista,
fenomeno descritto in più occasioni nelle pagine precedenti.
613 Questo, naturalmente, nel momento in cui il fenomeno viene
considerato dannoso, sotto diversi punti di vista.
383
Dall’altra parte ci sono coloro che pur rimanendo nell’ambito
della legalità, possono essere accusati di non sottrarsi, per
minimizzare i costi e aumentare i profitti, a logiche di
sfruttamento e ricatto nei confronti dei propri collaboratori.
Pagamenti iniqui o più spesso assenti, annullamento di
qualsiasi rischio imprenditoriale, ma soprattutto prese di
posizione che godono di un enorme squilibrio di potere che
deriva non soltanto dal possedimento di un capitale, spesso
poco rilevante, ma dai privilegi garantiti da un sistema che
favorisce tutto ciò. In primo luogo il sistema si autoalimenta
attraverso una tautologia: funziona così perché funziona così.
Ma soprattutto, l’editore può utilizzare come arma di ricatto
la dimensione sterminata dell’offerta che propone il mercato:
di fronte ad un rifiuto sporadico, ci sono innumerevoli
persone non solo disposte, ma ben propense ad accettare. Di
conseguenza, tanto da un punto di vista concettuale, quanto
da uno meramente pragmatico, il sistema riesce ad
alimentarsi e ad approfittare di questo sono tutti quegli editori
senza scrupoli che mirano esclusivamente a massimizzare i
guadagni. Sulla scia di questo ragionamento è facile spostarsi
al terzo ed ultimo piano dell’attribuzione di responsabilità,
quello che genera maggiori controversie e disaccordi. Il piano
dei collaboratori. Le posizioni in merito sono difficilmente
conciliabili. Questa ricerca ne ha individuate tre. La prima è
quella di coloro che reputano il lavoro non retribuito online
assolutamente normale o addirittura come di grande benificio
per la società. Nel mezzo si trova invece l’idea che concedere
il proprio lavoro gratuitamente614 sia sbagliato, ma che i
collaboratori siano le vittime e gli editori e il sistema i
614 Si parla sempre di lavoro svolto presso aziende for-profit,
naturalmente.
384
carnefici. L’ultima posizione, quella che come è evidente
viene abbracciata in questa tesi, non assolve coloro che
scrivono gratis, ma gli attribuisce delle precise responsabilità.
Principalmente quella di aver contribuito e di contribuire
all’inquinamento di un mercato oramai difficilmente
recuperabile e consequentemente quella di aver da una parte
danneggiato la categoria dei professionisti già formati,
dall’altra quella di aver trasformato l’accesso alla professione
in una palude da cui risulta incredibilmente difficile uscire, in
particolar modo puliti615.
Si presenta forse il caso di mitigare il pessimismo che
emerge dal quadro sin qui descritto. Tutto questo significa,
potrebbe essere lecito chiedersi, che diventerà sempre più
complicato poter vivere esercitando la professione
giornalistica? I lavoratori dipendenti continueranno a
diminuire con il passare degli anni? L’accesso alla
professione eserciterà sempre più una selezione economica e
classista616? La retribuzione verrà relegata definitivamente ad
una pretesa assurda o ad una chimera? Si smetterà di parlare
di professione giornalistica lasciando piuttosto spazio al
semplice hobby? In assenza di determinati cambiamenti,
ritengo che sia sufficiente una sola risposta a tutte queste
domande: sì. I cambiamenti cui si fa cenno hanno diversa
natura, sia legislativa sia di mentalità. Sono tuttavia
d’accordo con quanto sostenuto da Carlo Gubitosa e che per
molteplici ragioni l’idea che possa maturare una coscienza
collettiva sia utopica. Utilizzando le parole di Gubitosa: «I
diritti della categoria si devono affermare su due binari: nel
615 Soprattutto in assenza di un equipaggiamento all’avanguardia, quindi
particolarmente costoso. Sempre rimanendo nei confini della metafora. 616 E di propensione etica, si potrebbe aggiungere.
385
rispetto di alcuni principi di Legge che vanno stabiliti in
Parlamento e nel riconoscimento di alcuni diritti che va
stabilito nel rapporto tra editori e lavoratori mediato dai
sindacati617». Dal punto di vista legislativo, si parla di «una
normativa che impedisca anche a tutela del lettori di utilizzare
lavoro non retribuito in una testata registrata che fa anche
peraltro profitti. Questo dovrebbe essere chiaro per legge: io
domani non posso mettere su un’impresa edile con il
muratore che mi viene a lavorare gratis perché così fa
esperienza, si fa notare, cerca la visibilità. No, in tal caso
arriva l’ispettorato del lavoro e mi denuncia, perché quello è
lavoro nero618». Si è anche visto come il problema sia più
ampio e riguardi per certi versi il mondo del lavoro tout court,
come sostenuto da Sarah Kendzior. A tal proposito condivido
la linea di Francesco Sellari quando tra le misure necessarie
a contrastare il ricorso al lavoro non retribuito o sottopagato
parla del bisogno di fare in modo che gli stage, al di là della
loro natura, prevedano sempre un rimborso minimo. Si tratta
di processi che, anche qualora dovessero attivarsi – e non è
detto che questo si verifichi –, necessiteranno di molto tempo
prima che se ne possano testare gli effetti. Cosa dovrebbe fare
allora un aspirante giornalista? Quale la strada che un giovane
neolaureato dovrebbe intraprendere? Le risposte in tal senso
potrebbero essere molteplici. Nel momento in cui si decide di
respingere lo scenario del lavoro non retribuito credo esistano
tre diverse possibilità. La prima, sotto alcuni punti di vista la
più auspicabile, è quella di imbattersi nelle persone giuste al
momento giusto. Trovare una collaborazione retribuita
617 Queste parole sono prese dall’intervista che ho realizzato con Carlo
Gubirosa. 618 Queste parole sono prese dall’intervista che ho realizzato con Carlo
Gubirosa.
386
dignitosamente che dia la possibilità di crescere
professionalmente e fare esperienza senza dover accettare
compromessi scomodi. Senza peccare di cinismo, questa
rimane la via meno probabile, per quanto non impossibile. La
seconda possibilità affonda le proprie radici nelle potenzialità
della Rete. Ogni utente può diventare autore ed editore di sé
stesso. Se si crede nelle proprie capacità e nelle proprie idee,
non è peccato tentare perlomeno una volta di avviare un
proprio progetto. Nel momento in cui si deve scrivere gratis,
che sia almeno fatto per sé stessi. L’ultimo scenario è forse
quello più doloroso per coloro che amano questa professione:
dedicarsi ad altro, trovare un’altra strada, affidarsi ad una exit
strategy. Ritengo che le possibilità offerte dalla vita siano
infinite, ma soprattutto imprevedibili. La capacità di sapersi
reinventare è preziosa e l’essere costretti a farlo non ha
necessariamente accezione riduttiva, ma può invece essere
occasione di crescita e di arricchimento. Perché, utilizzando
le parole di Silvia Bencivelli, «la storia dei sogni, il lavoro dei
sogni è una stronzata619». Oppure, per utilizzare parole più
morbide, l’idea del lavoro dei sogni andrebbe quantomeno
ridimensionata: «Non credo che per inseguire il lavoro dei
tuoi sogni puoi ritrovarti a 40 anni ancora a scrivere
gratis620».
Lascio alcune righe a disposizione di una riflessione
conclusiva. Credo di aver scritto queste pagine
principalmente a scopo terapeutico. La scelta dell’argomento,
come già accennato nell’introduzione, nasce dall’esperienza
619 Queste parole sono prese dall’intervista che ho realizzato con Silvia
Bencivelli. 620 Queste parole sono prese dall’intervista che ho realizzato con Silvia
Bencivelli.
387
personale. Quando ho iniziato a lavorare a questa tesi, sapevo
già, approssimativamente, quello che avrei trovato. Perché
questo mondo lo conoscevo piuttosto bene. Nel mio percorso
di – quantomeno cercata – crescita professionale ho respinto
al mittente, o semplicemente scartato, decine di offerte inique
come quelle riportate in questo lavoro. Complessivamente ne
ho accettata una manciata: tutte retribuite, non molto, ma
perlomeno in linea con l’impegno e il tempo richiesti. Ma
questo almeno un paio d’anni fa. In seguito le proposte
dignitose sono lentamente scomparse, sparite, evaporate nel
mare magnum della Rete. E quel che è rimasto non era poi
così accattivante. E’ stato allora che ho cominciato a
guardarmi intorno, provando a regalare alla mia vita scenari
alternativi, al di fuori dell’universo giornalistico. Questo
lavoro è con ogni probabilità la mia ultima carezza a quel
mondo, che amo, ma non al punto di scendere a compromessi
per me inaccettabili. Nulla merita di sottostare a simili
condizioni: l’amore, quello maturo, adulto, è un’altra cosa. In
fondo questa ricerca non vuole neppure essere una denuncia,
manca completamente quella carica di rabbia morale
necessaria e qui assente, poiché svanita lentamente nel tempo.
Si tratta più probabilmente di una definitiva presa di
coscienza, una fotografia con cui riassumere i motivi di un
abbandono, di un “no, grazie”. Se un giorno nutrissi il
desiderio di riavvicinarmi a questo mondo, lo potrei fare per
altre vie, quelle comunque straordinarie offerte da Internet,
autogestendomi, come suggerito a più riprese da Carlo
Gubitosa. Nel frattempo mi dedicherò ad altro, concludendo
il mio percorso universitario di pari passo con il termine di un
processo di maturazione dettato più che altro dalla
disillusione. Sarebbe altrettanto necessario interrogarsi sulla
questione universitaria, con le sue lacune e contraddizioni.
389
Bibliografia
Berretti Alberto e Zambardino Vittorio
1995, Internet. Avviso ai naviganti, Donzelli, Roma
Bolter Jay David and Grusin Richard
1999, Remediation: Understanding New Media. MIT Press,
Cambridge
Bruno Nicola., Nielsen Rasmus
2012, Survival Is Success, Journalistic Online Start-Ups In
Western Europe, RISJ, University of Oxford
Carelli Emilio
2004 Giornali e giornalisti nella rete, Apogeo, Milano
Corchia Luca
2007, Che cos'è un ipertesto, Scuola di dottorato in Lingue e
letterature straniere, Università di Pisa, 1
Granieri Giuseppe
2009, Blog generation, Laterza, Roma
Landow George
1992, The Definition of Hypertext and Its History as a
Concept, Johns Hopkins University Press
Maistrello Sergio
2004, Come si fa un blog, Edizione Tecniche Nuove, Milano
390
Maistrello Sergio
2010 Giornalismo e nuovi media – L’informazione al tempo
del citizen journalism, Apogeo, Milano
McLuhan Marshall
1966 Understanding Media: The Extensions of Man,
McGraw-Hill
Nielsen Jakob
1990, The Art of Navigating Through Hypertext, Magazine
Communications of the ACM, New York
Pratellesi Marco
2004 New Journalism: teorie e tecniche del giornalismo
multimediale, Bruno Mondadori, Milano
Staglianò Riccardo
2002, Giornalismo 2.0, Fare informazione al tempo di
Internet, Carocci, Roma
Articoli
Abruzzo F., I giornalismi in francoabruzzo.it
(http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=99).
Abruzzo F., La riforma della professione giornalistica in
Impresa&Stato n.46 (http://impresa-
stato.mi.camcom.it/im_46/abruzzo.htm).
391
Abruzzo F., Registrazione delle testate on-line e R.O.C. in
altalex.com, 16 luglio 2001,
(http://www.altalex.com/index.php?idnot=3182).
Armano A., Un italiano su 550 è giornalista. Riformiamo
l’Ordine? in ilfattoquotidiano.it
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/30/un-italiano-su-
550-e-giornalista-iscritto-allordine-lo-riformiamo/579213/).
Arthur C., Twitter first with news of Osama bin Laden's death
via ex-Bush staffer in theguardian.com, 2 maggio 2011,
(http://www.theguardian.com/technology/blog/2011/may/02
/twitter-osama-bin-laden-death-leaked).
Bakkila S., Why You Should Never Have Taken That
Prestigious Internship in polycimic.com, 14 giugno 2013
(http://www.policymic.com/articles/48829/why-you-should-
never-have-taken-that-prestigious-internship).
Ball J. e Lewis P., Twitter and the riots: how the news spread
in theguardian.com, 7 dicembre 2011,
(http://www.theguardian.com/uk/2011/dec/07/twitter-riots-
how-news-spread).
Baratta L., Canetta T., L’Ordine dei Giornalisti porta le web
tv in tribunale in linkiesta.it, 4 aprile 2012,
(http://www.linkiesta.it/webtv-ordine-giornalisti).
Bartolini R., Ordine dei giornalisti, un peso morto da
pensionare in europaquotidiano.it, 2 marzo 2012
(http://www.europaquotidiano.it/2012/03/02/ordine-dei-
giornalisti-un-peso-morto-da-pensionare/).
Bekar M., Che fine ha fatto l’equo compenso per i giornalisti
freelance? in articolo21.org, 12 agosto 2013,
392
(http://www.articolo21.org/2013/08/che-fine-ha-fatto-lequo-
compenso-per-i-giornalisti-freelance/).
Bencivelli S., La generazione “lavoro gratis per avere una
vetrina” in linkiesta.it, 10 giugno 2013
(http://www.linkiesta.it/lavorare-gratis).
Bennett D., The definition of citizen journalism considered
(ignore my previous post!) in dsbennett.co.uk, 17 luglio 2008
(http://www.dsbennett.co.uk/2008/07/ignore-that-last-post-
defintion-of.html).
Biasio M., Dal reporter al "citizen journalism": come cambia
il racconto dei fatti, in unipd.it 11 novembre 2013
(http://www.unipd.it/ilbo/content/dal-reporter-al-citizen-
journalism-come-cambia-il-racconto-dei-fatti).
Blood R., A Few Thoughts on Journalism and What Can
Weblogs Do About It in rebeccablood.net, 15 aprile 2004,
(http://www.rebeccablood.net/essays/what_is_journalism.ht
ml)
Bracchi P., Violence, drugs, a fatal stabbing and a most
unlikely martyr in dailymail.co.uk, 8 agosto 2011,
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-2023556/Mark-
Duggan-Violence-drugs-fatal-stabbing-unlikely-
martyr.html).
Calderone M., Huffington Post Awarded Pulitzer Prize in
huffingtonpost.com, 16 aprile 2012,
(http://www.huffingtonpost.com/2012/04/16/huffington-
post-pulitzer-prize-2012_n_1429169.html).
Camporese A., Interventi efficaci e rapidi per superare una
crisi epocale in fnsi.it,
393
(http://www.fnsi.it/Download/RAPPORTO_LSDI_2012.pdf
).
Cella F., Arianna Huffington: “Pronta a portare il mio Post
anche in Italia”, in corriere.it, 1 ottobre 2011,
(http://vitadigitale.corriere.it/2011/10/11/arianna-huffington-
pronta-a-portare-il-mio-post-anche-in-italia/).
Ciolli B., Internet e informazione, come cambia il
giornalismo secondo Richard Rogers in lettera43.it, 22
ottobre 2013,
(http://www.lettera43.it/tecnologia/web/internet-e-
informazione-come-cambia-il-giornalismo-secondo-richard-
rogers_43675111299.htm).
Clune B., So Twitter is ruining journalism? Really? in
theguardian.com 13 novembre 2013,
(http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/13/s
o-twitter-is-ruining-journalism-really).
Curiat A., Disposti a tutto pur di diventare giornalisti
pubblicisti: anche a fingere di essere pagati. Ma gli Ordini
non vigilano? In repubblicadeglistagisti.it, 27 aprile 2010,
(www.repubblicadeglistagisti.it/article/articolo-finti-
pubblicisti-contromisure-ordini).
Curiat A., La testimonianza di Franca: «Dopo una serie di
stage logoranti, la scelta di pagarmi da sola i contributi da
pubblicista» in repubblicadeglistagisti.it, 27 aprile 2010,
(http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/testimonianza-
pubblicista).
Curiat A., L'avvocato Gianfranco Garancini: «Chi falsifica
la documentazione pur di entrare nell'albo dei giornalisti
pubblicisti commette reati penali» in
394
repubblicadeglistagisti.it, 27 aprile 2010,
(http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/intervista-
avvocato-franco-garancini-cosa-rischia-chi-falsifica-
documentazione-iscrizione-albo-giornalisti-pubblicisti).
D’Addario D., When should a young writer write for free? In
salon.com, 29 ottobre 2013
(http://www.salon.com/2013/10/29/when_should_a_young_
writer_write_for_free/).
De Biase L., Chi vuole fare il giornalista: un mestiere da
innovatori in blog.debiase.com, 3 dicembre 2012,
(http://blog.debiase.com/2012/12/chi-vuole-fare-il-
giornalista-un-mestiere-da-innovatori/).
De Judicibus D., World 2.0 in lindipendente.eu, 2 gennaio
2008, (http://www.lindipendente.eu/wp/it/2008/01/02/world-
2-0/).
De Luca D., Italia: il paese dei giornalisti invisibili in
ifg.uniurb.it 27 gennaio 2012,
(http://ifg.uniurb.it/2012/01/27/ducato-online/italia-il-paese-
dei-giornalisti-invisibili/17001).
De Martino G., Giornalisti, l’ordine che nessuno riesce a
cancellare in linkiesta.it, 15 aprile 2013,
(http://www.linkiesta.it/abolizione-odg).
Del Priore C., La testimonianza di Carlo: «Sono diventato
pubblicista scrivendo gratis: ma almeno le ritenute d’acconto
me le hanno pagate» in repubblicadeglistagisti.it, 27 aprile
2010,
(http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/testimonianza-
carlo-diventato-pubblicista-scrivendo-gratis-su-testata-
giornalistica-aziendale).
395
Ferrigolo A., “Due euro a pezzo”. Un’inchiesta sul
giornalismo precario in reset.it, 4 luglio 2013
(http://www.reset.it/caffe-europa/precari-nei-giornali-
uninchiesta).
Fittipaldi E., Giornalisti, tracce d'esame con errori. E la gaffe
viene "sbianchettata" online, in espresso.repubblica.it, 1
novembre 2013,
(http://espresso.repubblica.it/attualita/2013/11/01/news/gior
nalisti-tracce-d-esame-con-errore-il-pm-convalida-gli-
arresti-1.139692).
Fratti K., Dispatch From Italy: Citizen Journalism and
YouReporter Making Waves in mediabistro.com, 3 ottobre
2013
(http://www.mediabistro.com/10000words/youreporter-
citizen-journalism-abroad_b23092).
Garland E., Sexy dirty money in transitionistas.com, 6 marzo
2013 (http://www.transitionistas.com/2013/03/06/sexy-
dirty-money/).
Geier K., Op-ed of the day: Tim Kreider in the New York
Times, “Slaves of the Internet, Unite!” in
washingtonmonthly.com, 27 ottobre 2013
(http://www.washingtonmonthly.com/political-animal-
a/2013_10/oped_of_the_day_tim_kreider_in047523.php).
Gillmor D., Where Did "Citizen Journalist" Come From? in
citmedia.org, 14 luglio 2008
(http://citmedia.org/blog/2008/07/14/where-did-citizen-
journalist-come-from/).
Giuliani F. A cosa serve l'Ordine dei Giornalisti? Professione
e accademia a confronto in i-taly.org (http://www.i-
396
italy.org/18705/cosa-serve-lordine-dei-giornalisti-
professione-e-accademia-confronto).
Greenfield R., What the New York Times's 'Snow Fall' Means
to Online Journalism's Future in theatlanticwire.com, 20
dicembre 2012.
(http://www.theatlanticwire.com/technology/2012/12/new-
york-times-snow-fall-feature/60219/).
Grisolia M., Libertà di informazione e ordine dei giornalisti
alla luce della riforma degli ordinamenti professionali in
AIC (Associazione Italiana Costituzionalisti) rivista n.
4/2012, 12 dicembre 2012
(http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/alle
gati/Grisolia.pdf)
Gubitosa C., Appello a chi scrive gratis tanto per farsi
leggere: e' il momento di smetterla in giornalismi.info, 26
settembre 2012
(http://web.giornalismi.info/gubi/articoli/art_9600.html).
Hartley S., Korea's OhmyNews: how oppression inspired
citizen journalism in theguardian.com, 19 gennaio 2011
(http://www.theguardian.com/media/pda/2011/jan/19/ohmy
news-korea-citizen-journalism).
Huffington A., About That Lawsuit... in huffingtonpost.com,
13 aprile 2011, (http://www.huffingtonpost.com/arianna-
huffington/huffington-post-lawsuit_b_848942.html).
Ingmar W., Using Twitter to track political polarisation in
Egypt in aljazeera.com 4 ottobre 2013,
(http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/09/utilisin
g-twitter-track-political-polarisation-egypt-
201392714215315617.html).
397
Ingram M., No, writing for free isn’t slavery, and other
misconceptions about the economics of online media in
paidcontent.org, 28 ottobre 2013
(http://paidcontent.org/2013/10/28/no-writing-for-free-isnt-
slavery-and-other-misconceptions-about-the-economics-of-
online-media/).
Ingram M., The new economics of media: If you want free
content, there’s an almost infinite supply in paidcontent.org,
6 marzo 2013 (http://paidcontent.org/2013/03/06/the-new-
economics-of-media-if-you-want-free-content-theres-an-
almost-infinite-supply/).
Iurillo V., Giornalista ti assumo ma solo per finta in
ilfattoquotidiano.it, 10 settembre 2010
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/09/10/giornalista-ti-
assumo-ma-solo-per-finta/59173/)
Iurillo V., I ‘giornalisti’ a cui piace (o conviene) scrivere
gratis in ilfattoquotidiano.it, 30 marzo 2012
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/30/troppi-
giornalisti-piace-conviene-scrivere-gratis/).
Kendzior S., Managed expectations in the post-employment
economy in aljazeera.com, 12 marzo 2013
(http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/03/201331
116423560886.html).
Kendzior S., Surviving the post-employment economy in
aljazeera.com, 3 novembre 2013,
(http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/survivi
ng-post-employment-economy-201311373243740811.html).
Kendzior S., The moral bankruptcy of the internship economy
in sarahkendzior.com, 9 giugno 2013
398
(http://sarahkendzior.com/2013/06/09/the-moral-
bankruptcy-of-the-internship-economy/).
Kendzior S., Who is a 'journalist'? People who can afford to
be in aljazeera.com, 17 settembre 2013,
(http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/09/201391
764312806487.html).
Klein E., Why do journalists prefer Twitter to Facebook? in
washingtonpost.com, 11 novembre 2013,
(http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/
11/11/why-do-journalists-prefer-twitter-to-facebook/).
Lee D., Responding to No name Life Science Blog Editor who
called me out of my name in scientificamerican.com, 11
ottobre 2013 (http://blogs.scientificamerican.com/urban-
scientist/2013/10/11/give-trouble-to-others-but-not-me/).
Lemann N., Amateur Hour in newyorker.com, 7 agosto 2006
(http://www.newyorker.com/archive/2006/08/07/060807fa_f
act1).
Lewis D., It’s Totally Okay to Write Stuff for Free to Get
Exposure…if that’s what you’re actually doing in
medium.com, 28 ottobre 2013 (https://medium.com/i-m-h-
o/1b361d512b5).
Martelli F., Esame giornalisti professionisti, gli errori nelle
tracce e la difesa dell’Ordine in ilfattoquotidiano.it, 2
novembre 2013,
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/02/esame-
giornalisti-professionisti-errori-nelle-tracce-e-difesa-
dellordine/764593/).
399
McAdams M., Stuff to teach the next journalists in
mindymcadams.com, 7 ottobre 2008,
(http://mindymcadams.com/tojou/2008/stuff-to-teach-the-
next-journalists/).
Michael A., Shirky at NFAIS: How Abundance Breaks
Everything in scholarlykitchen.sspnt.org, 2 marzo 2010
(http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/03/02/shirky-at-
nfais-how-abundance-breaks-everything/).
Momigliano A., Dentro Internazionale in rivistastudio.com,
28 giugno 2012,
(http://www.rivistastudio.com/editoriali/media-
innovazione/nella-fabbrica-di-internazionale/).
O’Really T., What Is Web 2.0, Design Patterns and Business
Models for the Next Generation of Software in o’really.com,
30 settembre 2005,
(http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-
20.html?page=1).
Occhetta F., L’Ordine Nazionale dei Giornalisti in
laciviltacattolica.it, 19/09/2013
(http://www.laciviltacattolica.it/articoli_download/3216.pdf)
.
Orsini V., Caro Gubitosa, il tuo appello a chi scrive gratis,
non mi sta bene. Ti spiego perché in
criticissimamente.blogspot.it, 27 settembre 2012
(http://criticissimamente.blogspot.it/2012/09/caro-gubitosa-
il-tuo-appello-chi-scrive.html).
Pasteris V., Della dignità del giornalismo digitale in lsdi.it,
30 giugno 2008, (http://www.lsdi.it/2008/06/30/della-
dignita-del-giornalismo-digitale/)
400
Peters J., Huffington Post Is Target of Suit on Behalf of
Bloggers, in nytimes.com, 12 aprile 2011,
(http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2011/04/12/huffing
ton-post-is-target-of-suit-on-behalf-of-bloggers/?_r=1).
Pilkington E., Huffington Post bloggers lose legal fight for
AOL millions in theguardian.com, 1 aprile 2012,
(http://www.theguardian.com/media/2012/apr/01/huffington
-post-bloggers-aol-millions).
Plenel E., Le prix de la liberté in mediapart.fr, 16 marzo 2008,
(http://www.mediapart.fr/journal/france/100308/le-prix-de-
la-liberte).
Pozzi, P., Rea P., Ordine dei giornalisti. Dove c’è e dove non
c’è in Tabloid, luglio 2013, (http://www.lsdi.it/assets/Lsdi-
Tabloid-Ordini.pdf).
Rea P., Il giornalismo dopo internet: un mestiere “al
ribasso”? in lsdi.it, (http://www.lsdi.it/2008/il-giornalismo-
dopo-internet-un-mestiere-%E2%80%9Cal-
ribasso%E2%80%9D/).
Rea P., La fabbrica dei giornalisti / Il Rapporto completo in
lsdi.it, 30 novembre 2012 (http://www.lsdi.it/2012/la-
fabbrica-dei-giornalisti-il-rapporto-completo/).
Redazione Online, «San Giuda» terrorizza Gb, Olanda e
Francia. «Tempesta perfetta»: caos trasporti e black out in
corriere.it, 28 ottobre 2013,
(http://www.corriere.it/esteri/13_ottobre_28/san-giuda-
terrorizza-francia-gran-bretagna-tempesta-perfetta-caos-
trasporti-black-out-80b06d06-3fa5-11e3-9fdc-
0e5d4e86bfe5.shtml).
401
Redazione Online, Amateur journalists create jobs for
professional ones in economist.com, 1 giugno 2013,
(http://www.economist.com/news/international/21578662-
amateur-journalists-create-jobs-professional-ones-foreign-
correspondents).
Redazione Online, Aol, 315 milioni per l'Huffington Post, in
corriere.it, 7 febbraio 2011,
(http://www.corriere.it/economia/11_febbraio_07/aol-
acquista-Huffington%20Post_2148d7be-3287-11e0-8ce8-
00144f486ba6.shtml).
Redazione Online, Assolto Vanin, Pnbox non è una testata
giornalistica in pordenoneoggi.it, 11 luglio 2012,
(http://www.pordenoneoggi.it/notizie/assolto-vanin-pnbox-
non-%C3%A8-una-testata-giornalistica-005799).
Redazione Online, Avalanches kill three in Washington state
ski resorts in theguardian.com, 20 febbraio 2013,
(http://www.theguardian.com/world/2012/feb/19/avalanche-
washington-state-kills-three).
Redazione Online, Avvocati: in Italia sono il triplo della
media Ue. E fanno troppe cause per incidenti in
blitzquotidiano.it, 4 luglio 2013,
(http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/avvocati-italia-
triplo-media-ue-cause-incidenti-1610853/).
Redazione Online, Carta di Firenze: approvata a
larghissima maggioranza Fondamentale il ruolo delle
rappresentanze sindacali in fnsi.it, 22 novembre 2011,
(http://www.fnsi.it/esterne/Fvedinews.asp?AKey=13986).
Redazione Online, Caso Berlusconi e incandidabilità, alt
dell’Anm in corriere.it, 26 ottobre 2013,
402
(http://www.corriere.it/politica/13_ottobre_26/berlusconi-
anm-incandidabilita-questione-etica-6b4fe710-3e52-11e3-
bd5b-1a8e5e5a5692.shtml).
Redazione Online, Citizen journalism and Rising Voices in
rising.globalvoicesonline.org, 20 luglio 2008
(http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2008/07/20/citizen
-journalism-and-rising-voices/).
Redazione Online, Dati di lettura – Quotidiani – 2013/I in
primaonline.it, 27 maggio 2013,
(http://www.primaonline.it/2013/05/27/118185/dati-di-
lettura-quotidiani-2013i/).
Redazione Online, Due milioni senza luce. Sandy è a New
Yotk. Cuomo: «Almeno cinque morti» in corriere.it, 29
ottobre 2012,
(http://www.corriere.it/esteri/12_ottobre_29/sandy-
raggiunge-new-york_178c5b50-220f-11e2-867a-
35e5030cc1c9.shtml).
Redazione Online, È morto l'ex presidente Oscar Luigi
Scalfaro in corriere.it, 29 gennaio 2012,
(http://www.corriere.it/politica/12_gennaio_29/morto-oscar-
luigi-scalfaro_7d0ca31e-4a55-11e1-bc89-
1929970e79ce.shtml).
Redazione Online, Guardian's Alan Rusbridger on why his
paper will remain free online in editorsweblog.org, 26
gennaio 2010,
(http://www.editorsweblog.org/2010/01/26/guardians-alan-
rusbridger-on-why-his-paper-will-remain-free-online).
Redazione Online, L’uomo che ha twittato la morte di bin
Laden (senza saperlo) in ilpost.it, 2 maggio 2011,
403
(http://www.ilpost.it/2011/05/02/luomo-che-ha-twittato-la-
morte-di-bin-laden-senza-saperlo/).
Redazione Online, Lost in the Twitterverse, 13 novembre
2013, The Australian.
http://www.theaustralian.com.au/opinion/editorials/lost-in-
the-twitterverse/story-e6frg71x-1226758522447
Redazione Online, Man dead and police officer hurt in
Tottenham shooting in bbc.co.uk, 5 agosto 2011,
(http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-14412752).
Redazione Online, San Francisco, aereo finisce fuori pista
Almeno 2 vittime, 182 feriti in corriere.it, 6 luglio 2013,
(http://www.corriere.it/esteri/13_luglio_06/san-francisco-
aereo-si-schianta-in-pista-passeggeri-
intrappolati_411a7170-e670-11e2-ad19-
4496ac8ff7bf.shtml).
Robinson J., MailOnline: what is the secret of its success? In
theguardian.com, 15 novembre 2010
http://www.theguardian.com/media/2010/nov/15/mailonline
-daily-mail-website
Rogers T., What Is Citizen Journalism? in about.com
(http://journalism.about.com/od/citizenjournalism/a/whatisci
tizen.htm)
Roidi V., Esami di stato: troppi bocciati ma realmente a
qualcuno interessa? in giornalismoedemocrazia.it
(http://www.giornalismoedemocrazia.it/2012/05/15/esami-
di-stato-troppi-bocciatima-realmente-a-qualcuno-interessa/)
Rosen J., A Most Useful Definition of Citizen Journalism in
pressthink.org, 14 luglio 2008
404
(http://archive.pressthink.org/2008/07/14/a_most_useful_d.h
tml).
Rosen J., Brain Food for BloggerCon in pressthink.org,16
aprile 2004.
http://archive.pressthink.org/2004/04/16/con_prelude.html.
Rosen J., The People Formerly Known as the Audience in
pressthink.org, 27 giugno 2006
(http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html).
Scorza G., Allarme informazione online in
ilfattoquotidiano.it, 29 marzo 2012,
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/29/allarme-
informazione-online/200904/).
Sellari F., Dello scrivere gratis e dei miei nemici in
postille.wordpress.com, 29 settembre 2012
(http://postille.wordpress.com/2012/09/29/dello-scrivere-
gratis-e-dei-miei-nemici/).
Sofri L., Cosa è lo Huffington Post, davvero in
wittgenstein.it. 24 settembre 2012,
(http://www.wittgenstein.it/2012/09/24/cosa-e-lo-
huffington-post/).
Stempel J., Unpaid bloggers' lawsuit versus Huffington Post
tossed in reuters.com, 30 marzo 2012,
(http://www.reuters.com/article/2012/03/30/us-aol-
huffingtonpost-bloggers-idUSBRE82T17L20120330).
Sullivan A., Why I Blog in theatlantic.com, 1 novembre 2008
(http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/11/why
-i-blog/307060/).
405
Sullivan M., A Milestone Behind, a Mountain Ahead in
nytimes.com, 19 gennaio 2013,
(http://www.nytimes.com/2013/01/20/public-editor/a-
milestone-behind-a-mountain-
ahead.html?ref=opinion&_r=2&).
Sulzberger A., A Letter to Our Readers About Digital
Subscriptions in nytimes.com, 17 marzo 2011,
(http://www.nytimes.com/2011/03/18/opinion/l18times.html
).
Tedeschini M., Giornalisti online: che cosa debbono saper
“fare”? in mariotedeschini, 8 ottobre 2008,
(http://mariotedeschini.blog.kataweb.it/giornalismodaltri/20
08/10/08/giornalisti-online-che-cosa-debbono-saper-fare/).
Thayer N., A Day in the Life of a Freelance Journalist—2013
in natethayer.wordpress.com, 4 marzo 2013
(http://natethayer.wordpress.com/2013/03/04/a-day-in-the-
life-of-a-freelance-journalist-2013/).
Thoman F., L’eredità di Snow Fall: un New York Times
sempre più digitale in corriere.it, 15 luglio 2013,
(http://piazzadigitale.corriere.it/2013/07/15/leredita-di-
snow-fall-un-new-york-times-sempre-piu-digitale/).
Thompson D., Writing for Free in theatlantic.com, 28 ottobre
2013
(http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/10/writi
ng-for-free/280918/).
Trevisani A., “Se scrivi tanti articoli ti regaliamo uno
spazzolino” in linkiesta.it, 25 luglio 2013
(http://www.linkiesta.it/italiano-sveglia).
406
Ugolini B., Articolisti nella giungla del web in unita.it, 11
ottobre 2010,
(http://www.unita.it/commenti/brunougolini/articolisti-nella-
giungla-del-web-1.247709).
Veltroni V., “HuffPost”, un gioiello di piattaforma
tecnologica in primacomunicasione, 1 settembre 2012,
(http://www.ufficiostampa.rai.it/pdf/2012/2012-09-
01/2012090122696950.pdf).
Wheeler B., How the Daily Mail stormed the US in bbc.co.uk,
27 gennaio 2012, (http://www.bbc.co.uk/news/magazine-
16746785).
Yglesias M., People Writing for Free on the Internet Is an
Enormous Boon to Society in slate.com, 5 marzo 2013
(http://www.slate.com/blogs/moneybox/2013/03/05/writing
_for_free_on_the_internet_it_s_a_huge_boon_to_society.ht
ml).
407
Sitografia
http://datajournalismhandbook.org/
http://seosempmi.it
http://whopays.tumblr.com/
http://www.ansa.it/
http://www.comscoredatamine.com
http://www.dailymail.co.uk/
http://www.drudgereportarchives.com/
http://www.edelman.com/
http://www.governo.it/
http://www.huffingtonpost.com
http://www.linkiesta.it/
http://www.nytimes.com/
http://www.perlentaucher.de/
http://www.pewinternet.org/
http://www.theguardian.com/
http://www.wittgenstein.it
http://www2.agcom.it/