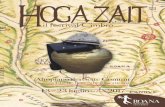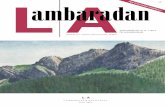Franco Brioschi - La Tradizione Della Modernità
-
Upload
ambra-ferrario -
Category
Documents
-
view
31 -
download
0
Transcript of Franco Brioschi - La Tradizione Della Modernità

Franco Brioschi – La tradizione della modernità
I. La letteratura e il suo doppio
Si può far risalire l’inizio della modernità al declino delle poetiche romantiche. In particolare, un testo che segnala chiaramente la transizione all’età moderna è Filosofia della composizione (1846), di Edgar Allan Poe, nel quale l’autore ricostruisce la tecnica di composizione del Corvo. Poe trae la sua materia dall’immaginario gotico-sentimentale comune ai romantici, ma rifiuta il ruolo di scrittore che compone in preda alla frenesia creativa, all’intuizione estatica.
In tal modo rifiutava il procedimento per il quale l’autore iscrive indelebilmente nel testo la sua fisionomia individuale di creatore (tramite l’espansione dell’io).
Il processo della creazione diventa per Poe un processo impersonale, nel senso che l’originalità che lo scrittore ricerca non è la traccia della sua emozione interiore, ma la novità del prodotto finito, commisurata all’ambizione di soddisfare le esigenze di mercato, il gusto popolare e il gusto critico ad un tempo.
Le opere successive della modernità presenteranno un fattore di continuità e un fattore di discontinuità da Poe:
1) continuità – il carattere impersonale attribuito alla strategia della creazione. Mallarmé e Zola accumunati dall’abbandono del soggetto demiurgico (primo Ottocento), il che è tutto dire. La soggettività non scompare, ma raramente i contenuti dell’esperienza vissuta assumeranno i contorni riconoscibili dell’individuo biografico senza subire radicali modifiche tipologiche (e per lo più, se accadrà, i contenuti saranno afferibili a psichismi inconsci).
2) discontinuità – dissoluzione del gusto che a Poe sembrava ancora componibile in accordo. La letteratura moderna è chiamata a definirsi nel momento stesso in cui si istituisce. L’atto creativo si accompagna all’indagine della sua origine, all’origine di ciò che lo qualifica e fonda. Tutti i grandi poeti, secondo Baudelaire, diventano fatalmente critici. Necessaria una crisi che renda per loro necessario ragionare sulla propria arte. Ricerca “infallibilità poetica”. Di fatto, questa ricerca dell’infallibilità produrrà una frattura tra letteratura “alta” (assorta nell’esplorazione delle sue motivazioni più autentiche) e letteratura “bassa” (fedele alle formule più collaudate e alle esigenze del pubblico). Del resto, fenomeno inevitabile in seguito all’allargamento della comunità letteraria (alfabetizzazione e mobilità sociale) e, da questo punto di vista, la frattura è pertiene anzitutto alla coscienza degli scrittori, prima di iscriversi nelle opere.

II. «Homo fictus»
Robert Musil, L’uomo senza qualità, 1930/33/42: ci tranquillizza la successione semplice degli eventi della vita. Poter semplificare gli avvenimenti caotici. «Beato colui che può dire: “allorché”, “prima che” e “dopo che!”. […] Da questo il romanzo ha tratto vantaggio». Agli uomini piace la serie ordinata dei fatti, che dà loro la sensazione di essere protetti dal caos. L’uomo ha smarrito la sua “epica primitiva” quando si rende conto di questo (Ulrich); l’io che costruisce non riesce più ad identificarsi con l’io costruito. Crisi. L’uomo si vede vivere (Pirandello) la scepsi sospende l’irreversibilità del tempo e sciogli i vincoli di responsabilità che ne derivano (“complesso di innocenza” di Zeno), oppure il senso di imprescrittibilità della realtà invade la coscienza dell’uomo (incubo di Gregor Samsa o Joseph K.).
Da un lato, dunque, se, come dice Nietzsche, non esistono i fatti, ma solo le interpretazioni, il passato non è più per sempre accaduto e immodificabile, bensì può essere riavvicinato alla memoria, esorcizzato e reso più confortevole. Dall’altro, se avviamo smarrito ogni chiave di interpretazione, presente e futuro precipiteranno tragicamente su di noi, senza lasciarci salvezza.
L’homo fictus dunque muta nella letteratura moderna e non può riconciliarsi con la tradizione per via dell’incessante trasmutazione dell’esperienza e del «moltiplicarsi di shock in cui consiste il Moderno», che «ha delegittimato e screditato irrimediabilmente la sua ancestrale autorità».
Questione ritratto unitario pag. 9.
III. Nel segno di Chronos
Gli anni ’20 del Novecento sono la fase culminante del modernismo letterario e sono, allo stesso tempo, il momento centrale di transizione all’interno del periodo in considerazione.
Il modernismo eredita dal secolo precedente il modulo dell’impersonalità: l’artista sparisce dietro alla sua opera (in Dedalus, Joyce scrive: «indifferente, occupato a curarsi le unghie»).
Parallelamente, l’emersione della soggettività subpersonale pervade i programmi delle avanguardie (dadaismo, espressionismo, surrealismo), alimentandone la ribellione contro l’istituto stesso della letteratura.
Il contrassegno più vistoso del modernismo è un tipo di sperimentazione formale del tutto nuovo anche rispetto al passato più recente. La ribellione alle precettistiche classiche aveva già denunciato l’artificiosità dei generi e

delle norme tradizionali; nel frattempo però il dubbio si è radicalizzato e ha investito i principi stessi che regolano il linguaggio naturale (sua logica, grammatica, sintassi). Tale svolta corrisponde al tramonto della cultura positivistica ed è parte di una più complessiva svolta epistemologica.
Il problema nasce dalla difficoltà (dall’impossibilità) di stabilire se le strutture che articolano le nostre rappresentazioni siano davvero iscritte nella realtà; difficoltà causata dal fatto che non possediamo un criterio di corrispondenza tra rappresentazione e realtà che sia formulabile indipendentemente da quelle strutture stesse.
Pag. 10/11.
Il succo è che ci si rende conto che non esistono leggi eterne, ma solo delle indicazioni che hanno valore finché non vengono superate. Questa consapevolezza riguarda anche la sperimentazione letteraria del modernismo. Non solo il repertorio formale della tradizione risulta fondato su un principio di ordine che non ha alcuna controparte nella realtà, ma lo stesso linguaggio naturale appare viziato all’origine, pretende di fissare la mobile fenomenologia delle cose nelle sue categorie fisse a priori.
Questa consapevolezza trova esimplificazione in un gran numero di esiti testuali, tra cui il romanzo d0analisi, il verso libero, il monologo interiore, le parole in libertà, e soprattutto l’istanza mimetica.
Il modernismo tende ad ampliare il dominio del rappresentabile con l’affrancamento del basso-mimetico del registro comico, che trova riscontro in un onnivoro mimetismo linguistico.
D’altro canto, i procedimenti e le tecniche di sperimentazione possono comportare, insieme al rifiuto dell’ordine discorsivo, una drastica svalutazione della rappresentazione stessa. L’opera ha deliberatamente cessato di comunicare e perciò non trasmette più un senso riconoscibile. La sovversione delle forme porta al formalismo, all’identificazione del fatto letterario con un uso della parola distinto e separato dal suo uso funzionale, comune. La norma è il superamento del passato, esprimere il mutamento è imperativo vitale.
L’effetto che si vuole raggiungere tramite la novità è non solo di sorpresa, di straniamento: è anche e soprattutto conoscenza. Il poeta mira a creare le condizioni per farsi veggente, tramite l’intensificazione inaudita delle sue facoltà percettive.
N.B. Il paradigma della visione è il maggior lascito del Romanticismo e del simbolismo alla letteratura moderna. Es. Leopold Bloom e Recherche.

Oltre le avanguardie
La letteratura del modernismo tende a definirsi in termini contrastivi, polemici, antagonistici, rivendicando autonomia dai saperi discorsivi e dalle pratiche strumentali ecc., come depositaria di valori conoscitivi morali ed esistenziali.
Atteggiamento diviso tra fedeltà ostinata ad un’utopia liberatrice e chiusura aristocratica. Pag. 15, mi rifiuto di prendere appunti.
Tre tendenze: una (che costituisce il più precipuo tratto distintivo dell’intero secolo) sperimentale, una “revisionista” (quella che chiamiamo letteratura istituzionale), una di intrattenimento.
La letteratura istituzionale è connotata da motivazioni estetiche, dal tentativo di dialogare col passato e dal tentativo di instaurare un rapporto col lettore. Strumento per raggiungere questi fini è l’adozione di una norma linguistica fedele ai criteri di coerenza, coesione ed intelligibilità che regolano l’uso comune. Contrariamente alla lingua avanguardistica, la quale replicava l’infrazione pregiudicando la propria individualità, la lingua della letteratura istituzionale consente di percepire le singole riproposte in termini di variazione. Il rispetto del vincolo di funzionalità raffigurativa non impedisce che si sperimenti dal punto di vista della struttura e della contaminazione dei generi (Thomas Mann).
La letteratura di intrattenimento condivide almeno in parte questi presupposti. Il fattore più immediato di modernizzazione, in questo caso, consiste proprio nel rapporto che essa istituisce con il mercato editoriale, accettando preventivamente la legge della domanda e dell’offerta.
I condizionamenti del mercato agiscono sull’opera con un effetto conservativo. I generi mantengono uno statuto più forte, quanto meno specialistiche sono le competenze richieste a un pubblico allargato o di scarsa acculturazione. La letteratura di intrattenimento, inoltre, continua a rispondere ad esigenze che la letteratura seria tende a delegittimare come extraestetiche. Ciò non significa che in questo macrogenere non ci sia innovazione di modelli e stereotipi e ibridazione (fumetto, fotoromanzo, cinema, radio, tv, pubblicità).
Le tre tradizioni non vivono d’altra parte in vicendevole isolamento. I confini appaiono comunque sfumati (in molti casi non è possibile una classificazione rigida); la distinzione non è solo tra gusti più o meno sofisticati, ma anche tra abitudini e occasioni di lettura variamente esercitate; la tensione imposta dal modernismo viene meno con la progressiva accettazione dei suoi risultati. Il risultato è che le diverse tradizioni possono sovrapporsi e contaminarsi. Pare che sia questo il postmoderno. Riconciliazione con il flusso di una modernità

con la quale abbiamo familiarizzato e che ha perso i tratti inquietanti. Generale autoassoluzione.
Letteratura dell’Italia unita
L’elaborazione della scrittura moderna in Italia appare influenzata innanzitutto dalla lingua, che per lungo tempo resta principalmente lingua scritta, poco parlata, estranea all’uso comune e quotidiano.
Ruggero Bonghi, Perché la letteratura italiana non sia popolare in Italia, 1855.
Non per nulla uno dei filoni più interessanti della nostra letteratura è costituito dalle opere di Dossi, Verga, Gadda, Pasolini ecc., nelle quali la contaminazione del dialetto è sottoposta al più alto livello di elaborazione stilistica.
Recentemente poi si assiste a una fioritura eccezionale della produzione in vernacolo, assunto polemicamente come lingua dell’autenticità, della memoria, contrapposto alla lingua italiana, ormai omologata.
All’avvento della civiltà borghese non corrisponde un consolidamento stabile del mercato librario. Non ci sono abitudini di lettura radicate diffusamente e non c’è una produzione “media” di sicuro riferimento.
Questo è uno dei motivi per cui in Italia l’egemonia del romanzo (genere borghese per eccellenza) si afferma molto lentamente e per cui l’esperienza modernista è meno consequenziale all’avvento della civiltà borghese (non sono certa di ciò che ho scritto).
La sperimentazione della neoavanguardia appare tanto più estremistica quanto più non è sostenuta da una tradizione ininterrotta. Gadda, che è il maggior equivalente italiano del modernismo europeo fra le due guerre, restituisce nella sua opera il caos non per una scelta indirizzata verso la destrutturazione e l’informale, ma come risultato di una ricerca frustata dell’ordine perduto.
Perciò, se è vero che l’infrazione alla norma acquista valore solo grazie al confronto con la norma stessa, è vero anche il contrario. Si realizzano dunque opere che esprimono fedeltà al canone, che perseguono un volontario anacronismo.
Esempi sono Umberto Saba, Elsa Morante (Menzogna e sortilegio, 1948), Italo Calvino p. 18/19/20.