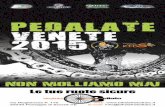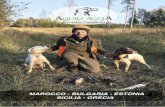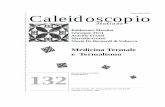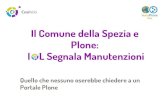DOCUMENTO DELLA CLASSE 5^ D LICEO SCIENTIFICO …D-2018... · Modalità di verifica ... Materiale...
Transcript of DOCUMENTO DELLA CLASSE 5^ D LICEO SCIENTIFICO …D-2018... · Modalità di verifica ... Materiale...
ESAME DI STATO 2018
DOCUMENTO DELLA CLASSE
5^ D LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Martini
2
8.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: Prof.ssa Laura Bauducco
Obiettivi raggiunti
La classe, pur non dimostrando, nel suo complesso, spiccato interesse per lo studio della letteratura,
ha lavorato con una certa diligenza e continuità nel corso del triennio; ciò ha consentito agli allievi
più motivati di acquisire progressivamente la capacità di rielaborare i contenuti appresi in forma
autonoma e personale e di maturare l'apertura a interessi culturali in senso lato (lettura, teatro, cinema,
musica). Permane tuttavia in gran parte della classe una certa difficoltà ad approfondire
adeguatamente l’analisi e la trattazione degli argomenti e a padroneggiare con sicurezza i mezzi
espressivi.
Metodologia
Il lavoro svolto con la classe nel corso dell'anno ha dovuto sottostare a ritmi molto sostenuti,
considerata la vastità del programma disciplinare e l'esiguità dell'orario.
La trattazione degli argomenti ha mirato ad esaminare in maniera soddisfacente l'illustrazione dei
movimenti e delle personalità principali, inserendoli nel più vasto contesto storico-culturale di
riferimento. Il momento centrale dello studio letterario è però consistito nella lettura in classe dei
testi, nella loro analisi ed interpretazione. L’analisi del testo poetico si è concentrata sulla parafrasi e
sull’individuazione delle principali figure retoriche (per i componimenti più lunghi e complessi ci si
è limitati a una presentazione sommaria dei contenuti); quella del testo narrativo ha riguardato
innanzitutto la comprensione, per poi estendersi all’esame degli aspetti stilistici e narratologici.
L'attività in classe, accanto agli indispensabili momenti di lezione frontale, è stata arricchita, tramite
l'uso della Lim, dall'integrazione con riferimenti e immagini tratti dalla rete; si è cercato di favorire il
confronto e la discussione, in modo che i ragazzi potessero abituarsi a formulare anche autonomi
giudizi, riflessioni e osservazioni, naturalmente motivati in maniera seria ed appropriata, e fossero in
grado di individuare collegamenti interdisciplinari con le materie affini.
Modalità di verifica
Per quanto riguarda lo scritto di Italiano sono state effettuate tre prove al quadrimestre che
riproducevano le tipologie ormai canoniche dell’analisi testuale, del componimento argomentativo
sotto forma di saggio breve, del tema di ordine generale o di argomento storico.
L'orale è stato testato il più possibile, compatibilmente con la necessità sempre impellente di
coniugare in modo proficuo il momento della verifica, che richiede l'impiego di una congrua quantità
di tempo, con quello indispensabile per le altre attività.
3
Contenuti
Il Romanticismo: coordinate spazio – temporali. Il Romanticismo europeo. I generi letterari: il teatro,
il romanzo e la poesia lirica. Il dibattito in Italia.
Madame de Staël: cenni biografici.
“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” – lettura di un passo.
P. Giordani:
“ Un italiano risponde alla lettera di Madame de Staël”
Giovanni Berchet:
Da “Lettera semiseria di Grisostomo ad un suo figliuolo”: La poesia popolare
A. Manzoni: cenni biografici.
Dalle "Odi Civili": Il 5 maggio.
Da “Lettera a Monsieur Chauvet”: Storia e invenzione poetica
Dall' "Adelchi": presentazione dell'opera;
Atto III, coro.
Atto IV, coro.
Atto V, scena VIII: La morte di Adelchi.
"I Promessi Sposi": presentazione dell'opera; lettura di passi e, in particolare, delle pagine
conclusive.
G. Leopardi: cenni biografici; il pensiero leopardiano.
Dallo "Zibaldone di pensieri”:
Passi sulla poetica del vago e dell’indefinito.
Dai "Canti":
La sera del dì di festa
L'infinito
Il sabato del villaggio
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
La ginestra.
Dalle "Operette Morali": Dialogo della Natura e di un Islandese
Cantico del gallo silvestre
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare
4
Dialogo di Tristano e di un amico
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Il secondo Ottocento: Il Positivismo e le reazioni alla sua egemonia culturale
La Scapigliatura : caratteri generali.
I. U. Tarchetti, “Fosca”: L’attrazione della morte.
C. Baudelaire. Dai "Fiori del Male": Corrispondenze - L' albatro.
L’età del Realismo e del Naturalismo: l’immaginario. La figura dell’artista.
E. e J. De Goncourt: Prefazione a "Germinie Lacerteux".
G. Flaubert. Da “Madame Bovary”: lettura di un passo.
E. Zola: la poetica del Naturalismo; presentazione dell'opera di Zola.
Da “L'Assommoir”: “Un fiume d'alcool invade Parigi”
G. Verga: cenni biografici; la poetica del Verismo.
Da “Vita dei campi”:Rosso Malpelo
Da “I Malavoglia”: presentazione dell'opera; passi dai capp. I, IV, IX, XV.
Da “Novelle rusticane”: La roba
“Mastro-don Gesualdo”: presentazione dell’opera; “La morte di Gesualdo”
G. Carducci: cenni biografici.
Da “Rime nuove”: Pianto antico
Dalle "Odi Barbare": Alla stazione in una mattina d'autunno
Il Decadentismo europeo : le sue manifestazioni letterarie. Il Decadentismo italiano.
G. Pascoli: cenni biografici.
Da “Pensieri e discorsi”: E’ dentro noi un fanciullino…
Da "Myricae": Lavandare
Il lampo
Novembre
L’assiuolo
X agosto
Da "Canti di Castelvecchio": Il gelsomino notturno Da “Poemetti”: Italy (lettura di alcune
strofe)
5
L'estetismo europeo
J.K. Huysmans. Da “A' rebours”: La realtà sostitutiva
G. D'Annunzio: cenni biografici; le novelle, i romanzi, la produzione poetica.
Da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
Da "Alcyone”: La pioggia nel pineto
I pastori
Il primo Novecento: la società di massa. La cultura delle avanguardie. La reazione al
dannunzianesimo.
Le Avanguardie:
Il Crepuscolarismo.
G. Gozzano: cenni biografici
Da “I colloqui”: La Signorina Felicita (lettura di alcune sezioni)
Il Futurismo.
F.T.Marinetti:
Manifesto del futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
da “Zang Tumb Tumb”: Bombardamento
A. Palazzeschi: da “L'incendiario”: E lasciatemi divertire!
L. Pirandello: Cenni biografici.
Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario
Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato
La signora Frola e il Signor Ponza, suo genero
Da “Il fu Mattia Pascal”: letturadi passi
Da “Uno, nessuno e centomila” : Nessun nome
Da“Sei personaggi in cerca d’autore”: Il teatro nel teatro.
I.Svevo: cenni biografici.
Da “Una vita”: “Le ali del gabbiano”
“Senilità”: presentazione dell’opera
Da “La coscienza di Zeno”: La morte del padre
La scelta della moglie
La vita attuale è inquinata alle radici
G. Ungaretti: cenni biografici.
6
Da “Allegria”: Il porto sepolto
Sono una creatura
Soldati
Veglia
San Martino del Carso
I fiumi
Da “Il dolore”: Non gridate più
E. Montale: cenni biografici.
Da "Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Non chiederci la parola…
Dalle "Occasioni": Non recidere, forbice, quel volto
Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio…
La letteratura nel secondo dopoguerra: lineamenti fondamentali
C. Pavese: cenni biografici.
“La luna e i falò”: Il falò di Santina
“La casa in collina”: lettura delle pagine finali
Da “Lavorare stanca”: I mari del sud
B. Fenoglio: cenni biografici.
“La paga del sabato”: lettura integrale
“La malora”: lettura di un passo
P. P. Pasolini: cenni biografici
“Una vita violenta”: lettura di un passo
“Scritti corsari”: Risposta a Italo Calvino sull'omologazione
Primo Levi: cenni biografici
o “Se questo è un uomo”: Il canto di Ulisse
o “Il sistema periodico”: Zolfo
D. Alighieri, La Divina Commedia, "Paradiso":
I, 1-72; 94-142.
III
VI
7
XI
XV
XVII, 46-99.
XXXIII, 1-39; 115-144.
Testi in adozione:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, Torino
voll. 4,5,6
Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso
L’Insegnante I rappresentanti di classe
Prof.ssa Laura Bauducco Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu
8
8.2 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA - INGLESE
DOCENTE: prof.ssa Roberta Ambroggio
TESTO: Into Science, E. Grasso, P. Melchiori, CLITT
Materiale su fotocopia
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Dopo un biennio in cui si sono avvicendate insegnanti diverse, il triennio è stato caratterizzato
da una continuità didattica con la sottoscritta, che ha cercato di colmare le lacune pregresse e di
portare tutta la classe ad un livello omogeneo. Nonostante tutto in generale lo studio è stato poco
costante e approfondito da una buona parte degli studenti. Globalmente la classe ha raggiunto
una conoscenza quasi discreta delle principali regole grammaticali e funzioni linguistiche.
Alcuni allievi hanno raggiunto competenze tali da permettere loro un buon uso della lingua in
contesti differenti, sia in forma scritta che orale. Si segnala la presenza di quattro allievi che
hanno superato il FIRST (due a maggio di quarta e due a dicembre di quest’anno scolastico). In
un certo numero di allievi permangono delle difficoltà nell’organizzazione di un discorso ben
articolato sia nella forma scritta che orale.
METODOLOGIA
Il programma di Lingua inglese ha previsto lo studio di alcuni argomenti di genere sc ientifico
affiancati ad altri di genere letterario collegati alle tematiche trattate (clonazione, biotecnologia
e medicina, robotica). I testi di argomento tecnico-scientifico sono stati letti e commentati in
classe; spesso l’insegnante ha sollecitato discussioni e dibattiti che si sono svolti nei limiti degli
interessi degli studenti e delle loro abilità linguistiche. Un valido supporto alle lezioni è anche
stata la visione di video sulle tematiche trattate (di solito dal sito www.ted.com). Per quanto
riguarda la letteratura, invece, la fase iniziale ha previsto una introduzione da parte
dell’insegnante sull’autore ed il periodo storico-sociale in cui si inserisce la sua opera, seguita
dalla visione della versione cinematografica. In seguito, gli allievi sono stati guidati nella lettura
e interpretazione di alcuni estratti dai romanzi.
Al fine di motivare e coinvolgere maggiormente gli allievi si sono creati gruppi di lavoro per
l’approfondimento di alcuni argomenti svolti in classe. In particolare gli studenti hanno lavorato
sulle applicazioni della robotica in diversi campi (medico, militare, agricolo…). Gli studenti
hanno lavorato in modo autonomo e hanno poi relazionato alla classe tramite presentazione
multimediale (PowerPoint). Tutti gli studenti hanno lavorato con serietà, anche se i risultati sono
stati diversi a seconda del tempo dedicato all’approfondimento degli argomenti e alle diverse
9
capacità linguistiche.Se ritenuto opportuno, gli studenti potranno far vedere la presentazione
durante il colloquio orale.
VERIFICA e VALUTAZIONE: Nel corso dell'anno sono state svolte verifiche orali in modo
sistematico e continuo.
Le verifiche scritte hanno avuto per oggetto gli argomenti di natura scientifica e letteraria trattati in
classe; sono state utilizzate domande a risposta aperta e brevi trattazioni sintetiche. Nel secondo
quadrimestre, per aiutare gli studenti a migliorare le prestazioni scritte sono state assegnate domande
da svolgere a casa o in classe. Alle risposte a volte è stata data una valutazione che ha influito sul
voto finale.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli
obiettivi prefissati nella programmazione, del possesso di determinati contenuti, dell'impegno
manifestato dagli allievi e delle effettive capacità e competenze acquisite.
La conoscenza dei contenuti è stata spesso privilegiata rispetto alla correttezza formale.
Con riferimento alle simulazioni di terza prova, si è adottata la tipologia B.
PROGRAMMA D’ESAME DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Grammatica: Ripasso dei seguenti argomenti grammaticali: - Tempi verbali attivi - Tempi
verbali passivi - Reported Speech – relative Clauses.
Module 1: Immunology
What is Immunology p. 188
The Immune System p. 189
Some questions and answers about our Immune System p. 191, 192, 193
Active and Passive Immunity p. 197, 198
Stress Can Weaken Vaccines p. 201
Disorders of the Immune System p. 202, 203,
Autoimmune disorders p. 205, 206, 207
Module 2: Biotechnology
Biotechnology p. 213
Genetic engineering p. 216
Bioremediation p. 220
Meet the microbes eating the Gulf oil spill p. 221
GMOs p. 222, 223
Biotechnology and medicine p. 227
Cloning p. 232
Human cloning p. 234, 235, 236
10
Module 3: Robotics
Five modern phenomena predicted by science fiction p. 242
What’s a robot? p. 244, 245, 246, 247
Japan nuclear crisis: where are the robots? p. 252
Medical – surgery branch p. 254
Space branch p. 257
Industrial branch p. 259
Robotic branches: ricerche a gruppi con presentazione multimediale
Module 4: New materials
Artificialskin p. 264
e-skin p. 267
Bioplastic p. 270
Italy bans the use of shopping plastic bags p. 272
Packaging that knows when food is going bad p. 274
Textiles p. 276
Curtain that block noise p. 282
New material temporary tightens skin photocopy
Clothes that Clean Themselves photocopy
Module 5: Science and literature (materiale su fotocopia)
An introduction to science fiction
Mary Shelley, Frankenstein, or the Modern Prometheus, visione del film
The novel: plot, narrative technique, main themes
From Frankenstein, excerpts
Robert Louis Stevenson, The Strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde
The novel: plot, narrative technique, main themes
Lavori a gruppi:
CHIAMBRETTO, GALLETTO, GIRAUDO, OBERTO: robots in the cinema industry;
BONO, ARACRI, ARGENTERO: robots in medicine;
FERRERO, GAVATORTA, LOVERA: militaryrobots;
MICCOLI, SCARATI, VOICULESCU: domoticand house automation;
FAZIO, FERRARI, MINA: robots in space;
BARADELLO, DROUSSI, TESTA: robots in entertainment
11
Si allega fascicolo con tutto il materiale fornito agli allievi dall’insegnante.
L’Insegnante I rappresentanti di classe
Prof.ssa Roberta Ambroggio Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu
12
8.3 INFORMATICA
DOCENTE: prof.ssa Alessandra Vassallo
Obiettivi
Affrontare situazioni complesse, scomporle in parti, analizzarle separatamente.
Potenziare la capacità di analisi e sintesi.
Argomentare, valutare
Comprendere un testo
Analizzare e risolvere un problema
Approfondire autonomamente argomenti tecnici
Saper classificare i sistemi
Riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà
Saper realizzare leggere un diagramma degli stati e/o una tabella di transizione rappresentativi di un automa
Conoscere il funzionamento della macchina di Turing
Comprendere le modalità di gestione hardware e software di una rete.
Saper progettare il collegamento di due computer in rete
Comprendere e analizzare le differenze tecniche operative dei vari strumenti hardware legati all'implementazione di una rete.
Saper individuare l’appartenenza di un host a una rete in base a indirizzo IP e maschera di sottorete
Saper riconoscere i diversi dispositivi di rete
Metodologia 1) Lezione frontale 2) Discussione guidata 3) Esercitazioni guidate e individuali
Strumenti
Libro di testo
Utilizzo della LIM
Presentazioni multimediali
Fotocopie
Verifiche e valutazione
Interrogazioni scritte
Tipologie di testi scritti secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali
Interrogazioni orali Si intendono raggiunti gli obiettivi didattici quando l’allievo dimostra di aver acquisito le parti essenziali degli argomenti trattati e applica le conoscenze senza commettere errori gravi. In particolare:
Teoria della computazione: conoscenza dei vari tipi di sistema e capacità di classificazione di sistemi reali; comprensione di un diagramma degli stati e capacità di ricavare le caratteristiche fondamentali
13
di un automa a starti finiti; comprensione del meccanismo di funzionamento di una Macchina di Turing (MdT) e capacità di determinare il risultato del funzionamento di una MdT date situazione iniziale e quintuple di programmazione.
Fondamenti di telematica: conoscenza dei principali elementi riguardanti la comunicazione tra calcolatori; saper classificare reti in base alle dimensioni; conoscere le caratteristiche di mezzi trasmissivi e dispositivi di rete; conoscere la struttura della pila TCP/IP e i principali protocolli utilizzati; saper individuare l’indirizzo di rete alla quale appartiene un host noti indirizzo IP e subnet mask.
PROGRAMMA D’ESAME DI INFORMATICA
TESTO
Gallo P. - Sirsi P., Informatica 3 - Quinto anno licei scientifici, Minerva scuola
CONTENUTI
Teoria della computazione
U.D. 1: SISTEMI E MODELLI
I sistemi
Caratteristiche e comportamento di un sistema
Sistemi di controllo a catena aperta e chiusa
Classificazione dei sistemi
Rappresentazione dei sistemi: i modelli
Classificazione dei modelli
U.D. 2: TEORIA DEGLI AUTOMI
Introduzione agli automi
Rappresentazione di automi
Il diagrammi degli stati
Le tabelle di transizione
Gli automi riconoscitori
Automi di Mealy e di Moore
U.D. 3 CALCOLABILITÀ E COMPLESSITÀ COMPUTAZIONALE
Problemi, algoritmi e modelli computazionali
Un modello computazionale: la macchina di Turing
Comportamento della macchina di Turing
Rappresentazione della funzione di transizione La complessità computazionale
Fondamenti di telematica
LE RETI DI COMPUTER E LA COMUNICAZIONE IN RETE
La comunicazione con le nuove tecnologie
Componenti del sistema di comunicazione
Modalità di comunicazione: simplex, half-duplex, full-duplex
Tecnologie di trasmissione: punto-punto, multi punto e broadcast
Segnale analogico e segnale digitale
14
Efficienza di un canale trasmissivo: larghezza di banda, velocità di trasmissione, tempo di bit, tasso di errore
Controllo e recupero dell’errore
Definizione di rete di calcolatori
Topologie di rete
Classificazione delle reti: LAN, MAN e WAN
Composizione di una rete di computer: terminali, host, nodi, linee di interconnessione
Mezzi fisici di trasmissione: conduttori in rame, fibre ottiche e trasmissioni wireless
Cenni su ADSL
La commutazione: di circuito, di pacchetto e di messaggio
L’esempio della rete telefonica commutata
Cenni sulle reti Ethernet
Apparati di rete: o Schede di rete o Repeater e hub o Bridge, switch e wireless access point o Il router
U.D. 2: I PROTOCOLLI DI RETE
Protocolli di comunicazione
Standardizzazione dei protocolli di comunicazione
Il modello ISO/OSI e i suoi livelli
La suite di protocolli TCP/IP
Il livello rete e gli indirizzi MAC
Il livello Internet e i suoi principali protocolli
Gli indirizzi IP e la loro classificazione
Maschere di sottorete e determinazione della rete a cui appartiene un host
Il modello client-server
Navigazione nel web e protocollo http: Server Proxy, indirizzi URL
Posta elettronica: protocolli SMTP, POP3 e IMAP
Calcolo numerico
LE RETI DI COMPUTER E LA COMUNICAZIONE IN RETE
Rappresentazione dei numeri
Matrici e vettori
Operazioni su matrici
Determinante di una matrice
Octave: o Calcolo matriciale o Variabili e operatori o Octave come linguaggio di programmazione o Le strutture di controllo o Bubble sort di un vettore
L'Insegnante I rappresentanti di classe
Prof.ssa Alessandra Vassallo Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu
15
8.4 MATEMATICA
DOCENTE: Prof.ssa Silvia Cavallo
Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi minimi richiesti per la sufficienza possono dirsi raggiunti pressoché globalmente da
quasi tutti gli allievi. Un gruppo di studenti conosce adeguatamente gli argomenti trattati, sa
identificare abbastanza agevolmente le situazioni problematiche, soprattutto quando esse rientrano
nei canoni tradizionali, e risolverle usando gli strumenti appropriati, anche se a volte incontra ancora
qualche difficoltà nel gestire ed organizzare i tempi a disposizione. Altri, invece, per la fragilità delle
conoscenze di base e delle doti attitudinali o a causa di un lavoro individuale poco efficace e non
sempre costante, evidenziano ancora qualche disagio nell'affrontare autonomamente gli esercizi. Solo
pochi allievi, con buone doti logiche e motivati dall'interesse per le discipline scientifiche, hanno
conseguito risultati ampiamente positivi e in alcuni casi ottimi.
Metodologia
Lezione frontale.
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli allievi (didattica della matematica per problemi, con
attenzione alla ricerca e alla scoperta).
Esercizi applicativi guidati.
Esercizi applicativi individuali.
Svolgimento prove di Esame di Stato degli anni precedenti.
Attività di recupero (sportello e corso di recupero).
Verifiche e valutazione
Tipologie delle prove di verifica:
Interrogazioni orali.
Verifiche scritte (esercizi e problemi articolati in vari punti, valutati assegnando un punteggio
ad ogni singola unità. La valutazione globale è scaturita dalla somma delle valutazioni dei
singoli esercizi ed ha avuto come voto massimo 10 e come limite inferiore 3).
Simulazione di seconda prova.
Fattori che hanno concorso alla valutazione finale della disciplina:
Impegno, attenzione e motivazione allo studio.
Partecipazione al dialogo educativo.
Interventi pertinenti.
Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo allievo e della classe stessa.
Puntualità e precisione nel rispetto delle consegne e nell’esecuzione dei compiti a casa.
Capacità di approfondimento e di rielaborazione.
Corsi di recupero
16
PROGRAMMA D’ESAME DI MATEMATICA
Testo
Leonardo Sasso, La Matematica a colori, Vol. 5 (Edizione Blu), Petrini
TEMA M Limiti e continuità
UNITA’
ARGOMENTO
RIFERIMENTO
TESTO
DIMOSTRAZIONE
Unità 1
Introduzione
all’analisi
Funzioni reali di
variabile reale:
dominio e studio del
segno
Pag. 12-16 -
Funzioni crescenti e
decrescenti, pari e
dispari, periodiche.
Funzione inversa.
Pag. 18-23 -
Unità 2
Limiti di funzioni
reali di variabile
reale
Introduzione al
concetto di limite.
Pag. 58-62 -
Dalla definizione
generale alle
definizioni particolari.
Pag. 62- 68 -
Teoremi di esistenza e
unicità sui limiti:
teorema del confronto
1, teorema di esistenza
e teorema della
permanenza del segno.
Pag. 69-73 NO
Le funzioni continue e
l’algebra dei limiti.
Pag. 74-82 NO
Forme di indecisione
di funzioni algebriche.
Pag. 82-85 NO
Forme di indecisione
di funzioni
trascendenti e limiti
notevoli.
Pag. 87-91 SI’ pag.90
Infinitesimi e infiniti. Pag. 93-97 -
Unità 4
Continuità
Funzioni continue. Pag.187- 188 -
Punti singolari e loro
classificazione.
Pag. 190-191 -
Proprietà delle
funzioni continue:
teorema di esistenza
degli zeri, teorema di
Weierstrass, teorema
dei valori intermedi.
Metodo di bisezione.
Pag. 193-197 NO
17
Asintoti e grafico
probabile di una
funzione.
Pag. 199-201 NO
TEMA N Calcolo differenziale
UNITA’
ARGOMENTO
RIFERIMENTO
TESTO
DIMOSTRAZIONE
Unità 5
La derivata
Il concetto di derivata:
significato geometrico del
rapporto incrementale e della
derivata in un punto.
Pag. 264-267 -
Legame tra continuità e
derivabilità.
Pag. 268 SI’
Derivate delle funzioni
elementari:
Funzione costante (5.2)
Funzione identica (5.3)
Funzione esponenziale
(5.6)
Funzione logaritmica
(5.7)
Funzione seno (5.8)
Pag. 269-272 SI’
Algebra delle derivate:
Linearità della derivata
Derivata del prodotto e
del quoziente di due
funzioni
Pag. 273-277 NO
Derivata della funzione
composta e della funzione
inversa e derivate delle inverse
delle funzioni goniometriche.
Pag.277-281 NO
Classificazione e studio dei
punti di non derivabilità.
Pag. 283-284 -
Applicazioni geometriche del
concetto di derivata: retta
tangente a una curva.
Pag. 287 -
Applicazione del concetto di
derivata nelle scienze:
interpretazione del rapporto
incrementale come velocità
media e della derivata come
velocità istantanea.
Pag. 289-291 -
Teoremi di Fermat, di Rolle e
di Lagrange. Primo e secondo
corollario del teorema di
Lagrange.
Pag. 339-346 SI’
No teorema 6.1
18
Unità 6
Teoremi sulle
funzioni derivabili
Funzioni crescenti e
decrescenti e criteri per
l’analisi dei punti stazionari:
studio del segno della derivata
prima
Pag. 347-349 NO
Problemi di massimo e
minimo
Esercizi -
Funzioni concave e convesse,
punti di flesso e legame con la
derivata seconda.
Pag. 359-362 NO
Teoremi di Cauchy e di de
l’Hopital
Pag. 365 e 367 NO
Unità 7
Lo studio di
funzione
Schema per lo studio del
grafico di una funzione:
Funzioni algebriche
polinomiali, razionali
frazionarie, irrazionali.
Funzioni trascendenti
esponenziali,
logaritmiche e
goniometriche.
Funzioni con valori
assoluti.
Pag. 426- 442 -
Grafici deducibili: dal grafico
di 𝑦 = 𝑓(𝑥) ai grafici di 𝑦 =
𝑓′(𝑥), 𝑦 =1
𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑒𝑓(𝑥),
𝑦 = 𝑙𝑛𝑓(𝑥)
Pag. 444-447 -
TEMA O Calcolo integrale ed equazioni differenziali
UNITA’
ARGOMENTO
RIFERIMENTO
TESTO
DIMOSTRAZIONE
Unità 8
L’integrale
indefinito
Primitive e integrale
indefinito
Pag. 522-524 NO
Integrali immediati e
integrali per
scomposizione.
Pag. 525-527 -
Integrazione di
funzioni composte e
per sostituzione.
Pag. 527-531 -
Integrazione per parti. Pag. 532-533 -
Integrazione di
funzioni razionali
frazionarie
Pag. 535-537 -
Dalle aree al concetto
di integrale definito:
Pag. 582-584 -
19
Unità 9
L’integrale definito
area come limite di una
somma, somma di
Riemann,
interpretazione
geometrica
dell’integrale definito.
Le proprietà
dell’integrale definito
e il suo calcolo: primo
teorema fondamentale
del calcolo integrale
Pag. 585-588 SI’
Applicazioni
geometriche degli
integrali definiti:
calcolo di aree, calcolo
dei volumi con il
metodo delle sezioni,
solidi di rotazioni e
metodo dei gusci
cilindrici.
Pag. 589-596 -
Altre applicazioni del
concetto di integrale
definito:
Applicazioni
alla fisica
Valore medio di
una funzione e
teorema del
valor medio.
Pag. 597-600 NO
Funzioni integrabili e
integrali impropri
Pag. 601-605 -
La funzione integrale e
secondo teorema
fondamentale del
calcolo integrale.
Pag. 607-608 NO
Integrazione
numerica:metodo dei
rettangoli, metodo dei
trapezi e metodo delle
parabole.
Pag. 610-613 NO
Unità 10
Le equazioni
differenziali
Introduzione alle
equazioni
differenziali.
Pag. 665-666 -
Equazioni differenziali
del primo ordine
lineari
a variabili
separabili
Problema di Cauchy
Pag. 666-668 NO
20
Equazioni differenziali
lineari del secondo
ordine omogenee
Pag. 670-671 -
Problemi che hanno
come modello
equazioni differenziali
Pag. 674-677 -
L’Insegnante I rappresentanti di classe
Prof.ssa Silvia Cavallo Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu
21
8.5 FISICA
DOCENTE: Prof. Giulio Marengo
Obiettivi raggiunti
La maggioranza degli allievi della classe ha raggiunto una preparazione sufficiente sugli argomenti
trattati;alcuni di loro, inoltre, hanno acquisito e rielaborato i concetti in modo profondo, maturando
una preparazione sicura e precisa.
Al contrario, un numero ridotto di studenti ha mostrato difficoltà pressochè costanti durante tutto
l’anno scolastico, nonostante i numerosi momenti di ripasso e l’ampio spazio dedicato alle domande,
alla correzione dei compiti ed ai chiarimenti.
Aldilà dei risultati raggiunti da ciascuno, la classe ha partecipato con attenzione e curiosità all’analisi
della teoria e dei fenomeni fisici affrontati.
Metodologia
Durante lo studio dell’elettromagnetismo si è fatto spesso ricorso al laboratorio di Fisica: in alcuni
casi la visualizzazione sperimentale dei fenomeni è avvenuta prima della loro formalizzazione teorica,
in altri casi l’esperienza in laboratorio è servita a confermare quanto già studiato.
Tutti i capitoli sono stati affrontati mediante lezioni frontali, stimolando il più possibile l’interazione
tra l’insegnante e gli allievi, grazie ai loro interventi ed alle loro riflessioni.
A completamento del percorso didattico di Fisica, la classe ha partecipato ad una visita del CERN in
data 11 aprile 2018.
Verifiche e valutazione
Nel I quadrimestre: 2 interrogazioni scritte, 1 prova in parte scritta ed in parte orale ed 1
simulazione di terza prova;
nel II quadrimestre: 2 interrogazioni scritte ed 1 prova in parte scritta ed in parte orale.
Nelle prove sono stati inseriti sia domande teoriche sia esercizi.
22
PROGRAMMA D’ESAME DI FISICA
Testi
Ugo Amaldi: L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu(Seconda edizione)- Volume 2
Ugo Amaldi: L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu(Seconda edizione)- Volume 3
Ed. Zanichelli
CONTENUTI:
ELETTROMAGNETISMO
Argomento Pagine libro di testo Deduzione della legge fisica
Magneti e campo magnetico Pagg.884 - 887 (volume 2)
Confronto tra campo
magnetico e campo elettrico Pagg.887 e 888
Campo magnetico generato da
un filo percorso da corrente:
esperienza di Oersted
Pagg.888 e 889
L’esperienza di Faraday Pag.889
L'interazione corrente-
corrente: esperienza di Ampère Pagg.890 e 891
Forza magnetica su un filo
percorso da corrente Pagg.894 e 895
Legge di Biot-Savart Pag.896 No
Campo magnetico di un
solenoide Pagg.899 e 900
Forza di Lorentz Pagg.924 e 925
Moto di una carica elettrica in
un campo magnetico uniforme Pagg.931 - 933
Flusso del campo magnetico e
teorema di Gauss per il
magnetismo
Pagg.936 - 938
No
La circuitazione del campo
magnetico: il teorema di
Ampère
Pagg.940 - 942
Sì (pagg.941 e 942)
Le proprietà magnetiche dei
materiali: sostanze
ferromagnetiche,
paramagnetiche e
diamagnetiche
Pagg.946 - 949
L’induzione elettromagnetica e
la legge di Faraday-Neumann e
di Lenz
Pagg.970 - 978 (volume 3)
Sì (pagg.977 e 978)
L’interruttore differenziale Pag.974
La legge di Lenz Pagg.980 e 981
Induttanza di un solenoide Pagg.985 e 986
23
Produzione di corrente
alternata con campi magnetici:
l’alternatore
Pagg.1006 e 1007
Forza elettromotrice alternata,
corrente alternata e relativi
valori efficaci
Pagg.1007 - 1009
Descrizione qualitativa del
circuito ohmico, del circuito
induttivo e del circuito
capacitivo
Pagg.1011 - 1013
Nessun calcolo svolto
Il trasformatore Pagg.1027 - 1029
La corrente di spostamento Pagg.1048 e 1049
Le equazioni di Maxwell Pag.1054
Le onde elettromagnetiche Pagg.1055 - 1058
La quantità di moto della luce Pagg.1062 e 1063
La polarizzazione delle onde
elettromagnetiche Pagg.1064 - 1068
La legge di Malus Pag.1068 No
RELATIVITA’ RISTRETTA
Argomento Pagine libro di testo Deduzione della legge fisica
Esperimento di Michelson e
Morley Pagg.1094 - 1097
Gli assiomi della Relatività
ristretta Pag.1098
Relatività della simultaneità di
due eventi Pagg.1098 - 1100
Dilatazione dei tempi Pagg.1103 - 1105 Sì (pagg.1103 e 1104)
Contrazione delle lunghezze Pagg.1107 - 1109 Sì (pag.1108)
Le trasformazioni di Lorentz Pagg.1112 e 1113 Sì (allegato 1)
L’intervallo invariante Pagg.1132 - 1134 No
La composizione relativistica
delle velocità Pagg.1143 - 1144 Sì (allegato 2)
L’equivalenza tra massa ed
energia Pagg.1147 - 1150 Sì (pagg.1148 e 1149)
Energia cinetica, massa e
quantità di moto relativistiche Pag.1154
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA E LA FISICA QUANTISTICA
Argomento Pagine libro di testo Deduzione della legge fisica
Il corpo nero Pagg.1190 - 1192
I quanti di Planck Pagg.1192 e 1193
L’effetto fotoelettrico Pagg.1194 - 1199
24
L’effetto Compton Pagg.1200 - 1203
L’esperimento di Millikan Pagg.1208 - 1210
Modello atomico di Bohr Pagg.1212 e 1213
Dualismo onda - corpuscolo
della luce Pag.1230
Lunghezza d’onda di De
Broglie
Pagg.1231 e 1232
Verifica della coerenza con la
relazione di Planck e con la
condizione di quantizzazione
di Bohr (pagg.1231 e 1232)
L’esperimento di Davisson e
Germer Pagg.1233
Enunciati del principio di
indeterminazione di
Heisenberg
Pagg.1235 – 1237
Modello di Bohr-Sommerfeld:
numeri quantici n, l, ml e ms Pagg.1249 - 1251 e 1256
FISICA DELLE PARTICELLE
Argomento Pagine libro di testo Deduzione della legge fisica
Lo spin delle particelle, i
bosoni edi fermioni Pagg.1264 e 1265
Il linac ed il ciclotrone Pagg.1362 - 1364
Interazioni elettromagnetica,
forte, debole e gravitazionale Appunti
Le particelle-materia, le
particelle-forza ed il Modello
Standard
Pag.1378
Campo di Higgs e bosone di
Higgs Appunti
L’Insegnante I rappresentanti di classe
Prof. Giulio Marengo Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu
25
Allegato 1 - Le trasformazioni di Lorentz
Consideriamo un sistema di assi cartesiani ortogonali, ed un altro che si sposta rispetto ad
esso con velocità costante v in modo che gli assi x e x'coincidano scivolando l'uno
sull'altro, e gli altri (y e y', z e z') restino paralleli fra di loro, e consideriamo i due diversi
sistemi di coordinate:
S (x, y, z, t) e S' (x', y', z', t')
riferiti rispettivamente alle origini O e O'.
S' si muove rispetto a S con velocità v;quindi, nel sistema di riferimento S, per la
contrazione delle lunghezze sarà:
O'P' = x'
(1)
Infatti, considerando in S un punto P dell'asse x = x', punto che corrisponde a P' nel
sistema S', le sue coordinate rispetto ai due sistemi risulteranno:
P (x, 0, 0, t) e P' (x', 0, 0, t')
Nel riferimento S, O'P' = x' se S' è fermo, ma se é in moto con velocità v esso si contrae
nella direzione del moto riducendosi ad una lunghezza data dalla (1).
Ma essendo O'P' = OP – OO' = x – v t , si deduce che
x-vt = x'
da cui:
26
x’ = ·(x - vt) (2)
Ordinata e quota rimangono uguali, visto il modo in cui S' si muove rispetto a S. Si
consideri invece la coordinata temporale. Il segmento OP rispetto al sistema S' é uguale
alla somma di:
OO' = v t’ con O'P = O'P' = x'
Il segmento OP, però, se S' fosse fermo, misurerebbe x; rispetto al riferimento S’ si muove
con velocità v, e dunque, nella direzione del moto, risulta più corto:
OP = x
quindi:
𝑣𝑡′ + 𝑥′ = x
e, utilizzando la (2):
𝑣𝑡′ + · (x − vt) = x
dividendo ambi i membri per ho:
𝑣𝑡′
+ (x − vt) =
x
𝟐
da cui si ricava:
𝑣𝑡′
+ (x − vt) = 𝑥 · (1 −
𝒗𝟐
c𝟐)
𝑣𝑡′
+ x − vt = 𝑥 −
𝒙𝒗𝟐
c𝟐
𝑣𝑡′
= vt −
𝒙𝒗𝟐
c𝟐
e, dividendo per v
27
𝑡′
= t −
𝒙𝒗
c𝟐
t′ = · (t − 𝒗𝒙c𝟐) (3)
Si hanno così le nuove trasformazioni chiamate TRASFORMAZIONI DI LORENTZ,
in onore di H.A.Lorentz, lo scienziato olandese da noi già citato.
Allegato 2 – Composizione relativistica delle velocità.
Richiamiamo le trasformazioni di Lorentz:
{
x = γ · (x′ + vt′)
y = y′
z = z′
t = γ·(t′ +𝒗𝒙′
c𝟐)
ed indichiamo con u il modulo della velocità di un punto nel sistema di riferimento
S (x, y, z, t) e con u’ il modulo della velocità dello stesso punto nel sistema di riferimento
S’ (x’, y’, z’, t’); il punto si muove nella direzione degli assi x e x’.
Allora u =dx
dt ed u′ =
dx′
dt′ .
Applicando le proprietà delle derivate risulta:
u =dx
dt=
dxdt′dtdt′
= γ·(𝑢′+ v)
γ·(1+𝒗𝒖′c𝟐
)
= 𝑢′+ v
1+𝒗𝒖′c𝟐
.
29
8.6 STORIA
DOCENTE: prof.ssa Mjriam Piras
Obiettivi raggiunti
Solo pochi alunni hanno pienamente raggiunto gli obiettivi indicati nella programmazione di inizio
anno scolastico e sanno orientarsi bene all'interno del quadro storico analizzato, sono in grado di
effettuare collegamenti su vasta scala temporale e anche a livello interdisciplinare, intuiscono le
relazioni di causa-effetto e mostrano curiosità e voglia di imparare.
La maggior parte della classe, forse a causa di una motivazione non troppo forte, ha raggiunto obiettivi
appena soddisfacenti per le proprie capacità, conosce gli avvenimenti storici in maniera poco
approfondita e solida e manca di uno spirito critico e di un valido metodo di studio perché non si è
impegnata a sufficienza e con costanza nella rielaborazione e nello studio personale.
Alcuni alunni, che non si sono impegnati quanto avrebbero potuto, hanno dimostrato difficoltà e
fragilità, a tal punto da aver conseguito solo gli obiettivi minimi.
Metodologia L'insegnante ha privilegiato le lezioni frontali perché la classe, ad eccezione di un gruppo molto ristretto di
alunni sempre pronti, disponibili ed attenti, non ha mostrato interesse quando sono state proposte discussioni
o si è tentato di effettuare la “lezione capovolta”.
Sono stati utilizzati fonti storiche e letterarie, perché ci fosse un “incontro” diretto con i testimoni
dell'Ottocento e del Novecento, e anche materiali multimediali (foto, video e documentari) sia prima che dopo
la spiegazione, in modo da suscitare la curiosità negli alunni o inquadrare ulteriormente un determinato fatto
o personaggio storico.
Verifiche e valutazione Sono state effettuate verifiche orali e scritte.
Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle capacità indicate negli
obiettivi di inizio anno, anche dell'impegno, della partecipazione in classe e della costanza nello studio.
30
PROGRAMMA D’ESAME DI STORIA
• TESTO
Andrea GIARDINA, Giovanni SABBATUCCI, Vittorio VIDOTTO, Lo spazio del tempo, Voll. 2 e 3
– Bari 2016
CONTENUTI
I PRIMI ANNI DELL'ITALIA UNITA Demografia, società ed economia: popolazione e alfabetizzazione, vita di città e di campagna, aziende
moderne, mezzadria e latifondo. Il divario tra Nord e Sud.
DESTRA E SINISTRA STORICA Il governo della Destra: l'accentramento politico, la riforma scolastica e quella elettorale, il problema del
brigantaggio e il malessere generale del Mezzogiorno. Lo sviluppo della rete ferroviaria, la crescita
dell'agricoltura e il mancato sviluppo industriale del Sud. La dura politica fiscale: il corso forzoso e la tassa
sul macinato.
Il completamento dell'unità: la conquista del Veneto e la presa di Roma. La questione romana e il fallimento
dei tentativi garibaldini. La terza guerra d'indipendenza e l'annessione del Veneto. La breccia di Porta Pia e la
fine del potere temporale dei papi. Le leggi Guarentigie e il Non expedit.
La caduta della Destra e il governo della Sinistra da Depretis a Crispi: il decentramento politico, la legge
Coppino, l'ampliamento del suffragio e la riforma elettorale del 1882, gli sgravi fiscali e il trasformismo di
Depretis. Il protezionismo. Il Codice Zanardelli, la politica estera e la fine del primo governo Crispi.
INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETÀ DI MASSA La seconda rivoluzione industriale: l'acciaio, la chimica, il motore a scoppio e l'elettricità. I traguardi della
scienza medica, la scoperta di farmaci efficaci e la costruzione di nuovi ospedali.
La società di massa e l'individuo. Industrializzazione e urbanizzazione: la produzione in serie e la
meccanizzazione. Le nuove stratificazioni sociali: le “aristocrazie operaie”, i “colletti bianchi” e gli impiegati.
L'istruzione e l'informazione: la scuola come servizio pubblico, l'obbligo scolastico e il conseguente calo
dell'analfabetismo; la diffusione dei giornali. Gli eserciti e i partiti di massa. La questione femminile: i primi
movimenti di emancipazione e le suffragette. I sindacati. La Seconda Internazionale, la reazione della Chiesa
con la Rerum novarum.
LE GRANDI POTENZE EUROPEE La Francia di Napoleone III e la guerra di Crimea.
Il conflitto tra Austria e Prussia.
La guerra franco-prussiana, la sconfitta dei francesi e l'unificazione tedesca.
La crisi della Francia, l'esperienza rivoluzionaria della Comune di Parigi e la Terza Repubblica.
L'Impero tedesco e la politica di Bismarck.
La Gran Bretagna: la questione irlandese.
La Russia di Alessandro II, l'abolizione della servitù della gleba e il tentativo di modernizzare il paese. Il
populismo.
L’IMPERIALISMO EUROPEO Il nuovo colonialismo: gli interessi economici e le motivazioni politico-economiche. La conquista e la
spartizione dell’Africa. Gli europei in Asia: la guerra dell'oppio in Cina. La colonizzazione russa nel Pacifico.
L'EUROPA E IL MONDO AGLI INIZI DEL '900 La Triplice Intesa.
Il "buco nero" d'Europa: i paesi slavi e le due guerre balcaniche.
La belle époque e le sue contraddizioni.
La Rivoluzione Russa del 1905 e la guerra col Giappone.
31
L'ITALIA TRA IL 1891 E IL 1914 Il primo governo Giolitti, la riforma finanziaria, le idee innovatrici e lo scandalo della Banca di Roma. Il
secondo mandato di Crispi, la repressione violenta delle insurrezioni e il fallimento della politica estera. La
rovinosa sconfitta ad Adua. I moti del 1898.
1901-1903: il governo Zanardelli-Giolitti.
Lo sviluppo economico e i problemi del meridione. Le condizioni di vita degli italiani. L'emigrazione. Il divario
tra Nord e Sud.
L'età Giolittiana: il controllo del Parlamento e il trasformismo, gli avversari di Giolitti, le leggi per il
Mezzogiorno e il suffragio universale. La nascita della Cgl e le scissioni socialiste. I democratici cristiani. I
nazionalisti e i progetti imperialisti in Nord Africa.
La guerra in Libia. Il patto Gentiloni. La fine del governo Giolitti.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE Un equilibrio instabile. Le cause del conflitto.
Una reazione a catena: l'attentato di Sarajevo e il meccanismo delle alleanze. Il fallimento della guerra-lampo;
dalla guerra di movimento a quella di posizione. Le prime trincee. Il piano Schllieffen: le battaglie sul fronte
occidentale e su quello orientale, la Marna, Tannemberg e Laghi Masuri. L'Italia dalla neutralità all'intervento:
il Patto di Londra e le radiose giornate di maggio. Le battaglie sull'Isonzo e a Verdun. La vita in trincea.
Il ritiro della Russia e l'entrata in guerra degli Stati Uniti. La svolta del '17. La disfatta di Caporetto e la
resistenza sul Piave. L'offensiva a Vittorio Veneto e l'Armistizio di Villa Giusti. La sconfitta ad Amiens. La
conferenza di pace del 18 gennaio '19. I trattati di Versailles, Saint Germain, Trianon e Sèvres.
Approfondimenti: i giornali e le propagande del '14, la partita di calcio del 25 dicembre '14.
Lettura e commento delle poesie “Veglia” e “Fratelli” "San Martino del Carso", "Soldati" e "Sono una creatura"
di Ungaretti.
LA RIVOLUZIONE RUSSA La rivoluzione di febbraio, il primo governo provvisorio e i soviet: il doppio potere. Lenin e le Tesi di aprile.
Il secondo governo provvisorio e la rivoluzione di ottobre. La nascita dell'Assemblea costituente e il colpo di
stato bolscevico. La guerra civile.
UN DIFFICILE DOPOGUERRA Le conseguenze economiche della guerra. I mutamenti della vita sociale. Il "biennio rosso": le lotte operaie, il
fallimento dei tentativi rivoluzionari in Francia e Gran Bretagna. La rivoluzione in Germania: il governo di
Ebert e il "doppio potere" dei Consigli. La Lega di Spartaco e la nascita della Repubblica di Weimar. I piani
Dawes e Young e gli accordi di Locarno.
DA LENIN A STALIN: LA RUSSIA COMUNISTA La Terza Internazionale. I 21 punti di Lenin. Il collasso economico della Russia: dal "comunismo di guerra"
alla Nep. La prima Costituzione della Russia rivoluzionaria, la nascita dell' Urss e del Pcus. Lo scontro tra
Stalin e Trotzij; l'eliminazione degli oppositori.
L'ITALIA: DOPOGUERRA E FASCISMO L'Italia del dopoguerra: un paese inquieto, scioperi e lotte agrarie. La "vittoria mutilata" e l'esperienza di
D'Annunzio a Fiume. Il biennio rosso: le elezioni del 1919, il ritorno di Giolitti, l'occupazione delle fabbriche
e la scissione del Psi.
Mussolini e la fondazione dei Fasci di combattimento. Le squadre d'azione e l'assalto a Palazzo d'Accursio.
Mussolini alla conquista del potere. Le elezioni del 1921; il patto di pacificazione con i socialisti e la nascita
del Pnf. Il debole governo Facta e la posizione di Vittorio Emanuele III. La marcia su Roma. 30 ottobre 1922:
il governo Mussolini. Dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime. Il Gran Consiglio e la Milizia volontaria
per la sicurezza nazionale, l'appoggio della Chiesa, la legge Acerbo e la riforma Gentile. Il delitto Matteotti.
La fine dello Stato liberale. Lettura di un passo tratto da "Nascita e avvento del fascismo" di A. Tasca e degli
articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 delle leggi fascistissime.
UNA CRISI PLANETARIA Gli Stati uniti: dalla ripresa alla crisi; il crollo della Borsa di Wall Street del ’29. La crisi diventa mondiale.
Roosevelt e il New Deal. L’intervento dello Stato in economia.
L'EUROPA DEGLI ANNI '30: DEMOCRAZIE E DITTATURE Democrazie in crisi e fascismi: i caratteri dei regimi. Società di massa e totalitarismi. Dall'igiene razziale alle
politiche di sterminio; la nazione come corpo unico.
L'ascesa del nazismo: Hitler, il carcere e il Mein Kampf. Il collasso della Repubblica.
32
Il consolidamento del suo potere: da cancelliere a capo di Stato. La "notte dei lunghi coltelli": le SS contro le
SA. Il Terzo Reich e la questione degli ebrei. Le leggi di Norimberga, la "notte dei cristalli" e la "soluzione
finale". I campi di concentramento. Il Concordato con la Chiesa. Lettura e commento di un passo di H. Arendt
(tratto da Le origini del totalitarismo, Milano 1967) e di uno di Friedrich e Brzezinskj: "I caratteri del
totalitarismo" (da Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, a c. di R. De Felice, Bari
1970). Lettura delle leggi di Norimberga e analisi della simbologia nazista. La svastica, un qui pro quo
hitleriano.
L'URSS DI STALIN L'Urss: collettivizzazione e industrializzazione forzate. La battaglia contro i kulaki. Gli effetti della repressione
e la carestia del '32-'33. I piani quinquennali. Il potere indiscusso di Stalin e la sua politica del terrore: le
"grandi purghe", i Gulag e i processi sotto tortura.
LE DIFFICILI RELAZIONI INTERNAZIONALI La prime iniziative internazionali di Hitler e le preoccupazioni degli altri Stati europei riuniti nel '35 a Stresa.
L'Internazionale comunista al suo VII congresso e la nascita dei "fronti popolari". I piani di espansione di
Hitler, l'appeasement della Gran Bretagna e la crisi in Francia. L'annessione tedesca dell'Austria, il caso dei
Sudeti e la conferenza di Monaco di Baviera.
L'ERA FASCISTA La situazione italiana alla fine degli anni '20. Le organizzazioni di massa e i Patti lateranensi. I cattolici al voto
nel 1929 e l'ovvia vittoria del fascismo. Scuola, cultura e informazione. I provvedimenti di Mussolini in ambito
economico: il protezionismo e la "battaglia del grano", la rivalutazione della lira, la promozione dei lavori
pubblici e l'intervento statale nella crisi bancaria. La politica estera: l'impresa etiopica, l'Asse Roma-Berlino e
il patto anti-Comintern. Le leggi razziali. Visione di un cinegiornale dell'Istituto Luce sulla fondazione di una
nuova città fascista: Carbonia (Sulcis – Sardegna).
LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA La guerra civile e il colpo di Stato dei "nazionalisti". Gli interventi esterni e la vittoria dei franchisti. Guernica:
il dramma del 1937.
GUERRA MONDIALE, GUERRA TOTALE Le origini e le responsabilità. Dalla Cecoslovacchia alla Polonia. L'Italia e il “patto d'acciaio”. Il patto tedesco-
sovietico. La distruzione della Polonia, la sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna. La figura
di Winston Churchill. L'Italia e la “guerra parallela”: dalla non belligeranza alla dichiarazione di guerra. I primi
fallimenti. Il fronte africano. L'intervento tedesco nei Balcani.
L'entrata in guerra di Urss e Stati Uniti nel 1941. L'attacco tedesco all'Unione Sovietica e la resistenza di
quest'ultima. Gli aiuti americani e la Carta atlantica. La guerra nel Pacifico. Il patto delle Nazioni Unite. La
Shoah. Il progetto di sterminio: dalle fucilazioni alle camere a gas. Le battaglie decisive: la guerra sui mari.
Dallo sbarco in Sicilia a quello in Normandia. L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio. Resistenza e guerra
civile. La fine della guerra e la bomba atomica.
Programma da effettuarsi dopo il 15 maggio:
- QUADRO GENERALE SULLA GUERRA FREDDA.
L’Insegnante I rappresentanti di classe
Prof.ssa Mjriam Piras Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu
33
8.7 FILOSOFIA
DOCENTE: prof. Simone Mammola
Obiettivi raggiunti
La classe ha cambiato il docente di filosofia all’inizio di quinta e questa novità ha richiesto
inevitabilmente una fase iniziale di reciproca conoscenza e adattamento, sulla base peraltro di un
interesse pregresso per la disciplina mai veramente sbocciato nel corso degli anni precedenti. Alla
luce di questa situazione di partenza, va perciò sottolineato e apprezzato lo sforzo esercitato
complessivamente dagli studenti nel seguire con costanza e disponibilità la proposta didattica fornita
dall’insegnante, che ha cercato di individuare e sottolineare per ciascun argomento i punti-chiave da
comprendere e ricordare, suggerendo di volta in volta possibili richiami all’attualità e a questioni
capaci di attirare maggiormente il loro interesse, ma con l’obiettivo dichiarato e condiviso di
promuovere soprattutto una preparazione funzionale in vista dell’Esame di Stato. In questo modo,
sebbene la partecipazione alle lezioni sia stata prevalentemente passiva, la classe ha comunque
raggiunto complessivamente una conoscenza soddisfacente dei contenuti previsti dal programma,
anche se non sempre accompagnata da un’esposizione chiara e linguisticamente adeguata (limite
emerso soprattutto nelle prove scritte). Il fatto di avere avuto a disposizione solo un anno per lavorare
insieme non ha purtroppo consentito di allenare attraverso specifiche attività didattiche (se non
attraverso le interrogazioni orali) la capacità di rielaborazione critica e personale degli argomenti
proposti, che dipende perciò in gran parte dall’intraprendenza e dalla vivacità intellettuale dei singoli
studenti: così, se alcuni allievi hanno dimostrato di possedere una certa propensione a stabilire
collegamenti e relazioni fra i temi studiati, l’approccio complessivo della classe verso la disciplina è
apparso invece per lo più di tipo nozionistico e non eccessivamente approfondito.
Metodologia
La metodologia prevalente è stata quella della lezione frontale, corredata dall’utilizzo di presentazioni
attraverso la LIM. La lettura dei testi si è limitata ad alcuni brani di facile comprensione, selezionati
per lo più fra quelli presentati dal libro di testo. Per favorire il consolidarsi delle conoscenze e uno
studio distribuito nel tempo, in vista delle interrogazioni e delle verifiche sono state programmate
delle lezioni di ripasso orientato dalle domande degli studenti.
Verifiche e valutazione
Primo quadrimestre: due interrogazioni orali e una prova scritta sotto forma di simulazione di
Terza Prova.
Secondo quadrimestre: due prove scritte (di cui una sotto forma di simulazione di Terza
Prova) e almeno un’interrogazione orale.
34
PROGRAMMA D’ESAME DI FILOSOFIA
Testo
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, Pearson, voll. 2B, 3A e 3B.
CONTENUTI
1. Hegel
Inquadramento storico del pensiero hegeliano
Le tesi di fondo del sistema hegeliano e il concetto di Spirito
La dialettica e i suoi tre momenti
La Fenomenologia dello Spirito e le sue figure (con particolare riferimento all’autocoscienza
e alla dialettica servo-padrone)
La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo (diritto astratto, moralità,
eticità), la filosofia della storia, lo spirito assoluto.
2. La sinistra hegeliana, Feuerbach e Marx
a) La sinistra hegeliana e Feuerbach
Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito sulla religione e sulla politica
Feuerbach: il rovesciamento della filosofia hegeliana, l’essenza del cristianesimo, la teologia
come antropologia capovolta, l’ateismo e l’alienazione, la filosofia dell’avvenire.
b) Marx
I rapporti con Hegel e con Feuerbach
La critica alla società borghese
La riflessione sulla società capitalistica e sulle varie forme di alienazione
La concezione materialistica della storia (struttura/sovrastruttura)
Il Capitale: l’analisi del capitalismo e dei suoi limiti
3. Il positivismo e Darwin
Caratteri generali del positivismo
Saint-Simon e la distinzione tra epoche organiche ed epoche critiche
Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia
Darwin: la teoria della selezione naturale
4. I critici di Hegel
a) Kierkegaard
La riflessione sull’esistenza: possibilità, scelta, singolarità
L’angoscia
L’aut aut e gli stadi della vita (estetico, etico, religioso)
b) Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il velo di Maya e la volontà
Il pessimismo e la sofferenza universale
Le vie di liberazione dalla volontà
35
5. Nietzsche
Inquadramento del pensiero di Nietzsche
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco
La storia e la vita
Il metodo genealogico
La morale dei signori e la morale degli schiavi
Il superuomo
Così parlò Zarathustra e le tre metamorfosi
La volontà di potenza
L’eterno ritorno
6. Freud
La rivoluzione psicoanalitica
L’inconscio
Le vie di accesso all’inconscio
Le due topiche
Principio di piacere e principio di realtà
L’interpretazione psicoanalitica di società e religione
7. Bergson
Tempo spazializzato e durata reale
Tempo e memoria
8. Popper
La teoria della scienza e il problema della demarcazione
Scienza e pseudoscienza: la critica a Marx e Freud e l’ammirazione per Einstein
Il fallibilismo
L’Insegnante I rappresentanti di classe
Prof. Simone Mammola Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu
36
8.8 SCIENZE NATURALI
DOCENTE: prof.ssa Annalida Di Nola
Obiettivi raggiunti
Seguo gli allievi della 5D dallo scorso anno, quando insegnavo loro soltanto la Chimica, mentre la
Biologia era compito della collega titolare. La classe è costituita da pochi studenti di notevoli capacità
e livello di preparazione, in grado di ottenere degli ottimi risultati. Un altro gruppo di allievi ha
ottenuto agevolmente dei risultati da discreti a buoni. Infine c’è stato un gruppo di studenti che ha
raggiunto la sufficienza con qualche difficoltà. Per qualcuno di essi alcune capacità, ad esempio
quella di una esposizione orale sintetica ed accompagnata da un pertinente linguaggio scientifico,
risultano essere ancora non completamente soddisfacenti. In generale però gli alunni si sono mostrati
attenti agli stimoli e curiosi.
Conoscenza ed interpretazione di fenomeni e processi chimici e loro rappresentazione simbolica
(formule ed equazioni di reazione). Esecuzione di calcoli relativi.
Acquisizione di conoscenze fondamentali di chimica inorganica, chimica organica, biochimica e
biotecnologie.
Acquisizione e perfezionamento del linguaggio scientifico.
Consolidamento della capacità di analizzare fenomeni complessi e individuazione di elementi
essenziali
Metodologia
Il corso di Scienze ha come obiettivo principale di portare lo studente verso la conoscenza dei
principali processi chimici e biologici che si verificano sul nostro pianeta.
Il programma svolto quest’anno ha lo scopo principale di mettere gli allievi nelle condizioni più
idonee per affrontare un corso universitario di tipo scientifico, e nello stesso tempo di prendere
coscienza di quanto sia necessaria una cultura scientifica seria. Nella nostra società altamente
tecnologica non basta saper usare determinati strumenti ma è quanto mai indispensabile conoscere i
processi biologici e chimici che regolano il nostro pianeta e noi stessi. L’Uomo ha il dovere di
prendere coscienza delle sue grandi potenzialità e sentirsi responsabile di questo nostro mondo e della
vita che ospita. Ogni futuro cittadino si troverà a dover prendere decisioni che riguarderanno la sua
persona, la sua famiglia, la società in cui vive. Una conoscenza dei meccanismi biologici e fisici di
quanto ci circonda è sicuramente fondamentale.
La Chimica viene spesso chiamata “SCIENZA CENTRALE” per le sue interazioni con le altre
discipline scientifiche: dalla medicina, alla biologia, dalla fisica alla geologia e dalle biotecnologie
all’ecologia, ecc.
Se da una parte si è cercato di fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare problemi di
stechiometria, saper riconoscere e scrivere formule chimiche e reazioni, dall’altra si è tentato di
dimostrare agli studenti che questa disciplina non è soltanto un insieme di leggi e di formule, ma ci
permette di soddisfare tutti i bisogni dei nostri giorni, da quelli primari, quali nutrirsi e difendersi
dalle malattie, a quelli che riguardano l’alta tecnologia, nuovi materiali, nanotecnologie ecc.
37
Nello stesso modo la Biologia è stata affrontata seguendo gli stessi principi: una conoscenza seria ed
approfondita per affrontare i corsi universitari e la consapevolezza che la biosfera è un sistema retto
da equilibri delicati e complessi di cui noi stessi facciamo parte.
Verifiche e valutazione
Sono state effettuate prove orali nella forma di interrogazioni individuali e prove scritte articolate
sotto forma di domande aperte, chiuse e calcoli stechiometrici
In sede di valutazione finale sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:
Assiduità nella frequenza alle lezioni
Partecipazione al dialogo scolastico
Conoscenza dei contenuti
Utilizzo del linguaggio scientifico
Capacità di analisi e di sintesi
Capacità di strutturazione della risposta e collegamento dei contenuti
Sono state effettuate tre simulazioni di terze prove con domande di Scienze
PROGRAMMA D’ESAME DI CHIMICA INORGANICA
Testo
James E. Brady, Fred Senese, Maria Cristina Pignocchino, Chimica.blu Dal legame chimico
all’elettrochimica, Parte 3 e 4, Zanichelli
CONTENUTI
Equilibri in soluzione acquosa
Teorie acido-base secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis (quest’ultima soltanto definizione)
Coppie coniugate acido-base.
Sostanze anfotere e anfiprotiche
Forze relative di acidi e basi coniugate. Prodotto ionico dell’acqua e relazione con la temperatura
Soluzioni neutre, acide e basiche. Scala del pH. pH-metro e indicatori acido-base
Calcolo di pH e pOH dalle concentrazioni di H+ ed OH-
Acido e base forti: calcolo del pH.
Acido e base deboli: costanti di ionizzazione, pK e calcolo del pH.
Utilizzo di formule inverse.
Applicazioni degli equilibri in soluzione acquosa
38
Titolazione acido forte-base forte (con esperimento in laboratorio). Punto di equivalenza, punto
finale e curva di titolazione
PROGRAMMA D’ESAME DI CHIMICA ORGANICA
Testo
Campbell, Biologia concetti e collegamenti PLUS, quinto anno, LINX
CONTENUTI
Composti organici e loro classificazione. Rappresentazione delle molecole organiche
Ibridazioni del Carbonio. Idrocarburi. Vari tipi di isomerie. Isomeria di struttura (catena e posizione);
isomeria configurazionale (ottica e geometrica) e conformazionale (cenni). Chiralità.
Sistema di notazione R, S. Misura dell’attività ottica delle molecole organiche tramite il polarimetro.
Alcani: nomenclatura; proprietà fisiche; reazioni di combustione, alogenazione e cracking.
Carbonio primario, secondario, terziario e quaternario.
Alcheni: nomenclatura semplice; proprietà fisiche; isomeria cis-trans; reazioni di addizione elettrofila
(idratazione, alogenazione, idrogenazione catalitica, addizione di idracidi). Regola di Markovnikov.
Cos’è un carbocatione.
Alchini: nomenclatura; proprietà fisiche; reazioni di addizione al triplo legame (idrogenazione con
catalizzatore Lindlar o Na, dialogenazione, mono alogenazione, idratazione)
Idrocarburi ciclici: nomenclatura dei più semplici idrocarburi ciclici; cicloesano: conformazioni,
posizioni assiali ed equatoriali.
Idrocarburi aromatici: nomenclatura; reazione di sostituzione elettrofila aromatica.
I diversi gruppi funzionali.
Alcoli: nomenclatura, primari, secondari e terziari; proprietà fisiche, reazioni di ossidazione.
Fenoli: nomenclatura, acidità del fenolo (con risonanza).
Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (utilizzo come solvente).
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (proprietà conservante e solvente),
reazione di addizione nucleofila (addizione di alcool per ottenere emiacetale e acetale da aldeide,
emichetale e chetale da chetone).
Acidi carbossilici: nomenclatura, reazione di formazione del carbossilato in ambiente basico e di
esteri.
Esteri: nomenclatura, sintesi di trigliceride e saponificazione.
Cenni di ammine e ammidi.
39
PROGRAMMA D’ESAME DI BIOCHIMICA
Testo
Campbell, Biologia concetti e collegamenti PLUS, quinto anno, LINX
CONTENUTI
Il carbonio e le biomolecole. Gruppi funzionali delle molecole biologiche.
Le macromolecole sono polimeri di monomeri. Reazioni di sintesi e degradazione dei polimeri
(perdita e aggiunta di acqua).
I carboidrati: mono-, di- e polisaccaridi (strutturali e di deposito). Anomeri α e β.
I lipidi: grassi, fosfolipidi e steroidi
Le proteine: amminoacidi; binomio struttura-funzione; le quattro strutture delle proteine.
Gli acidi nucleici: ruolo e strutture di DNA ed RNA
La respirazione cellulare. Struttura e idrolisi dell’ATP. Tappe della respirazione cellulare. Ruolo di
NAD+ e FAD. Glicolisi: le due fasi; fosforilazione a livello del substrato; rendimento.
Decarbossilazione ossidativa; ciclo dell’acido citrico: passaggi e rendimento. Fosforilazione
ossidativa: catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi. Rendimento complessivo.
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica.
PROGRAMMA D’ESAME DI BIOTECNOLOGIE
Testo
Campbell, Biologia concetti e collegamenti PLUS, quinto anno, LINX
CONTENUTI
La genetica dei virus. Com’è fatto un virus. Ciclo riproduttivo dei batteriofagi: cicli litico e lisogeno.
Virus ad RNA e suo ciclo riproduttivo. I retrovirus: ciclo riproduttivo dell’HIV. Plasmidi e trasposoni
(taglia e incolla e copia incolla).
La genetica dei batteri. Trasferimento del DNA batterico: trasformazione, trasduzione e
coniugazione. Coniugazione e trasferimento del fattore (plasmide) F.
Il DNA ricombinante. La clonazione genica. Enzimi di restrizione. Organismi geneticamente
modificati. Utilizzo di procarioti, eucarioti. Mammiferi ricombinanti. Modalità di modifica delle
cellule di un mammifero. La tecnologia del DNA ricombinante in medicina: farmaci e vaccini. Piante
GM ed animali GM. Valutazione rischi salute umana. Rischi per l’ambiente. Terapia genica ed
esempio di procedura. Casi di applicazione della terapia genica e i dubbi etici.
40
Metodi di analisi del DNA. Ogni individuo è caratterizzato da un diverso profilo di DNA. PCR.
Elettroforesi su gel. Analisi delle STR. Metodo di Sanger. Clonazione di piante ed animali.
Clonazione per trasferimento nucleare. Il caso della pecora Dolly. Cellule staminali, embrionali e
adulte. Clonazione terapeutica.
NB: per quanto riguarda la chimica organica sono stati analizzati i meccanismi di reazione per
l’alogenazione degli alcani, per l’addizione di idracido ad alchene (con formazione del carbocatione
intermedio e regola di Markovnikov), per la sostituzione elettrofila aromatica, per l’addizione di
alcool ad aldeidi e chetoni con formazione di emiacetale (oemichetale) e acetale (o chetale). In ogni
caso si è partiti da substrati semplici o generici.
Per la parte della respirazione cellulare è stato mostrato ai ragazzi l’intero meccanismo sia della
glicolisi che del ciclo di Krebs, ma si è poi richiesto loro di soffermare attenzione su substrati di
inizio, fine e su intermedi chiave.
Per il modulo CLIL dal testo consigliato: Paolo E. Balboni, Percorsi di biologia CLIL, Loescher
Durante il II quadrimestre sono state svolte 8 ore di intervento CLIL di Scienze Naturali sugli
argomenti di seguito elencati. Tali argomenti sono stati successivamente approfonditi in italiano.
Genetic Engineering Techniques
A modernform of biotechnology
DNA double helix
Restrictionenzymes
Recombinant DNA
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Gel electrophoresis and DNA analysis
Modernbiotechnology
Genetically modified organisms
The microorganisms “factory”
GM animals as a study model
Genetically modified plants
GMOs: threat or resource?
L'Insegnante I rappresentanti di classe
Prof.ssa Annalida Di Nola Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu
41
8.9 STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: prof.ssa Maria Teresa Testa
La programmazione di Disegno e Storia dell’Arte per l’anno scolastico 2017/2018 è stata concordata
in occasione della riunione di Dipartimento e in altri momenti di confronto avvenuti nella fase iniziale
dell’anno scolastico. Gli insegnanti, durante tali riunioni, hanno definito e coordinato i percorsi
didattici, la metodologia, gli obiettivi e le competenze, i contenuti disciplinari e le modalità di verifica
e valutazione. Il contratto formativo tiene conto dei programmi di riordino dei Licei (indirizzo
scientifico e scienze applicate) e delle indicazioni contenute nel D.M. n° 139 del 22/08/2007 (assi
culturali e competenze chiave di cittadinanza), oltre che del verbale della riunione del Dipartimento
Asse dei Linguaggi tenutasi in data 21/09/2017 ai quali si rimanda.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe che seguo dalla classe prima ha raggiunto, nonostante l’interesse e la partecipazione non
siano stati sempre costanti, livelli di preparazione buoni per una buona parte della classe, discreti
per il rimanente gruppo. Solo alcuni allievi hanno riscontrato, nel corso dei cinque anni, difficoltà
ad esprimere con l’analisi e il confronto un giudizio personale sui significati e sulle specifiche
caratteristiche delle opere d’arte.
CONOSCENZE
- Conoscere la storia dell’Arte dal Realismo all’Arte delle Avanguardienelle sue principali scansioni
cronologiche stilistiche e tematiche, nonché nei suoi vari ambiti di produzione
- Conoscere il contesto storico-culturale ed artistico in cui l’opera viene a formarsi e ad esprimersi.
- Conoscere le strutture fondamentali del linguaggio artistico e un adeguato lessico tecnico e critico
nelle sue definizioni generali e specifiche.
COMPETENZE
- Comprendere gli argomenti nelle loro linee fondamentali di sviluppo.
- Analizzare l’oggetto artistico secondo le sue componenti formali e tecniche.
- Possedere un adeguato, corretto ed articolato lessico tecnico e critico, da utilizzare per formulazioni
generali e specifiche.
- Individuare il contesto socio-culturale entro il quale il prodotto artistico si è formato, l’eventuale
rapporto con la committenza, l’apporto individuale dell’artista e della destinazione dell’opera.
CAPACITA’
- Saper leggere, analizzare, comprendere e valutare criticamente le opere d’arte e i movimenti
esaminati, considerati nella loro complessità e nelle loro relazioni con la storia e la cultura del
tempo.
- Saper fare confronti fra le varie correnti ed i vari artisti studiati
- Saper esprimere con l’analisi e il confronto un giudizio personale sui significati e sulle specifiche
caratteristiche delle opere d’arte affinando nel contempo le proprie capacità estetiche e critiche,
intese come stimolo per il miglioramento della qualità della vita.
METODOLOGIA
Le diverse unità didattiche sono state presentate mediante lezione frontale volta a chiarire, con
opportune motivazioni, i contenuti ed il contesto storico-culturale dei percorsi artistici, lasciando
spazi a favore di un processo interattivo con il singolo studente e con il gruppo classe. Si è rivolta
42
particolare attenzione alla lettura dell’opera d’arte, in particolar modo aquella pittorica, mettendoin
evidenza le strutture del linguaggio visivo, attraverso i valori formali e i contenuti e si è cercato di
potenziare le capacità storico-critiche degli alunni, sia attraverso la conoscenza delle correnti di
pensiero sull’arte, sia attraverso la conoscenza del periodo storico dell’arte italiana collegata all’arte
europea e mondiale.
Alcuni argomenti sono stati affrontati a livello interdisciplinare in base alla programmazione
avviata nel consiglio di classe. Per favorire l’approccio globale allo studio dell’opera d’arte, sono
stati utilizzati diversi strumenti operativi e di analisi quali schede di lettura, lavori di
approfondimento, discussioni guidate su particolari argomenti. Nello svolgimento del programma i
libri di testo in adozione sono stati integrati da materiale bibliografico reperibile nella scuola o nelle
strutture pubbliche, dall’uso della LIM, da sussidi che utilizzano linguaggi grafici, fotografici e
televisivi per permettere allo studente di accostarsi concretamente agli aspetti visivi delle opere e
per trasmettere una più ampia documentazione iconografica.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza della classe, della partecipazione,
dell’interesse e dell’impegno dimostrato nell’attività didattica, del grado di maturazione e di
responsabilità evidenziati all’interno della classe, della rielaborazione critica dei contenuti appresi e
ha rappresentato un momento di crescita, di presa di coscienza da parte dell’alunno del suo operato
scolastico ed è stata gestita dialetticamente con gli alunni e orientata a criteri di trasparenza.
Sono state programmate prove di verifica di tipo diverso (colloqui orali, verifiche a domanda
aperta),con un minimo di due verifiche quadrimestrali e sono stati proposti test scritti relativi alla
tipologia della “terza prova” inserita nell’esame di fine corso liceale in collaborazione con gli altri
colleghi di dipartimento. Durante l’interrogazione orale l’alunno deve analizzare le opere richieste
osservandole sul libro di testo e può scorrerlo per eventuali collegamenti su altre opere di artisti
diversi. Anche nelle terze prove è possibile vedere l’opera richiesta, lasciandola appesa alla lavagna
o sulla cattedra.
La valutazione ha avuto carattere prevalentemente orientativo e funzione di incentivo per
conseguire migliori risultati sia sul piano qualitativo sia su quello del metodo e dell’organizzazione
personale del lavoro, con riferimento al paragrafo ‘Valutazione” della Programmazione Educativa e
Didattica d’istituto e alle intese di dipartimento.
ATTIVITA’ PROGRAMMATE DOPO IL 15 MAGGIO
Approfondimento sulle avanguardie artistiche del Novecento e del percorso artistico tra le due guerre.
Verifiche, interrogazioni e ripasso.
CONTENUTI
Testo adottato: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’Arte”, vol.3 Ed.
Zanichelli
Si è considerata irrinunciabile nel corso dell’anno la trattazione delle opere, degli artisti e dei
movimenti che hanno determinato nuovi orientamenti nella storia, nella cultura figurativa, plastica ed
architettonica nel corso dell’Ottocento e del Novecento.
Un inquadramento storico ha preceduto l’approfondimento dei vari fenomeni artistici ed ogni
qualvolta è stato possibile si sono cercati collegamenti interdisciplinari con le altre materie, anche per
meglio affrontare le simulazioni per la terza prova dell’Esame di Stato.
In dettaglio gli argomenti affrontati sono stati i seguenti i seguenti:
43
Realismo: concetti generali, l’opera di Courbet
G.Courbet, Funerale ad Ornans,1849, Parigi, Musée d’Orsay
G.Courbet, Gli spaccapietre, 1849, olio su tela, Dresda
G. Courbet, L’atelier del pittore, 1855, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay
G. Courbet Fanciulle sulla riva della Senna,1857, olio su tela, Parigi, Musée du Petit Palais
Il fenomeno dei Macchiaioli e l’opera di Giovanni Fattori.
G. Fattori, Campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862, olio su tela, Firenze, Palazzo Pitti
G. Fattori, La rotonda di Palmieri, 1859, olio su tela, Milano, Collezione privata
G. Fattori, In vedetta, 1872, olio su tela, Valdagno, Collezione privata
G. Fattori, Bovi al carro, 1867, olio su tela, Firenze, Galleria d’Arte Moderna
L’urbanistica della seconda metà dell’800.
Architettura del ferro in Europa nella seconda metà dell’800 e le Esposizioni Universali:
il Palazzo di Cristallo, la Galleria delle macchine e la torre Eiffel, la Galleria Vittorio Emanuele
II di Milano.
La stagione dell’Impressionismo :
Generalità sul periodo storico: Parigi come centro artistico, nuove tecnologie, la corrente
dell’attimo fuggente, le mostre, rapporto con la fotografia.
L’invenzione della fotografia.
Caratteri generali e principali esponenti: Manet, Monet, Degas, Renoir
Lettura di opere d’arte:
Edouard Manet, La colazione sull’erba, 1863, olio su tela, Parigi, Muséed’Orsay
Edouard Manet, Olympia, 1863, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay
Edouard Manet, Il bar delle Folies-Bergères,1881, olio su tela, Londra, Courtauld Institute of Art
Claude Monet, la gazza, 1868-1869, olio su tela, Parigi, MuséedOrsay
Claude Monet, Impressione,sole nascente, 1872, olio su tela, Parigi, Museo Marmottan
Claude Monet, La Cattedrale di Rouen (serie), 1894, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay
Claude Monet, Lo stagno delle ninfee, 1904, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay
Claude Monet, La grenouillère, 1869, olio su tela, New York, MetropolitanMuseum of Art
Edgar Degas,Famiglia Bellelli, 1858–1867, olio su tela, Parigi, Musée d'Orsay
Edgar Degas, Classe di danza (La lezione di ballo), 1874, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay e
confronto con altri dipinti raffiguranti ballerine
Edgar Degas, L’assenzio, 1875, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay
Auguste Renoir, La grenouillère, 1869, olio su tela, Stoccolma, National-museum
Auguste Renoir, Moulin de la Galette, 1876, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay
Auguste Renoir, Colazione dei canottieri,1881, olio su tela, Washington, Philips Collection
-Il post-impressionismo:
generalità sul periodo storico: la corrente scientifica e la corrente espressiva del Post-
Impressionismo
44
Seurat, Cezanne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Gauguin
Lettura di opere d’arte:
Paul Cézanne La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 1872-1873, olio su tela, Parigi,
Muséed’Orsay
Paul Cézanne, Giocatori di carte, 1892, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay
Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire, 1905, olio su tela, Zurigo, Kunsthaus
Paul Cézanne,I bagnanti,1890, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay (confronto con altre tele con
analogo tema)
Vincent Van Gogh, Mangiatori di patate, 1885, olio su tela, Amsterdam, Museo Van Gogh
Vincent Van Gogh, Autoritratto con cappello in feltro grigio (serie),1887, olio su
cartone,Amsterdam, StedelijkMuseum
Vincent Van Gogh, Veduta di Arles con iris, 1888, olio su tela, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent
Van Gogh
Vincent Van Gogh, Notte stellata, 1889, olio su tela, New York, The Museum of Modern Art
Vincent Van Gogh, Campo di grano con volo di uccelli, 1890, olio su tela, Amsterdam,
Rijksmuseum Vincent Van Gogh
Paul Gauguin, L’onda, 1888,olio su tela, New York, Collezione privata
Paul Gauguin,Ahaoefeii? 1892, olio su tela, Mosca, Museo Puskin
Paul Gauguin, Il Cristo giallo, 1889, olio su tela, Buffalo, Albright-Knos Art Gallery
Paul Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?,1897198, olio su tela, Boston, Museum
of Fine Arts
Georges Seurat, Domenica alla Grande-Jatte, 1884-86, olio su tela, Chicago, The Art Institute
Georges Seurat Une baignade à Asnières, 1883-1884, olio su tela, Londra, National Gallery
Georges Seurat, Il circo, 1891, olio su tela, Parigi, Muséed’Orsay
Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge, 1892-1893, olio su tela, Chicago, The Art Institute
Toulouse-Lautrec, Au salon de la Rue des Moulin, 1894, carboncino e olio su tela,Chicago, The Art
Institute
-Presupposti all’Art Nouveau:
generalità sul periodo storico: industrializzazione, rivalutazione delle arti minori, l’artigiano
come creatore di opere d’Arte, mercato per la borghesia, oggetti di design.
W. Morris, Arts and Crafts
-L’Art Nouveau e il panorama europeo:la Secessione viennese, G.Klimt e il ritratto, J. Maria
Olbrich e il Palazzo della Secessione
Lettura di opere d’arte:
Gustav Klimt, Giuditta I, 1901, olio su tela, Vienna, OsterreichischeGalerie Gustav Klimt, Danae, 1907-8, olio su tela, Vienna, GalerieWurthle Gustav Klimt,Ritratto di Adele Bloch-Bauer, 1907, olio su tela, Vienna, OsterreichischeGalerie Gustav Klimt, fregio di Beethoven,1902, Vienna, palazzo della Secessione Gustav Klimt, Il bacio, 1908, Vienna, OsterreichischeGalerie
- I linguaggi delle Avanguardie:
inquadramento generale delle avanguardie storiche,
45
artisti che preludono all’Espressionismo: J. Ensor e le maschere, E. Munch
Lettura di opere d’arte:
Edvard Munch, Il grido, 1893, tempera e pastello su cartone, Oslo, Munch-Museet Edvard Munch, Sera nel corso Karl Johann, 1892, olio su tela, Bergen Edvard Munch, Pubertà, 1894, olio su tela, Oslo, Nasjonalgalleriet
Edvard Munch, la fanciulla malata, 1885-1886, olio su tela, Oslo, Nasjonalgalleriet
J. Ensor, Ingresso di Cristo a Bruxelles,1888-1889, olio su tela, Anversa, Musée des Beaux Arts
La linea dell’espressione: i Fauves e Matisse, il gruppo “Die Brucke”, l’espressionismo
austriaco, il gruppo del Blaue Reiter, F. Marc, V. Kandinskij,
Lettura di opere d’arte:
Henri Matisse Donna con cappello, 1905,olio su tela, San Francisco, Museum of Modern Art Henri Matisse, La stanza rossa, 1908, olio su tela, San Pietroburgo, Ermitage Henri Matisse, La danza, 1910,Olio su tela, San Pietroburgo, Ermitage
il gruppo “Die Brucke”: Ernst Ludwig Kirchner, Due donne per strada, 1914, olio su tela, Dusseldorf, KunstsammlungNordrhein-Westfalen Ernst Ludwig Kirchner, Cinque donne per strada, 1913, olio su tela, Colonia, Wallraf-Richartz-Museum E. Heckel, Giornata limpida, 1913, olio su tela, Monaco di Baviera, PinakothecderSammlung Moderne Kunst Oskar Kokoschka, La sposa del vento, 1914, olio su tela, Basilea, Kunstmuseum Oskar Kokoschka, Ritratto di Adolf Loos, 1909, olio su tela, Berlino, Castello di Charlottenburg Egon Schiele, L’abbraccio, 1917, olio su tela, Vienna, OsterreichischeGalerie Franz Mark, I cavalli azzurri, 1911, olio su tela, Minneapolis,Walzer Art Center Franz Mark, Capriolo nel giardino di un monastero, 1912, Monaco, StadtischeGalerieimLenbachhaus Vasilij Kandinskij, Il cavaliere azzurro, 1903, olio su tela, Zurigo, Collezione privata
L’inizio dell’arte contemporanea: il Cubismo, generalità sulla corrente, l’innovazione cubista,
il superamento della prospettiva,i ritratti, la nascita della pittura moderna.
P. Picasso e G. Braque
Lettura di opere d’arte:
Pablo Picasso, Les demoisellesd’Avignon, 1907, olio sutela, New York, Museum of Modem Art Pablo Picasso, Poveri in riva al mare,1903, olio su tavola, Washington, National Gallery of Art Pablo Picasso, La famiglia di saltimbanchi, 1905, olio su tavola, Washington, National Gallery of Art Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910, olio su tela, Mosca, Museo Puskin Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata, 1912, olio e tela cerata su tela, Parigi, Pablo Picasso, Guernica, 1937, olio su tela, Madrid, Centro de Arte Reina Sofia Georges Braque, Case all’Estaque, 1908, olio su tela, Berna, Kunstmuseum Georges Braque, Violino e brocca, 1910, olio su tela, Basilea, Offentlichekunstsammlung Georges Braque, Le Quotidien, violino e pipa, 1912, Papier collé e olio su tela, Parigi, Musée National d’Art Moderne
46
La stagione italiana del Futurismo: componenti ideologiche e principi del Futurismo
secondo Marinetti; principali esponenti: Umberto Boccioni, A. Sant’Elia,G. Balla, G.
Dottori
Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911, olio su tela, New York, The Museum of Modern Art Umberto Boccioni, Stati d’animo: gli addii,….- 1^ serie 1911, olio su tela, Milano, Museo del Novecento Umberto Boccioni, Stati d’animo: gli addii,….2^ serie1911, olio su tela, New York, The Museum of Modern Art Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913, Milano, Civico Museo d’Arte Contemporanea Antonio Sant’Elia, La centrale elettrica,1914, matita e inchiostro, Milano, Collezione Paride Accetti Antonio Sant’Elia, La città nuova, 1914, inchiostro nero e matita, Como, Musei Civici Antonio Sant’Elia, Stazione d’areoplani…., 1914,inchiostro nero e matita, Como, Musei Civici Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, olio su tela, Buffalo, Albright-knox Art Gallery Giacomo Balla, Velocità astratta, 1913, olio su tela, Torino, Pinacoteca Agnelli Giacomo Balla, Compenetrazioni iridescenti, 1912, olio su tela, Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna Gerardo Dottori, Trittico della velocità: il via, 1925-1927,Tecnica mista su
tela, Museo di Palazzo della Penna
Il Dadaismo e il Surrealismo, M. Duchamp, M. Ray, J. Mirò, Max
Ernst, R. Magritte, S. Dalì
Marcel Duchamp, Fontana, 1916, Ready-made, Milano, Galleria Schwarz Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919, Ready-made rettificato : la Gioconda con i baffi, New York, Collezione Privata Man Ray, Cadeau, 1921, Ready-made, Chicago, Collezione privata Joan Mirò, Montroig, la chiesa e il paese,1919, olio su tela, Collezione Maria Dolorès Mirò de Punyet Joan Mirò, Il carnevale di Arlecchino,1925,olio su tela, Buffalo, Albright-knox Art Gallery Joan Mirò, La scala dell’evasione, 1940,tempera,gouache,uovo,olio,e,pastelli su carta, New York, Museum of Modem Art Joan Mirò, Blu III, 1961, olio su tela, Parigi, Musée National d’Art Moderne René Magritte, L’uso della parola I, 19281929, olio su tela, New York, Collezione privata René Magritte, Le passeggiate di Euclide, 1955, olio su tela, Minneapolis, The Minneapolis Institute of Arts René Magritte, La condizione umana, 1933, olio su tela, Washington, National Gallery Salvator Dalì, Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936, olio su tela, Philadelphia Museum of Art Salvator Dalì, Sogno causato da un volo di un ape, 1944, olio su tavola, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza Salvator Dalì, Apparizione di un volto …., 1938, olio su tela, Hartford, Collezione Ella Gallup Salvator Dalì, Ritratto di Isabel…, 1945, Berlino, StaatlicheMuseen
La nascita del Cavaliere Azzurro: forza del colore, potenza espressiva della linea, distacco dalla
realtà, lo spirituale nell’opera d’arte.
L’Astrattismo lirico e geometrico: Kandinskij, P. Klee e Mondrian
Lettura di opere d’arte
Vasilij Kandinskij, Senza titolo, 1910, Matita,acquerello su carta, Parigi, Musée Georges Pompidou Vasilij Kandinskij, Composizione VI, olio su tela, 1913, San Pietroburgo, Ermitage Vasilij Kandinskij, Coppia a cavallo, 1906-1907, olio su tela, Monaco
47
Vasilij Kandinskij, Alcuni cerchi, 1926, olio su tela, New York, The Solomon R.Guggenheim Museum Paul Klee, Adamo e la picco/a Eva, 1921, tecniche varie su cartoncino, New York, Museum of Modem Art Paul Klee, Monumenti a G., 1929, gesso e acquerello su tela, New York, The Metropolitan Museum of Art Piet Mondrian, Mulino Oostzijde…., 1907-1908, L’Aia, Gemeentemuseum Piet Mondrian, Mulino al sole, 1908,olio su tela, L’Aia, Gemeentemuseum Piet Mondrian, L’albero rosso, L’albero blu, l’albero orizzontale, l’albero grigio, Melo in fiore: evoluzione stilistica, L’Aia, Gemeentemuseum Piet Mondrian, composizione 10, 1915, olio su tela, Otterlo, RijksmuseumKroller-Muller Piet Mondrian, composizione 11, 1930, olio su tela, New York, Collezione privata La Pittura Metafisica, il gruppo Novecento e il ritorno all’ordine, G. De Chirico, C. Carrà,
Lettura di opere d’arte:
Giorgio de Chirico, Il grande metafisico, 1917, olio su tela, New York, The Museum of Modern Art Giorgio de Chirico, Il canto d’amore, 1914, olio su tela, New York, The Museum of Modern Art Giorgio de Chirico, L’enigma dell’ora, 1911, olio su tela, Milano, Collezione privata Giorgio de Chirico, Le Muse inquietanti, 1917, olio su tela, Milano, Collezione Mattioli Giorgio de Chirico, Il trovatore, 1954-1955, olio su tela,collezione privata Giorgio de Chirico, La vittoria, 1928, olio su tela, Milano, Collezione privata Giorgio de Chirico, dipinti relativi alle Piazze d’Italia Carlo Carrà, La musa metafisica, 1917, olio su tela, Milano, Pinacoteca di Brera Carlo Carrà, L’ovale delle apparizioni, 1918-1919, olio su tela, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna Carlo Carrà, I funerali dell’anarchico Galli,1911, olio su tela, New York, The Museum of Modern
Art
Cenni sull’Arte moderna e sull’arte contemporanea
La classe ha partecipato ad alcune attività aggiuntive:
- mostra «Fontana e Manzoni. Tesori nascosti dalla collezione La Gaia», Fossano
- visita fondazione Renzo Piano –Genova
-visita teatro Carlo Felice
L’Insegnante I rappresentanti di classe
Prof.ssa Maria Teresa Testa Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu
48
8.10 SCIENZE MOTORIE
DOCENTI: prof.ssa Beatrice Bosio
prof. Luigi Catalfamo
OBIETTIVI OPERATIVI
La formulazione degli Obiettivi Operativi da raggiungere è legata alla valutazione iniziale delle
capacità degli studenti. Il livello di difficoltà va mantenuto entro certi limiti affinchè sia superabile
dagli allievi con uno sforzo ragionevole.
L’attività didattica svolta durante le ore di Educazione Fisica non concorre soltanto al
soddisfacimento di Obiettivi Specifici della materia, e neppure al semplice conseguimento degli
Obiettivi Operativi. Vi sono infatti Obiettivi Trasversali che investono la sfera cognitiva e
comportamentale dello studente, che vanno perseguiti e che possono essere realizzati attraverso il
programma di Educazione Fisica pur investendo una sfera interdisciplinare.
Per quanto riguarda la parte teorica si sono prese in considerazione le capacità condizionali e la loro
applicazione alle attività sportive svolte in palestra.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
° Miglioramento delle conoscenze e delle abilità motorie rispetto alla situazione di
partenza.
° Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e
contraddizioni dell’età.
° Maturazione della coscienza relativa alla corporeità in ambiente naturale e di libera
espressività.
° Acquisizione di una cultura delle attività sportive per promuovere la pratica moto-
ria come costume di vita.
° Tollerare un carico submassimale per un tempo prolungato.
° Vincere resistenze a carico naturale.
° Compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo possibile.
° Avere controllo segmentario.
° Compiere gesti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali.
° Conoscere due sport di squadra ( Pallavolo, Pallacanestro).
° Conoscere le tecniche dell’Atletica Leggera.
° Rispettare le regole.
° Avere capacità di autocontrollo.
° Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero.
° Saper lavorare in gruppo.
° Avere consapevolezza di sé
° Riconoscere i propri limiti.
° Avere capacità di critica e di autocritica.
° Saper affrontare situazioni problematiche.
° Saper valutare i risultati.
49
METODOLOGIA
Si è ricercato il miglioramento delle qualità fisiche attraverso lavori prolungati in situazione aerobica
o con metodo intervallato per quanto riguarda la resistenza, con esercizi a carico naturale per lo
sviluppo della forza, con prove ripetute di brevi distanze ed esercizi di rapidità esecutiva o di velocità
di reazione atti a sviluppare la velocità ed infine con esercizi di stretching e movimenti ampi per
sviluppare la mobilità articolare.
Le capacità coordinative sono state migliorate tramite presa di coscienza ed elaborazione di
informazioni spazio-temporali e corporee (Aerobica per i gruppi femminili).
Per l’acquisizione di capacità sportive è stato dato ampio spazio ai giochi di squadra ( Pallavolo,
Pallacanestro, Calcio), nonché alle attività sportive individuali (Specialità dell’Atletica Leggera,
Tennis, Nuoto).
Le proposte di lavoro sono state svolte adottando metodi globali ed analitici a seconda delle
difficoltà dell’attività e della preparazione raggiunta dagli allievi. Si sono alternati momenti di
dimostrazione diretta a momenti in cui l’unica guida era rappresentata dalla richiesta verbale
dell’insegnante.
VERIFICA E VALUTAZIONE
L’impegno e la costanza nell’applicazione sono stati costantemente tenuti presenti dato il carattere
formativo della disciplina che verte non soltanto allo sviluppo delle potenzialità fisiche, ma anche ad
una armonica crescita della personalità.
All’interno di ogni obiettivo specifico l’accertamento è stato effettuato mediante prove specifiche che
sono servite a dare una valutazione del miglioramento qualitativo o quantitativo conseguito dagli
studenti tenendo conto della situazione di partenza verificata attraverso i test d’ingresso.
PROGRAMMA
Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base;
Potenziamento fisiologico;
Esercizi di resistenza , velocità , forza ,elevazione, estensione;
Ginnastica a corpo libero, di mobilità articolare, di coordinazione a carattere preatletico generale,
esercizi di rafforzamento per gli arti inferiori e superiori, per i muscoli addominali e dorsali.
Pallavolo: fondamentali individuali (ruolo dell’alzatore, dello schiacciatore…..)
Impostazione del gioco di squadra e semplici schemi.
Calcio.
Pallacanestro: fondamentali individuali ( il gioco di gambe, la presa, il passaggio, il giro, il palleggio,
il tiro); fondamentali di squadra (la difesa a zona e la difesa a uomo).
Atletica: didattica delle seguenti specialità- mt 100 , mt 1000, salto in lungo, salto in alto.
Lezioni di zumba e difesa personale femminile.
Gli Insegnanti I rappresentanti di classe
Prof.ssa Beatrice Bosio Davide Gavatorta
Prof. Luigi Catalfamo Nicola Voiculescu
50
8.11 RELIGIONE
DOCENTE: prof.ssa M. Grazia Isoardi
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezione frontale, dibattito, lettura ed analisi di articoli
di rivista specializzati, libri, articoli di riviste, materiale audiovisivo.
MODALITA’ DI VERIFICA: Ai fini della verifica si è tenuto conto del grado di interesse e
della partecipazione attiva al confronto e la capacità di cogliere i nuclei essenziali delle tematiche
affrontate. Più che soddisfacente il grado di conoscenza ampio ed approfondito con capacità di sintesi
e collegamento, partecipazione attiva e costante. Gli allievi hanno acquisito apertura e disponibilità
al confronto critico con problematiche e sistemi di significato diversi. Sanno individuare possibili
collegamenti fra le unità didattiche svolte e contenuti storico–culturali affrontati in altre discipline.
OBIETTIVI RAGGIUNTI: sono da ritenersi esaustivi così come il grado di conoscenza
essenziale mentre la partecipazione è sempre stata costante e costruttiva.
CONTENUTI: 1. Il rapporto fede-ateismo
La questione Dio nella cultura contemporanea
Le ragioni di una scelta atea
Le ragioni della fede
La deriva del fanatismo religioso
2. La Chiesa nel Novecento
- La Shoah: credere in Dio dopo Auschwitz
- Il ruolo della Chiesa nel periodo nazi-fascista
- Il Concilio Vaticano II
- Papa Francesco I
3. L’etica delle relazioni
L'altro come diverso da me
- La ricerca di significato esistenziale
Il comandamento cristiano
TESTI ADOTTATI : Nuovi Confronti. Per il triennio. 2.
Michele Contadini , A. Marcuccini , A. Paola Cardinali , Alessandra Marcuccini edito da Elledici
L’Insegnante I rappresentanti di classe
Prof.ssa Maria Grazia Isoardi Davide Gavatorta
Nicola Voiculescu