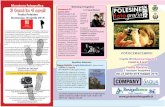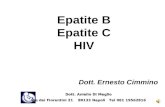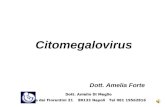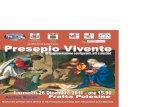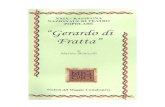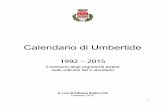Documento del Consiglio di Classe€¦ · ITALIANE - STORIA Fratta Teresa LAB. SISTEMI E AUT. D’...
Transcript of Documento del Consiglio di Classe€¦ · ITALIANE - STORIA Fratta Teresa LAB. SISTEMI E AUT. D’...

Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” Settore Tecnologico
SEDE CENTRALE: Via G. C. Falco - 81043 Capua (Ce) Distretto Scolastico n. 17 – C. S. : CETF 05000Q - C. F. :80113080610 - TEL. 0823622744
SEDE ASSOCIATA: Via Cesare Battisti 81046 Grazzanise ( Ce) Distretto Scolastico n° 17--- C.S. : CETF 05001R – TEL. O823991697
Documento del Consiglio di Classe (Redatto ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n°323/1998 e successive modifiche eApprovato
dal Consiglio di Classe il 7/05/2015 )
INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
ARTICOLAZIONE: MECCANICAE MECCATRONICA
CLASSE VMM SEZ. A
Docente coordinatore della classe:Prof. Andreana Crispino
Anno scolastico 2015/2016

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE V AMMcomposto come segue:
visto il quadro normativo;
vista la programmazione educativo - didattica del Consiglio della classe VMM sez. A
relativa all'A.S. 2015/2016;
visti i piani di lavoro formulati, per l'anno scolastico 2015/2016, dai Docenti membri del
Consiglio di Classe per le singole discipline previste dal piano di studio;
viste le attività educativo-didattiche curriculari ed extracurriculari effettivamente svolte
dalla classe nel corso dell'A.S. 2015 / 2016;
DISCIPLINA INSEGNATA
DOCENTE
FIRMA
LINGUA E LETTERE
ITALIANE - STORIA Fratta Teresa
LAB. SISTEMI E AUT. D’ Aniello Paolo
INGLESE Capotorto Ira
MATEMATICA Sibillo Tommasina
MECCANICA, MACCHINE
ED ENERGIA Montuori Pietro
DISEGNO, PROGETTAZ.
ED ORG. INDUSTRIALE. de Rosa Bruno
TECNOLOGIE MECCAN.
DI PROCESSO E DI PROD. Lista Michele
SISTEMI E AUTOMAZIONE Casaburo Luigi
RELIGIONE Crispino Andreana
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE Merola Maddalena
LABORATORIO (D.P.O.) Tonziello Pasquale
LABORAT. (MECCAN.;
TECNOL.; SISTEMI. ) Natale Antonio Vincenzo
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Paolo Tutore

DELIBERA
di redigere il DOCUMENTO del 15 Maggio relativo alle attività didattiche ed educative svolte
dalla classe VMM sez. A, specializzazione MECCANICA E MECCATRONICA nell'A.S. 2015
/ 2016, come di seguito indicato:
INDICE
1. L’ISTITUTO Pagina
1.1 la storia
1.2 il contesto
1.3 la realtà scolastica
5
5
6
2. IL CORSO DI PERITO INDUSTRIALE in MECCANICA E
MECCATRONICA 7
2.1 la struttura del corso
2.2 il profilo professionale
2.3 il quadro orario
7
7
8
3. LA CLASSE ed il CONSIGLIO di CLASSE 9
3.1 Composizione del consiglio di classe
3.2 Commissari interni
3.3 Elenco degli studenti
3.4 Presentazione della classe
9
9
10
10
4. IL PERCORSO FORMATIVO 12
4.1 Obiettivi cognitivi e formativi generali
4.2 Obiettivi dell’area linguistico - espressiva
4.3 Obiettivi dell’area tecnico-scientifica
4.4 Profilo formativo della classe in uscita
4.5 Contenuti. Disciplina non linguistica in lingua Inglese
12
13
13
13
14

5. STRUMENTI e METODOLOGIE DIDATTICHE 15
5.1 Metodi
5.2 Mezzi, spazi, tempi
5.3 Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati
5.4 Attività di recupero e sostegno
15
15
15
15
6. VALUTAZIONE 16
6.1 Criteri per le valutazioni intermedie e finali
6.2 Credito scolastico e criteri di attribuzione
6.3 Griglie di Valutazione
17
19
20
7. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 23
8. TIPOLOGIA e SIMULAZIONE della TERZA PROVA 24
9. ALLEGATI 25
9.1 Schemi simulazione Terza Prova
9.2 Programmi e Relazioni
26
40

1. L’ISTITUTO
La sede centrale dell'Istituto Tecnico Industriale "GIULIO CESARE FALCO" è situata a Capua,
paese in provincia di Caserta, in via Giulio Cesare Falco, n. 1. L'Istituto è intitolato all'ingegnere militare capitano Giulio Cesare Falco. 1.1 La storia
L'ITIS "G.C. Falco" è nato nel 1972 come sezione staccata dell' ITIS " F. Giordani" di Caserta, con
il solo indirizzo di Meccanica, per sostenere il processo di industrializzazione del Basso Volturno
con prima sede in via Asilo Infantile.
Nell'anno scolastico 1979/80, con il raggiungimento dell'autonomia, l’Istituto prese il nome
dall'ingegnere militare capitano Giulio Cesare Falco.
Venne, quindi, istituito l'indirizzo "Elettronica e Telecomunicazioni" per armonizzare l'offerta
formativa con la domanda avanzata dalle industrie di settore presenti sul territorio e con le
richieste della produzione industriale di tutti i settori che richiedeva l'automazione dei processi
produttivi.
Dall'anno scolastico 2003/2004 sono state attivate le specializzazioni di Termotecnica e Costruzioni
Aeronautiche, per rispondere alle richieste occupazionale del territorio.
Dall’a.s. 2010/2011 , in seguito all’entrata in vigore della riforma degli istituti tecnici, è diventato
un istituto tecnico - settore tecnologico. Gli indirizzi di studio sono i seguenti :
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Trasporti e Logistica
Informatica e Telecomunicazioni
Dall'a.s.2004/2005 è in funzione anche la sede "Associata" in Grazzanise ubicata al secondo piano
della Scuola Media “F. Gravante” dello stesso Comune.
L’indirizzo attivato in questa sede è Trasporti e Logistica (Conduzione del mezzo).
1.2 Il contesto
L' I.T. " G.C. Falco" è ubicato nella città di Capua, centro di grande patrimonio storico di cui
conserva splendide testimonianze di notevole valore artistico e culturale. Cinta da mura, la città
conta parecchi edifici antichi, il Duomo del X secolo, Chiese medievali, una porta turrita fatta
costruire da Federico II, la cinta bastionata, due Musei ( L'importante Museo Campano ed il
Museo Diocesano) e la Polveriera austriaca: un ponte romano sul Volturno che la collega alla via
Appia. Capua, secondo Cicerone, tra le Città italiche solo a Roma seconda, è parte di un ampio

territorio che comprende il Basso Volturno, l'Agro Caleno e parte dell'Agro Aversano. Si
connota, pertanto, come centro in cui confluiscono parecchi paesi limitrofi.
Il territorio ha una economia agricolo - industriale: accanto alle piccole, medie o grandi aziende
agricole, di tipo prevalentemente lattiero-caseario, sorgono insediamenti industriali.
Le Industrie che caratterizzano il territorio appartengono, non solo, al settore conserviero ma,
numerose sono le industrie nel settore dell'elettronica e telecomunicazioni e della meccanica.
Inoltre, lo sviluppo dell'industria aeronautica, la costruzione nell'immediato futuro di un
interporto a Grazzanise, garantiscono il potenziamento del settore terziario e assicurano agli
studenti ulteriori sbocchi occupazionali.
1.3 La realtà scolastica Da sempre il bacino di utenza dell'IT G.C. Falco è stato caratterizzato dalla consistente affluenza di
alunni da una "pluralità" di Comuni: non sempre e non tutti limitrofi. Infatti il contesto
territoriale di provenienza degli alunni dell'IT comprende (pur nelle variazioni succedutesi nel
corso degli anni) mediamente 25 - 30 Comuni dislocati in una vasta zona i cui ideali "confini"
comprendono: Mondragone, Sparanise, Vitulazio, Casapulla, Recale, Acerra, Aversa.
L’Istituto porta avanti una progressiva transizione dal vecchio ordinamento al nuovo ordinamento,
che ha preso l’avvio a partire dall’a.s. 2010/2011 solo per le classi iniziali e che quest'anno si
completerà estendendosi a tutte le classi.
Funzionano, nell'Istituto, i laboratori di: informatica, fisica, chimica, costruzioni
aeronautiche, tecnologia e disegno, elettronica, T.D.P., sistemi, meccanica, inglese,
nonché la biblioteca e varie strutture sportive.

2 IL CORSO di Perito in MECCANICA E MECCATRONICA
2.1 La struttura del corso
Il corso di studi ITI è suddiviso in due cicli distinti: un biennio comune ed un secondo biennio e quinto anno
che costituiscono un percorso formativo unitario di specializzazione in Meccanica che consente,
attraverso l'Esame di Stato, di conseguire il diploma di Perito in MECCANICA .
2.2 Il profilo professionale
Il PERITO MECCANICO deve conoscere i criteri per poter operare scelte sui materiali da costruzione e
sull'impiego delle macchine utensili, ed avere nozione dei principi fondamentali di organizzazione della
produzione industriale e delle norma antinfortunistiche per la sicurezza del lavoro. Egli deve essere
inoltre preparato ad affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, sapendo scegliere in modo
flessibile te strategie di soluzione ed essendo capace di usare tecnologie informatiche per la progettazione
e la gestione dei processi produttivi.
Il PERITO MECCANICO è in grado di svolgere mansioni relative a:
fabbricazione e montaggio di pezzi meccanici con elaborazione dei relativi cicli di lavorazione;
programmazione, avanzamento e controllo della produzione;
dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;
progettazione di elementi e di semplici gruppi meccanici;
controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e produzione;
sviluppo di programmi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC;
controllo e messa a punto di impianti, macchinari e gestione di servizi di manutenzione con attenzione
alla sicurezza del lavoro e alla tutela dell'ambiente.

2.3 Quadro Orario
DISCIPLINE
ORE SETTIMANALI
1° Biennio 2° Biennio
anno
4°
anno
5 °
1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno
Lingua e Lettere italiane 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Geografia 1
Lingua straniera 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Complementi di matematica 1 1
Diritto e Economia 2 2
Scienze
integrate
Scienze della Terra e Biologia 2 2
Fisica e laboratorio 3(1) 3(1)
Chimica e laboratorio 3(1) 3(1)
Tecnol. e tecniche di rappresent. grafiche 3(1) 3(1)
Tecnologie informatiche 3(2)
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
AREA D’INDIRIZZO
Scienze e Tecnologie Applicate 3
Meccanica, Macchine ed Energia 4(2) 4(2) 4(2)
Tecnologie meccaniche di processo e prodotti 5(3) 5(4) 5(4)
D.P.O.I. 3(1) 4(2) 5(3)
Sistemi e automazione industriale 4(2) 3(1) 3(1)
Totale ore settimanali 33(5) 32(3) 32 (8) 32 (9) 32 (10)
* Tra parentesi le ore di laboratorio.

3. LA CLASSE ED IL CONSIGLIO DI CLASSE
3.2 Commissari interni
DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA
1 Sibillo Tommasina MATEMATICA
2 Montuori Pietro MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
3 Merola Maddalena SCIENZE MOTORIE
DOCENTE
DISCIPLINA INSEGNATA
Fratta Teresa LINGUA E LETTERE ITALIANE
Fratta Teresa STORIA
Capotorto Ira INGLESE
Sibillo Tommasina MATEMATICA
Montuori Pietro MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
Lista Michele TECNOLOGIE MECCAN. DI PROCESSO
E DI PROD.
de Rosa Bruno D.P.O.I
Casaburo Luigi SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Crispino Andreana RELIGIONE
Merola Maddalena SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Tonziello Pasquale LABORATORIO D.P.O.I
Natale Antonio LAB. MECC; TECN.MECCAN.
D’ Aniello Paolo LAB. SIST. E AUTOMAZ. IND.

3.3 Elenco degli studenti
N° ALLIEVI Data e luogo di nascita
Crediti
3 anno
a.s 13/14
Crediti
4 anno
a.s 14/15
1 Armillotta Luigi 19/ 07/ 1997 CAPUA 4 5
2 Buonpane Pasquale 01/12/1995 NAPOLI 4 5
3 Cipullo Francesco 21/05/1997 S. MARIA C. V. 4 4
4 Cucarano Benito 28/02/1997 CAPUA 4 4
5 De Gennaro Giuseppe 10/12/1997 S. MARIA C. V. 3 3
6 Ilkiv Volodymyr 12/03/1996 UCRAINA 4 4
7 Manzo Bernardino 07/06/1997 CAPUA 4 4
8 Massa Libera 19/12/1995 CASTELLAMMARE
DI STABIA 4 4
9 Mastroianni Antonio 04/12/1996 CASERTA 3 4
10 Villano Alessio 13/02/1997 CASERTA 4 5
11 Visconte Francesco 13/06/1995 CASERTA 4 4
12 Vozza Alessio 17/03/1998 CAPUA 6 5
3.4 Presentazione della classe La classe VAMM formata inizialmente da 12 allievi, allo stato attuale risulta di 11 poiché
l’ alunna diversamente abile Massa Libera risulta assente dall’ inizio dell’ anno scolastico. Gli
alunni, sufficientemente scolarizzati e con comportamenti sempre corretti, provengono, tutti ad
eccezione di Visconte Francesco che risulta ripetente, dalla 3^AMM dell’anno scolastico 2013-
2014, fattore che ha contribuito a rendere la classe unita sul piano della socializzazione e della
collaborazione.
La continuità didattica non è stata mantenuta, nel corso del triennio, per tutte le discipline. Nella
prima parte dell' a.s. per gli alunni che hanno avuto giudizi insufficienti, sono state attivate forme
di recupero in itinere secondo le modalità approvate dal Collegio Docenti.
L'andamento didattico-disciplinare è stato sottoposto a diverse verifiche per cui le
programmazioni stesse delle diverse discipline non hanno subito rallentamenti rispettando i
tempi prestabiliti.
Per quanto riguarda una disciplina tecnica in lingua inglese, art.8 del D.P.R n. 88 del 15 marzo
2010, sono stati trattati argomenti di Meccanica, Macchine ed Energia da parte del prof,

Montuori Pietro affiancato dalla docente di Lingua Inglese Capotorto Ira.
La classe, durante tutto l'anno, ha mostrato un atteggiamento collaborativo e interessato
riuscendo a consolidare le proprie conoscenze in quasi tutte le materie. Si può dire che il profitto
risulta essere abbastanza eterogeneo con i seguenti livelli di apprendimento: alcuni allievi hanno
raggiunto, per impegno e partecipazione, una preparazione discreta.
Un gruppo ha acquisito i nuclei basilari delle materie di studio con un livello di approfondimento
delle conoscenze e di sviluppo delle abilità accettabile sebbene l’impegno profuso nel lavoro
domestico non sia stato sempre costante nel tempo;
un gruppo ha conseguito un livello di preparazione quasi sufficiente settoriale e poco
approfondito.
Alcuni hanno raggiunto risultati sufficienti se rapportati alla situazione di preparazione iniziale,
recuperando parzialmente le carenze e le lacune pregresse, nella seconda parte dell’anno
scolastico, con un maggiore impegno nello studio.
La frequenza alle lezioni è stata quasi regolare anche se va sottolineato che l’alunno Visconte
Francesco ha effettuato numerose assenze perché affetto da patologia ampiamente documentata
da certificazione medico-specialistica che, appunto nei periodi di riacutizzazione lo ha obbligato
ad assentarsi di sovente dalle attività scolastiche e che hanno condizionato il rendimento
scolastico.

4. PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo, nonché l’organizzazione nello studio, sono stati caratterizzati da scelte
operative e culturali, che hanno tenuto conto di:
analisi della situazione di partenza, riferita anche alle risorse ed alle attrezzature laboratoriali;
opportunità offerte dal territorio e dall’ambiente socio - economico in cui opera l’Istituto;
valutazione diagnostica, che ha rilevato la condizione iniziale degli studenti, sia per la sfera
cognitiva (prerequisiti), sia per quella socio – affettiva (rapporto con gli altri , atteggiamento
verso la Scuola, verso la disciplina);
finalità dell’offerta formativa in relazione all’indirizzo professionale dell’Istituto, che prevede nella
dinamica della vita sociale, una formazione culturale in campo umanistico e una valida
preparazione professionale, una conoscenza adeguata della lingua straniera, un buon utilizzo
degli strumenti informatici.
Il Consiglio di Classe ha suddiviso gli obiettivi in :
obiettivi comuni alle varie discipline;
obiettivi dell’area linguistica-espressiva;
obiettivi specifici dell’area tecnico –scientifica;
4.1 Obiettivi cognitivi e formativi generali
In funzione dei presupposti sopra elencati e dai risultati dell’analisi della situazione di partenza,
l’azione didattica si è rivolta al conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi – operativi comuni
per le varie discipline:
conoscenza, intesa come capacità di creare un bagaglio di nozioni ben memorizzate;
comprensione, intesa come capacità di comprendere le conoscenze;
applicazione, intesa come uso delle conoscenze acquisite, sotto forma di idee personali,
metodi e regole di precisione;
analisi e sintesi , intese come abilità e competenze a saper scomporre la comunicazione nei
suoi elementi fondamentali e costitutivi e capacità ad elaborare, al fine di pervenire a
strutture contenutistiche più facilmente assimilabili.
Questi obiettivi comuni fondamentali sono, come è noto, accompagnati da ulteriori obiettivi , intesi
come capacità, che si possono così sintetizzare:
Capacità di osservazione;
Capacità di concentrazione e riflessione;
Capacità di pianificazione e programmazione;
Capacità di cercare dati ed informazioni;
Capacità di rilevare errori e di auto - correzione;
Capacità di superamento dell’insuccesso;
Capacità di lavorare in gruppo;
Capacità di relazionarsi;
Capacità di esporre il proprio pensiero e le proprie conoscenze in maniera lineare e chiara;
Capacità di usare un linguaggio discorsivo senza mai trascurare l’aspetto rigoroso e formale.

4.2 Obiettivi specifici dell’area linguistico-espressiva
saper comprendere ed analizzare il testo letterario;
riflettere sulla letteratura e sua prospettiva storica;
saper produrre testi di apprezzabile livello espressivo;
essere capace di stabilire collegamenti nell’ambito della stessa disciplina o discipline
diverse nella ricerca dei denominatori comuni;
saper organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;
avere capacità di analisi e di sintesi;
saper ricercare la parola - chiave con sviluppo logico - comunicativo;
saper riconoscere strutture di pensiero in ordine alla complessità crescente.
4.3 Obiettivi specifici dell’area tecnico-scientifica:
conoscere le caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità dei
materiali;abilità di progettazione e di sviluppo (anche con utilizzo di disegno CAD);
conoscere le caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;
conoscere i principi fondamentali della organizzazione e gestione della produzione industriale;
conoscere i principi di funzionamento delle macchine a fluido;
conoscere le norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro;
saper consultare manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni;
saper effettuare calcoli matematici o saper trasformare gli enunciati simbolici in materiale
matematico - verbale, nonché le conoscenze delle leggi e teorie acquisite e renderle concrete.
Il livello di raggiungimento delle conoscenze, competenze e capacità degli allievi sono
analiticamente descritte nella sezione del documento relativa alle singole discipline.
4.4 Profilo formativo della classe in uscita
1) Obiettivi di minima: ottenere da parte dell’alunno conoscenze ed una capacità ad esprimerle
con linguaggio specifico appropriato, anche se semplice ( la percentuale degli allievi che ha
raggiunto tali obiettivi si aggira intorno al 20 %);
2) Obiettivi di massima: ottenere da parte dell’alunno un’apprezzabile livello di conoscenze, oltre
che apprezzabili capacità a saper elaborare le stesse ( la percentuale degli allievi che ha
raggiunto tali obiettivi si aggira intorno al 30 %) .
La restante parte della classe ha raggiunto “obiettivi intermedi”.
4.5 Contenuti
I contenuti disciplinari sono desumibili dai piani di lavoro individuali dei singoli docenti ed allegati
al documento. Essi sono stati selezionati in base ai seguenti criteri:
linea segnata dai programmi ministeriali;
capacità effettive della classe in termini di prerequisiti;
evoluzione tecnologica in atto e competenze per il raggiungimento del profilo tecnico professionale
richiesto dalle aziende locali.

4.5.1 Disciplina non linguistica in lingua Inglese
Con riferimento all'articolo 8 del D.P.R Comma 2 lettera b del 15 Marzo del 2010 n. 88 che
prevede l'insegnamento in lingua inglese, per una parte del monte ore, di una disciplina tecnica,
sono stati trattati, con la collaborazione dell'insegnante di Inglese, argomenti di Disegno,
Progettazione ed Organizzazione industriale.
Gli argomenti che sono stati trattati in modo più approfondito sono:
MATERIE CONTENUTI
LINGUA E LETTERE
ITALIANE
Luigi Pirandello
STORIA Il Fascismo
LINGUA STRANIERA Automazione
MATEMATICA Studio delle derivate
MECCANICA,MACCH.
ED ENERGIA
Motori a C.I. di tipo alternativo. Organi di trasmissione del moto
con cinghie e ruote dentate.
D.P.O.I
Processi produttivi e logistica. Centri di costo. Lay-out degli
impianti. La qualità.
SISTEMI Il P.L.C.
TECNOLOGIA MECC. Corrosione e metodi di protezione. CNC.
EDUCAZIONE FISICA
I percorsi formativi seguiti dal Consiglio di Classe sono stati articolati ed organizzati mediante unità
didattiche o sezioni modulari, in quanto, come è noto, consentono l’interdisciplinarità ed
opportunicollegamenti e confronti. La scansione di tempo è segnata alla fine di ogni unità, sia per la
parte teorica che per il laboratorio.

5 STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE
5.1 Metodi
Per interagire con gli allievi e per favorire il conseguimento degli obiettivi, tutti i docenti si sono
serviti di:
- Lezioni frontali;
- lezioni interattive;
- problemsolving;
- lavoro di gruppo;
- discussione guidata;
- attività di laboratorio;
- attività di recupero e/o sostegno.
5.2 Mezzi, Spazi, Tempi
Mezzi : Testi (libri in adozione, dispense, giornali) , sussidi audiovisivi (adoperati peralcune
materie), risorse multimediali.
Spazi : Aule e laboratori.
Tempi : Orario curricolare e pomeridiano.
5.3 Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati
Prove strutturate a risposta chiusa, prove strutturate a risposta aperta, prove tradizionali,
interrogazioni orali, interventi dal banco e/o posto di lavoro, compiti a casa.
In vista dell’esame di Stato, che prevede la terza prova scritta, il Consiglio di classe ha elaborato ed
approntato due prove pluridisciplinari, allegate al Documento, mediante questionari a risposta
multipla ed a risposta aperta, al fine di far acquisire alla classe determinate conoscenze su
contenuti opportunamente selezionati e comunque in relazione agli obiettivi fissati dalla
programmazione di classe.
5.4 Attività di recupero e sostegno
Consapevoli che le finalità della Scuola pubblica è quella di garantire a tutti gli studenti una
sostanziale parità di opportunità, la nostra scuola offre servizi che integrano le attività curriculari
e rendono l’ambiente scolastico sensibile alle esigenze degli studenti.
Al fine di promuovere il successo formativo e alla luce del D.m n. 80 del 3 ottobre 2007, si attivano
interventi di compensazione, integrazione e recupero innovativi ed efficaci .

6 LA VALUTAZIONE
La valutazione è relativa non solo all’acquisizione delle competenze di base e trasversali
programmate, ma tiene conto anche dell’intero percorso degli allievi, dei progressi ottenuti
rispetto alla situazione di partenza, dell’interesse e dell' impegno con il quale essi hanno
partecipato alle attività curriculari ed opzionali , ai risultati ottenuti nelle attività progettuali e di
recupero svolte all’interno del curricolo locale. Per la verifica degli apprendimenti essi sono
sottoposti a verifiche periodiche del processo di apprendimento e formazione mediante:
prove scritte programmate e concordate anche con la componente allievi/e; sono escluse più
prove scritte nello stesso giorno
test sia di tipo formativo che sommativo, con quesiti a risposta singola e/o a risposta multipla, a
risposta aperta e/o strutturata
verifica dell'avvenuto svolgimento del lavoro per casa
interrogazioni
relazioni individuali di argomenti studiati e/o approfonditi;
verifica e valutazione dei lavori di gruppo e/o di laboratorio, in quest’ultimo caso anche
individuali.
Per i descrittori per la misurazione dell’apprendimento si sono prese in considerazione:
le conoscenze;
le competenze acquisite;
le capacità dimostrate.
A ciascuna di queste tre sezioni sono collegate delle definizioni che descrivono i diversi livelli di
apprendimento a cui corrisponde, in via indicativa, un valore numerico. La seguente tabella di
riferimento mette in relazione gli elementi della valutazione con diverse fasce di voto.
Il voto così proposto dal singolo docente per ogni disciplina costituisce elemento di valutazione del
consiglio di classe.

6.1 Criteri di valutazione
INDICATORI DESCRITTORI VOTO LIVELLO
CONOSCENZE
Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata ed
approfondita con capacità di operare collegamenti
interdisciplinari efficaci.
10
Raggiungimento
sicuro, completo e
personale degli
obiettivi
disciplinari
ABILITA’
Eccellente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo
preciso e sicuro delle procedure, degli strumenti e dei
linguaggi disciplinari.
COMPETENZE
Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro preciso e ben
articolato. Esposizione personale valida, approfondita ed
originale, arricchita da contributi critici. Piena
consapevolezza e autonomia nell’applicazione/utilizzo di
dati e concetti specifici, differenti e nuovi, con soluzioni
originali. Organizzazione accurata del proprio lavoro.
CONOSCENZE Acquisizione dei contenuti completa ed approfondita con
capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
9
Raggiungimento
sicuro e completo
degli obiettivi
disciplinari
ABILITA’
Soddisfacente padronanza delle strumentalità di base.
Utilizzo sicuro delle procedure, degli strumenti e dei
linguaggi disciplinari.
COMPETENZE
Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e ben articolato.
Esposizione personale valida e approfondita. Piena
autonomia nell’applicazio-ne di dati e concetti in contesti
specifici, differenti e nuovi. Organizzazione efficace del
proprio lavoro.
CONOSCENZE Buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di
operare adeguati collegamenti interdisciplinari.
8
Raggiungimento
completo degli
obiettivi
disciplinari
ABILITA’
Buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo
autonomo e corretto delle procedure, degli strumenti e dei
linguaggi disciplinari.
COMPETENZE
Linguaggio verbale, orale e scritto chiaro ed appropriato.
Esposizione personale adeguata del proprio lavoro.
Organizzazione autonoma e proficua del proprio lavoro.
CONOSCENZE Discreta acquisizione dei contenuti.
7
Raggiungimento
complessivo degli
obiettivi
disciplinari
ABILITA’
Sostanziale padronanza delle strumentalità di base.
Discreto utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei
linguaggi disciplinari.
COMPETENZE
Linguaggio verbale, orale e scritto chiaro e corretto.
Esposizione personale adeguata e pertinente.
Organizzazione autonoma del proprio lavoro.
CONOSCENZE Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità 6 Raggiungimento

di consolidamento. essenziale degli
obiettivi
disciplinari ABILITA’
Apprendimento accettabile delle strumentalità di base.
Utilizzo piuttosto meccanico delle procedure e dei
linguaggi disciplinari.
COMPETENZE
Linguaggio verbale, orale e scritto semplice, chiaro ma non
del tutto corretto e approfondito. Parziale autonomia
nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti.
Organizzazione non sempre autonoma e adeguata del
proprio lavoro.
CONOSCENZE
Acquisizione superficiale dei contenuti con presenza di
lacune.
5
Raggiungimento
parziale degli
obiettivi
disciplinari
ABILITA’
Parziale apprendimento delle strumentalità di base.
Mediocre autonomia nell’uso delle procedure, degli
strumenti e dei linguaggi disciplinari.
COMPETENZE
Linguaggio verbale, orale e scritto, non adeguato e/o non
sempre pertinente. Esposizione personale superficiale.
Difficoltà nell’applicazione di dati e concetti.
Organizzazione inadeguata del proprio lavoro con
tendenza alla dispersione.
CONOSCENZE Mancata acquisizione dei contenuti minimi.
4
Mancato
raggiungimento
degli obiettivi
disciplinari
ABILITA’ Mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarso
utilizzo delle procedure e dei linguaggi disciplinari.
COMPETENZE
Linguaggio verbale, orale e scritto, molto semplice e poco
chiaro, non corretto e/o pertinente. Esposizione personale
molto superficiale. Mancata autonomia
nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti. Inadeguata
organizzazione del proprio lavoro.
CONOSCENZE Mancata acquisizione dei contenuti minimi per
impreparazione abituale e/o scadente preparazione di base.
3/2
Mancato
raggiungimento
degli obiettivi
disciplinari.
ABILITA’
Mancato apprendimento delle strumentali di base.
Incapacità di utilizzare le procedure dei linguaggi
disciplinari. Atteggiamento di rifiuto nell’apprendimento
delle strumentalità di base.
COMPETENZE
Notevoli difficoltà nell’uso dei linguaggi. Incapacità di
orientarsi anche se guidato. Esposizione personale
scadente, limitata da conoscenza molto lacunosa o
inesistente dei contenuti disciplinari, oppure conseguente
all’atteggiamento di chiusura nei confronti
dell’apprendimento.

6.2 Credito scolastico
Criteri di attribuzione del credito scolastico (inclusivo del credito formativo) agli studenti
del triennio conclusivo
Credito formativo: Il credito formativo è derivato da esperienze acquisite al di fuori della scuola frequentata, ma dotate delle seguenti caratteristiche: esperienze qualificate, ovvero significative e rilevanti
esperienze debitamente documentate
esperienze non saltuarie, ma prolungate nel tempo.
Gli ambiti in cui esso può essere acquisito sono esperienze conseguite non solo nella formazione
professionale e del lavoro in settori coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ma anche
nell’ambito del volontariato, della solidarietà, della cooperazione, dello sport e delle attività
culturali ed artistiche.
Credito scolastico La media dei voti conseguita dallo studente al termine dell’anno scolastico consente il suo
inserimento in una banda di oscillazione, secondo la tabella A del D.M. 99/09:
TABELLA PER ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO D.M. 99 del
16/12/2009
M = media 3° anno 4° anno 5° anno
M=6 3 - 4 3 - 4 4 - 5
6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6
7<M<=8 5 - 6 5 - 6 6 - 7
8<M<=9 6 - 7 6 - 7 7 – 8
9<M<=10 7 – 8 7 – 8 8 – 9
Il singolo consiglio di classe, all’interno della banda di appartenenza dello studente in base alla
media dei voti conseguita al termine dell’anno scolastico, tiene conto di alcuni indicatori per
attribuire il valore più alto consentito dalla banda di oscillazione:
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola;
eventuali crediti formativi presentati e certificati;

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1° PROVA SCRITTA
INDICATORI
Tipologia A:
analisi del testo
Tipologia B:
saggio breve o
articolo di
giornale
Tipologia C-D:
tema
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ADERENZA ALLA TRACCIA 1 2 3
COESIONE E COERENZA
DELL’ARGOMENTAZIONE 1 2 3 1 2 3
CORRETTEZZA ED EFFICACIA
ESPOSITIVA 1 2 3 1 2 3 1 2 3
QUALITÀ DEL CORREDO
INFORMATIVO 1 2 3
CONTESTUALIZZAZIONE 1 2 3
COMPRENSIONE 1 2 3
APPORTI PERSONALI E
ORIGINALI 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PUNTEGGIO ATTRIBUITO /15 /15 /15
Legenda:
1 = basso
2 = medio
3 = alto

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA
INDICATORI
VALUTAZIONE
CONOSCENZA E PADRONANZA DEGLI ARGOMENTI
1 2 3
COMPLETEZZA DELLA PROVA
1 2 3
CAPACITA’ DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
1 2 3
EFFICACIA ESPOSITIVA E CAPAITA' DI CALCOLO
1 2 3
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1 2 3
PUNTEGGIO ATTRIBUITO /15
Legenda:
1 = basso
2 = medio
3 = alto

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (B+C)
PER LA TIPOLOGIA “B”:
TIPOLOGIA “C” - PUNTEGGIO PER OGNI RISPOSTA ESATTA : 0,25.
TOTALE QUESITI N.27 :
TIPOLOGIA “B “ N.11
TIPOLOGIA “C” N.16
INDICATORI
Nullo
0,00
Inadeguato
0,10
Parzialmente
Adeguato
0,15
Adeguato
0,20
Completo
0,25
Pertinenza della
risposta
Conoscenza dei
contenuti
Abilità di sintesi
Competenze
linguistiche ed
uso di linguaggio
specifico
TOTALE 1 / 15

7. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO
Manifestazioni culturali
e progetti
extracurriculari
Open day dell’ Istituto Capua (CE)
Culture Day Capua (CE)
Incontri con la Guardia di Finanza Capua (CE)
Conferenza sulla sicurezza stradale Capua (CE)
Visite guidate
Viaggio d'istruzione Praga
Orientamento
Open day Capua (CE)
Facoltà di Ingegneria

8. SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA In vista dell’Esame di Stato, che prevede la terza prova scritta, il Consiglio di classe ha elaborato ed
approntato due prove pluridisciplinari, allegate al Documento, mediante questionari a risposta
multipla (tipologia C) e a risposte aperte (tipologia B) al fine di far acquisire alla classe determinate
conoscenze su contenuti opportunamente selezionati e comunque in relazione agli obiettivi fissati
dalla programmazione di classe , in ordine anche alle conoscenze disciplinari.
Sono state somministrate due prove con le seguenti modalità:
Tipologia Data Materie coinvolte Tempo assegnato
B+C Marzo 2016
STORIA
INGLESE 90 min
MATEMATICA
SISTEMI ED AUT.IND SCIENZE MOTORIE
Maggio 2016
STORIA
INGLESE
B+C
MATEMATICA
SISTEMI ED AUT. IND. 90 min
SCIENZE MOTORIE VALUTAZIONE TERZA PROVA: tipologia B+C vedi griglia allegata

ALLEGATO 1

Esame di Stato a. s. 2015-16
Simulazione TERZA PROVA
Allievo _____________________________________________________________________ Classe:
_____V_____ Sez. __AMM______Data: __________________
V a l u t a z i o n e P r o v a
1. Tipologia
La terza prova di esame si compone di 4 quesiti a risposta multipla (tipologia C) e 2 a risposta aperta (tipologia B) per le
discipline STORIA,MATEMATICA, SISTEMI E AUTOMAZIONE, SCIENZE MOTORIE, cui si aggiungono n. 3 quesiti a
risposta aperta (tipologia B) per la l’accertamento della lingua straniera (INGLESE).
2. Modalità di risposta
Per ogni quesito di tipologia C, sono riportate 4 risposte di cui una esatta da evidenziare con una crocetta. Per i quesiti di
tipologia B occorre scrivere la risposta nellerelative righe sottostanti. Non sono ammesse correzioni.
3. Durata
La durata della prova è di 90 minuti.
4. Criteri di Valutazione
Per i quesiti di tipologia C sarà attribuito un punteggio pari a 0.25 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta
errata. Per ogni quesito a risposta aperta è previsto un punteggio massimo di 1 punto con i seguenti indicatori: a) pertinenza
della risposta; b) conoscenza dei contenuti; c) capacità di sintesi; d) uso di linguaggio specifico. Per ogni indicatore saranno
attribuiti i seguenti punteggi parziali: (0) nullo; (0.10) inadeguato; (0.15) parzialmente inadeguato; (0.20) adeguato; (0.25)
completo.
Il punteggio complessivo sarà espresso in QUINDICESIMI sommando i punti ottenuti in tutti i quesiti.
R I S U L T A T I D E L L A P R O V A
DISCIPLINA
Punteggio complessivo quesiti per ogni
disciplina
Totale
Parziale
Tipo C
Tipo B
1) STORIA
2) MATEMATICA
3) INGLESE
4) SISTEMI E AUTOMAZIONE
5) SCIENZE MOTORIE
VALUTAZIONE
TOTALE
/15
* Durata massima complessiva della prova 90 minuti.

STORIA
1. Perché Giolitti cercò l’alleanza con i cattolici? a) Perché egli, liberale laico in origine, col tempo si era convertito b) Perché Pio X aveva ottenuto il non expedit che allontanava i cattolici dalla politica c) Per controbilanciare i risultati elettorali della sinistra d) Perché voleva evitare la vittoria dei cattolici
2. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento si incominciò a sfruttare nell'industria un'importante invenzione: quale?
a) La macchina a vapore b) Il motore a scoppio c) Il telaio meccanico d) La catena di montaggio
3. Quali nazioni facevano parte della Triplice Alleanza? a) Austria-Russia-Prussia b) Germania-Austria-Italia c) Russia-Francia-Gran Bretagna d) Inghilterra-Francia-Russia
4. Quale clausola della Triplice Alleanza permise all'Italia di non entrare in guerra nel 1915?
a) Il fatto che fosse "difensiva" b) Il fatto che fosse stata stipulata da un Presidente del Consiglio che non era più in carica c) Il fatto che fossero coinvolte già due nazioni su tre d) Il fatto che fosse "offensiva"
A RISPOSTA APERTA:
1. Spiega il concetto di “ imperialismo “
2. La “vittoria mutilata” in Italia

IT “G.C. FALCO”
a.s. 2015/16
CLASSE VAMM
Prof.ssa CAPOTORTO IRA
SIMULAZIONE DELLA PROVA DI INGLESE
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS
1. Please describe the three main functions carried out by computers and the devices necessary to
fuffil the task (4 lines)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. What are the three main areas of knowledge when studying car engines? (3 lines)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Can you describe the internal combustion cycle? (free)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATICA
1) la funzione y= log (x - 4) :
a) è definita per ogni x
b) si annulla per x=5 e per x = 3
c) è definita per ogni x ≠ 4
d) è definita per ogni x > 4
2) la funzione y =𝟐𝐱−𝟏
𝐱𝟐− 𝟓 :
a) positiva per x < - √5
b) negativa per ½ < x < √5
c) positiva per - √5<x< ½ e x > √5
d) non positiva per x > √5
3) il valore del limite 𝐥𝐢𝐦𝒙→∞
(𝟐𝒙−𝟑
𝒙+𝟓) è:
a) + ∞
b) 1
c) 2
d) nessuno dei precedenti valori
4) una funzione è detta continua in 𝒙𝟎 se :
a) lim𝑥→0
𝑓(𝑥) = 𝑥0
b) lim𝑥→0
𝑓(𝑥) ≠ f(𝑥0)
c) lim𝑥→0
𝑓(𝑥) = ∞
d) lim𝑥→0
𝑓(𝑥) = f(𝑥0)
5) determinare gli asintoti della seguente funzione: y = 𝒙𝟐− 𝟑𝒙
𝟑𝒙+𝟏

6) determinare il valore del seguente limite : 𝐥𝐢𝐦𝒙→+∞
(𝟐 𝒆−𝒙
𝒔𝒆𝒏 (𝒆−𝒙))
SISTEMI E AUTOMAZIONE
1. I trasduttori analogici:
□ Hanno una risoluzione migliore di un trasduttore digitale
□ Hanno una precisione maggiore di un traduttore digitale
□ Hanno un segnale in uscita che varia con continuità
□ Hanno un segnale in uscita che varia in modo discreto
2. Quale, tra i seguenti, è un trasduttore di forza?
□ Estensimetro
□ Potenziometro
□ Fotocellula
□ Encoder
3. L’errore di offset di un trasduttore:
□ È il rapporto tra la variazione dell’uscita e la corrispondente in ingresso
□ È il rapporto tra la variazione in ingresso e la corrispondente variazione in uscita
□ È la più piccola variazione dell’ingresso in grado di produrre una variazione rilevabile
□ È il valore dell’uscita corrispondente a un ingresso nullo
4. In un motore elettrico la potenza meccanica disponibile all’albero è data dalla relazione:
□ Coppia motrice / velocità angolare
□ Coppia motrice x velocità angolare
□ Velocità angolare/ Coppia motrice
□ Coppia motrice x numero di giri
5. Descrivere un attuatore pneumatico lineare a semplice effetto :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Descrivere gli elementi fondamentali di un motore elettrico a commutazione meccanica:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

EDUCAZIONE FISICA
IL Crampo è: a ) una contrazione involontaria e passeggera delle fibre muscolari b) una contrazione dovuta all’accumulo di acido lattico nelle fibre muscolari c ) una contrazione involontaria e persistente delle fibre muscolari, dovuta al mancato rilasciamento delle stesse dopo la contrazione. d) una contrazione involontaria delle fibre muscolari per effetto di una fase di rilasciamento troppo lunga.
Perche si fa uso di sostanze dopanti?
a ) Per tonificare il corpo
b) Per ridurre il peso
c) Purificare il sangue
d) Per migliorare le prestazioni fisiche e superare la fatica
Nella pallavolo la palla può essere colpita:
a) Solo con le mani
b) Con qualsiasi parte del corpo
c) Solo con qualsiasi parte del corpo
d) con i piedi
Il fumo provoca degli effetti nocivi sull’organismo quali:
a) Cancro polmonare ,danni cerebrali e danni cardiaci
b) Malattie respiratorie , cardio-vascolari e cardiache
c) Cancro polmonare e in altri organi, malattie respiratorie e cardiovascolare, danni al feto
d) Danni cardiaci e malattie respiratorie

Indica quale sport preferisci ed i motivi di tale scelta:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiega in modo semplice le cause del doping:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esame di Stato a. s. 2015-16
Simulazione TERZA PROVA
Allievo _____________________________________________________________________ Classe:
_____V_____ Sez. __AMM______Data: __________________
V a l u t a z i o n e P r o v a
1. Tipologia
La terza prova di esame si compone di 4 quesiti a risposta multipla (tipologia C) e 2 a risposta aperta (tipologia B) per le
discipline STORIA,MATEMATICA, SISTEMI E AUTOMAZIONE, SCIENZE MOTORIE, cui si aggiungono n. 3 quesiti a
risposta aperta (tipologia B) per la l’accertamento della lingua straniera (INGLESE).
2. Modalità di risposta
Per ogni quesito di tipologia C, sono riportate 4 risposte di cui una esatta da evidenziare con una crocetta. Per i quesiti di
tipologia B occorre scrivere la risposta nellerelative righe sottostanti. Non sono ammesse correzioni.
3. Durata
La durata della prova è di 90 minuti.
4. Criteri di Valutazione
Per i quesiti di tipologia C sarà attribuito un punteggio pari a 0.25 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta
errata. Per ogni quesito a risposta aperta è previsto un punteggio massimo di 1 punto con i seguenti indicatori: a) pertinenza
della risposta; b) conoscenza dei contenuti; c) capacità di sintesi; d) uso di linguaggio specifico. Per ogni indicatore saranno
attribuiti i seguenti punteggi parziali: (0) nullo; (0.10) inadeguato; (0.15) parzialmente inadeguato; (0.20) adeguato; (0.25)
completo.
Il punteggio complessivo sarà espresso in QUINDICESIMI sommando i punti ottenuti in tutti i quesiti.
R I S U L T A T I D E L L A P R O V A
DISCIPLINA
Punteggio complessivo quesiti per ogni
disciplina
Totale
Parziale
Tipo C
Tipo B
1) STORIA
2) MATEMATICA
3) INGLESE
4) SISTEMI E AUTOMAZIONE

5) SCIENZE MOTORIE
VALUTAZIONE
TOTALE
/15
* Durata massima complessiva della prova 90 minuti.
STORIA
1. La forza politica che agli inizi del '900 assunse la guida del nascente movimento operaio fu:
a) Il partito socialista b) Il partito comunista c) Il mondo cattolico d) La Confederazione generale dell'industria
2. Quale, tra le seguenti definizioni, ti sembra più adatta per "imperialismo"? a) Questo termine definisce il ritorno dell'impero b) Questo termine definisce in sostanza il colonialismo, ma più precisamente in relazione al suo
periodo di massima espansione, 1870-1914 c) Questo termine definisce la politica delle grandi potenze in Africa, legittimata da accordi
internazionali d) Questo termine definisce una politica aggressiva, tesa ad affermare una nazione a danno
delle altre
3. Allo scoppio della prima guerra mondiale, l’Italia non partecipò alle ostilità a) perché era interessata alla conquista del Giappone b) perché il popolo votò per la pace c) perché l’Austria non l’aveva informata e aveva dato inizio ad una guerra offensiva d) perché i soldati non vollero combattere
4. La “vittoria mutilata” significò per l’Italia a) un riprendere le ostilità b) insoddisfazione per come si erano svolte le trattative alla conclusione della guerra c) una promessa di futuri miglioramenti d) una vittoria, che se anche non completa, aveva soddisfatto tutti
5. In seguito a quale avvenimento Mussolini fu arrestato?

6. Grazie a chi o a che cosa Hitler divenne capo del governo tedesco?
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GIULIO CESARE FALCO” – CAPUA
A.S. 2015/16
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DI: INGLESE
PROF.SSA: IRA CAPOTORTO
CLASSE: V SEZIONE: AMM
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:
1) Please provide a description of “processing” (3 lines)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) What is a water-fuelled car? (2lines)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) What are the most important forms of mechanical energy? (3lines)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Terza prova di matematica
TRACCIA II
1) La funzione y= x−3
√x−1
a) È definita per x≠1 b) È definita per x≠3 c) È definita per x>1 d) È definita in tutto l’insieme dei numeri reali
2) Il valore del limite lim𝑥→+∞
x+2√x
3x−1
a) +∞ b) 1/3 c) 0 d) -∞
3) La funzione y=x³+4
x+1
a) Non ha asintoti b) Ha un asintoto orizzontale x=1 c) Ha un asintoto obliquo y=x-1 d) Ha un asintoto verticale x=-1
4) La derivata della funzione y= x ln x a) D(y)= lnx+1 b) D(y)= lnx c) D(y)= x²+lnx d) D(y)= x +lnx
5) Data la funzione 𝑦 = √16 − 𝑥2individuare gli intervalli in cui la funzione è crescente e quelli in cui è decrescente.
6) Studiare la concavità della funzione y= x²-3x+1

SISTEMI E AUTOMAZIONE
2. In funzione di quali elementi basilari il PLC stabilisce le variabili di uscita?
□ Controllo del programma
□ Dimensione degli attuatori
□ Disposizione degli attuatori
□ Acquisizione degli ingressi ed elaborazione del programma utente
7. I finecorsa di un attuatore pneumatico si collegano al PLC:
□ Nella morsettiera degli ingressi
□ Nella morsettiera delle uscite
□ Possono essere collegate sia nella morsettiera degli ingressi che delle uscite
□ I finecorsa non sono collegati al PLC
8. Il flusso logico nel diagramma Ladder
□ Va da sinistra verso destra
□ Va da destra verso sinistra
□ Va dall’alto verso il basso
□ Va dal basso verso l’alto
9. Il braccio di un robot è costituito da:
□ Un insieme di elementi flessibili che si possono muovere l’uno rispetto all’altro
□ Un insieme di elementi rigidi che si possono muovere l’uno rispetto all’altro
□ Un insieme di elementi rigidi che non si possono muovere l’uno rispetto all’altro
□ Un insieme di elementi flessibili che non si possono muovere l’uno rispetto all’altro
10. Disegna e descrivi gli elementi fondamentali che costituiscono il PLC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Disegna e descrivi gli elementi fondamentali di un alimentatore del PCL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
Educazione Fisica
Il campo di pallavolo è diviso in:
a)Zona di attacco e zona di difesa b)Zona di attacco , zona di difesa e zona di servizio c)Zona di attacco e zona di battuta d)Zona di gioco e zona di battuta
Il termine binge- drinking significa:
a)Bere per divertirsi b)Bere fino a dimenticare c)Bere fino ad ubriacarsi d) Bere per rilassarsi
Quale tra i seguenti non è effetto dell’alcol?
a)Stimolante
b)Problemi di memoria
c) Incapacità di apprendimento
d)Minor visibilità all’abbagliamento
Rispetto alle regole del calcio quelle del calcetto sono:
a)Simili

b)Molto diverse c)Identiche d)Più complesse La dipendenza:Parlane ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… I fondamentali della Pallavolo. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe V AMM
ALLEGATO 2
LINGUA E LETTERE ITALIANE
STORIA
LINGUA STRANIERA
MATEMATICA
MECCANICA , MACCHINE ED ENERGIA
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROC. E DI PRODOTTO
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORG. INDUSTRIALE
SISTEMI E AUTOMAZIONE
RELIGIONE
EDUCAZIONE FISICA

Programma di italiano
L’età del Realismo
Il Naturalismo francese.
Il Verismo italiano
G.Verga : Dai Malavoglia: il ritorno di Ntoni;
La crisi dell’io Decadentismo : caratteri generali;
G.Pascoli :Arano,Lavandare,Il gelsomino notturno;
G.D’Annunzio :La pioggia nel pineto;
I.Svevo e il romanzo psicologico: Dalla “ Coscienza di Zeno”:
Il vizio del fumo;
Lo schiaffo;
L.Pirandello: la frantumazione dell’io.
La poesia del 900
Crepuscolarismo,Futurismo,Ermetismo:caratteri generali.
G.Ungaretti:il poeta soldato :Veglia-S.Martino del Carso.
E.Montale: il male di vivere : Merigiare pallido e assolto:
Spesso il male di vivere ho incontrato.
S.Quasimodo e l’impegno civile : ed è subito sera.
U.Saba un poeta a sé :Mio padre è stato per me “l’assassino”.
Produzione scritta
Tema di ordine generale e di Storia-Articolo di giornale e Saggio breve-analisi e commento di testi
poetici.
Modulo di Cittadinanza e Costituzione Il volto dell’Europa che cambia: i flussi migratori.
Gli alunni L’insegnante
………………….. ………………….

…………………..
…………………..
PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE V ACM MECCANICA
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
1 - GLI ALBORI DEL NOVECENTO : ASPETTI E PROBLEMI.
L’Europa all’inizio del Novecento La “belle époche” - Il Nazionalismo - Le rivalità internazionali - La corsa agli armamenti -
L’espansionismo tedesco - Il revancismo francese - Triplice alleanza e triplice intesa - Scienza e
filosofia: tramonta l’età delle certezze.
L’ Italia all’inizio del Novecento Giolitti - La distinzione fra Stato e Governo - Il suffragio universale maschile - Le riforme sociali - I
cattolici e la politica - I socialisti - La politica estera di Giolitti - La conquista della Libia - Lo sviluppo
dell’industria - L'emigrazione.
2 - LA GRANDE GUERRA
La prima guerra mondiale Considerazioni generali - L’inizio della “grande guerra” - Dalla “guerra lampo” alla guerra di trincea
- L’Italia dalla neutralità all’intervento - Le operazioni belliche e i fronti interni - 1917: l’anno della
svolta - L’ultimo anno di guerra - La guerra sul fronte italiano - La difficile costruzione della pace.
3 - L’EUROPA DEI REGIMI TOTALITARI
La Rivoluzione Russa (caratteri generali)
Stati europei tra le due guerre La crisi della Repubblica di Weimar - La reinsorgenza del nazionalismo e l’affermazione dei fascismi
- La guerra di Spagna .
Il Fascismo al potere La crisi dello stato liberale in Italia – La nuova destra – L’occupazione delle fabbriche – Dal
Parlamento alle piazze – Mussolini conquista il potere - Dal liberismo allo statalismo

La ricerca e l’organizzazione del consenso – La Conciliazione – L’ideologia fascista – La politica
estera.
Il totalitarismo nazista in Germania Un’ ascesa facile e pseudolegale – L’ideologia nazista – La costruzione dello Stato nazista –
Nazismo e società : terrore e disgregazione sociale – Lager e deportazioni: fasi e finalità.
4 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE
La seconda guerra mondiale Verso il conflitto – Le prime operazioni – La “guerra lampo”- L’attacco nazista all’URSS e
l’intervento americano – 1942-1943: inizia la crisi delle forze del patto tripartito – Il crollo del
regime fascista; l’offensiva alleata in Italia; la Resistenza in Europa – La conclusione del conflitto e
la sconfitta del nazismo – I trattati di pace – Le due guerre: un confronto e un bilancio – L’Italia
dalla caduta del fascismo alla Liberazione.
Il secondo dopoguerra L’Europa dei blocchi – La “guerra fredda”.
Modulo Cittadinanza e Costituzione: il volto dell’Europa che cambia: i flussi migratori.
Gli alunni Prof.ssa

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO
CLASSE V AMC
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PROF.SSA FRATTA TERESA
La classe, dal punto di vista comportamentale, non ha sempre avuto un atteggiamento disciplinato e
responsabile, poco l’interesse e scarsa la volontà di studio e per alcuni di essi la presenza non è stata
sempre costante: è stato per tanto necessario attivare strategie didattiche di coinvolgimento per rendere
gli allievi attivi e partecipativi alla vita scolastica.
Dal punto di vista cognitivo, essa, all’inizio dell’anno presentava un diverso grado di preparazione degli
alunni dovuto in massima parte ad uno scarso impegno nello studio: la classe è formata da 27 alunni ( 24
maschi e 3 femmine di cui una diversamente abile non più frequentante). Si potevano distinguere nella
classe tre gruppi differenti fra loro: un primo gruppo caratterizzato dal desiderio di migliorarsi, un secondo
gruppo caratterizzato da difficoltà di fondo ma dotato di buona volontà, un terzo gruppo indolente e poco
propenso al dialogo educativo. Attraverso opportune strategie e attività didattiche di rimotivazione, ho
cercato di intervenire oculatamente per mettere tutti nelle condizioni di raggiungere il massimo sviluppo
delle loro potenzialità e capacità, cercando di far crollare l’apatia e il disinteressa che regnava in classe.
Nella fase intermedia e verso la fine dell’anno, con l’avvicinarsi della data degli esami, la maggior parte
degli allievi ha fatto registrare un miglioramento nel rendimento scolastico grazie ad una più viva
partecipazione al dialogo educativo. Essi hanno conseguito, compatibilmente con le proprie capacità e
attitudini, gli obiettivi formativi e disciplinari fissati nella programmazione didattica.
Le verifiche sono state per lo più scritte data la numerosità degli allievi.
Nella valutazione finale di ogni studente ho tenuto conto più che dei risultati delle verifiche, del grado di
maturazione generale, delle capacità di apprendimento e soprattutto dei miglioramenti rispetto alla
situazione di partenza e della partecipazione al lavoro svolto in classe.

RELAZIONE FINALE DI STORIA
CLASSE V AMC
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PROF.SSA FRATTA TERESA
Attraverso lo studio della Storia ci si è proposti di far comprendere agli allievi che la realtà in cui vivono è
qualcosa in continuo movimento che è stato ed è soggetto a continue modifiche il cui artefice principale è
l’uomo. Partendo da tale presupposto, sono stati individuati gli obiettivi di seguito indicati:
1) Sviluppare la capacità di individuare le connessioni, i rapporti tra particolare e generale.
2) Sviluppare la capacità di mettere in relazione gli eventi e cogliere il rapporto causa-effetto.
3) Acquisire la consapevolezza che la costruzione storica si basa su una pluralità di fonti che la storia
seleziona, riordina, interpreta.
4) Favorire l’attitudine alla lettura critica della realtà sociale e politica.
5) Rafforzare la consapevolezza che la comprensione del passato può facilitare la lettura del presente.
Per realizzare le finalità sopra indicate l’organizzazione del curriculo di Storia è analoga a quella del
curriculo di Italiano.
Il piano di lavoro, pertanto, è risultato costituito da moduli e unità didattiche che, ove possibile, sono state
svolte in parallelo con l’Italiano. A seconda delle particolari esigenze del curriculo, si è fatto ricorso a
strategie di intervento di vario tipo quali la lezione frontale, la conversazione guidata, il lavoro individuale o
di gruppo visione di filmati.
La verifica dell’apprendimento è stata effettuata in itinere e si basata su test, relazioni, interrogazioni.
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
la conoscenza dei dati;
la capacità di orientarsi nell’ambito delle tematiche trattate;
la capacità di analisi e di sintesi;
la capacità di formulare valutazioni e riflessioni personali;
la padronanza del mezzo linguistico.
Gli studenti oltre che sul manuale, hanno operare su documenti, brani di opere storiografiche, carte
storiche, tabelle cronologiche, carte geografiche.

PROGRAMMA DI
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
CLASSE V SEZIONE A INDIRIZZO MECCANICA
PROF.SSA IRA CAPOTORTO
Si riporta qui di seguito la scansione modulare dei contenuti affrontati nella classe VAMM durante
l’A.S: 2015/16
PRIMO MODULO
Titolo: Brani di civiltàsuargomenti di variogenere, inquadratinelcomplesso campo
d’azionedellameccanica
Ore complessive: 20 + 2
Pre-requisiti:
1) Saper formulare liste 2) Saper coniugare i verbi in tutte le forme e tempi 3) Saper fare paragoni
Obiettivi:
1) Saper usare i principali acronimi 2) Saper gestire brani di difficoltà media e di contenuti tecnici 3) Saper utilizzare il verbo fare nelle sue forme particolari
Esponenti linguistici:
1. I sostantivi collettivi 2. Il presentperfect, tutte le forme e usi 3. Le principali espressioni di tempo
Verifiche: Le verifiche, di tipo oggettivo e soggettivo, descritte nella parte generale
accompagneranno tutta l’attività didattica e saranno somministrati test finaliche serviranno per le
valutazioni quadrimestrali.
SECONDO MODULO
Titolo: Car engines
Ore complessive:15 + 1

Pre-requisiti:
1) Conoscenza generale della meccanica delle macchine 2) Saper descrivere una macchina con linguaggio appropriato 3) Saper usare i verbi frasali 4) Conoscere le forme passate dei verbi
Obiettivi:
1) Acquisire una terminologia specifica relativa alle macchine 2) Saper dare ed eseguire istruzioni 3) Saper usare la forma passiva
Esponenti linguistici:
1) Imperativo 2) Forma passiva 3) Comparativi e superlativi
Verifiche: Le verifiche, di tipo oggettivo e soggettivo, descritte nella parte generale
accompagneranno tutta l’attività didattica e saranno somministrati test finaliche serviranno per le
valutazioni quadrimestrali.
TERZO MODULO
Titolo: Car enginesApprofondimenti
Ore complessive:15 + 1
Pre-requisiti:
1. Conoscenza generale delle varie tipologie di motore 2. Saper descrivere una macchina e i cicli benzina e diesel con linguaggio
appropriato 3. Saper utilizzare le forme del periodo ipotetico
Obiettivi:
1. Acquisire una terminologia specifica relativa alle macchine 2. Saper dare ed eseguire istruzioni 3. Saper usare le informazioni per formulare ipotesi e programmi
Esponenti linguistici:
1. Il periodo ipotetico 2. Le varie forme di futuro
Verifiche: Le verifiche, di tipo oggettivo e soggettivo, descritte nella parte generale
accompagneranno tutta l’attività didattica e saranno somministrati test finaliche serviranno per le
valutazioni quadrimestrali.

QUARTO MODULO
Titolo: Metodo
Ore complessive: 20 + 2
Pre-requisiti:
1) Conoscere la sintassi della lingua inglese a livello intermediate 2) Riconoscere le situazioni ed affrontare dialoghi pertinenti 3) Saper parlare al passato e saper fare previsioni per il futuro
Obiettivi:
1) Conoscere le strategie per analisi testuali approfondite 2) Saper operare confronti, interpretazioni e paragoni 3) Approfondire il lessico, i sinonimi e i contrari 4) Saper riferire di azioni abituali che accadevano in passato ma non più nel
presente
Esponenti linguistici:
1) Comparativi e superlativi irregolari 2) Il futuro, tutte le forme e usi 3) Il simplepast vs il presentperfect
Verifiche: Le verifiche, di tipo oggettivo e soggettivo, descritte nella parte generale
accompagneranno tutta l’attività didattica e saranno somministrati test finali che serviranno per le
valutazioni quadrimestrali.
QUINTO MODULO
Titolo: Computers and automation
Ore complessive: 20 + 2
Pre-requisiti:
1) Conoscere le principali macchine ed il loro impiego 2) Sapere operare delle differenze 3) Sapere evidenziare i rapporti causa-effetto
Obiettivi:
1) Conoscere lo sviluppo dell’automazione e della robotica e la loro applicazionenella produzione
2) Saper utilizzare i verbi anche nelle forme del passivo Esponenti linguistici:

1) La forma passiva dei verbi Verifiche: Le verifiche, di tipo oggettivo e soggettivo, descritte nella parte generale
accompagneranno tutta l’attività didattica e saranno somministrati test finaliche serviranno per le
valutazioni
Tutte le attività si sono svolte con regolarità e il programma è stato rispettato nel suo complesso.
Le attività hanno trovato puntuale riscontro nelle verifiche periodiche sia scritte che pratiche che
orali.
La classe ha seguito un percorso CLIL di preparazione in lingua veicolare sul seguente argomento:
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Lo studio è stato accompagnato da attività di ricerca e dalla visione del film Modern Times, di e
con Charlie Chaplin.
La classe ha altresì svolto un percorso modulare di Cittadinanza e Costituzione, avente per
argomento MECHANICAL ENERGY e ENERGY SOURCES.
Capua, lì
La Docente
Ira Capotorto

RELAZIONE FINALE CLASSE V AMM DOCENTE: Ira Capotorto
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (Indirizzo Meccanica)
Presentazione della classe
La classe è articolata in due differenti indirizzi di studio, ma la materia inglese è comune per ambo le parti.
La classe VAMM, composta da 12 alunni, mostra un livello generale di conoscenze quasi soddisfacente, ad
eccezione di alcuni alunni dal rendimento alquanto scarso i quali, nonostante gli incoraggiamenti e le
incitazioni ad una crescita non solo didattica, ma proprio di maturità personale, hanno mostrato un
atteggiamento superficiale e maldestro nei confronti delle discipline e del discorso didattico/istituzionale in
generale. Si rimanda alle decisioni collegiali di fine anno.
Si auspica che gli stessi mostrino, nel rush finale, un minimo di recupero, e si ritiene, eventualmente, di dar
loro la possibilità di accedere all’esame di stato per la disciplina in questione. Si segnala che l’alunna Massa
Libera non frequenta più.
Osservazioni sullo svolgimento del programma:
Grazie alla partecipazione di un gruppo leader e alla motivazione dei discenti più incoraggianti, il
programma è stato svolto in modo lineare e continuativo, intervallato da momenti di riflessione e
approfondimento.
Risultati conseguiti e criteri di valutazione.
I risultati conseguiti sono buoni per un numero molto esiguo di alunni, quasi sufficienti per altri.
I criteri di valutazione tengono conto di quanto segue:
a. conoscenza. b. capacità di rielaborazione. c. utilizzazione di un linguaggio corretto e di una terminologia specifica. d. capacità di applicazione. e. capacità di collegamento ed approfondimento. f. capacità critica.
Altri interventi didattici curriculari:

La classe ha seguito un percorso CLIL di 5 ore nella materia Meccanica nell’ambito della Seconda
Rivoluzione Industriale con riferimento alle Linee Guida Ministeriali.
Il Modulo di Cittadinanza e Costituzione affronta le varie fonti energetiche alternative.
Metodologie e sussidi impiegati Le lezioni di spiegazione e verifica si sono svolte attraverso le seguenti metodologie:
a. lezione frontale. b. discussione di gruppo. c. verifiche scritte ed orali. d. Ricerche e attività laboratoriali
Utilizzando i seguenti strumenti:
a. libri di testo e di potenziamento. b. materiale fotostatico. c. lavagna elettronica
Eventuali osservazioni e proposte.
Nulla
La Docente

I.T. “G.C.FALCO” AS. 2015/2016
Programma di MatematicaV°ACA+V°AMM
Docenti: Sibillo Tommasina
UNITA’ 1 : Le funzioni di una variabile
Generalità sulle funzioni
Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione
Alcune caratteristiche delle funzioni analitiche
Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione
UNITA’ 2: Limiti di funzioni
Nozioni elementari : intorni, punti di accumulazione, punti isolati, punti di frontiera
Definizione di limite di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito
Definizione di limite di una funzione f(x) per x che tende a più o meno infinito
Teoremi sui limiti ( definizione)
UNITA’ 3 : Funzioni continue e calcolo dei limiti
Funzioni continue
Forme indeterminate
Limiti che si presentano in forma indeterminata
Limiti notevoli
Punti di discontinuità di una funzione
Infinitesimi
Infiniti
UNITA’ 4: Concetto di derivata

Definizione di derivata di una funzione di una variabile
Derivabilità e continuità di una funzione
Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile
Equazione della retta tangente a una curva in un suo punto
UNITA’ 5: Calcolo delle derivate di una funzione di una variabile
Derivata di alcune funzioni elementari
Teoremi sul calcolo della derivata ( definizione)
Derivazione delle funzioni inverse
Derivazione di funzioni composte
Derivate di ordini superiore
UNITA’ 6 : Teoremi sul calcolo differenziale
Teorema di Rolle ( definizione)
Teorema del valor medio o di Lagrange( definizione)
Teorema degli incrementi finiti o di Cauchy( definizione)
La regola di De L’Hòpital e le sue applicazioni
UNITA’ 7: Studio di funzioni analitiche con il calcolo differenziale
Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione
Concavità di una curva
Rappresentazione grafica delle funzioni.
Gli allievi Docente
Sibillo Tommasina

RELAZIONE FINALE
Classe V A.C.A.,VAMM
A.S. 2015-2016
Prof.ssa Tommasina Sibillo
Finalità
In accordo con la programmazione educativa e didattica promossa dal consiglio di classe , mi sono
prefissata nella didattica disciplinare della Matematica , un’azione formativa quanto più adatta alle
esigenze formative degli studenti considerate negli aspetti cognitivi , affettivo-motivazionali e relazionali .
IN tale contesto la Matematica si manifesta come disciplina portante in quanto il suo ruolo di modello e di
linguaggio permette di individuare e formalizzare dati . L sua valenza educativa, infatti, si evidenzia nel
momento in cui si usano processi logici ipotetico deduttivi che permettono di ordinare il pensiero in ogni
sua manifestazione . La consequenzialità impostata su una logica correlazione tra i dati ne fanno uno
strumento didattico altamente educativo e propedeutico ad altre discipline a maggiore indirizzo
umanistico.
Metodologia
Ritengo che un valido rapporto educativo-cultural debba facilitare al ,massimo le domande , stimolando la
curiosità di sapere indirizzandola in processi di costruzione culturale correttamente mirati e verificati nella
loro produttività . La lezione frontale è stata impostatail più possibile in forma dialogica e problematica.
L’intervento dei discenti è stato sollecitato sia nella ricerca delle soluzioni ( attraverso informazioni
espresse anche informalmente , scaturite dalle intuizioni e dalle deduzioni dei singoli alunni ) sia nelle
successive analisi e correzioni dei contenuti emersi .
Questo metodo di procedere ha favorito l’attenzione e lo sviluppo delle attività intuitive, evidenziando la
logica stringente del ragionamento e la necessità di procedere nello studio in modo personale e critico
utilizzando la memoria in maniera costruttiva
Verifiche e Valutazione
Le verifiche sono state proposte agli studenti con scansioni temporali non sempre regolari per temprare la
loro autonomia di studio. Le competenze acquisite sono state accertate sia attraverso verifiche orali(
individuali, collegiali, interventi spontanei o sollecitati che scritte ( prove oggettive strutturate, test, compiti
tradizionali). Le verifiche hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi e le diverse abilità dei discenti.
Nel valutare ho considerato fondamentale la valorizzazione del ragionamento ( causa) che porta a

formulare coerenti ipotesi e coerenti affermazioni ( effetti) . Dal punto di vista scolastico considero come
maggiore risultato un corretto processo che un corretto risultato .
Nella valutazione finale si è tenuto conto dei risultati delle verifiche nonché di tutti gli elementi che
denotano la formazione culturaledegli alunni quali autonomia nel lavoro scolastico ,
partecipazione,interesse ,impegni e progressi registrati in itinere. Al fine di ottenere una valutazione
numerica il più oggettiva possibile per le verifiche si è fatto riferimento alle griglie presenti nel P.O.F.
Livelli raggiunti dalla classe
Gli studenti hanno utilizzato al meglio il tempo scuola, mostrando interesse per gli argomenti proposti .
Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta è stata generalmente positiva anche se diversificata per lo studio
domestico e personali attitudini .
In Matematica la conoscenza globale dei contenuti e le competenze testuali non sono patrimonio di tutta la
classe : tutti gli studenti identificano i dati di un testo , metà riesce a elaborarli, un terzo è in grado di
rielaborarli in modo critico e personale così da coglierne le linee di raccordo..
DOCENTE
SIBILLO TOMMASINA

I.T.I.S. "GIULIO CESARE FALCO" - CAPUA (CE)
PROGRAMMA DI MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
V AMM a.s. 2015/ 2016
Proff. MONTUORI PIETRO e NATALE ANTONIO
MECCANICA
Consolidamento conoscenze pregresse
Ripetizione tipologia e generalità sui vincoli, soluzione travi isostatiche, sollecitazioni semplici, momenti
d’inerzia, moduli di resistenza, sollecitazioni composte, dimensionamento e verifica di un albero.
Meccanismo di biella e manovella
Generalità
Studio cinematica: Spostamento del piede di biella; Velocità del piede di biella; Accelerazione del piede di
biella.
Forze di inerzia: Forze d’inerzia alterne; Forza d’inerzia centrifuga.
Momento motore.
Dimensionamento biella.
Alberi a manovelle e volani
Manovelle.
Calcolo delle manovelle di estremità: Perno di manovella; Perno di banco; Verifica della sezione tangente al
mozzo del perno di biella; Verifica della sezione tangente al mozzo dell’albero.

Calcolo delle manovelle a gomito: Albero a gomito con due supporti; Albero a gomito con più supporti;
Alberi a gomiti per motori endotermici.
Cenni all’equilibramento degli alberi a gomiti: statico e dinamico delle masse rotanti; statico e dinamico
delle masse alterne.
Regimi periodici: Fluttuazione dell’energia; Calcolo della massa del volano; Dimensionamento del volano e
verifica della resistenza alla forza centrifuga.
Alberi, perni e cuscinetti
Calcolo degli assi.
Calcolo degli alberi soggetti a semplice torsione.
Calcolo degli alberi soggetti a torsione e flessione.
Velocità critica degli alberi: Oscillazioni flessionali; Oscillazioni torsionali.
Dimensionamento dei perni portanti d'estremità, intermedi. Dimensionamento dei perni di spinta.
Cuscinetti a strisciamento ed a rotolamento. Verifiche.
Trasmissione del moto, organi di collegamento, giunti ed innesti
Generalità, caratteristiche e tipologia delle ruote dentate. Dimensionamento di ruote dentate cilindriche a
denti dritti. Dimensionamento di un sistema di trasmissione a cinghie piane e trapezoidali.
Giunti rigidi ed elastici.
Organi di collegamento
Chiavette e linguette. Collegamenti bullonati.
Macchine di sollevamento
Classificazione.
Gru a ponte, a cavalletto ed a torre.
I principi della termodinamica
Breve ripetizione di: leggi dei gas perfetti, primo principio della termodinamica, diagramma pressione-
volume, trasformazioni isometriche, trasformazioni isobariche, trasformazioni isotermiche, trasformazioni
adiabatiche.
Cicli termodinamici

Ciclo Otto. Ciclo Diesel ideali ed indicati.
Motori a carburazione
Motori a quattro tempi.
Motori a due tempi.
La carburazione.
La distribuzione.
L’accensione.
Motori a combustione graduale
Motori diesel a quattro tempi.
Motori diesel a due tempi.
Distribuzione ed iniezione.
Diagrammi caratteristici motori a combustione interna.
Cittadinanza e Costituzione
Generalità sul Contratto Collettivo Nazionale
Capua 11 Maggio 2016 Prof. Prof.
Montuori Pietro Natale Antonio
____________________ ____________________
Gli allievi
______________________ _________________________
______________________ _________________________
______________________ _________________________

Istituto Tecnico Industriale Statale
"GIULIO CESARE FALCO" - CAPUA (CE) VIA G. C. FALCO - 81042 CAPUA (CE
RELAZI ONE FINALE
dei Proff.Pietro Montuorie Antonio Natale
Docenti di MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
nella classe V Sez. . AMC
Specializzazione MECCANICA E MECCATRONICA
ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016
1) Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte.
L’inizio delle lezioni è avvenuto in data 13.10.2015, giacché in
precedenza la cattedra non era stata assegnata.

La classe è composta di 12 alunni, di cui uno non frequentante, ed
è associata ad altri alunni appartenenti alla specializzazione Costruzioni
Aeronautiche. Il programma svolto ricalca quanto stabilito in sede di
programmazione didattica con la sola eccezione del modulo riguardante
le macchine di sollevamento e trasporto che è stato trattato solo
superficialmente per mancanza di tempo. In considerazione del basso
livello di conoscenze inizialmente riscontratoin quasi tutta la classe, sia
in meccanica che nelle discipline collegate, nella prima parte
dell’a.s.sono stati ripetuti dettagliatamente gli argomenti dei precedenti
anni. Per coinvolgere, inoltre, gli alunni meno motivati, si è cercato di
seguire delle linee di indirizzo didattico, funzionali e realistiche.
Nell’insegnamento della materia, pertanto, si è mirato anche a
semplificare i concetti e le conoscenze per permettere agli alunni con
maggiori carenze di affrontare con una migliore sicurezza gli
apprendimenti. Nonostante, però, le varie interruzioni delle attività
scolastiche dovute ai lavori di ripristino del fabbricato, ai vari incontri,
all’alternanza scuola lavoro ed alla consultazione elettorale, con la
collaborazione degli altri docenti si riusciti a raggiungere gli obiettivi
minimi programmati.
2) Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e giudizio sul rendimento di ciascuna classe.
Solo qualche alunno mostra un interesse ed un impegno nello
studio con raggiungimento di un livello di competenze, conoscenze e
capacità più che sufficiente, che in qualche caso trascina, anche se non
in modo continuo, l’intera classe. La parte della classe con minori
carenze di base riesce a mantenersi ad un livello accettabile come
rendimento scolastico, raggiungendo livelli di preparazione sufficienti.
Rimane una parte della classe con lacune nelle discipline di base, che ne
condiziona il rendimento, ma si è riusciti a recuperare in parte tali
lacune disciplinari ed a consolidare correttamente, anche se solo
parzialmente, le conoscenze pregresse mal assimilate ed interiorizzate,

raggiungendo livelli di conoscenza, competenza e capacità quasi
sufficienti. Il comportamento della classe è stato abbastanza corretto e
rispettoso.
3) Osservazione sui rapporti con le famiglie. Attività parascolastiche e uso dei sussidi didattici.
Gli atteggiamenti dei familiari degli allievi sono stati per la maggior
parte collaborativi, anche se vi sono casi in cui non è stato possibile
stabilire alcun rapporto. In generale, per l’esecuzione delle esercitazioni
si è usufruito nella prima parte dell’a.s. solo della LIM presente
nell’aula, non essendo disponibile il laboratorio di tecnologia meccanica
e di meccanica ubicati nel capannone. A partire dal mese di Febbraio,
con l’ultimazione dei lavori, è stato possibile cominciare ad usare le
attrezzature presenti nei laboratori.
4) Osservazioni sui programmi ed i libri di testo. Proposte relative.
Per ottenere una migliore comprensione ed un maggiore
coinvolgimento degli alunni Nel corso dell’a.s. sono stati utilizzati sliders
e filmati riguardanti gli argomenti trattati. Glii alunni sono stati spronati
all’uso del manuale del perito meccanico e delle calcolatrici.
Capua, 11.05.2016
I docenti
Prof. Montuori Prof. Natale
______________________ _______________________

TECNOLOGIE MECCANICHE, DI PROCESSO E DI PRODOTTO


MATERIA DISEGNO, PROG.
ED ORG. IND.
DOCENTI: Bruno de Rosa
Pasquale Tonziello
TESTO ADOTTATO Disegno, Prog. Organizzazione Industriale Tecniche CAM Vol.3
L. Caligaris S. Fava C. Tomasello Ed. Paravia
ALTRI STRUMENTI
DIDATTICI
FOTOCOPIE, APPUNTI, TABELLE
QUESTIONARI, MANUALE
STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE
Lezioni individualizzate
Lavori di gruppo
CONTENUTI
BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI
MODULO 1
TECNOLOGIE APPLICATE
ALLA
PRODUZIONE
Tempi e metodi nelle lavorazioni. Relazione di Taylor.
Macchine operatrici: scelta, potenza, tempi e parametri di taglio.
Utensili ed attrezzi: tornio, fresa, trapano, rettificatrice. Brocciatrice,
dentatrice.
MODULO 2
CICLI DI FABBRICAZIONE E
DI MONTAGGIO
Cicli di lavorazione: dal disegno di progettazione al disegno di
fabbricazione.
Criteri per impostare un ciclo di lavorazione: dal cartellino al foglio di
analisi.Esempi di cicli di lavorazione.

MODULLO 3
ATTREZZATURE DI
FABBRICAZIONE E
DI MONTAGGIO
Attrezzature: generalità. Elementi normalizzati componibili.
Progettazione di semplici attrezzature meccaniche.
MODULO 4
AZIENDA, FUNZIONI,
STRUTTURE, COSTI
E PROFITTI.
Evoluzione storica. Le funzioni aziendali. Strutture organizzative.
Contabilità nelle aziende. Costi di produzione.
Analisi Costi-Profitti. Centri di costo. Punto di equilibrio (BEP).
Margine di sicurezza.
MODULO 5
CONOSCENZA DEI
PROCESSI
PRODUTTIVI. COSTI E LAY-
OUT IMPIANTI
Prodotto: innovazione, progettazione e fabbricazione.
Piano di produzione. Tipi di produzione e processi. Costi preventivi.
Lotto economico di produzione.
Sicurezza e legislazione antinfortunistica.
MODULO 6
TECNICHE DI
PROGRAMMAZIONE
AFFIDABILITA' E
CONTROLLO DI QUALITA'
Ricerca operativa.Tecniche reticolari.
Programmazione in officina. Diagramma di Gantt
Esercitazioni in classe.
Magazzini e loro gestione: generalità
La qualità. Sistema di qualità. Affidabilità.
Attività laboratoriali di CAD col TOPSOLID.

STRATEGIE
DIDATTICHE
Lezione frontale
Lavori di gruppo e/o individuali
Esposizione libera, spontanea e guidata
VERIFICHE
TIPOLOGIA
VERIFICHE FRONTALI (colloqui individuali brevi e lunghi)
RELAZIONI ED ESERCITAZIONI SCRITTE
Capua, 12-05-2016
Gli insegnanti
de Rosa Bruno
Tonziello Pasquale
________________________
Gli alunni
__________________________________
_____________________________________

RELAZIONE FINALE di
DISEGNO PROG. ED ORG. IND.
nella classe VAMM Anno scolastico 2015/2016
L’ATTIVITA’ DIDATTICA
II programma svolto, pur con qualche rallentamento, ha di fatto realizzato nella
quasi sua interezza la programmazione definita ad inizio anno scolastico. Particolare
attenzione è stata dedicata a quegli argomenti del programma che riguardavano la
progettazione di dispositivi meccanici, icicli di lavorazione degli stessi, i tempi e i
costi di produzione con riferimento ai diversi metodi della organizzazione della
produzione. L’attenzione ed il coinvolgimento degli allievi sono stati sollecitati
attraverso diverse esercitazioni scritte, sia individuali che di gruppo che richiedevano
l’utilizzo del manuale.
Il programma nei contenuti si è sviluppato attraverso i moduli indicati.
MEZZI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE
Con domande da posto, colloqui alla lavagna ed esercitazioni e relazioni scritte;
partendo dalle esperienze culturali dei singoli studenti, è stato rilevato il grado di
conoscenza relativo alle problematiche della materia studiata nel triennio del corso di
studio.
LIVELLI RILEVATI
Da una prima indagine la classe, formata da 12 studenti , ha evidenziato un livello di
partenza disomogeneo, dipendente dall'impegno e dall'interesse per la materia
edalle diverse capacità di analisi e di sintesi: alcuni hanno mostrato, nei confronti
della disciplina, un atteggiamento non sempre in linea con le aspettative e le
potenzialità proprie conseguendo risultati appena sufficienti; qualcuno,
interessandosi ed impegnandosi nello studio è riuscito ad ottenere una discreta
preparazione; altri, pur con qualche difficoltà, hanno una conoscenza accettabile
dell'organizzazione della produzione.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
Le attività di recupero relative alla materia d’insegnamento, sono state effettuate in
itinere, soffermandosi, nel corso delle lezioni, sugli argomenti di scarsa conoscenza
favorendone l’interiorizzazione dei contenuti proposti e contribuendo a migliorare
interesse,attenzione e memorizzazione.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Gli interventi didattici sono stati innanzitutto finalizzati a creare nella classe un clima
di fiducia riguardo alla possibilità di riuscita e di successo, ciò anche attraverso
modalità relazionali e comportamentali rispettose delle esperienze degli studenti e
dei loro ritmi e stili di apprendimento. Gli argomenti sono stati presentati non come
un insieme di dati da apprendere e da ricordare, ma come un problema aperto a più
soluzioni tutte ipoteticamente valide, in questo modo essi sono stati sollecitati, dalla
problematicità dell’esposizione a porre domande a cui bisognava dare delle risposte
in termini scientifici. Sono stati sviluppati ed elaborati diversi disegni meccanici e
cartellini di cicli di lavorazione. Le lezioni frontali sono state di breve durata; sono
state privilegiate le attività di lavoro e di ricerca di gruppo come momento in cui si
impara facendo.
S T R U M E N T I D I L A V O R O
LIBRI DI TESTO.
TESTI TECNICI,MANUALI E FOTOCOPIE
V E R I F I C A E V A L U T A Z I O N E
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Sono stati effettuati frequenti controlli durante le ore di lezione per individualizzare
l’insegnamento e organizzare il recupero; al termine di ogni unità didattica o dopo lo
svolgimento di sue parti significative sono state effettuate verifiche periodiche

scritte e orali in modo da poter controllare lo svolgimento graduale del programma
e valutare in itinere il processo di insegnamento–apprendimento.
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA :
Per la valutazione sommativa, finale quadrimestrale,si sono utilizzate prove orali, e
prove scritte; la valutazione a fine periodo ha tenuto conto altresì dell’impegno e
partecipazione,dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza e del raggiungimento
dei livelli minimi disciplinari di conoscenza e competenza.
Capua, 12-05-2016
Gli insegnanti
de Rosa Bruno
Tonziello Pasquale

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
“Giulio Cesare Falco”
CAPUA
PROGRAMMA DI SISTEMI E AUTOMAZIONE
Anno Scolastico 2015 – 2016
Classe : 5AMMINDIRIZZOIN MECCANICA, MECCATRONCA ED ENERGIA
Docenti: Prof. CASABURO Luigi e Prof. D’ANIELLO Paolo
Disciplina: SISTEMI E AUTOMAZIONE
Trasduttori
Classificazione dei trasduttori – Parametri caratteristici dei trasduttori – Trasduttori attivi e passivi
– Trasduttori meccanici : a deformazione meccanica, elastica, termica – Estensimetro a filo –
Termocoppia – Potenziometro – Celle fotovoltaiche – Encoder.
Attuatori
Richiami sulla corrente continua e corrente alternata - Grandezze elettriche – Concetto di
rendimento – Attuatori termici –Attuatori per illuminazione: lampade ad incandescenza, lampade
alogene, lampade a scarica nei gas e nei vapori – Motori elettrici: motori a corrente continua,
Motore Brushless - Motore passo – passo – Attuatori pneumatici: lineari e rotanti.

Logica cablata
Elementi elettromeccanici: pulsanti N.A. e N.A., - Relè elettromagnetico monostabile e bistabile (
Principio di funzionamento) – Circuiti logici : circuito YES, NOT, AND, OR, Semplici circuiti
combinati – Circuito di autoritenuta.
Controllori a logica programmabile
Concetti introduttivi – Classificazione dei PLC – Architettura dei PLC – Unità centrale di processo
(CPU) – Funzionamento – Memorie – Periferiche – Alimentazione – Terminale di programmazione
– Acquisizione di ingressi - Comando di uscite – Sicurezza – Normativa.
Linguaggi di programmazione
Tipi di linguaggi i programmazione – Linguaggio a contatti (Ladder): elementi grafici, regole di
tracciamento – Semplici applicazioni di azionamenti elettromeccanici e pneumatici del linguaggio
ladder – Cenni sul linguaggio booleano e grafcet.
Fondamenti di robotica industriale
Concetti introduttivi – Schema a blocchi del robot – Concetto di robotica - Robotica industriale -
Anatomia del robot - Spazio di lavoro del robot – Meccanica del robot – Manipolatori – Gradi di
libertà - Sistemi di attuazione – Sistema sensoriale – Sistema di visione – Sistema di controllo –
Programmazione.

Cittadinanza e costituzione: sviluppo dell’automazione industriale.
Capua, 30/04/2016
GLI ALUNNI Docenti
Prof . Luigi CASABURO
____________________ _________________________
____________________
Prof . Paolo D’ANIELLO
____________________ _______________________

Classe 5AMM - MECCANICA E MECCATRONICA-a.s. 2015-2016
MATERIA: Sistemi e Automazione.
DOCENTI: Prof. Luigi CASABURO-
Prof. Paolo D’ANIELLO.
TESTO ADOTTATO P. GUIDI. : “SISTEMI E AUTOMAZIONE vol. 3”, Zanichelli.
ALTRI STRUMENTI
DIDATTICI
Appunti delle lezioni, altri testi, manuali, siti internet, LIM.
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3
VALUTAZIONI : Verifiche scritte, orali e pratiche
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE
CONTENUTI
ARGOMENTI
.
Trasduttori- Attuatori- Logica cablata- Controlli a logica programmabile- Linguaggi di
programmazione- Fondamenti di robotica industriale-Cittadinanza e costituzione
STRATEGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali

Lavori di gruppo
Ricerche
Esercitazioni
VERIFICHE
TIPOLOGIA
OBIETTIVI
Prove scritte
Verificare il grado di interesse e di conoscenza dei
contenuti svolti, delle competenze e capacità degli
studenti.
Esercitazioni
Prove orali

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G.C. FALCO”
Capua (CE)
Relazione finale di SISTEMI E AUTOMAZIONE
Anno scolastico 2015/2016
Classe: 5AMM - Meccanica e Meccatronica
Docenti: Prof. Luigi CASABURO - Prof. Paolo D’ANIELLO.
Livello iniziale degli allievi:La classe inizialmente è composta da 12 alunni di cui uno non
frequentante. Il livello culturale presenta un numero limitato di alunni con buon livello di
preparazione e un buon numero di alunni con una preparazione sufficiente; infine alcuni alunni
denotano un livello di apprendimento quasi sufficiente purmostrando impegno e partecipazione
alle attività svolte.
Cenni sul programma svolto, criteri adottati e interdisciplinarità: Il programma svolto in rapporto
alle ore di lezione a disposizione ed effettivamente praticate ed al fatto che, talvolta, è stato
opportuno soffermarsi più del previsto su taluni argomenti, ha rispecchiato di massima quello
preventivato.
Il programma svolto è stato diviso in moduli o aree di intervento con particolare attenzione per le
applicazioni pratiche.
Nello svolgere il programma lo scrivente ha dovuto spesso integrare e richiamare concetti, in
termini elementari, di altre materie e ciò specialmente dal punto di vista applicativo.
Andamento disciplinare delle classe con indicazione degli episodi più salienti: Il comportamento
della classe è stato per lo più corretto ed improntato alla buona etica scolastica.
Risultati ottenuti: I risultati ottenuti possono essere sufficienti per la maggior parte della classe,
più che sufficienti per un numero limitato di studenti.
Capua lì, 30 aprile 2016 I Docenti :
Prof. Luigi CASABURO ………………………..
Prof. Paolo D’ANIELLO ………………………....

CLASSE Quinta Sezione A Meccanica
MATERIA RELIGIONE DOCENTE Prof. ssa Crispino Andreana
Obiettivi raggiunti
- Gli studenti sono in grado di conoscere, nelle sue linee
essenziali, la proposta cristiana sul destino dell’uomo; - Conoscono, in termini culturali e non di fede, la funzione della
Chiesa di annunciare al mondo contemporaneo secolarizzato, Gesù Cristo, modello di vera umanità;
- La fede e ragione non sono necessariamente in contrasto nel dare risposte alle domande esistenziali.
- Sono consapevoli delle implicazioni sociali e politiche della religione cattolica, soprattutto in riferimento al tema dei diritti umani, della giustizia sociale tra nord e sud del mondo.
Mezzi e strumenti
Libro di testo: Flavio Pajer, RELIGIONE, Edizioni SEI Fotocopie
Strumenti di verifica
- Esercitazioni - Interventi spontanei - Discussione in Classe
PROGRAMMA DI RELIGIONE IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE Scienza e fede, sorelle o nemiche? La scienza si emancipa dalla tutela della Religione Verso la riconciliazione tra scienza e fede Il miracolo: una sfida alla scienza? L’Universo è antropocentrico. La sfida delle biotecnologie.
LA GIUSTIZIA SOCIALE A tutti gli uomini spetta il necessario per vivere: le ingiustizie più intollerabili nel mondo La Dottrina Sociale della Chiesa: Che cosa è. Quando è nata la Dottrina Sociale della Chiesa. Le principali tappe della Dottrina Sociale della Chiesa. I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa Il soggetto della Dottrina Sociale della Chiesa.
LA RELIGIONE CATTOLICA Il piano della creazione Il piano della redenzione

IL DIO CRISTIANO L’equazione Dio=Amore La rivelazione di Gesù Cristo: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo La comunione trinitaria “Che cosa fa” il Dio cristiano: ama La creazione come atto di amore La redenzione supremo gesto d’amore
Gli alunni La docente

RELAZIONE FINALE
del Prof.ssa Andreana Crispino
docente di RELIGIONE
Gli allievi che costituiscono la V AM sono 11. Hanno partecipato alle lezioni di religione, in maniera regolare. Tutti hanno conseguito gli obiettivi formativi e curriculari prestabiliti in fase di programmazione iniziale, pur se il livello di attenzione e di comprensione è risultato diversificato, come pure le capacità, l'attitudine e il grado di consapevolezza.. Il rapporto docente-discente è stato in ogni modo accettabile e continuamente arricchito dal contributo di esperienze e di proposte formulate da alcuni discenti. L'interscambio curriculare e didattico con l'insieme del gruppo classe, durante il decorso dell'anno scolastico, ha evidenziato anche stimoli culturali ed esperienziali. In ogni fase del lavoro di classe si sono tenuti sempre in debita considerazione l'importanza delle dinamiche relazionali e comportamentali, sia tra i singoli allievi che tra essi e il docente, in modo che fossero sempre vissute in piena coscienza e conoscenza, in tutta la sua vasta gamma di sfumature, le implicazioni umane, esistenziali e sociali. Tutte le volte che si è presentata l’occasione, non si è mancato di evidenziare come vadano perseguite le proprie peculiarità senza rinunciare alla solidarietà e come l'interesse individuale non vada conseguito a scapito delle attese e delle aspettative degli altri, intesi singolarmente e nella totalità del gruppo comunitario. Ogni discussione, curriculare e formativa, è stata impostata con particolare attenzione al vissuto antropologico.
Prof.ssa Andreana Crispino

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Classe : 5 AMC
MODULO 1: SPORT DI SQUADRA ED INDIVIDUALI
1. PALLAVOLO
2. TENNIS TAVOLO
3. CALCIO A 5
4 . L’ATLETICA LEGGERA teoria (LE CORSE, LA STAFFETTA)
OBIETTIVI: CONOSCERE
La struttura del campo di gioco
I regolamenti di gioco
I fondamentali individuali
I ruoli dei giocatori
II principali schemi di gioco
ESSERE CAPACE DI
Utilizzare i fondamentali individuali in funzione della situazione di gioco
Inserirsi negli schemi di gioco della squadra in base alla strategia adottata
Ricevere e passare la palla
Occupare la posizione in campo a seconda del ruolo ricoperto
Verificare il proprio livello di esecuzione di alcuni individuali fondamentali
Individuare e applicare i vari schemi di gioco in tempi brevi
MODULO2 EDUCAZIONE E TUTELA DELLA SALUTE
1 .I benefici del movimento 2. I comportamenti di base 3. Igiene e sport OBIETTIVI:
CONOSCERE
Come lo sport contribuisce alla salute dell’individuo Conoscere igiene personale e igiene alimentare
MODULO 3 : TRAUMA, PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE
1. Che cos’è un trauma
2. Il primo soccorso
3. Le situazioni di emergenza
OBIETTIVI:
CONOSCERE
le fondamentali regole del primo soccorso
le principali situazioni di emergenza e le cause che le determinano
i traumi da incidenti domestici e i relativi interventi di primo soccorso
ESSERE CAPACE DI
prestare il primo soccorso in attesa dell’intervento medico
verificare la presenza dell’attività respiratoria e circolatoria
riconoscere una situazione d’emergenza

MODULO 4 : TRAUMATOLOGIA SPORTIVA
Anatomia e fisiologia del corpo umano:
1. LE LESIONE OSSEE
2. LE LESIONI MUSCOLARI
3. LE LESIONI ARTICOLARI
4. LE LESIONI DEI TEGUMENTI
5 . L’APPARATO RESPIRATORIO
OBIETTIVI:
CONOSCERE
La definizione di traumatologia sportiva
La classificazione dei traumi sportivi
Gli interventi di primo soccorso
I due momenti fondamentali della respirazione(Inspirazione, Espirazione)
ESSERE CAPACE DI
Classificare i traumi sportivi in relazione alla parte lesa
Distinguere le lesioni ossee, muscolari, tendinee e articolari e tegumentarie
Intervenire con tecniche adeguate in attesa dell’intervento medico
Individuare la terapia più adeguata
MODULO5: LA DIPENDENZA : FUMO ,ALCOL , DROGA E DOPING 1. IL FUMO E I SUOI EFFETTI. IL FUMO PASSIVO.
2 L’ALCOL E I SUOI EFFETTI.
3. LE DROGHE E I SUOI EFFETTI.
4 IL DOPING E LE SOSTANZE VIETATE.
5 LE OLIMPIADI.
OBIETTIVI:
CONOSCERE
Le caratteristiche delle sostanze che creano dipendenza
Le sostanze e i metodi vietati
Le principali sostanze assunte nel doping
I giochi olimpici nell’antichità e dell’era moderna.
ESSERE CAPACE DI
Individuare gli effetti prodotti dalle sostanze che provocano dipendenza
Riconoscere le sostanze d’abuso legali e non
Riconoscere le sostanze che inducono assuefazione e dipendenza
GLI ALUNNI LA DOCENTE
_____________________ Maddalena Merola
____________________
____________________

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016
Classe : 5 AMC
L’anno scolastico ha presentato un andamento regolare, consentendo, pertanto al gruppo
classe una partecipazione generalmente attiva e produttiva alle attività didattiche.
Nel fare il bilancio del lavoro svolto, posso considerare che gli allievi, presentandosi con un
normale complesso di caratteristiche morfologiche, funzionali e psicomotorie, mi hanno consentito
di sviluppare la programmazione iniziale ed hanno raggiunto, comunque, un livello di preparazione
teorico-pratico, in generale, discreto.
La classe composta da n. 28 alunni, ha seguito con interesse ed attenzione le attività proposte
durante l’anno scolastico. Si è data particolare attenzione:
all’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e
sportive, di espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità
equilibrata e stabile,
al consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come
capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi
pluridisciplinari;
al raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso
l’affinamento della capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuro-muscolari;
all’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio
anche alle attitudini e propensioni personali, favorisca l’acquisizione di capacità trasferibili
all’esterno della scuola;
all’arricchimento culturale attraverso lo studio di argomenti che trovano riscontro concreto
nel periodo evolutivo degli alunni, per fornire agli stessi le conoscenze adeguate per
affrontare i problemi legati alla devianza giovanile e a quelli che possono incorrere nella
pratica dello sport.
Le finalità indicate, coerenti con quelle generali della scuola, definiscono l’ambito operativo
specifico dell’educazione motoria.. Il ruolo prioritario è stato dato all’acquisizione del valore
della corporeità che, punto nodale dell’intervento educativo, è fattore unificante della persona e
quindi di aiuto al superamento dei disagi tipici dell’età giovanile che possono produrre
comportamenti devianti. Inoltre si è mirato a rendere la persona capace in modo consapevole di
affrontare, analizzare e controllare situazioni problematiche personali e sociali; di utilizzare
pienamente le proprie qualità fisiche e neuro-muscolari; di raggiungere una plasticità neuronale
che consenta di trasferire in situazioni diverse le capacità acquisite, determinando le condizioni
per una migliore qualità della vita.
L’insegnamento di Scienze Motorie e Sportive, inoltre, ha guidato lo studente a comprendere il
ruolo del corpo in ambito sociale, per riconoscerne la valenza sia a livello personale sia a livello
comunicativo come avviene in campo sportivo e nel linguaggio del corpo.
Le caratteristiche, dunque, delle finalità e degli obiettivi hanno richiesto una metodologia basata
sull’organizzazione di attività “in situazione”, sulla continua indagine e sull’individuazione ed
autonoma correzione dell’errore. Tale metodologia ha consentito di creare i presupposti della
plasticità neuronale e della trasferibilità delle abilità e competenze acquisite ad altre situazioni
ed ambiti. Conseguentemente, ciascuna attività ha tenuto conto, nella sua organizzazione e
realizzazione, della necessità di dare spazio ad una serie di varianti operative e al contributo
creativo e di elaborazione che ciascuno degli studenti può apportare.

Al fine di far conseguire agli studenti la capacità di organizzare progetti autonomi, utilizzabili
anche dopo la conclusione degli studi secondari, sono state utilizzate opportune forme di
coinvolgimento attivo dello stesso nelle varie fasi dell’organizzazione dell’attività dalla
progettazione alla realizzazione dei percorsi operativi e metodologici da adottare.
La valutazione dello studente ha consentito di apprezzare sia la capacità esecutiva delle varie
attività sia la conoscenza teorica e scientifica della disciplina e dei processi metodologici
utilizzati. La tipologia delle prove utilizzate si è realizzata in lezioni frontali, ricerche mirate,
relazioni di approfondimento e strumenti multimediali per quanto riguarda la parte teorica. In
esercitazioni pratiche, propedeutici ai giochi di squadra e alle attività individuali, simulazione di
partite per quanto riguarda la parte attiva e pratica delle proposte disciplinari.
LA DOCENTE
PROF.SSA Maddalena Merola