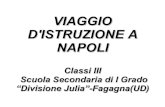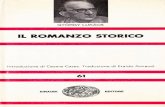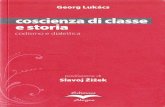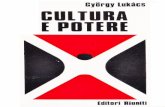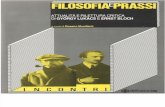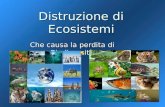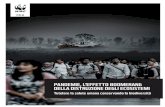Distruzione Della Ragione - Lukacs
-
Upload
magallanico -
Category
Documents
-
view
65 -
download
9
description
Transcript of Distruzione Della Ragione - Lukacs

La distruzione della ragione, Gyorgy Lukacs (1954)
1. Tappe storiche fondamentali della Germania (dal XVI secolo al 1933)- 31 ottobre 1517: Martin Lutero appende le 95 tesi alla Chiesa di Wittenberg- primavera 1525: rivolta dei contadini guidati da T. Müntzer repressa- 25 settembre 1555: pace di Augusta, cuius regio eius religio- 1806: Napoleone sconfigge esercito prusso a Jena; nasce la confederazione del Reno; il
Sacro Romano impero si scioglie (fine I Reich)- 1815: congresso di Vienna: riva est del Reno organizzata in confederazione composta da 39
formazioni politiche sotto controllo della Prussia e dell’Impero d’Austria- giugno-luglio 1866: la Prussia guidata da Bismarck sconfigge l’esercito austriaco; gli stati
tedeschi della confederazione vengono annessi al regno- 18 gennaio 1871: Bismarck proclama il II Reich tedesco con Kaiser Guglielmo I di Prussia,
inizio imperialismo- 6 febbraio 1919: prima assemblea nazionale a Weimar della Repubblica democratica
tedesca (Weimarer Republik)- 24 ottobre 1929: crollo della borsa di Wall-street; crisi economica che colpisce duramente
la Germania- 30 gennaio 1933: Hindenburg nomina Hitler cancelliere (inizio III Reich)- 28 febbraio 1933: incendio del parlamento diventa il pretesto per Hitler per sciogliere la
camera e liberarsi degli oppositori politici
2. Cause storiche dell’avvento del nazionalsocialismoLukacs nel capitolo sulle “Caratteristiche dell’evoluzione tedesca” ricerca sia le cause remote
del Nazismo, legate allo sviluppo economico sociale della Germania a partire dal XVI secolofino al XX, sia le cause prossime rintracciabili nel decennio che precede l’ascesa di Hitler.
Cause remote:• Arretratezza economica della Germania - “Il destino, la tragedia del popolo tedesco
consiste nel ritardo con cui esso è giunto allo sviluppo borghese moderno”. Proprio mentrenegli altri stati europei si sviluppava un’economia capitalista (XVI secolo) e unaccentramento politico del potere, gli staterelli della Germania mantenneroun’organizzazione economica ancora radicalmente feudale e medievale fino alla secondametà dell'Ottocento.
• Frammentazione politica della Germania - Parallela (e non sconnessa) all’aratretezzaeconomica fu la frammentazione politica in vari stati durata fino al 1866. Essa impedì unarivoluzione e un’educazione democratica come vi fu negli altri paesi. La “nazione tedesca"rimase un concetto meramente ideale romantico che specialmente dopo l’arrivo diNapoleone risvegliò negli intellettuali germanici sentimenti nazionalisti: odio antifrancesee identità nazionale basata sull’appartenenza di sangue.
• Mentalità religiosa luterana - Può aver contribuito alla mancata rivoluzione sociale tedescala Weltanschauung del luteranesimo che Lukacs definisce “psicologia del suddito": la ciecaobbedienza alla volontà di Dio può potenzialmente tradursi a livello esteriore ad una totalesubordinazione alla volontà del sovrano. Basta pensare alla massima del tipico funzionariotedesco: “attuare in modo tecnicamente perfetto le scelte imposte dall’autorità statale”.
• Modalità dell’unificazione della Germania - Nel 1866 gli stati ad est del Reno furonoconquistati dal regno di Prussia; questo era in quel momento guidato dal primo ministro

Von Bismarck, esponente dell’estrema destra conservatrice, antidemocratico, antiborghesee animato da un forte senso della nazione. L’intera Germania subì così l’influenza di talementalità militare e nazionalista prussiana.
• Borghesia incapace di agire - Quando nella seconda metà dell’800 dopo l’unificazioneprussiana si formò una classe borghese, questa non ebbe la capacità di agire e riformare irapporti di potere; fu sempre vinta dalla maggioranza conservatrice.
Cause prossime:➢ Fallimento repubblica di Weimar - La repubblica democratica tedesca fallì principalmente
per due motivi: (1) perchè fu una democrazia ”imposta” a causa della sconfitta del paesenella Grande Guerra: mancava la partecipazione necessaria dei cittadini per uno statodemocratico, ero “uno stato democratico senza democratici”; (2) per vari motivi larepubblica non riusciva a dare ai propri cittadini uno stato di benessere sufficiente.
➢ Fallimento lotte socialiste - Lukacs sottolinea anche il fatto che molti operai tedeschi(generalmente marxisti o socialisti), delusi dalle mancate riforme sociali nel paese, silasciarono trascinare dalle correnti nazionaliste.
➢ Contraddizioni evidenti del capitalismo - La crisi del 1929, gli innumerevoli disordinisociali in Germania, furono le più evidenti prove che il sistema capitalistico modernoborghese non poteva in alcun modo autosostenersi e garantire le sue promesse di benesseree uguaglianza.
➢ Disperazione del popolo - Lo stato di totale disperazione del popolo tedesco dagli anni ‘20al ‘33 generò una sorta di “attesa di miracoli”, un attesa di un salvatore della patria chefavorì la credenza in Hitler come rimedio a tutti i mali dello stato.
3. Metodologia e tesi fondamentali• Metodo filosofico storicista: “Una delle tesi fondamentali di questo libro è che non c’è
nessuna Weltanschauung innocente [...] l’assumere posizione a favore della ragione oppurecontro di essa decide al tempo stesso dell’essenza di una filosofia come filosofia, della suafunzione nello sviluppo sociale. Questo già per il fatto che la ragione stessa non può esserequalcosa di neutrale che se ne stia, senza prender partito, al di sopra dell’evoluzionesociale, ma rispecchia sempre, e conduce al concetto, la razionalità concreta (ol’irrazionalità) di una situazione sociale, di una direzione di sviluppo; e con ciò la favorisceo la ostacola”. L’opera di Lukacs si muove secondo il principio della forte interdipendenzatra teoresi filosofica e prassi sociale: un certo pensiero è sempre figlio e specchiodell’ordine economico sociale in cui è prodotto. Tuttavia la filosofia non assume il ruolo dimera sovrastruttura, bensì essa può avere un ruolo attivo: una posizione filosofia puòfungere sì da ideologia mascherando, legittimando o addirittura peggiorando il proprioordine sociale con le sue contraddizioni; ma allo stesso tempo ha anche la possibilità diopporsi, non senza fatica, all’ordine sociale vigente promuovendo un modo di pensarediverso da quello dominante nel proprio tempo. Il metodo lukacsiano cerca quindi non solodi analizzare le varie dottrine filosofiche irrazionaliste, ma di vedere come tali dottrinepotenzialmente possano esserso tramutate in azioni all’interno della società germanica,indipendentemente dall’intenzionalità degli autori (pensiero tradotto in prassi). Si rifiutal’idea di uno sviluppo “immanente” delle idee filosofiche: c’è sempre un camminoparallelo tra sviluppo economico-sociale e sviluppo filosofico.
• L’irrazionalismo filosofico ha favorito l’avvento del Nazionalsocialismo - la tesi principale

dell’autore è che quelle posizione filosofiche germaniche che a partire dal Romanticismo sisono opposte (hanno “reagito”) con tutte le loro forze alla ragione illuministica prima e aquella “socialista” dopo (post 1848), hanno contribuito a risvegliare nella popolazionetedesca sentimenti nazionalistici e regressivi. Così facendo l’irrazionalismo ha primaaccelerato la venuta di un “Reich” autoritario e razzista, per poi fungere da ideologia per ilNazismo stesso. L’ascesa di quest’ultimo non può essere stato un evento accidentale bensìun fenomeno storicamente e filosoficamente “preparato” da lungo tempo.
4. Caratteristiche dell’irrazionalismoL’irrazionalismo è quel filone di pensiero reazionario borghese caratterizzato principalmente
dalla tendenza a deoggettivare la ragione, sia essa storica, gneoseologica o metafisica. Ilfilosofo irrazionalista, nel momento in cui coglie le contraddizioni della conoscenza categorialeintellettiva, si rifiuta (più o meno consapevolmente) di elaborare una meta-razionalità hegelianain nome di una presunta forma di conoscenza assoluta a carattere intuitivo o mitologico. In altreparole, l'irrazionalismo, invece di cercare di sviluppare una logica dialettica che sopperisca alleaporie della razionalità formale, taglia direttamente la corda rifiugiandosi o in un sempliceagnosticismo, o in una filosofia completamente a-logica (al di fuori della razionalità).
Per l’autore, le prime tracce di tale tendenza si riscontrano negli intellettuali tedeschi che sioppongono alla ragione illuminista, alla rivoluzione francese e al concetto storico di progresso(Schopenhauer, Schelling, Kierkegaard). Dopo i moti del 1848, la nascita del socialismo, losviluppo delle idee di Feuerbach, Marx e Engels, l’irrazionalismo filosofico comincia asviluppare idee tendenzialmente antisocialiste, contro il materialismo storico e le analisidialettiche della società (Nietzsche, la filosofia della vita, Heidegger).
Sebbene ogni filosofo irrazionalista mantenga una certa peculiarità di pensiero e svolga la suaattività sempre in un contesto storico-sociale differente, tuttavia è interessante riassumereschematicamente le caratteristiche filosofiche che accomunano tali pensatori:➢ gneoseologia aristocratica: “la conoscenza della realtà ultima del mondo non può avvenire
attraverso ragionamenti trasparenti e universali ma attraverso intuizioni non comuni o attiinteriori di fede”
➢ soggettivizzazione della storia: “la storia non ha leggi razionali che la governano”➢ pessimismo antropologico: “le contraddizioni del proprio contesto economico-sociale sono
intrinseche all’inevitabile debolezza della natura umana”Un’ultima caratteristica dell’irrazionalismo, molto cara a Lukacs, è l’idea di apologetica
indiretta: essa “mette in rilievo senza riguardo i lati cattivi e gli orrori del capitalismo, maafferma che essi non sono proprietà specifiche del capitalismo, ma della vita umana,dell’esistenza in generale”. Per apologetica l’autore intende un’esaltazione e legittimazione delsistema capitalistico; tuttavia, nei filosofi irrazionalisti, apparentemente anticapitalisti, essa èindiretta poichè legittimano il sistema economico-sociale vigente considerandolo come l’unicopossibile in quanto le sue contraddizioni fanno parte della realtà stessa o dell’esistenza umanain quanto tale. La tendenza dell’irrazionalista a negare la realtà, a negare la storia si trasformacosì a livello sociale in una sua incondizionata e subdola affermazione.
5. Principali filosofie “irrazionaliste”➔ Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) - Il giovane Schelling, interessato alla
filosofia della natura e autore del “Sistema dell’idealismo trascendentale” (1800), èconsiderato da Lukacs il primo filosofo irrazionalista. Egli ha sotto gli occhi sia le

contraddizioni pratiche della ragione illuminista (esiti della rivoluzione francese), sia leantinomie filosofiche del razionalismo kantiano (natura meccanicistica di “Critica dellaragion pura”). Pertanto tenta di elaborare un sistema di pensiero fondato sull’intuizioneintellettuale, per principio opposta al concetto razionale, considerato necessariamenteantinomico. L’obiettivo era quello di riuscire a pensare una natura viva, panteistica, dallaquale l’uomo ha origine. In sintonia con i Romantici, l’arte è per il giovane Schellingl’organo della filosofia, l’intuizione estetica l’oggettivarsi del pensiero creatore. Tuttavia, ilpasso decisivo verso l’irrazionalismo avviene nella maturità con la pubblicazione di“Filosofia e religione” (1804): da interessi naturalistici l’autore comincia a porre al centrodel suo pensiero il mito, la religione e la conoscenza mistica di Dio. Schelling avvia perciòquella tendenza reazionaria a negare il progresso storico, negare l’oggettività dellaconoscenza razionale in nome di una mitizzazione della realtà e di un’esaltazione delsentimento, dell’esistenza, della rivelazione divina.
➔ Arthur Schopenhauer (1788-1860) - Quando Schopenhauer pubblica la sua principale opera“Il mondo come volontà e rappresentazione” (1818), la sua filosofia è tenuta ai margini daquella hegeliana. Dopo il 1848 il suo pensiero diventa a livello internazionale la guida perla borghesia d’èlite “ribelle” o presunta tale. L’idea di una conoscenza scientificapuramente fenomenica e illusoria fondata su una volontà nounomenica irrazionale edistruttiva è assai attraente per quel tipo di classe sociale; innanzitutto perchè sembraspiegare esaurientemente le contraddizioni sociali di quel periodo, e poi perchè conferisceuna presunta libertà dal mondo ad attività tipicamente borghesi come l’arte contemplativa el’ascesi. Così facendo Schopenhauer maschera le contraddizioni del capitalismoriconducendole ad una volontà trascendente e nello stesso tempo esula i suoi lettori daqualsiasi impegno civile o sociale volto a cambiare l’ordine attualmente vigente. Lafilosofia di Schopenhauer quindi, oltre ad avere elementi di mitizzazione esoggettivizzazione della realtà e del divenire storico tipici dell’irrazionalismo, dà inizio allatendenza borghese dell’apologetica indiretta (vedi §4).
➔ Soren Kierkegaard (1813-1855) - Il pensiero kierkegaardiano muove dalla critica alladialettica quantitativa di Hegel, nella quale la coscienza finita si risolve e viene assorbitadal movimento infinito della ragione, del pensiero logico. A ciò Kierkegaard oppone unadialettica qualitativa (o dialettica dell’esistenza): ogni azione della coscienza finita èrottura nei confronti del movimento infinito della storia; anche colui che formula unsistema di pensiero razionale e universale non può non farlo dalla posizione relativa eindividuale dell’esistenza: anche il pensare è un atto esistenziale. Tuttavia, ogni singoloatto ha la sua dignità, l’interiorità dell’individuo (specialmente se cristiano) ha la flebilepossibilità di non lasciarsi trascinare dal destino perseguendo una verità concreta (esistenzaautentica) fatta di singoli gesti di opposizione ad esso. Sebbene questa possa apparire unaposizione filosoficamente ragionevole, Kierkegaard, in alcuni suoi passi, mostra una certatendenza, irrazionalistica, a considerare la storia come un destino immutabile guidatodall’imperscrutabile volontà di Dio. Inoltre, la sua etica religiosa, a-logica, interiore rischiadi diventare l’etica del borghese che ritirandosi in se stesso abbandona il campo dei doverisociali. Infine, anche l’idea di una “verità esistenziale” più autentica di quella razionalecostituisce un’irrazionalistica soggettivizzazione della realtà.
➔ Friedrich Nietzsche (1844-1900) – Nietzsche è considerato da Lukacs il fondatoredell'irrazionalismo nell'età dell'imperialismo tedesco, nonchè l'ideologo della borghesiadecadente. Con la nascita di nuovi movimenti socialisti nella seconda metà dell'Ottocento,

la borghesia capitalista ha un nuovo nemico sul terreno intellettuale: il materialismo storicoe il metodo dialettico. Gran parte del pensiero nietzscheano si dichiara in apertaopposizione al socialismo e alla democrazia. Rispetto a tali tendenze, Nietzsche si dimostraestremamente reazionario, contrapponendo ad esse una teoria della razza che esalti la“bestia bionda germanica”, che a differenza dei valori “da schiavi” di uguaglianza,fraternità e libertà, sia detenitrice di valori “aristocratici” basati sulla forza fisica e sullacapacità di imporsi violentemente sugli altri (“Genealogia della morale” 1888). La suaconcezione della storia come eterno ritorno, le sue prese di posizioni contro le veritàscientifiche e razionali in nome dell'arte e del mito, arricchischino il pensiero conservatoredi Nietzsche di altri elementi chiaramente irrazionalisti. In particolare per Lukacs, lafilosofia nietzscheana si presta facilmente all'ateismo religioso, cioè quella tendenza dellaborghesia con la crisi delle religioni rivelate a trasferire la loro adorazione religiosa ad altreforme mitiche con l'illusione di avere un atteggiamento indipendente e anticonformista.Tale modo di pensare, come quello di Schopenhauer, risulta estremamente efficace per ilpubblico borghese d'èlite: rende consapevole la borghesia del loro momento di decadenza,la rende partecipe di una sua superiorità spirituale rispetto al “gregge” delle masse e lefornisce una presunta via d'uscita dallo stato di depressione in cui si trova, proponendo unapseudo rivoluzione intellettuale, artistica; ovviamente tale rivoluzione non potrà mai avereun carattere sociale ma esclusivamente riservato ai più nobili d'animo. Tutto ciò scritto inuno stile accattivante ed esteticamente valido.
➔ La filosofia della vita – con tale denominazione, Lukacs intende denotare “l'ideologia[irrazionalista] dominante in Germania durante tutto il periodo imperialistico”. Essa ha lafunzione di mascherare le grandi contraddizioni sociali di quell'epoca e combattere ilsocialismo. Da un punto di vista filosofico, la filosofia della vita cerca di rivendicarecontrariamente al positivismo e ai nuovi sviluppi della scienza contemporaneal'indipendenza della vita (comprese le sue declinazioni in anima, esistenza o coscienza) daqualsiasi razionalizzazione. La dimensione della Leben ha la pretesa di imporsi come realtàassoluta: soggettiva perchè vi partecipano attivamente tutti i singoli soggetti individuali,oggettiva in quanto legislatrice della realtà stessa; materiale e ideale allo stesso tempo. Daciò consegue un sostanziale scetticismo nei confronti della razionalità della conoscenza eduna mitizzazione della realtà: la presunta “terza via” tra idealismo e materialismo collassain un idealismo dogmatico. Sotto la categoria di Lebensphilosophie, l'autore include, più omeno giustificatamente, una serie di pensatori assai differenti fra loro: Wilhelm Dilthey(1833-1911), principale esponente della filosofia della vita e sostenitore di una storiafondata sulla psicologia, Georg Simmel (1858-1918), il quale traspone problemieconomico-sociali del capitalismo su un piano esistenziale e religioso, Oswald Spengler(1880-1936), apertamente contro qualsiasi tipo di scientificità naturale e storica, MaxScheler (1874-1928), fenomenologo allievo di Husserl che tenta di conciliare logicaformale e coscienza, Karl Jaspers (1883-1969), psichiatra ed esistenzialista, MartinHeidegger (1889-1976).
6. Heidegger e l'irrazionalismoL'opera che Lukacs prende in considerazione per criticare il pensiero heideggeriano è “Essere
e tempo”, pubblicata nel 1927. In questi anni (periodo della Repubblica di Weimar) laGermania si trova in una profonda crisi sociale: le contraddizioni del capitalismo sono sotto gliocchi di tutti; l'intellettuale borghese, sentendosi continuamente minacciato dai disordini sociali,

si trova in uno stato di depressione e angoscia.La Lebensphilosophie, durante l'imperialismo dominante, entra così in crisi poichè viene a
mancare per la borghesia quella sicurezza e stabilità sociale che le permetteva di“abbandonarsi“ alla dinamica dimensione della vita. Il concetto heideggeriano di Dasein(“esserci”, esistenza), rispetto a quello “fluttuante” di vita, rimarca maggiormente lo stare quied ora, ossia l'identità di un soggetto ampiamente travolto dal divenire accidentale del mondo.
La dimensione dell'esistenza all'interno della teoria heideggeriana rappresenta una “terza viafilosofica” rispetto ai dualismi fenomeno/noumeno e soggetto/oggetto: è una dimensionetemporale “del qui e dell'ora” ma allo stesso tempo è la dimensione dell'essere, delle cose in sè;è soggettiva poichè costituita dai singoli soggetti, ma anche oggettiva in quanto per certi aspettinon sottomettibile alla volontà di questi. Il soggetto esistente, il Dasein, è un ente gettato nelmondo, non è uno spettatore del mondo; tuttavia ha in sè la possibilità di farsi carico dei proprilimiti e diventare padrone del proprio destino attraverso le singole autentiche scelte.Quest'ultimo aspetto progettuale dell'esistenza scaturisce da quella visione anticipatrice dellamorte che porta l'individuo in uno stato d'animo di kierkegaardiana angoscia.
L'ontologia esistenziale di Heidegger diventà perciò l'ideologia dominante dell'individuoborghese che, angosciato di fronte al divenire accidentale di una società caotica e disordinata,ritrova la propria identità pura, senza fare niente per cambiare le strutture economiche dellasocietà che tale caos generano. Tutto ciò è testimoniato da una serie di elementi irrazionalistiche Lukacs individua nel pensiero di Heidegger:
➢ Costruttivismo ontologico: “l'essere è soltanto nell'intendere [verstehen] dell'ente, al cuiessere appartiene qualcosa come la comprensione dell'essere”. Le cose sono ciò chesono in virtù di un soggetto che comprendendole le costituisce.
➢ Tendenza al soggettivismo: sebbene Heidegger tenti di perseguire la “terza viafilosofica”, nel momento in cui il dualismo reale/non reale è sostituito daautentico/inautentico e, nel momento in cui la dimensione più autentica della realtà ècostituita da categorie emotive del soggetto come l'angoscia, la gettatezza, la visionedella morte, la scelta, il suo pensiero collassa nel soggettivismo o nell'idealismo.
➢ Deoggettivazione della ragione: la polemica di Heidegger contro il tecnicismo dellascienze matematiche lo porta sotto certi aspetti a negare l'oggettività dei loro risultati.
➢ Apologetica indiretta: se il mondo sociale, considerato dal filosofo come il mondoquotidiano del “Man”, è necessariamente inautentico data la sua dimensione collettiva,ciò esula l'individuo da qualsiasi progettualità sociale.
➢ Soggettivizzazione della storia: “il luogo dei problemi della storia non va cercatonell'indagine scientifica [Historie] sulla storia […] L'essere propriamente per la morte,cioè il carattere finito della temporalità, è il fondamento riposto della storicità dell'esseredeterminato”; il senso della storia risiede nell'interiorità del soggetto, nella suapercezione della morte.
➢ Etica individualistica: il risvolto etico della teoria heideggeriana consiste in una condottameramente individuale di “preparazione alla morte” che ricorda l'etica protestante della“vita come colpa”.