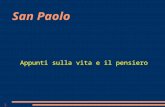Barbaglio Giuseppe - Pablo de Tarso Y Los Origenes Cristianos[1]
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ... file · Web viewPERCORSO CLASSICO...
-
Upload
truongdung -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ... file · Web viewPERCORSO CLASSICO...
A.S. 2007-08 LICEO CLASSICO “DI RUDINÌ” NOTO - III sez A -
PERCORSO CLASSICO GRECO
DISPENSA prof Paolo Randazzo
PAOLO DI TARSO, LETTERA AI ROMANI
CRONOLOGIA DI LUDERMANN
- 30 = presunta morte di Gesù.
- 33 = conversione di Paolo a Damasco.
- 36 = Prima visita di Paolo a Gerusalemme.
- 37 – 41 = Viaggio con Barnaba in Siria, in Cilicia, Galazia del sud, a Filippi, Tessalonica,
Atene e Corinto.
- 50 = Seconda visita di Paolo a Gerusalemme per il Primo Concilio
- 51 = Visita a Corinto e incontro col proconsole Gallione.
- 53 – 55 = Permanenza a Efeso, in Macedonia e a Corinto.
. 55 Terza visita a Gerusalemme per portare la colletta; arresto di Paolo e cambio del
procuratore della Giudea (da Antonio Felice a Porcio Festo)
- 56 – 58 = Arrivo di Paolo a Roma, prigionia di due anni e probabile martirio.
Le lettere considerate autentiche da tutti gli studiosi si porrebbero tra il 41 e il 58 nel
seguente ordine: I Ai Tessalonicesi, I Ai Corinzi, Ai Galati, II Ai Corinzi, Ai Romani, Ai
Filippesi, A Filemone
PAOLO, LE SUE LETTERE E QUELLE DEGLI ALTRI APOSTOLIDi Alceste Santini
Le Lettere o epistole degli apostoli che fanno parte del Nuovo Testamento sono 21 di
cui 14 scritte da Paolo di Tarso, una da Giacomo, due da Pietro, tre da Giovanni e una da
Giuda, fratello di Giacomo, da non confondere con il Giuda Iscariota che tradì Gesù. Gli
apostoli, facendo propria questa forma letteraria, hanno seguito una consuetudine praticata
durante l'impero romano di scrivere delle lettere su carta di papiro e di carattere pubblico sia
da parte dell'imperatore che di letterati o di semplici cittadini. Quelle scritte dagli apostoli,
almeno la gran parte di esse, sono, però, molto più lunghe rispetto, per esempio, a quelle di
Seneca o di Cicerone. E, soprattutto, quelle di Paolo sono sempre dettate dalle circostanze
1
o dal bisogno di chiarire rispetto agli attacchi di cui viene fatto bersaglio, questioni dottrinarie
e morali alle comunità cristiane a cui, in modo particolare, si rivolge perché all'interno di
esse l'insegnamento di Gesù non era sempre interpretato in modo corretto ed univoco. Ed è
chiaro che le sue tesi hanno finito per assumere valore dottrinario per tutta la Chiesa. È
quello che i Pontefici hanno continuato a fare con le loro encicliche e con le lettere
apostoliche. Senza voler sminuire l'importanza di una Lettera rispetto ad un'altra, non c'è
dubbio che assumono un rilievo peculiare quelle redatte da Paolo di Tarso. Infatti, questi,
rispetto agli altri apostoli, emerge per la sua vasta cultura generale e biblica, per il suo
temperamento piuttosto focoso e battagliero, per la sua esperienza religiosa singolare per la
sua capacità di parlare schietto ma anche di saper adattare il suo linguaggio alle situazioni e
di ricercare un onorevole compromesso con i pubblici poteri. Pietro, Giovanni, ossia i primi
discepoli di Gesù, hanno cominciato a scoprire interiormente e lentamente la fede ricevuta
dal loro Maestro, come i cristiani di oggi che vengono battezzati dopo la nascita per un atto
che scaturisce da un certo ambiente familiare e si trovano a scoprire il fattore religioso
entrato nella loro formazione attraverso l'esperienza quotidiana nel confronto con gli altri
nella società civile in cui vivono. Paolo invece è un convertito perché solo da adulto dice di
essere stato come "afferrato" da Gesù sulla via di Damasco, senza averlo conosciuto
personalmente. Era, infatti, nato giudeo sia per pane materna che paterna (venne circonciso
otto giorni dopo la nascita come la tradizione imponeva) ed aveva ricevuto una cultura di
impronta ebraica ed ellenistica tanto che nella sua giovinezza era stato un avversario e,
persino, un persecutore dei. cristiani. È dal momento della conversione, avvenuta nel 34,
che Paolo vive la sua passione per Gesù e le sue lettere sono uno documento
indispensabile per seguire l'evoluzione di quella scoperta che aveva sconvolto la sua vita,
della sua concezione religiosa eminentemente cristocentrica perché tutto vede in rapporto al
Cristo, Figlio di DIO, redentore e unico mediatore fra Dio e gli uomini.
Nato intorno all'anno 15 a Tarso, capitale della Cilicia in Asia Minore e crocevia di
civiltà diverse, il futuro apostolo era stato chiamato Saul, un nome giudaico che ricordava re
Saul che si era distinto nella lotta contro gli Idumei, il popolo da cui veniva la dinastia di
Erode che in quel tempo regnava sulla Giudea e su parte della Palestina. La scelta di un
nome come Saul, che non era causale nel mondo semitico, indicava l'appartenenza di Paolo
alla tribù di Beniamino. Era, inoltre, nato cittadino romano ossia con quei particolari diritti e
la dignità del civis che i poteri pubblici erano obbligati in tutto l'impero a far rispettare. Una
sorta di salvacondotto che gli servirà anche dopo che, convertitosi al cristianesimo ed
assunto il nome greco di Paulos e, poi, quello romano di Paolo, ebbe a scontrarsi più volte
con la giustizia dell'impero.
Aveva frequentato l'università della città di Tarso, che allora contava circa trecentomila
abitanti, dove Cicerone aveva fatto il governatore della Cilicia, dove Giulio Cesare fu accolto
da trionfatore e dove Antonio incontrò, come scrive Plutarco, l'affascinante e fatale
2
Cleopatra regina d'Egitto. Perciò, Paolo, che parlava, oltre l’aramaico e l'ebraico appresi in
famiglia, correntemente il greco con la pronuncia attica e conosceva pure il latino essendo
un obbligo per tutti i cittadini romani esprimersi in questa lingua, si rivolse con queste parole
ad un tribuno romano: "Io sono un giudeo di Tarso di Cilicia, cittadino di una città non certo
senza importanza". A Gerusalemme andò a studiare da rabbino e suo padre lo fece
ammettere alla scuola più ellenizzata e liberale dei maestri di quel tempo, Gamaliele,
considerato un grande rabbi che esercitava sull'assemblea del Sinedrio, di cui era membro,
una enorme influenza. Così, Saul perfezionò la lingua ebraica per leggere i libri del Vecchio
Testamento, e l'aramaico per potersi servire dei targum ossia dell'interpretazione dei libri
sacri in lingua volgare e leggere libri importanti come quelli di Daniele e di Esdra e il
Testamento dei Dodici Patriarchi che certamente li ispirarono. Inoltre, il giovane Saul aveva
ricevuto anche una formazione da giurista, che gli servì quando lo processarono più tardi a
Gerusalemme ed abilmente fece appello a Cesare per essere giudicato a Roma e sottrarsi
così alla giustizia di tribunali periferici poco sicuri. Infatti, più tardi a Roma, dove era arrivato
da Malta nella primavera del 58 in seguito ad un avventuroso viaggio fino a Pozzuoli
proseguendo poi a piedi per la capitale dell'impero, fu assolto e restituito pienamente alla
libertà nel 63 dopo due anni di carcere. Aveva anche appreso, com'era d'uso, nozioni di
medicina, che aveva messo in pratica nell'aiutare i medici a contenere un'epidemia di
dissenteria quando, in seguito ad una violenta tempesta, la nave che lo portava a Roma si
era infranta nelle coste di Malta e, cosi, aveva potuto guadagnarsi vitto e alloggio.
Questi sono soltanto alcuni degli episodi che arricchiscono la vita di questo
personaggio, davvero straordinario nella storia del cristianesimo, su cui si sono costruite
anche delle leggende e racconti verosimili secondo cui da Roma si sarebbe recato in
Spagna e, poi, ripercorrendo a ritroso la rotta che aveva fatto verso Occidente come
indicano le lettere a Tito e a Timoteo, avrebbe concluso la sua vita in Asia. Ma alle sue
aperture mentali aveva influito pure quella esperienza di relazioni internazionali (aveva
parenti in Cilicia, in Macedonia, a Gerusalemme come a Roma) acquisita sin da giovane,
ossia da quando, rabbino e sposato, aveva esercitato il mestiere di famiglia,,il tessitore di
tende, nel periodo in cui la città di Tarso era uno dei punti più importanti del commercio
internazionale trovandosi all'incrocio fra il mondo semitico, l'altopiano anatolico, le città
greche e le isole e, al di là di esse, verso l'Egitto e l'Europa fino a Roma. Era cresciuto e si
era formato, quindi, in un ambiente familiare e culturale dagli orizzonti mondiali e con un
grande desiderio di sapere. Ecco perché, durante i suoi viaggi, si portava dietro pergamene
e papiri su cui scriveva le sue annotazioni quotidiane di circa trenta righe, come facevano gli
intellettuali del tempo, e conservava gli schemi e gli appunti dei suoi discorsi e interventi per
essere in grado, quando le circostanze lo richiedevano, di citare i passaggi ritenuti più
importanti e necessari. È con questo vasto bagaglio culturale, religioso e metodologico, che
Paolo intraprende la sua predicazione ai pagani ed i suoi viaggi missionari per le vie del
3
mondo tanto da essere, poi, definito "l'apostolo delle genti". Gli si è riconosciuto di essere
stato un punto di unione tra il cristianesimo ed il mondo greco-romano e per aver diffuso il
Vangelo nei vasti territori dell'impero romano fino a Roma lasciando in eredità alla Chiesa
un insegnamento prezioso ed un metodo di dialogo con le diverse culture. Ecco perché
abbiamo voluto tracciare, sta pure a grandi linee anche per stimolare la lettura delle sue
lettere, un breve profilo di questo personaggio dotato di un forte e moderno senso della
comunicazione, che soffrì molto per aver dovuto fronteggiare non pochi contrasti ed accuse
all'interno delle prime comunità, cristiane e dovendosi misurare pure con i poteri pubblici.
Rimane, perciò, una delle più forti ed inconfondibili personalità della Chiesa e della storia,
un uomo molto amato ma anche contrastato.
* * *
COME LEGGERE LA LETTERA AI ROMANI
Di Romano Penna
C’è un doppio, fondamentale consiglio da dare a chi si accinge alla lettura di questo
scritto: prepararsi a qualcosa di impegnativo e poi non scoraggiarsi! Se questo vale in
generale per tutte le lettere di Paolo, tanto più è vero per questa lettera in particolare. Ma
una cosa è certa: la pazienza sarà abbondantemente premiata, perché ci si accorgerà che
ne valeva davvero la pena. Infatti, siamo davanti allo scritto più importante dell’Apostolo,
quello in cui egli impegna maggiormente se stesso nell’interpretazione di ciò che significa
l’evangelo per l’uomo, per ogni uomo.
D’altronde, la lettera ai Romani ha avuto nella storia della Chiesa e della teologia
cristiana un influsso non minore di quello che hanno avuto, poniamo, Platone o Aristotele
sulla filosofia occidentale. Quindi, chi non si stancherà di misurarsi con l’argomentazione qui
dispiegata da Paolo meriterà la promessa che leggiamo nell’Apocalisse: «Al vincitore che
persevera fino alla fine… darò autorità sopra le nazioni» (Ap 2,26); oppure, il che è lo
stesso, verificherà di persona quanto siano vere le parole di Lutero nel suo commento: «Fu
come se per me si aprissero le porte del paradiso».
Le circostanze della composizione
Se la lettera ai Romani è importante per noi, bisogna dire che prima lo è stata già per
Paolo stesso. Infatti, quando egli la scrive si trova in un momento significativo e delicato
4
della sua biografia apostolica. È ormai verso la fine del suo terzo viaggio missionario e sta
soggiornando a Corinto (probabilmente al termine dell’anno 54 o all’inizio del 55), appena a
un quarto di secolo dopo la morte di Gesù e dopo aver scritto già un certo blocco di lettere,
cioè: almeno una ai cristiani di Tessalonica, due a quelli di Corinto, una a quelli di Filippi,
una a Filemone (un cristiano della città di Colosse, nell’entroterra di Efeso), e una ai cristiani
della Galazia.
Soprattutto ciò che si verificò nelle Chiese di quest’ultima regione aveva rappresentato
per lui un’esperienza drammatica: l’infiltrazione di alcuni predicatori cristiani ma giudaizzanti
aveva rischiato di imporre ai Galati un’ermeneutica dell’evangelo assai diversa, se non
contraria a quella da lui predicata. Essi infatti pretendevano di coniugare l’adesione a Cristo
con la necessità di osservare la legge mosaica, sicché per essere giusti davanti a Dio non
sarebbe bastata la fede ma si doveva contare anche sulle opere religiose e morali compiute
dall’uomo. Nella lettera indirizzata appunto a quelle Chiese, Paolo aveva affrontato di petto
la questione trattandola in termini molto forti, energici nei toni e radicali nella sostanza. Egli
vi aveva difeso a spada tratta «la verità dell’evangelo» (Gal 2,14), cioè la libertà del cristiano
da ogni vincolo esterno che non sia la pura grazia di Dio manifestatasi in Gesù Cristo e
accolta con nient’altro che non sia la fede.
Inoltre, quando scrive ai romani, Paolo si trova di fronte a un’altra sfida, che questa volta
egli fa a se stesso. Le regioni e le città fino ad allora interessate dalla sua attività
evangelizzatrice, tenendo conto anche del racconto fattoci da Luca negli Atti, erano state
davvero molte: in Siria, la città di Antiochia; a Cipro, quelle di Salamina e Pafo; in Anatolia,
alcune città delle zone centro-meridionali della Panfilia (Perge), della Pisidia (Antiochia,
Iconio) e della Licaonia (Listra, Derbe), e in più la zona anatolica centro-settentrionale della
Galazia; in Asia, la costa dell’Egeo (Efeso, Colosse); in Grecia, la Macedonia (Filippi,
Tessalonica) e l’Acaia (Atene, Corinto). In ciascuna di queste località aveva suscitato delle
Chiese, cioè dei gruppi (anche se piccoli) di credenti in Cristo provenienti sia dal giudaismo
sia dal paganesimo.
Detto all’ingrosso e con le sue parole, egli ha ormai predicato l’evangelo «da
Gerusalemme e dintorni fino all’Illiria» (Rm 15,19), e a questo punto pensa di non avere più
un sufficiente campo d’azione in quelle regioni (cf. Rm 15,23a). Da tempo egli coltivava già
l’idea di recarsi finalmente a Roma (cf. Rm 1,13; 15,23b), capitale dell’impero; e poiché
questa per un uomo dell’Oriente è comunque una città occidentale, Paolo progetta
addirittura di spingersi fino all’estremo Occidente dell’area mediterranea, puntando verso la
Spagna (cf. Rm 15,24.28).
Sappiamo, dunque che verso la metà degli anni ’50 Paolo non era ancora stato di
persona a Roma; quindi la Chiesa romana in quanto tale non aveva ancora avuto contatti
concreti con lui. Resta però il fatto che egli, non solo aveva notizia della fede dei romani (cf.
Rm 1,8; 16,19a), ma in più doveva avere tra loro qualche punto d’appoggio, come risulta da
5
almeno un paio di indizi: uno è l’interessante serie di ben 24 persone salutate per nome al
termine dello scritto (cf. Rm 16,3-15: un lungo elenco non riscontrabile in nessun’altra
lettera); un altro è l’accorata richiesta di un sostegno nella preghiera in vista del suo
imminente viaggio verso Gerusalemme, dove egli prevede che le cose non sarebbero
andate bene per lui (cf. Rm 15,30-32), come effettivamente avvenne (cf. At 21,17-39).
Certo non sappiamo se la Chiesa di Roma da parte sua avesse il desiderio che egli vi
si recasse a farle visita. Comunque, i cristiani della capitale dovevano non solo aver sentito
parlare di lui, ma anche essere venuti a conoscenza di qualche sua tesi audace, come
quella dell’assoluta preminenza della grazia di Dio nei confronti di ogni comportamento
morale dell’uomo: mentre in alcuni ciò aveva suscitato un’adesione fin troppo entusiasta
spinta fino al travisamento (cf. Rm 3,8), nella maggior parte dei romani aveva suscitato
un’opposizione molto netta (cf. Rm 16,17-18).
L’intento formale dello scritto
In ogni caso, la nostra lettera secondo le intenzioni del mittente avrebbe dovuto
fungere da auto-presentazione e da credenziale. L’estensione e il contenuto del testo
epistolare pongono però un problema di rilievo. Infatti, sapendo che la lettera è composta di
ben 7.100 parole1[1], è inevitabile dedurne che non abbiamo a che fare con un elaborato
qualsiasi. Se già il breve biglietto a Filemone (di sole 335 parole) coniuga il caso personale
dello schiavo Onesimo con la questione più generale della schiavitù dal punto di vista
cristiano, tanto più una lettera così ampia come la nostra non è assolutamente riducibile a
questioni di basso profilo.
In effetti, Paolo non ha scritto né soltanto per presentare la propria carta d’identità, né
soltanto per rintuzzare eventuali accuse, né soltanto per raccomandarsi al supporto dei
romani e tanto meno soltanto per condividere con loro un patrimonio ideale dato già per
scontato. Nella lettera, infatti, i toni amichevoli si trovano solo nella sua cornice (cioè:
all’inizio in Rm 1,1-14; e alla fine in Rm 15,14-16,27); d’altra parte, l’allocuzione diretta ai
destinatari con il «voi» della seconda persona plurale, dagli effetti coinvolgenti, si trova
raramente nel corpo del testo (cf. Rm 1,8-15; 6,1-7,6; 8,9-11.13; 11,13); è invece più
frequente nei capitoli dedicati all’esortazione morale (Rm 12,1-15,13), di cui perciò intere
sezioni molto importanti sono prive (cf. Rm 1,18-5,21; 7,7-8,8.14-39; quasi interamente i cc.
9-11); la stessa interpellazione diretta dei destinatari con l’appellativo di «fratelli», tenuto
conto dell’estensione del discorso, è ancora più rara (cf. Rm 7,1; 10,1; 11,25; 12,1; 15,14;
16,17).
Evidentemente Paolo ha intenzione di trattare delle questioni che vanno molto al di là
della situazione propria dei suoi lettori immediati e che investono le componenti
fondamentali dell’identità cristiana in quanto tale. La lettera perciò si avvicina al genere che
1
6
oggi chiameremmo un saggio. È come se Paolo, al punto in cui si trova della sua vita,
volesse – una volta per tutte – chiarire anche a se stesso che cosa significa in definitiva ciò
che da anni andava annunciando in giro per il mondo: si tratta di spiegare non tanto il
contenuto dell’evangelo, che è già chiaro per tutti (cioè: l’identità personale di Cristo come
figlio di Dio e la sua morte-risurrezione per i nostri peccati), quanto piuttosto come vada
concepito l’impatto antropologico di questo annuncio (cioè: che cosa significhi per l’uomo un
evento del genere).
Questo, finora, non lo aveva ancora fatto; o meglio, lo aveva fatto solo parzialmente
nella lettera ai Galati. Ma là, come abbiamo accennato, il tono del discorso era molto
polemico, motivato com’era sia dall’attacco frontale infertogli da alcuni intrusi giudaizzanti,
sia dal fatto che i destinatari della lettera erano cristiani suscitati e quasi generati da lui (cf.
Gal 4,19), il che gli permetteva di esprimersi con una certa libertà di linguaggio (cf. Gal 1,6;
3,1; 5,12). La nostra lettera, invece, è indirizzata a dei lettori che Paolo per lo più non
conosce personalmente e con i quali perciò è – per così dire – obbligato a impiegare toni di
maggiore urbanità e comunque pacati, pur senza rinunciare per nulla ai capisaldi del suo
pensiero.
È questo dato contingente, insieme alle circostanze accennate più sopra, che gli offre
l’occasione di ripensare, ma anche lo induce a farlo, quale sia la portata dell’evangelo a
proposito di ciò che esso stimola e produce nell’uomo. Non che egli offra una
sistematizzazione del proprio pensiero. Paolo non era nato con la vocazione dello scrittore,
e altrettanto egli non sa costruire la propria argomentazione sulla base della ferrea logica
aristotelica, benché provenga dalla diaspora di lingua greca e non sia affatto digiuno delle
regole che presiedono alla composizione di un discorso.
Anche dopo l’evento della strada di Damasco, la sua matrice semitico-ebraica è
rimasta intatta, e soprattutto è rimasto intatto il suo temperamento generoso e passionale,
che lo portano all’accumulazione dei concetti, all’iperbole, all’antitesi, e persino
all’anacoluto, con cui una frase viene interrotta per passare senza preavviso a un altro
soggetto grammaticale (cf. Rm 2,18-20.21; 5,12; 8,3). D’altra parte, l’annuncio evangelico
non è rinchiudibile negli schemi della logica umana; esso non è dimostrabile, ma semmai
persuasibile, e ciò del resto è conforme all’antica arte retorica dei discorsi, che appunto
tendeva non tanto a dimostrare quanto a convincere; e ciò avviene servendosi di tecniche
retorico-espositive particolari.
In effetti, si vede bene che il linguaggio di cui Paolo dispone dal punto di vista lessicale e
sintattico non è sufficiente a contenere il messaggio che deve trasmettere, e, viceversa, si
percepisce altrettanto bene che in ultima analisi l’annuncio evangelico e la riflessione su di
esso eccedono enormemente le possibilità di quel che è possibile dirne. C’è una sfasatura
tra la parola e il concetto e, se si eccettua il codice linguistico proprio dell’Apocalisse di
Giovanni, solo Paolo (o almeno Paolo più di altri) all’interno delle origini cristiane dimostra
7
quanto sproporzionato sia il rapporto tra il messaggio e il linguaggio. Il pensiero deborda lo
scritto, il quale non è un argine bastevole per incanalarne la forza straripante.
Il fatto è che Paolo non espone le cose didatticamente, come potrebbe fare un freddo
cattedratico, che separa la propria scienza dalla propria umanità. È ben diverso dire che due
più due fanno quattro e dire che in Gesù Cristo Dio ha amato tutti gli uomini, me compreso,
fino a definirlo un «Dio per noi» (Rm 8,31). Ecco, Paolo è coinvolto in ciò che dice e scrive,
perché ne va della vita e del senso che ad essa può derivarne dall’evangelo, sicché in gioco
non c’è solo una visione oggettiva delle cose, ma una profonda compromissione soggettiva
ed esistenziale.
L’effettiva posta in gioco
Prima di incontrare personalmente i cristiani di Roma, dunque, Paolo espone loro il
proprio pensiero sulla natura e sulle implicanze dell’evangelo, così che essi sappiano bene
che cosa pensa colui del quale avrebbero dovuto poi fare la conoscenza. L’Apostolo però sa
che a Roma la fede cristiana è vissuta secondo un’interpretazione che non è la sua.
Ciò sarà significativamente confermato nel sec. IV dal primo commentatore romano della
lettera paolina, noto sotto lo pseudonimo di Ambrosiaster (vissuto al tempo di papa
Damaso, 366-384):
I romani… pur non vedendo né segni né miracoli né alcuno degli apostoli, avevano
accolto la fede in Cristo sebbene in un senso falsato: infatti non avevano sentito
annunciare il mistero della croce di Cristo… L’Apostolo impiega tutte le sue energie
per toglierli dalla legge, perché «la legge e i profeti vanno fino a Giovanni», e per
fissarli nella sola fede in Cristo (in sola fide Christi), e quasi contro la legge difende il
vangelo, non distruggendo la legge, ma anteponendo il cristianesimo (Prologo al suo
commento).
Come si vede da questa testimonianza, che esprime l’autocoscienza propria della
stessa Chiesa romana, sono in gioco i grandi concetti di legge e di fede, tra i quali la croce
di Cristo fa da relais e nello stesso tempo da spartiacque. I cristiani di Roma, infatti, erano in
realtà pressoché tutti giudeo-cristiani, cioè facevano coesistere l’adesione a Cristo con
l’osservanza della Torà, sicché la morte di Cristo poteva significare al massimo l’abolizione
dei sacrifici templari (cf. Rm 3,25) ma non l’accantonamento dei vari precetti legali
(classificati successivamente dai rabbini in numero di 613).
Da parte sua, invece, Paolo distingue nettamente i due termini: come accennato, egli
aveva già fatto questa operazione nella lettera ai Galati, ma ora riprende quella tematica e
la sviluppa più ampiamente. Perciò è assolutamente importante rendersi conto di come
8
proceda l’esposizione del suo pensiero e come esso vada a strutturare il quadro generale
della lettera e segnatamente il suo corpo centrale (cioè Rm 1,16-15,13.
L’articolazione della lettera
La prima, fondamentale osservazione riguarda l’organizzazione bipartita dell’intera
argomentazione. L’indizio più importante del passaggio da una parte espositiva a un’altra è
l’uso del verbo «esortare» in Rm 12,1, mai impiegato nelle pagine precedenti: con esso
Paolo passa decisamente a un discorso di genere morale, cioè alla richiesta di una condotta
etica che viene dettagliata fino a Rm 15,13 con ammonimenti vari, di carattere sia generale
(incentrati comunque tutti sulla necessità dell’agàpe/amore vicendevole) sia particolari
(come il rapporto all’esterno con le autorità politiche [Rm 13,1-7] e all’interno con coloro che,
essendo deboli nella fede, praticano astinenze da cibi e bevande [Rm 14,1-15,13]).
A questo indizio se ne aggiunge un altro complementare, quello della dossologia con
cui si conclude la sezione precedente in Rm 11,33-36: abbiamo qui una sorta di inno, che
canta l’insondabilità della sapienza di Dio e che per le sue movenze celebrative rappresenta
l’apice di quanto esposto prima.
Perciò l’ultima sezione epistolare, che si apre con uno stacco ben marcato (Rm 12,1:
«Vi esorto, dunque, fratelli»), si presenta come una deduzione di comportamenti vissuti da
intendersi come conseguenza di tutto ciò che l’Apostolo ha precedentemente esposto da
Rm 1,16 fino a Rm 11,36. Ciò che appare sorprendente è il patente sbilanciamento
quantitativo tra le due parti: ai 71 versetti di quest’ultimo segmento epistolare si oppongono i
ben 300 del segmento precedente!
Se dunque la lettera si divide in due parti, risulta evidente che la prima è la più
importante, poiché è qui che si trovano i princìpi e le basi della condotta cristiana. Appare
quindi chiaro che a Paolo interessa di più (e non solo prima) fare un discorso sui fondamenti
che non sulle sue sovrastrutture, sulle radici che non sull’albero, sull’essere che non
sull’agire, in una parola sulle componenti pre-morali della condotta cristiana. Ecco, la lettera
ai Romani ci insegna proprio questo: a non anteporre il dover fare al dover essere. Paolo sa
che, se si chiariscono bene gli elementi portanti, allora la vita cristiana crescerà da sola
producendo naturalmente frutti omogenei alle sue premesse costitutive.
Ebbene, detto in breve, la sezione Rm 1,16-11,36 si può strutturare nel modo
seguente.
Tutto si apre con un’enunciazione di principio, che definisce l’annuncio cristiano nei suoi
elementi formali (Rm 1,16-17).
Seguono tre ampie sotto-sezioni, che ricamano su questo tema e trattano
rispettivamente:
9
a) della situazione di tutti gli uomini, giudei e gentili, accomunati davanti a Dio sia nel
peccato (Rm 1,18-3,20) sia nella giustificazione per fede (Rm 3,21-5,21);
b) della nuova esistenza dei battezzati in Cristo e nello Spirito; qui alle categorie giuridiche
della sezione precedente (giustizia, assoluzione) subentrano altre di tipo mistico
(comunione, filiazione): Rm 6,1-8,39;
c) dell’incredulità di Israele di fronte all’evangelo e della persistente fedeltà di Dio alla
propria promessa di salvezza: Rm 9,1-11,36.
Come si vede, il quadro è ampio e ricco. Non resta che immergervisi, sapendo che
limitarsi a guardarlo ne pregiudica l’esatta comprensione, poiché ciascuno di noi ne fa
comunque parte integrante.
* * *
BRANI DELLA LETTERA AI ROMANI
Cap 5: La giustificazione 1 - 11
Dikaiwqšntej oân ™k p…stewj e„r»nhn œcomen prÕj tÕn qeÕn di¦ toà kur…ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà, di' oá kaˆ t¾n prosagwg¾n ™sc»kamen [tÍ p…stei] e„j t¾n c£rin taÚthn ™n Î ˜st»kamen,
kaˆ kaucèmeqa ™p' ™lp…di tÁj dÒxhj toà qeoà. oÙ mÒnon dš, ¢ll¦ kaˆ kaucèmeqa ™n ta‹j ql…yesin, e„dÒtej Óti ¹ ql‹yij Øpomon¾n katerg£zetai, ¹ d � Øpomon¾ dokim»n, ¹ d dokim¾ ™lp…da� ·¹ d ™lpˆj oÙ� kataiscÚnei, Óti ¹ ¢g£ph toà qeoà ™kkšcutai ™n ta‹j kard…aij ¹mîn di¦ pneÚmatoj ¡g…ou toà doqšntoj ¹m‹n, œti g¦r CristÕj Ôntwn ¹mîn ¢sqenîn œti kat¦ kairÕn Øpr ¢sebîn ¢pšqanen.
mÒlij g¦r Øpr dika…ou tij ¢poqane‹tai· Øpr g¦r toà ¢gaqoà t£ca tij kaˆ tolm´ ¢poqane‹n· sun…sthsin d t¾n ˜autoà ¢g£phn e„j ¹m©j Ð qeÕj Óti œti ¡martwlîn Ôntwn ¹mîn CristÕj Øpr ¹mîn ¢pšqanen. pollù oân m©llon dikaiwqšntej nàn ™n tù a†mati
10
aÙtoà swqhsÒmeqa di' aÙtoà ¢pÕ tÁj ÑrgÁj. e„ g¦r ™cqroˆ Ôntej kathll£ghmen tù qeù di¦ toà qan£tou toà uƒoà aÙtoà,
pollù m©llon katallagšntej swqhsÒmeqa ™n tÍ zwÍ aÙtoà· oÙ mÒnon dš, ¢ll¦ kaˆ kaucèmenoi ™n tù qeù di¦ toà kur…ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà, di' oá nàn t¾n katallag¾n ™l£bomen.
Iustificati igitur ex fide pacem habeamus ad Deum per Dominum nostrum Iesum Christum
per quem et accessum habemus fide in gratiam istam in qua stamus et gloriamur in spe
gloriae filiorum Dei non solum autem sed et gloriamur in tribulationibus scientes quod
tribulatio patientiam operat patientia autem probationem probatio vero spem spes autem
non confundit quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus
est nobis ut quid enim Christus cum adhuc infirmi essemus secundum tempus pro impiis
mortuus e vix enim pro iusto quis moritur nam pro bono forsitan quis et audeat mo
commendat autem suam caritatem Deus in nos quoniam cum adhuc peccatores essemus
Christus pro nobis mortuus est multo igitur magis iustificati nunc in sanguine ipsius salvi
erimus ab ira per ipsum si enim cum inimici essemus reconciliati sumus Deo per mortem Filii
eius multo magis reconciliati salvi erimus in vita ipsi non solum autem sed et gloriamur in
Deo per Dominum nostrum Iesum Christum per quem nunc reconciliationem accepimus.
Cap 5: La giustificazione 15 - 21
'All' oÙc æj tÕ par£ptwma, oÛtwj kaˆ tÕ c£risma· e„ g¦r tù toà ˜nÕj paraptèmati oƒ polloˆ ¢pšqanon, pollù m©llon ¹ c£rij toà qeoà kaˆ ¹ dwre¦ ™n c£riti tÍ toà ˜nÕj ¢nqrèpou 'Ihsoà Cristoà e„j toÝj polloÝj ™per…sseusen. kaˆ oÙc æj di' ˜nÕj ¡mart»santoj tÕ dèrhma· tÕ mn g¦r kr…ma ™x ˜nÕj e„j kat£krima� , tÕ d � c£risma ™k pollîn paraptwm£twn e„j dika…wma. e„ g¦r tù toà ˜nÕj paraptèmati Ð q£natoj ™bas…leusen di¦ toà ˜nÒj, pollù m©llon oƒ t¾n perisse…an tÁj c£ritoj kaˆ tÁj dwre©j tÁj dikaiosÚnhj lamb£nontej ™n zwÍ basileÚsousin di¦ toà ˜nÕj 'Ihsoà Cristoà. ”Ara oân æj di' ˜nÕj paraptèmatoj e„j p£ntaj ¢nqrèpouj e„j kat£krima, oÛtwj kaˆ di' ˜nÕj dikaièmatoj e„j p£ntaj ¢nqrèpouj e„j dika…wsin zwÁj· ésper g¦r di¦ tÁj parakoÁj
11
toà ˜nÕj ¢nqrèpou ¡martwloˆ katest£qhsan oƒ pollo…, oÛtwj kaˆ di¦ tÁj ØpakoÁj toà ˜nÕj d…kaioi katastaq»sontai oƒ pollo….
nÒmoj d pareisÁlqen †na pleon£sV tÕ par£ptwma� · oá d � ™pleÒnasen ¹ ¡mart…a, Øpeper…sseusen ¹ c£rij, †na ésper ™bas…leusen ¹ ¡mart…a ™n tù qan£tJ, oÛtwj kaˆ ¹ c£rij basileÚsV di¦ dikaiosÚnhj e„j zw¾n a„ènion di¦ 'Ihsoà Cristoà toà Kur…ou ¹mîn.
Sed non sicut delictum ita et donum si enim unius delicto multi mortui sunt multo magis
gratia Dei et donum in gratiam unius hominis Iesu Christi in plures abundavit et non sicut per
unum peccantem ita et donum nam iudicium ex uno in condemnationem gratia autem ex
multis delictis in iustificationem si enim in unius delicto mors regnavit per unum multo magis
abundantiam gratiae et donationis et iustitiae accipientes in vita regnabunt per unum Iesum
Christum igitur sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem sic et per
unius iustitiam in omnes homines in iustificationem vitae sicut enim per inoboedientiam
unius hominis peccatores constituti sunt multi ita et per unius oboeditionem iusti
constituentur multi lex autem subintravit ut abundaret delictum ubi autem abundavit delictum
superabundavit gratia ut sicut regnavit peccatum in morte ita et gratia regnet per iustitiam in
vitam aeternam per Iesum Christum Dominum nostrum
Cap 7: La legge provoca trasgressioni 1 - 25
T… oân ™roàmen; Ð nÒmoj ¡mart…a; m¾ gšnoito· ¢ll¦ t¾n ¡mart…an oÙk œgnwn e„ m¾ di¦ nÒmou, t»n te g¦r ™piqum…an oÙk Édein e„ m¾ Ð nÒmoj œlegen, OÙk ™piqum»seij. ¢form¾n d laboàsa ¹ ¡mart…a di¦ tÁj ™ntolÁj kateirg£sato ™n� ™moˆ p©san ™piqum…an· cwrˆj g¦r nÒmou ¡mart…a nekr£.
™gë d œzwn cwrˆj nÒmou potš� · ™lqoÚshj d tÁj ™ntolÁj ¹� ¡mart…a ¢nšzhsen, ™gë d ¢pšqanon� , kaˆ eØršqh moi ¹ ™ntol¾ ¹ e„j zw¾n aÛth e„j q£naton· ¹ g¦r ¡mart…a ¢form¾n laboàsa di¦ tÁj ™ntolÁj ™xhp£thsšn me kaˆ di' aÙtÁj ¢pškteinen. éste Ð mn nÒmoj ¤gioj� , kaˆ ¹ ™ntol¾ ¡g…a kaˆ dika…a kaˆ ¢gaq». TÕ
12
oân ¢gaqÕn ™moˆ ™gšneto q£natoj; m¾ gšnoito· ¢ll¦ ¹ ¡mart…a, †na fanÍ ¡mart…a, di¦ toà ¢gaqoà moi katergazomšnh q£naton· †na gšnhtai kaq' Øperbol¾n ¡martwlÕj ¹ ¡mart…a di¦ tÁj ™ntolÁj.O‡damen g¦r Óti Ð nÒmoj pneumatikÒj ™stin· ™gë d s£rkinÒj� e„mi, pepramšnoj ØpÕ t¾n ¡mart…an. Ö g¦r katerg£zomai oÙ ginèskw· oÙ g¦r Ö qšlw toàto pr£ssw, ¢ll' Ö misî toàto poiî. e„ d � Ö oÙ qšlw toàto poiî, sÚmfhmi tù nÒmJ Óti kalÒj. nunˆ d oÙkšti� ™gë katerg£zomai aÙtÕ ¢ll¦ ¹ o„koàsa ™n ™moˆ ¡mart…a. oda� g¦r Óti oÙk o„ke‹ ™n ™mo…, toàt' œstin ™n tÍ sark… mou,
¢gaqÒn· tÕ g¦r qšlein par£keita… moi, tÕ d katerg£zesqai tÕ� kalÕn oÜ· oÙ g¦r Ö qšlw poiî ¢gaqÒn, ¢ll¦ Ö oÙ qšlw kakÕn toàto pr£ssw. e„ d Ö oÙ qšlw � [™gë] toàto poiî, oÙkšti ™gë katerg£zomai aÙtÕ ¢ll¦ ¹ o„koàsa ™n ™moˆ ¡mart…a. EØr…skw ¥ra tÕn nÒmon tù qšlonti ™moˆ poie‹n tÕ kalÕn Óti ™moˆ tÕ kakÕn par£keitai· sun»domai g¦r tù nÒmJ toà qeoà kat¦ tÕn œsw ¥nqrwpon, blšpw d ›teron nÒmon ™n to‹j mšles…n mou� ¢ntistrateuÒmenon tù nÒmJ toà noÒj mou kaˆ a„cmalwt…zont£ me ™n tù nÒmJ tÁj ¡mart…aj tù Ônti ™n to‹j mšles…n mou.
tala…pwroj ™gë ¥nqrwpoj· t…j me ·Úsetai ™k toà sèmatoj toà qan£tou toÚtou; c£rij d tù qeù di¦ 'Ihsoà Cristoà toà kur…ou� ¹mîn. ¥ra oân aÙtÕj ™gë tù mn no douleÚw nÒmJ qeoà, tÍ d sarkˆ nÒmJ ¡mart…aj.
Quid ergo dicemus lex peccatum est absit sed peccatum non cognovi nisi per legem nam
concupiscentiam nesciebam nisi lex diceret non concupisc occasione autem accepta
peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam sine lege enim
peccatum mortuum erat ego autem vivebam sine lege aliquando sed cum venisset
mandatum peccatum revixit ego autem mortuus sum et inventum est mihi mandatum quod
erat ad vitam hoc esse ad mortem nam peccatum occasione accepta per mandatum seduxit
me et per illud occidit itaque lex quidem sancta et mandatum sanctum et iustum et bonum
13
quod ergo bonum est mihi factum est mors absit sed peccatum ut appareat peccatum per
bonum mihi operatum est mortem ut fiat supra modum peccans peccatum per mandatum
scimus enim quod lex spiritalis est ego autem carnalis sum venundatus sub peccato quod
enim operor non intellego non enim quod volo hoc ago sed quod odi illud facio si autem
quod nolo illud facio consentio legi quoniam bona nunc autem iam non ego operor illud sed
quod habitat in me peccatum scio enim quia non habitat in me hoc est in carne mea bonum
nam velle adiacet mihi perficere autem bonum non invento non enim quod volo bonum hoc
facio sed quod nolo malum hoc ago si autem quod nolo illud facio non ego operor illud sed
quod habitat in me peccatum invenio igitur legem volenti mihi facere bonum quoniam mihi
malum adiacet condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem video autem aliam
legem in membris meis repugnantem legi mentis meae et captivantem me in lege peccati
quae est in membris meis infelix ego homo quis me liberabit de corpore mortis huius gratia
Dei per Iesum Christum Dominum nostrum igitur ego ipse mente servio legi Dei carne autem
legi peccati
Cap. 8 l’opera dello Spirito santo 26 - 39
`WsaÚtwj d kaˆ tÕ pneàma sunantilamb£netai tÍ ¢sqene…v ¹mîn· tÕ g¦r t… proseuxèmeqa kaqÕ de‹ oÙk o‡damen, ¢ll¦ aÙtÕ tÕ pneàma Øperentugc£nei stenagmo‹j ¢lal»toij· Ð d � ™raunîn t¦j kard…aj oden t… tÕ frÒnhma toà pneÚmatoj� , Óti kat¦ qeÕn ™ntugc£nei Øpr ¡g…wn� . o‡damen d Óti to‹j ¢gapîsin� tÕn qeÕn p£nta sunerge‹ e„j ¢gaqÒn, to‹j kat¦ prÒqesin klhto‹j oâsin. Óti oÞj prošgnw, kaˆ proèrisen summÒrfouj tÁj e„kÒnoj toà uƒoà aÙtoà, e„j tÕ enai aÙtÕn prwtÒtokon ™n pollo‹j� ¢delfo‹j oÞj d proèrisen� , toÚtouj kaˆ ™k£lesen· kaˆ oÞj ™k£lesen, toÚtouj kaˆ ™dika…wsen· oÞj d ™dika…wsen� ,
toÚtouj kaˆ ™dÒxasen.
T… oân ™roàmen prÕj taàta; e„ Ð qeÕj Øpr ¹mîn� , t…j kaq' ¹mîn; Ój ge toà „d…ou uƒoà oÙk ™fe…sato, ¢ll¦ Øpr ¹mîn p£ntwn� paršdwken aÙtÒn, pîj oÙcˆ kaˆ sÝn aÙtù t¦ p£nta ¹m‹n car…setai; t…j ™gkalšsei kat¦ ™klektîn qeoà; qeÕj Ð dikaiîn· t…j Ð katakrinîn; CristÕj ['Ihsoàj] Ð ¢poqanèn, m©llon d ™gerqe…j� , Öj
14
ka… ™stin ™n dexi´ toà qeoà, Öj kaˆ ™ntugc£nei Øpr ¹mîn� . t…j ¹m©j cwr…sei ¢pÕ tÁj ¢g£phj toà Cristoà; ql‹yij À stenocwr…a À diwgmÕj À limÕj À gumnÒthj À k…ndunoj À m£caira; kaqëj gšgraptai Óti “Eneken soà qanatoÚmeqa Ólhn t¾n ¹mšran,
™log…sqhmen æj prÒbata sfagÁj. ¢ll' ™n toÚtoij p©sin Øpernikîmen di¦ toà ¢gap»santoj ¹m©j. pšpeismai g¦r Óti oÜte q£natoj oÜte zw¾ oÜte ¥ggeloi oÜte ¢rcaˆ oÜte ™nestîta oÜte mšllonta oÜte dun£meij oÜte Ûywma oÜte b£qoj oÜte tij kt…sij ˜tšra dun»setai ¹m©j cwr…sai ¢pÕ tÁj ¢g£phj toà qeoà tÁj ™n Cristù 'Ihsoà tù kur…J ¹mîn.
Similiter autem et Spiritus adiuvat infirmitatem nostram; nam quid oremus sicut oportet
nescimus; sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Qui autem
scrutatur corda scit quid desideret Spiritus, quia secundum Deum postulat pro sanctis.
Scimus autem quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum his qui secundum
propositum vocati sunt sancti. Nam quos praescivit et praedestinavit conformes fieri imaginis
Filii eius ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Quos autem praedestinavit, hos et
vocavit; et quos vocavit, hos et iustificavit; quos autem iustificavit, illos et glorificavit.
Quid ergo dicemus ad haec? si Deus pro nobis, quis contra nos? Qui etiam proprio Filio suo
non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quo modo non etiam cum illo omnia nobis
donabit? Quis accusabit adversus electos Dei? Deus qui iustificat? Quis est qui condemnet?
Christus Iesus qui mortuus est, immo qui et resurrexit, qui est ad dexteram Dei, qui etiam
interpellat pro nobis? Quis ergo nos separabit a caritate Christi? Tribulatio? an angustia? an
persecutio? an fames? an nuditas? an periculum? an gladius? sicut scriptum est
Quia propter te mortificamur tota die
aestimati sumus ut oves occisionis.
Sed in his omnibus superamus propter eum, qui dilexit nos. Certus sum enim quia neque
mors neque vita, neque angeli neque principatus neque virtutes, neque instantia neque
15
futura, neque fortitudo, neque altitudo neque profundum neque creatura alia poterit nos
separare a caritate Dei, quae est in Christo Iesu Domino nostro
Incontro con Padre Adriano Minardo: “Paolo e il problema della giustificazione”
“SE CRISTO SUPERA LA LEGGE CHE VALORE CONTINUA AD AVERE LA LEGGE PER
ISRAELE, PER I CRISTIANI E PER NOI?”
Il tema trattato da San Paolo nella Lettera ai Romani è quello della giustificazione,
tema che viene trattato con toni più polemici nella Lettera ai Galati, nella quale San Paolo si
batte contro l’ideologia d’Israele.
San Paolo nacque qualche anno dopo la nascita di Gesù a Tarso in Cilicia. In seguito
si trasferisce a Gerusalemme dove incontrerà il rabbino Gamaiele. A Roma parteciperà
anche al complotto contro Stefano martire. Convertitosi al cristianesimo Paolo annunciò il
cristianesimo oltre la Palestina;noti sono i suoi numerosi viaggi funzionali a questo scopo.
Andò ad Efeso,poi ad Atene,a Corinto,in seguito tornò a Gerusalemme dove venne
condannato e imprigionato dai Giudei, ma essendo cittadino romano poté appellarsi
direttamente all’imperatore per essere giudicato secondo la legge romana (si può trovarne
riscontro negli Atti degli Apostoli).Così arriva a Roma dove subirà il martirio (la datazione di
tale evento è ancora controversa,si ipotizzano il 61 e il 67 d.c.). Nel suo viaggio verso Roma
Paolo toccò i porti di Malta,di Siracusa e di Pozzuoli.
San Paolo scrive la Lettera ai Romani intorno al 54 d.c. mentre si trovava a Corinto.
Ricordiamo che San Paolo scrisse circa tredici lettere, delle quali due sono indubbie. La
Lettera ai Romani risponde ad una domanda precisa ed ha la funzione di lettera
preparatoria visto che è indirizzata alla comunità dei Giudei presenti a Roma che Paolo non
conosce. In altre lettere Paolo tratterà temi come quelli della riconciliazione e della
pace,mentre in questa lettera il tema è quello della giustificazione.
16
Difatti all’inizio dal cristianesimo Gesù si pone come novità e perciò la sua dottrina
deve farsi conoscere da tutti. Per tale ragione Paolo rivolge la sua lettera ai Giudei
rispondendo così a questioni molto dibattute tra Giudei e Cristiani:
- i Giudei devono abbandonare la loro Legge(la Torah) oppure no?
- coloro che sono fedeli, ma non ebrei, devono o no essere circoncisi?
Alla seconda domanda Paolo risponde dicendo che non è necessario che un pagano venga
circonciso,difatti la circoncisione è un elemento esterno e non necessario per il
conseguimento della salvezza.
La prima questione invece risulta molto più dibattuta. I Giudei non volevano convertirsi
al cristianesimo non ritenendo necessaria la figura di Gesù per raggiungere la salvezza:
nella loro cultura infatti l’unico elemento necessario a tale fine era la Torah. Nella loro ottica
Gesù era sì un salvatore, ma non il loro.
Paolo nella Lettera ai Romani deve così dimostrare che la circoncisione non è
necessaria e che la sola Torah non basta per la salvezza,il tutto deve essere ricondotto alla
diversa concezione di giustizia dei Giudei e di Paolo. Per il Giudeo è giusto chi segue la
Legge, per Paolo invece Dio è giusto perché è rimasto fedele alle sue promesse inviando
Cristo e riesce a rendere ragione al comportamento dell’uomo, ma l’uomo in realtà, pur
seguendo la Torah,non può considerarsi intimamente giusto perché il suo cuore è malvagio.
Le opere considerate esternamente giuste da chi segue la Legge possono essere viziate
internamente dal nostro sentimento; Gesù stesso lottò contro questo carattere delle opere.
Di conseguenza la Legge non giustifica l’uomo dinanzi a Dio.
Dio non è indifferente al male che l’uomo commette, per questa ragione
Paolo,apportandola come argomento,sfrutta “l’ira di Dio” per sottolineare il fatto che l’ultimo
giudizio spetta sempre a Dio.
Per rendere giusto l’uomo era necessario che qualcuno si assumesse tutte le colpe
dell’uomo,tale fu il ruolo di Gesù,che con la sua venuta ha quindi reso giusto l’uomo
redimendolo dal peccato. Dio,primo fra i giusti,rende giusto l’uomo.
Quest’ultimo concetto è stato indiscusso dall’inizio del I sec d.c. fino al XV sec. Nel XVI
sec fu Martin Lutero a dare una forte scossa a questo impianto dottrinale. Per la prima volta
il cristianesimo si scontra con la categoria aristotelica della storia. Il pensiero di Lutero ha
origine dalla stessa lettura delle Lettere paoline che colpisce la sua spiccata sensibilità,egli
infatti dimostrò la sua immane paura dell’ira di Dio e ne trovò riscontro in San Paolo. In una
notte di temporale,difatti,lesse il versetto 17 del Cap I della Lettera ai Romani,”il giusto vivrà
per fede”, questa frase gli fece capire che le opere buone non servivano per raggiungere la
salvezza che ha già conquistato Gesù con il suo sacrificio,ma si rende anche conto che
Gesù non rende l’uomo giusto intrinsecamente,ma si limita a coprire i peccati. La
giustificazione protestante è così solo formale e non inerisce la persona. Lutero si era
accorto che la natura dell’uomo era corrotta,ma per il cattolicesimo la natura dell’uomo non
17
è corrotta in quanto la visione antropologica cristiana è positiva:è la Grazia che coopera
insieme alle opere buone per la salvezza. Le opere buone non sono una causa strumentale
ma cooperano con la Grazia che ha una funzione preventiva. Fu appunto questa la risposta
che il Concilio di Trento diede a Lutero. Oggi grazie al dialogo ecumenico il tema della
giustificazione non interessa più i teologi.
Dopo queste argomentazioni la risposta alla domanda iniziale è molto semplice:per
Israele la Legge è come la Magna Charta dell’alleanza con Dio, che non può esistere senza
la Torah,per gli ebrei, difatti la Legge è essenziale;per i cristiani l’osservanza della Legge di
per sé non è una cosa negativa,ma la Legge può dire solo cosa si deve fare,ma non
salva;per noi la Legge oggi ha lo stesso valore che ha per i cristiani.
* * *
Paolo e la cultura ebraica
Per quanto riguarda questa problematica citiamo i punti di vista del biblista Paolo Sacchi e
dello teologo e filosofo ebreo Taubner come descritto e spiegato dalla studiosa Donatella Di
Cesare.
Paolo e il fondamento della morale cristiana
Vorrei provare a mostrare come può essere nato in Paolo un problema e come cercò
di risolverlo: il discorso risulterà più complesso, perché non si fonda su uguaglianze
statiche, ma sulla ricerca di una dinamica, che faccia risaltare il problema adducendo vari
referenti mentali che aiutarono Paolo a risolverlo.
Si legge nel vangelo di Marco che Gesù, in quanto Figlio dell'Uomo, cioè giudice
supremo in luogo di Dio e in funzione della sua giustizia, aveva anche il potere di perdonare,
evidentemente proprio perché giudice assoluto. E' l'episodio della guarigione del paralitico
che si trova nella prima parte del vangelo (Marco, 2, 1-12). Il fatto è noto: Gesù, vedendo la
pistis (fede, come è tradotto normalmente, o meglio, in questo caso, fiducia) di coloro che gli
hanno portato il paralitico e forse anche del paralitico stesso, dice rivolto al paralitico: "Sono
rimessi i tuoi peccati". Il perdono non dipende da una richiesta, nemmeno implicita, che
presupporrebbe il pentimento. E' atto assolutamente gratuito.
A Paolo un comportamento di Gesù di questo genere creò problemi, o meglio, li creò
negli animi dei suoi ascoltatori ebrei, che non poterono non porli a Paolo, la cui risposta fu
complessa, segno che il problema era difficile a risolversi in termini razionali anche da parte
18
sua. Ciò è documentabile non agli inizi della sua predicazione, ma fra gli anni 54 e 57, anni
probabili della composizione delle Epistole ai Corinzi e di quella ai Romani. Non è tanto la
parola pistis , che egli intende ormai come fede , che fa difficoltà a Paolo e ai suoi ascoltatori,
ma il rapporto, anomalo per la maggior parte degli ebrei, che si viene ad instaurare fra
comportamento umano e retribuzione divina. Paolo deve reinterpretare le scritture e la loro
tradizione interpretativa, per potervi iscrivere anche il comportamento e il pensiero di Gesù.
Per trovare il senso del presente, deve rifarsi al passato scritturistico: niente di più ebraico.
Scrive Paolo in Romani, 3, 21 sgg.: "Ora, dunque, indipendentemente dalla Legge si è
manifestata la giustizia di Dio, cui la Legge stessa e i profeti (cioè la scrittura nel suo
insieme, intesa come testo profetico) rendono testimonianza: giustizia di Dio che si ottiene
mediante la fede in Gesù Cristo, a disposizione di tutti coloro che credono - senza
distinzione (cioè fra ebrei e pagani), perché tutti (lo ha già detto prima, al v. 12 ed ora
riprende le conclusioni già enucleate) hanno peccato, cosicché tutti sono privi della gloria di
Dio, ma giustificati gratuitamente dalla grazia di lui, per mezzo della redenzione che avviene
per mezzo di Gesù Cristo".
Ho insistito più volte che il concetto di giustificazione è in quest'epoca pangiudaico,
perché è ormai coscienza comune che il giusto oggetto delle cure di Dio, di cui spesso
parlano le scritture, né esiste, né può esistere. Anche gli esseni credevano in una
giustificazione più o meno per fede, i farisei in una giustificazione per mezzo delle opere
(cioè, detto semplicemente, una certa quantità di opere buone cancellava una certa quantità
di opere cattive). Nel I secolo pertanto il problema non era "chi è il giusto che si salva", ma
"chi può essere considerato giusto da Dio, così da essere salvato".
Il problema, dunque, di Paolo non era la giustificazione in quanto tale, né le sue
condizioni. Anche su questo punto non aveva dubbi: era la fede nel Cristo. Il problema di
Paolo era un altro. Come è possibile predicare una morale di vita (e Paolo certamente la
predicava) e dichiarare contemporaneamente che questa era indifferente rispetto alla
salvezza? Qualcuno, infatti, che aveva ascoltato la predicazione di Paolo, lo aveva
interpretato nel senso che egli avesse abolito ogni morale, se non addirittura che avesse
consigliato di compiere quanto più male possibile. Lo racconta egli stesso in Romani, 3, 8:
"Perché non dovremmo fare il male, affinché venga il bene, come alcuni...ci calunniano,
dicendo che lo affermiamo?".
Predicare una vita attiva nel bene e contemporaneamente dichiarare inutili alla
salvezza le opere doveva produrre un certo smarrimento in mezzo ai credenti, specie se
provenienti dalle file del farisaismo. Ma non doveva essere migliore nemmeno la condizione
spirituale di coloro che venivano dall'essenismo. Sapevano che la salvezza era per fede, ma
19
nel loro predeterminismo, consideravano la Legge come lo specchio voluto da Dio in cui
l'uomo poteva cogliere, diciamo così nel suo esame di coscienza, il suo procedere sulla via
della salvezza. La Legge era valida, perché voluta da Dio e i suoi eletti non potevano che
praticarla. Ma Paolo era radicale nell'annunciare il superamento della Legge stessa, il cui
valore era duplice: storicamente era il pedagogo che ci aveva condotti al Cristo;
filosoficamente era il mezzo attraverso il quale il male che è tale già prima della legge e,
quindi, indipendentemente da questa, diventa trasgressione (Romani, 7, 13). E' per questo,
come è noto, che la Legge, per Paolo, non può portare alla salvezza.
Di questa difficoltà derivante dai contorni nettissimi della teologia paolina della
salvezza per fede c'è eco anche in Pietro. Dovevano essere situazioni spirituali come quelle
descritte sopra che fecero sospirare il buon Pietro con queste parole (Seconda epistola di
Pietro, 3, 16): "Le sue (di Paolo) lettere contengono passi difficili a comprendersi, il
significato dei quali...viene sconvolto dagli ignoranti e dai deboli, a loro perdizione". Questa
menzione dei "deboli" sembra proprio alludere al problema morale.
Paolo avverte la necessità di legare la vita attiva dell'uomo cristiano a quella unità che
è l'uomo destinato alla salvezza o alla perdizione. E il problema gli nasce certamente
dall'esperienza della predicazione, dai contatti umani che ne seguivano. In 6, 12 della Prima
epistola ai Corinzi c'è una frase che ha sempre fatto difficoltà ai commentatori e che talora
viene stampata fra virgolette, come pensiero di Paolo travisato, sia pure appartenente alla
sua predicazione o addirittura come pensiero di qualche avversario. In definitiva, non
sarebbe pensiero di Paolo, o almeno non pensiero di Paolo da porre in questo contesto.
Credo invece che si tratti non solo di pensiero paolino, ma di pensiero paolino che sviluppa
il discorso in cui è inserito. Solo che per capirlo va calato nei referenti mentali degli ebrei del
tempo. Si legge, dunque, in questo versetto: "Tutto mi è permesso, ma non tutto giova".
Conseguenza del superamento della Legge (il pedagogo che ci ha portati al Cristo) è
proprio il fatto che non ha più un senso parlare di "è lecito" e di "non è lecito" ed è da frasi
come questa che può essere nata la diceria che Paolo aveva abolito la morale. Ma anche
Paolo si accorgeva col passare degli anni che alla sua predicazione morale mancava una
base unitaria, ché per gli ebrei, per tutti gli ebrei, l'unico fondamento della morale era la
Legge. E' vero che Paolo, e prima di lui l'autore del Documento di Damasco, avevano
scoperto quel concetto che, in termini moderni, potrebbe essere definito della "morale
naturale". Ma nella Prima Epistola ai Corinzi Paolo non si mette su questa strada, cerca
qualcosa di più concreto, di più comprensibile ai suoi connazionali.
Se è vero che, superata la Legge, tutto diventa lecito, resta tuttavia il fatto che non
tutto giova. Cerchiamo ora di individuare i referenti mentali di Paolo e degli ebrei dell'epoca
20
che possono chiarire questo punto. Ma prima guardiamo come si sviluppa il discorso di
Paolo fino al punto in cui ha inserito la frase discussa "Tutto mi è lecito...". Paolo stava
facendo un'aspra rampogna contro chi commetteva ingiustizia. Non si facciano illusioni i
cristiani (dunque, qualcuno se le faceva) : fornicatori, idolatri, adulteri,..., ladri, avari,
ubriaconi, maldicenti, rapinatori non erediteranno il regno di Dio. Paolo prosegue ricordando
che il cristiano è un giustificato. E' a questo punto che viene fuori la frase "Tutto mi è
permesso". E' come se dicesse: E' vero che la giustificazione è indipendente dalle opere,
ma non per questo siete liberi di commettere il male, perché il male è fra le cose che non
giovano.
Quest'affermazione piuttosto oscura per chi ha letto Machiavelli e non solo per quello,
era invece chiarissima per un ebreo del tempo. Una categoria del giudaismo (spesso
discussa, ma generalmente accettata da tutti gli ebrei di tutti i tempi) è quella del
puro/impuro. Senza volerne qui ripercorrere la storia fin dalle origini, possiamo dire che il
concetto di impuro al tempo di Gesù era quanto mai vasto. L'impurità era una realtà (una
cosa) negativa per l'uomo che era legata sia ad alcune cose (come il sangue, gli animali che
strisciano, il cadavere) sia alla vita sessuale (l'atto sessuale contamina sempre
indipendentemente dalla sua liceità), sia o ciò che oggi chiamiamo vita morale, perché
anche il peccato contamina, cioè depotenzia e, in definitiva, distrugge l'uomo. Il sesso era
considerato una fonte di impurità molto grave. Si noti come Paolo nell'elenco delle colpe che
i cristiani devono evitare cominci proprio dalla fornicazione. Era un modo comune di
ragionare di allora. Già i Settanta avevano invertito l'ordine del quinto e del sesto
comandamento. La logica classica era "Non togliere la vita, non rubare la donna, non rubare
le cose". Adesso la logica è "Non contaminare (il sesto comandamento ha così allargato e
cambiato il suo valore originario), non uccidere, non rubare". Norme di purità
particolarmente severe riguardavano soprattutto coloro che erano addetti al culto nel
tempio.
Ed ecco come prosegue il discorso di Paolo. "Non sapete che i vostri corpi sono
membra di Cristo?" E ancora e più chiaramente: "Non sapete che il vostro corpo è tempio
dello Spirito Santo?". In questo passo Paolo fa il tentativo di fondare la morale cristiana sul
modo con cui ci si deve comportare al tempio, in quanto il cristiano, in un certo senso, è
sempre nel tempio. L'affermazione è tutt'altro che audace per un ebreo del I secolo: anche
gli esseni da tempo consideravano la loro comunità sostitutiva del tempio; ogni esseno era
una pietra del tempio puro, che sostituiva quello contaminato di Gerusalemme. Come si
vede, motivi per opporsi gli uni agli altri agli ebrei non mancavano, ma si trattava di scontri
che presupponevano sempre idee e problemi ebraici. Paolo non fa eccezione a questa
regola.
21
Paolo si deve bene essere reso conto che questa via non risolveva il problema, perché
i contenuti della purità erano stati modificati da Gesù. Così Paolo, quando riprese la
metafora del tempio nella Seconda Lettera ai Corinzi (cap. 6, 16) per indicare l'insieme di
coloro che credono nel Cristo ("Noi siamo il tempio del Dio vivente") allargò il discorso ad
una forma di ascesi, per cui il cristiano è chiamato "a purificarsi da ogni macchia della carne
e dello spirito" (7, 1). La vita cristiana deve procedere come vita di separazione dai pagani o
almeno dai loro vizi, ma il versetto biblico citato da Paolo a conferma della sua tesi è quello
che è: (6, 17) "Uscite di mezzo a quelli e separatevene e non toccate nulla di impuro" (Isaia,
52, 11, riadattato da Paolo).
Ma se questa via di ascesi è essenzialmente negativa (separazione dai vizi dei pagani,
con l'espressione equivalente e quanto mai significativa "non toccate nulla di impuro"),
Paolo cerca di battere anche un'altra via con motivazioni opposte, positive e non negative.
Penso al famoso cap. 13 della Prima Epistola ai Corinzi, che è tutto un inno all'Amore.
Quest' Amore (con la A maiuscola) di cui parla Paolo non va confuso con l'amore per il
prossimo, perché anche se un uomo desse tutti i suoi beni ai poveri, non ne trarrebbe alcun
giovamento: è la stessa logica che ha guidato il ragionamento di Paolo della Seconda ai
Corinzi: è vero che tutto è lecito, ma è altrettanto vero che non tutto giova: sia chiaro,
nemmeno dare il suo ai poveri giova: dunque, non è un problema semplicemente di amore
per il prossimo. E Paolo sta cercando di indicare che cosa sia quello che giova. Lo sfondo
concettuale, l'insieme dei referenti mentali che giustificano le conclusioni vanno ricostruiti
dal discorso stesso, perché Paolo non li indica mai chiaramente: forse non era in grado egli
stesso di verbalizzarli.
Quest'Amore che Paolo ha in mente è affine alle virtù umane e a quelle caratteristiche
cristiane quali la fede e la speranza, ma si distingue da queste per un motivo fondamentale:
mentre tutte le virtù sono destinate a scomparire, legate come sono a questa vita effimera
nel corpo, l'Amore non può scomparire mai (13, 8): in altri termini, è eterno. L'Amore, perciò,
è qualcosa che appartiene già alla sfera del divino. Chi vive nell'Amore è talmente legato a
Dio, che non può agire se non secondo la Sua volontà.
Quest'idea che sembra così paolina (anche se qualcuno ne ha messa in dubbio
l'autenticità) e così nuova, è nuova solo nel senso che in Paolo si radica nella fede nel
Cristo e non altrimenti, ma qualcosa di molto simile si può ritrovare anche presso gli esseni.
Vorrei avvicinare al passo paolino uno tratto dalla Regola della Comunità, 4, 3, passo che
appartiene secondo recenti studi alla fase più tarda dell'essenismo: siamo pertanto in
un'epoca non molto anteriore a quella in cui visse Paolo.
22
"(Lo spirito del bene o di verità) illumina il cuore dell'uomo e stende davanti a lui tutte le vie
della giustizia vera, fa sì che il suo cuore tema i giudizi di Dio; (e questa via di vera giustizia
è costituita da) umiltà (ruah `anawah), pazienza ('orek 'appaym), amore abbondante (rob
rahamim), Bene eterno o cosmico (tob `olamim), intelletto (sekel), intelligenza (binah),
somma sapienza (hokmat geburah)."
In questo elenco abbiamo tre virtù pratiche e tre dianoetiche, disposte in climax ascendente:
umiltà, pazienza, amore e intelletto, intelligenza, sapienza somma. Cerniera fra le due serie
di virtù umane è il tob `olamim, che le trascende: non è più umano, ma cosmico o eterno. Il
primo gradino umano è formato da umiltà e intelletto, il secondo da pazienza e intelligenza,
il terzo da amore e somma sapienza. La linea di una ascesi è tracciata con la massima
chiarezza.
Chi è salito fino al terzo gradino raggiunge il tob `olamim, che in qualche modo lo eterna. E'
la sfera del divino che penetra nell'uomo. Nell'apocalittica del Libro dei Vigilanti l'uomo
portava in sé un'anima immortale destinata a vivere nelle caverne dei beati o in quelle dei
dannati, ma anima e corpo sono come separati fra di loro: l'uomo giusto, o comunque degno
della salvezza, attende di penetrare nel mondo dello spirito. Nell'essenismo avviene il
rovescio: la sfera dello spirito e del divino penetra nell'uomo già in questa vita. Non fa
stupore pertanto che nei testi essenici non si parli mai in maniera esplicita dell'immortalità
dell'anima, che sarebbe problema destinato a restare sub iudice, se non avessimo
l'affermazione esplicita di Giuseppe Flavio. In realtà, l'esseno raggiunge l'eterno e se ne
lascia compenetrare già in questa vita.
Vengono adesso pubblicati alcuni frammenti di un'opera intitolata dagli editori Regola della
liturgia dell'olocausto del sabato, che doveva contenere tredici inni da recitarsi in occasione
dei tredici sabati della prima stagione dell'anno. Si tratta di una liturgia degli angeli alla quale
partecipano anche gli esseni. L'esseno vive già in questa vita nel tempio eterno degli angeli
e di Dio.
Questo che abbiamo detto adesso è essenismo e non cristianesimo, ma un rapporto fra il
pensiero di Paolo e quello di Qumran esiste ed è ben marcato.
Ritornando a Paolo, è chiaro che una volta che l'uomo ha raggiunto l'Amore si trova in una
situazione simile a quella di chi ha raggiunto il Bene eterno. L'espressione essenica è più
oggettiva di quella di Paolo. Paolo sembra far coincidere nell'Amore ciò che gli esseni
tenevano separato come amore e come Bene eterno, dove il primo è passo obbligato per
raggiungere il secondo. In Paolo l'Amore riassume in sé, per sua natura, anche l'amore con
23
la a minuscola, ma l'Amore di Paolo ha lo stesso carattere di eternità del Bene eterno
essenico.
A questo punto il problema del "lecito" e del "non lecito" è manifestamente superato: Dio è
nello stesso tempo fonte dell'essere e del comportamento dell'individuo. Non c'è più frattura
fra ciò che noi chiamiamo l'essere e il dover essere.
Guardiamo un caso di novità in Paolo, in cui si coglie bene sia il suo distacco
dall'essenismo, sia la sua innegabile maggiore vicinanza al pensiero essenico che a quello
farisaico. Esiste una lunga tradizione di pensiero che è partita dalla prima apocalittica,
secondo la quale la natura del mondo e dell'uomo è stata sciupata da un peccato
commesso fuori di essa: il peccato angelico. L'essenismo riprese l'idea modificandola nel
senso che il peccato angelico non fu peccato libero, in quanto Satana fu creato tale da Dio,
per "odiarlo", come dice la Regola della Comunità (4, 1); ma l'idea che la natura sia stata
sciupata da questo fatto, sia pure diversamente valutato, fu anche essenica. Anzi
l'essenismo la radicalizzò vedendo nell'uomo solo una struttura di peccato, peccatore in
questo senso fino dal seno materno. L'assenza di questa concezione della natura sciupata
nel farisaismo crea uno scarto robustissimo fra le due correnti, o meglio: fra farisaismo e
sadduceismo da un lato, e tutte le altre correnti dall'altro.
Ora noi vediamo che Paolo non conosce il peccato angelico, pur conoscendo Satana, con
funzioni di tentatore, ma non molto marcate, perché del diavolo Paolo. Per Paolo la natura
umana è sì sciupata, ma a causa del peccato di Adamo e la differenza non è piccola, anche
se la categoria paolina si iscrive perfettamente nel pensiero ebraico e solo in quello. E'
chiaro che il peccato di Adamo ha la stessa funzione, nel pensiero di Paolo, che
nell'apocalittica e nell'essenismo aveva il peccato angelico, ma il fatto di aver scelto un mito
diverso per spiegare la stessa cosa ha la sua importanza: il peccato ha la sua origine nella
sfera umana. "Per colpa di uno la condanna si è riversata su tutti" (Romani, 5, 18).
Ed è interessante notare che la concezione paolina fu ripresa anche in ambienti apocalittici,
se il Quarto Libro di Ezra (inizi del II sec. d.C.) l'accoglie, la sviluppa e la radicalizza, fino ad
arrivare ad una concezione molto pessimistica del destino umano: l'uomo è libero e quindi
pienamente responsabile delle sue azioni, ma è anche sottoposto alla legge (3, 19-20; 9,
31-32), che finisce sempre col tradire; il suo destino non può essere che la dannazione
eterna. Sarebbe stato meglio che la terra non avesse mai prodotto Adamo.
Se l'esigenza di unificare la Legge o comunque di trovarne il denominatore comune è tipica
del cristianesimo e si ritrova in qualche testo apocalittico, come già abbiamo visto, non fu
estranea nemmeno al farisaismo, anche se questa esigenza ebbe nel farisaismo e nel
24
cristianesimo due esiti completamente diversi. Nel cristianesimo prevalse la tendenza a
unificare la Legge sotto l'indice del comandamento supremo ("Chi ama il prossimo, adempie
alla Legge [Romani, 13, 8]); nel farisaismo posteriore al 70 d.C. (nel Formative Judaism e
poi alle origini del rabbinismo vero e proprio) prevalse una tendenza speculativa. La Legge
venne identificata con la Sapienza che era stata creata prima delle cose (cfr. Proverbi, 8,
22). La Legge, dunque, fu creata prima delle cose (cfr. Targum frammentario di Genesi, 1,
1; Bereshit Rabba 1, 4 e 24, 4). Essa rappresenta pertanto il piano di Dio creatore ed è di
fatto la struttura portante dell'universo, che può sussistere solo in quanto è un ordine e, in
definitiva, la proiezione fisica della Legge. Penetrare i significati della Legge significa
penetrare i segreti del cosmo. Come il cosmo si presenta, pur nella sua unità, sotto
numerosi aspetti, così la Legge ha una sua unità intrinseca che si rifrange nella molteplicità
dei comandamenti.
Dunque, il problema della libertà di scelta, che è legato alla concezione della natura umana,
se integra o in qualche modo sciupata, divise il farisaismo e il sadduceismo dal
cristianesimo e dall'essenismo. La libertà di scelta per il fariseo era assoluta e tale fu
ribadita anche nel giudaismo della Mishnah. Al contrario essa era assente o molto ridotta
nell'essenismo e in ogni caso sentita come condizionata dal cristianesimo. In questo campo
il cristianesimo sembra soprattutto erede dell'apocalittica che affermava
contemporaneamente la corruzione della natura umana e la libertà di scelta assoluta.
Penso che Giuseppe Flavio, il quale ci ha lasciato un quadro delle principali sette religiose
del suo tempo avesse sostanzialmente ragione ad assumere come criterio fondamentale di
distinzione il modo con cui si ponevano davanti al problema della libertà di scelta. Certo,
Giuseppe Flavio parla solo di farisei, sadducei ed esseni. Non parla né dell'apocalittica, né
del cristianesimo, ma non è difficile inserire anche questi movimenti in questo schema. Si
veda il riassunto che Giuseppe Flavio fa in Antiquitates Iudaicae, 13, 171-173 della più
ampia esposizione già fatta nel Bellum Iudaicum, 2, 119-166.
Questa carrellata finale ha voluto aggiungere qualche altro elemento al quadro del tempo
delle origini cristiane allo scopo di rafforzare la mia tesi di fondo che il cristianesimo fu, alle
sue origini, un movimento giudaico in mezzo agli altri numerosi.
La vena anarchica di Jacob Taubesdi Donatella Di Cesare
«Il tempo incalza», perché ha un termine, una fine. Quando al termine della storia, il
tempo «principe della morte» sarà sottomesso, farà il suo ingresso il tempo della fine . Sarà
arrivato il Messia. L'impazienza messianica , antico paradigma ebraico, nuovo paradigma
25
della tarda modernità, guida tutta la ricerca di Jacob Taubes, a cominciare dal suo unico
libro Escatologia occidentale (Garzanti, 1997), una ermeneutica della storia narrata come un
testo, a sua volta interpretato a partire dal testo della Torah, della Bibbia ebraica. Filosofo,
teologo, esegeta, Taubes sfugge ad ogni classificazione; resta però un rabbino, saldamente
ancorato all'ebraismo ortodosso. Nella sua apertura al cristianesimo così come nei confronti
estremi con Heidegger e con Schmitt, il rabbino-filosofo mantiene il punto di vista ebraico.
Quel che spinge Taubes a rintracciare nella storia dell'occidente l'idea messianica è
l'esigenza di chi è sopravvissuto all'ultima apocalisse, lo sterminio degli ebrei. Reagire
all'annientamento significa delineare un processo escatologico che si svolge nella storia, ma
è anti-storico, dove la Shoah diviene necessaria. Questa è la sfida lanciata da Taubes dove
è contenuta già la risposta che promette un compimento della teologia politica: il
messianismo. Ma la questione si amplia - e si amplierà anche nel percorso di Taubes.
Come pensare infatti il messianismo ebraico post Christum, dopo la cristianità e il suo
apparente risolversi in secolarizzazione?
Mentre riconduce la storia escatologica dell'occidente alle sue radici ebraiche, Taubes
riannoda con il filo del pensiero apocalittico ebraismo e cristianesimo, pur tenendoli ben
distinti. Ma legge il cristianesimo delle origini attraverso l'ebraismo. Per Taubes, che si
definisce dall'inizio un «apocalittico della rivoluzione», la parola originaria è la «estraneità»
che nel vocabolario gnostico rinvia alla frattura tra uomo e mondo, Dio e mondo. Uomo e
Dio sono così accomunati dalla loro estraniazione al mondo. La estraniazione si traduce
nell'erranza che segna il passaggio dalla natura alla storia, dal mondo pagano al mondo
ebraico-cristiano. È nel popolo di Israele, «luogo storico dell'apocalittica rivoluzionaria», che
l'erranza si manifesta per la prima volta assumendo quella forma teologico-politica che con
un termine greco viene detta «teocrazia».
Il tema, toccato già nell'Escatologia, è affrontato da Taubes soprattutto negli ultimi anni
a partire dal seminario intitolato Teologia politica come problema ermeneutico. Usato per la
prima volta da Flavio Giuseppe, quando descrive la rivolta degli zeloti, dei gruppi di
resistenza ebraica contro l'Impero romano, il termine «teocrazia» viene rilanciato nella
modernità da Spinoza. Fenomeno fondamentale della teologia politica, la teocrazia è «un
immediato dominio di Dio che esclude ogni forma di dominio dell'uomo sull'uomo», fino al
rifiuto di ogni guida politica. Viene così alla luce la vena anarchica del pensiero di Taubes.
Il patto di alleanza con Dio esclude ogni altro patto o vincolo terreno e fa di Israele una
comunità politica senza autorità, una società che non si costituisce attraverso uno stato. «La
teocrazia si basa sull'animo sostanzialmente anarchico di Israele». Qui Taubes segue
un'antica linea interpretativa che nel novecento passa per Gustav Landauer e Martin Buber.
Pone però l'accento sull'originaria estraneità a se stesso del popolo ebraico, stirpe nomade
destinata a restare deterritorializzata - come direbbe Deleuze - popolo «non-popolo» il cui
diritto, a differenza del diritto romano, vieta la proprietà privata, «popolo senza spazio» e
26
perciò «popolo del tempo», il cui unico luogo è il non-luogo del deserto in cui si rivela «il Dio
universale che guida la storia del mondo». Questo Dio straniero ed escatologico è un Dio
sovversivo perché «contesta il mondo in sé e annuncia quello nuovo».
Il pericolo però della spinta sovversiva e rivoluzionaria è quello di affondare nel vuoto
nulla oppure di differire il suo télos , il suo fine, nel futuro. In breve: la spinta apocalittica
rischia di mostrare solo la sua tragicità se privata dell'idea messianica. Soltanto se
quest'ultima regge, può delinearsi la «nuova alleanza» che è il vero télos della rivoluzione.
Di qui l'interesse di Taubes per le prime comunità cristiane che si oppongono al potere
imperiale e l'attenzione per le due figure capaci di rivelare l'essenza dell'escatologia: Gesù
di Nazareth e soprattutto Paolo di Tarso. Ma la lettura che Taubes fa di queste due figure è
una lettura ebraica.
«Gesù non va considerato come l'iniziatore di qualcosa di nuovo, ma come un
fenomeno dell'ondata apocalittica in Israele». Il suo annuncio del Regno va inteso «secondo
l'espressione ebraica»: importante non è che cosa il Regno sia, ma il fatto che è vicino, che
anzi forse c'è già. Anticipando quello che sarà un importante filone di ricerca Taubes guarda
dunque al Cristo storico. Gesù di Nazareth, ebreo, carpentiere itinerante, del ramo
impoverito della stirpe di David, chiede al popolo un atto politico decisivo per il Regno di Dio
seppure non violento: se tutta l'ecumene è sottomessa all'Impero, al popolo libero di Israele
non resta che l'esodo nel deserto. Ma la profezia di Cristo non è adempiuta. La delusione
nelle comunità ebraico-cristiane è immensa. È qui che entra in scena Paolo, Saul di Tarso,
per predicare che «nonostante il ritardo della parusia il nuovo eone è già cominciato». Così
mantiene la tensione messianica tra il già e il non-ancora - tensione che va definitivamente
perduta con l'escatologia individuale di Agostino e il riconoscimento della Chiesa come
impero. Si comprende allora perché la figura di Paolo assuma per Taubes un significato
particolare che si sviluppa e si precisa nella sua riflessione fino al seminario di Heidelberg
pubblicato postumo con il titolo La teologia politica di San Paolo (Adelphi, 1997).
Mentre l' Imperium si espande ineluttabilmente, Paolo riesce a farsi carico
dell'estraneità dal mondo delle masse spingendole a un «epocale raccoglimento»,
condizione alternativa al potere imperiale. Allontanarsi dall'Impero è seguire il Messia .
Contro la versione cattolica che fa di Paolo un normalizzatore e soprattutto il fondatore di
una nuova religione, Taubes lo interpreta come un eversore, esponente radicale del
messianismo ebraico.
Ma è questa interpretazione che produce lo scontro con Scholem, uno scontro che
investe il concetto stesso di messianismo. La questione si incentra sulla Legge ebraica,
sulla Halakhah. Per parte sua Taubes ribadisce la validità della Legge condivisibile da tutti
nella «sobrietà quotidiana della giustizia» - e rilancia la sfida ebraica contro l'arbitrio
dell'amore. Paolo - e questo è il punto - non ha inteso per nulla negare la Legge; piuttosto
ha voluto ripensare il rapporto tra Legge e fede. L'attualità di questo ripensamento per la
27
politica è stata sottolineata da Giorgio Agamben: un sistema irrigidito che pretende di
normare tutto è il segno di una perdita di senso della legge (Il tempo che resta. Un
commento alla Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, 2000). Scholem fraintende il gesto
antinomico di Paolo ricondotto a una crisi della tradizione; così la redenzione ebraica
sarebbe un evento pubblico, quella cristiana un evento spirituale. Deriva anche da qui il
messianismo che Scholem propone: il prezzo che il popolo ebraico ha dovuto pagare per
l'idea messianica sarebbe «una vita vissuta nel differimento», un rinvio dunque della venuta
del Messia - rinvio che tende a trattenere, a conservare, e che indebolisce l'ebraismo.
Perciò Taubes si affretta ad abbattere quella barriera dell'interiorità che Scholem ha eretto
tra ebraismo e cristianesimo - ma occorre dire che critiche in tal senso sono state mosse a
Scholem anche dal noto cabbalista Moshe Idel.
La «trasgressione» di Paolo non vuole essere una negazione, ma un compimento
della Legge perché se il Messia è venuto, la Legge è compiuta. È questa la via di Damasco,
l'eresia che l'ebraismo ovviamente non può seguire. Ma è un'eresia ebraica, come eresie
ebraiche sono quelle di Gesù di Nazareth o di Shabbatai Zvi, il falso Messia dell'età
moderna. Per Taubes non si tratta tuttavia di riportare a casa un eretico, quanto piuttosto di
giungere attraverso Paolo e la sua «interiorizzazione» del messianismo a una auto-
comprensione più complessa dell'ebraismo post Christum .
«La Lettera ai Romani - scrive Taubes nel seminario di Heidelberg - è una teologia
politica perché è una dichiarazione di guerra politica » contro l'Impero. Quando la profezia
viene meno, la speranza della redenzione vacilla, la grandezza di Paolo sta nel fronteggiare
interiormente la crisi e di farne l'epicentro stesso della vita messianica. Ciò che allontana
Taubes da Scholem al tempo stesso lo avvicina al modo in cui Benjamin intende la teologia,
ossia come messianismo, pensando la redenzione non nel futuro, ma in ogni istante in cui si
raccoglie e si riscatta anche il passato. «La comunità messianica non è priva di storia ; tutto
il passato spinge verso un adesso ; esiste in un permanente stato di eccezione ». Qui Taubes
non esita a confrontarsi con Carl Schmitt - di cui conosceva bene i trascorsi nazisti. Davvero
sovrano - aveva detto Schmitt - non è chi definisce la norma, ma «chi decide sullo stato di
eccezione». La differenza tuttavia è che per Schmitt teologia e politica si identificano e il
potere si autolegittima: nella sua interpretazione di Paolo la forza che ritarda la venuta
dell'anticristo è l'Impero. Al contrario per Paolo interpretato da Taubes la forza
antimessianica è l'Impero contestato nella sua illegittimità. Sovrano è solo il Messia , perché
solo il Messia può compiere la legge e perciò sospenderla. La teologia in Taubes non si
identifica per nulla con la politica; proprio il loro divergere può accelerare «l'avvento del
regno messianico».
Nel ripensare radicalmente teologia politica e filosofia della storia Taubes sa dare
risposte alle questioni urgenti della fine della sovranità e della fine della storia. E lo fa
28





























![Barbaglio Giuseppe - Pablo de Tarso Y Los Origenes Cristianos[1]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/577c7e171a28abe054a084e4/barbaglio-giuseppe-pablo-de-tarso-y-los-origenes-cristianos1.jpg)