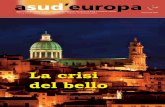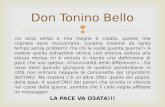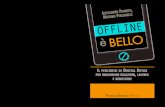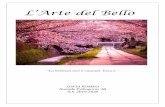Curi l'Apparire Del Bello
-
Upload
guglielmobilancioni -
Category
Documents
-
view
224 -
download
2
Transcript of Curi l'Apparire Del Bello
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
1/53
Presentazione
Bello un concetto di inquietante complessit, un giacimento di idee e intuizionidilatatosi nel tempo fino ai confini estremi della riflessione. Bello, bellezza, sono tra leparole pi ricorrenti per definire immagini, aure, fantasie e nutrire estri letterari, indugifilosofici. Si parla di bello in riferimento allaspetto di una persona, alla suggestione di
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
2/53
un paesaggio, alla forza comunicativa di unopera darte. Ma si usa anche per indicarela capacit argomentativa di un discorso, la qualit di unidea, la coerenza di una leggeo la configurazione di una galassia. Eppure, a dispetto di una cos grande diffusione,non vi affatto chiarezza n univocit nel modo di intendere questo concetto.
Umberto Curi delinea un percorso affascinante e innovativo che, muovendo dal mondoclassico greco-latino, quando il bello era ritenuto il requisito di ci che non mancava dinulla, conduce al pensiero moderno e contemporaneo e ai tremendi angeli rilkiani,quando ormai il bello deve lasciare spazio allassenza. Lapparire del bello, suggerisceCuri, coincide con la manifestazione di unambivalenza insuperabile, con la rivelazionedi uno scandalo, con lemergenza di una contraddizione, che tuttavia scalda i l cuore eci consola.
Umberto Curi professore emerito di Storia della filosofia presso lUniversit diPadova e docente presso la Facolt di Filosofia dellUniversit San Raffaele di Milano.Tra i suoi libri pi recenti: Miti damore. Filosofia delleros (2009), Straniero (2010) ePassione (2013). Presso Bollati Boringhieri ha pubblicato Plemos. Filosofia comeguerra (2000), La forza dello sguardo (2004), Meglio non essere nati. La condizioneumana tra Eschilo e Nietzsche (2008, premio Capalbio per la filosofia) e Via di qua.Imparare a morire (2011).
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
3/53
Tutti i diritti riservati.Traduzione autorizzata dalledizione in lingua inglesepubblicata da Prometheus Books
2013 Bollati Boringhieri editoreTorino, corso Vittorio Emanuele II, 86
Gruppo editoriale Mauri Spagnol
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
4/53
ISBN 978-88-339-7262-6
Schema grafico della copertina di Pierluigi Cerri
www.bollatiboringhieri.it
Prima edizione digitale agosto 2013Questopera protetta dalla Legge sul diritto dautore. vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata
Temi240
Lapparire del bello
A mio nipote Pietro,genuino esempio di kalokagatha
Incipit
Il percorso delineato nelle pagine seguenti fondato su alcuni assunti di base, che dunque opportuno preliminarmente esplicitare. Non si tratta appena il caso disottolinearlo di convinzioni granitiche e immodificabili, quanto piuttosto di alcuneipotesi di lavoro, di per s ancora molto problematiche, senza le quali tuttavia losviluppo delle argomentazioni contenute in questo saggio apparirebbe se non altromeno chiaro, se non completamente arbitrario.
Il concetto occidentale di bellezza questo il primo fra i prolegomeni deriva dal
pensiero dei maggiori filosofi del periodo greco classico, ai quali si deve altres unaprima sistematizzazione degli spunti formulati dai lirici e dai sapienti dellet arcaica.Di qui lidea secondo la quale la stessa discussione moderna e contemporanea sulconcetto di bellezza rischia di restare incomprensibile, o esposta a sostanzialifraintendimenti, ove non si definiscano nella maniera pi circostanziata possibile lecoordinate del problema, quale si esprime nel mondo antico greco-latino.
La seconda tesi riguarda la distinzione fra la riflessione sul bello, ricorrente in numerosiautori, in un arco di tempo che va da Omero a Tucidide, e poi Platone e Aristotele, edunque fra lVIII e il IV secolo, e la concezione dellarte, la quale prende avvio e sisviluppa al di fuori di ogni riferimento vincolante alla nozione di bellezza. Dovedovrebbe essere evidente che la concezione classica di tchne non riconducibile allanozione moderna di arte, non solo per il carattere polisemico del termine greco usatoper indicare sia ci che poi si chiamer tecnica, sia per indicare unattivitartigianale, pi che strettamente artistica ma anche per la valenza conoscitiva, enon soltanto imitativa, attribuita alla tchne in et classica.
Si comprende allora ed il terzo passaggio per quali motivi ogni tentativo diproiettare a ritroso le moderne teorie dellestetica (sconosciuta gi come termine, epi ancora come concetto, nel mondo antico), parlando dunque di estetica antica,incontri ostacoli insormontabili, sotto il profilo concettuale, oltre che sul piano filologico
e testuale.
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
5/53
Per rendere meno apodittica questa affermazione baster pensare che la sequenzaopera darte gusto estetica, sulla quale si basa la trattazione di A.G. Baumgarten(primo inventore del termine estetica), sostanzialmente sconosciuta nella culturaclassica, nella quale, invece, la nozione di bello compare prevalentemente in relazionealle nozioni di buono e di vero, configurando cos una concezione filosofica
storicamente e concettualmente anteriore (e di oltre 2 millenni) alle distinzionidisciplinari introdotte nel clima illuministico.
Cos, per accennare ad un solo esempio, il cittadino greco della seconda met del Vsecolo poteva dire bella una tragedia non solo perch essa era conforme adeterminate regole, ed era dunque ben costituita, ma anche perch essa facevaconoscere, secondo il nesso fondamentale che connette i pathmata ai mathmata. Larappresentazione del pthos doveva condurre a una conoscenza.
Sia pure soltanto per inciso, si pu qui osservare che sembra essere cadutatotalmente nel vuoto la raccomandazione formulata nellimmediato secondodopoguerra da Martin Heidegger, quando ammoniva a diffidare degli ismi, rilevandoche i Greci hanno pensato senza denominazioni poi diventate di uso comune comelogica, fisica e etica (alle quali a maggior ragione si potrebbe aggiungereanche estetica).
Una volta che si sia definitivamente chiarito che, per dirla un po allingrosso, alle originidella cultura occidentale il bello non loggetto di una disciplina specialisticachiamata estetica, e che invece pi in generale la ricerca sul bello internaallindagine che riguarda lessere in quanto tale, o che pertinente al piano del giudiziomorale, un ulteriore aspetto deve essere accuratamente segnalato, sia pure per ora in
forma puramente enunciativa.
Fin dai primi documenti della tradizione culturale occidentale, e poi via via nei testiclassici, fino almeno a Plotino, bellezza il nome di un paradosso, pi che di unarealt univoca e ben determinata. Indica, infatti, qualcosa che non sta per s, marinvia strutturalmente ad altro da s. To kaln termine doppio per antonomasia.Esprime una eccedenza, ancor pi che una presenza. Non compendia in s i requisitiper i quali qualcosa possa essere riconosciuta come bella, ma allude piuttosto a unpiano di realt altro e diverso, rispetto a quello dellesperienza ordinaria.
Lapparire del bello viene cos a coincidere con la manifestazione di unambivalenza
insuperabile, destinata a riproporsi costantemente nel percorso non lineare ediscontinuo che conduce dallantichit greca fino al pensiero moderno econtemporaneo.
Tutto ci non per dissimulare che (come fuori discussione) sono tante le cose (nelsenso di autori, testi, problemi) che mancano in questo saggio. doverosoriconoscere, infatti, che siamo qui ben lontani da una trattazione esauriente(qualunque cosa possa voler dire questo termine) del concetto di bellezza. Malesaustivit non era lintento di questo testo. Si intendeva, piuttosto, contribuire aricollocare al centro della ricerca filosofica un tema da tempo assente, o perch pi o
meno legittimamente annesso ad altri ambiti di indagine, o perch colpito da unatroppo affrettata dichiarazione di morte. Mentre forse oggi pi che mai necessario
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
6/53
interrogarsi su quel fenomeno complesso che lapparire del bello.
1. Tra Omero e Tucidide
1. In un quaderno redatto a Londra nel 1942, poche settimane prima di morire, Simone
Weil annotava: Tutte le volte che si riflette sul bello, si arrestati da un muro. Tutto ciche stato scritto al riguardo miserabilmente ed evidentemente insufficiente. Pocherighe pi avanti, la stessa autrice precisava i motivi che erano alla base di unasentenza cos perentoria, vale a dire per quali ragioni ci che era stato scritto sul bellodoveva considerarsi comunque insufficiente: Il bello consiste in una disposizioneprovvidenziale grazie alla quale la verit e la giustizia, non ancora riconosciute,richiamano in silenzio la nostra attenzione.
Anche al di l della spiegazione fornita dalla Weil, si pu assumere il giudizio sul belloproposto dalla filosofa come punto di partenza di una riflessione che tenda a fareemergere i principali problemi, e le difficolt, connessi con il tentativo di definire labellezza.
La questione principale riguarda il muro, di fronte al quale viene a trovarsi lindagineintorno a questo concetto. In tutta evidenza, il riferimento al muro allude al fatto che, nelpercorrere il cammino, la strada risulta bloccata, il pros si manifesta come a-pora.
Un primo passo, ancora insufficiente per lasciarsi definitivamente alle spalle losbarramento, ma insieme necessario per avviare almeno il percorso, indicato dallastessa Weil, quando sottolinea che non possibile concepire il bene senza passareper il bello. Ci perch quando ogni altra cosa sia stata tacitata, rimane solo un
mistero, relativo allazione svolta da quellenergia che agisce nel particolare. Di questomistero, il bello soltanto permette di farsi unidea.
Pur essendo qui espressa in forma aforistica, lintuizione della filosofa pu essereassunta come segnalazione della strada lungo la quale incamminarsi. Non pretenderedi poter capire cosa sia la bellezza isolando questo concetto, ma al contrarioripristinare il contesto a cui esso appartiene, e senza il quale rischia di restareinintelligibile, o se non altro esposto a pesanti deformazioni. Di qui lesigenza divalorizzare la relazione costitutiva del bello col vero, il giusto e il bene, mettendo conci almeno provvisoriamente tra parentesi ogni accezione riduttivamente estetica.
Dalle parole della Weil emerge infatti una suggestione di ricerca, pi ancora che uncanone metodologico, di cui si sagger dora innanzi la plausibilit: esplorare imolteplici nessi che almeno originariamente collegano organicamente la nozione dibellezza ad una pluralit di lemmi con essa non immediatamente coincidenti, e taloraanche notevolmente distanti. Fino a scoprire che per lappunto questa peculiarit ilprimo e pi significativo principio di individuazione di ci che si soliti chiamarebellezza. E cio il fatto che il bello resta inafferrabile, oltre che indefinibile, ove se nepresupponga uno statuto autonomo, una sorta di realt intrinseca, perch invece essosi rivela allorch si manifesti la sua relazione costitutiva e insopprimibile con laltro das.
2. Per ricostruire sia pure sommariamente la genesi storico-concettuale della nozionedi bellezza, necessario risalire ad alcuni documenti letterari arcaici, nei quali
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
7/53
compare per la prima volta il termine greco kals. Gi in Saffo (fr. 34 V), nel cuore delVII secolo a.C., troviamo lespressione klan selnnan, nel contesto di un frammento digrande intensit: Stelle intorno alla bella luna/ di nuovo celano lo splendenteaspetto/ogni volta che, piena, risplenda sopra/la terra intera. Il contesto manifestacon evidenza la sostanziale equivalenza fra i due aggettivi attribuiti alla luna, e dunque il
fatto che essa possa dirsi klan e dunque bella non gi per un requisitoestetico, quanto piuttosto perch plthoisa, e cio piena. Ci significa che quellaluna pu dirsi klan, pu essere definita bella, proprio in quanto piena, proprioperch essa appare del tutto compiuta. Il plenilunio presumibilmente loccasione peresaltare la bellezza di una fanciulla-luna, che, irraggiando luce dal volto, offusca lecompagne-stelle, costringendole a nascondere il loro fulgido viso, come dinanzi auna compagna pi bella.
Una impostazione analoga ricorre, sia pure indirettamente, anche in altri due frammentidella poetessa di Lesbo, l dove la bellezza posta in relazione con leros Diconoalcuni che la cosa pi bella [klliston] sulla nera terra sia una schiera di cavalieri, altri difanti, altri di navi; io invece ci che uno ama [iratai] (fr. 16) , ovvero quando il venirmeno della bellezza, dovuto allavanzare della vecchiaia, rappresentato come unprocesso di graduale perdita dellintegrit giovanile: Ma il corpo giovane, una voltavecchio, ormai ha preso i capelli bianchi invece di scuri. [...] Di questo io mi lamento,ma cosa fare? (fr. 58).
La bellezza coincide dunque con una condizione nella quale non manca nulla. Siidentifica non gi con un requisito soggettivo come tale di principio opinabile econtrovertibile ma con una sorta di costituente oggettivo, come espressione dellapienezza, della compiutezza di ci a cui si attribuisce la caratteristica della bellezza.
bello ci che integro.
Accanto a questo aspetto costitutivo della bellezza nel contesto arcaico, gi in Omerocomincia a prendere forma un tema che trover la sua prima sistemazione inErodoto e Senofonte, vale a dire il rapporto fra il bello e il buono. Da notare,tuttavia, che, in particolare nellIliade, ci di cui ci troviamo in presenza spessolunione accidentale, se non lassoluta opposizione, fra bello e buono. Certamentebellissima, da questo punto di vista superiore alle venti donne scelte di Troia (IX, 139) Elena, la quale tuttavia non per ci stesso anche buona, come peraltro bella manon buona Clitemnestra. Anzi, pur essendo terribilmente somigliante a una dea perla sua bellezza, si auspica che Elena se ne vada via sulle navi e non resti pi a Troia,provocando la rovina degli abitanti della citt e dei loro figli (III, 156-60). Ancora piesplicita la disgiunzione fra bello e buono nella figura di Paride: bench sia idosriste, bello di aspetto, egli anche d!spari, un disgraziato: meglio sarebbe statoper lui non essere nato, o almeno non aver mai contratto matrimonio (III, 39).
Il contrasto fra la piacevolezza dellaspetto e la qualit morale fra tutte pi onorata,quale il coraggio, si ritrova anche nelle parole rivolte da Glauco a Ettore, allorch ilprimo esclama: Ettore, di aspetto sei bello [idos riste], ma vali poco in battaglia;vana la tua fama perch sei un vile (XVII, 142-43). Nei poemi omerici, non apparedunque ancora chiara la connessione fra la bellezza e la bont, anche se non vi
dubbio che, allorch si tratti di Achille, ci che viene maggiormente valorizzato la suaandria, la sua forza e il suo coraggio, pi che altre qualit attinenti al suo animo.
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
8/53
ristos il grado ultimo della bont, ma non quella dellanima, bens quella riferita alcorpo: la forza, la potenza, laudacia in guerra costituiscono anche la bellezza.
Per restare ad Omero, ritroviamo il termine kals impiegato anche in altre dueaccezioni, comunque irriducibi li a una valenza in senso stretto estetica. Bella ,
infatti, anche unimpresa che produca un utile per qualcuno (IX, 615), e bello ancheci che conveniente, come ascoltare chi parla, senza interromperlo (XIX, 178),ovvero anche rivolgere delle domande allospite, solo dopo che a lui si consentito diristorarsi con il cibo che gli stato offerto (Odissea, III, 69).
3. Il termine kals ritorna in una accezione molto simile a quella che abbiamo colto inSaffo anche in un contesto cronologicamente lontano dalla poetessa di Lesbo, non piin un testo lirico, ma in un documento storico, vale a dire nel famoso epitphios lgos,pronunciato da Pericle nella Storia del Peloponneso di Tucidide. Sottolineando lasuperiorit degli Ateniesi rispetto agli altri popoli dellEllade, lo storico afferma che ladifferenza va individuata soprattutto in due caratteristiche peculiari. Da un lato, infatti afferma Pericle noi amiamo ci che bello con un buon compimento[philokalomen met eutelias], mentre daltra parte noi amiamo il sapere senzamollezza [philosophomen neu malachas].
Come noto, nella formulazione impiegata da Tucidide si compendiano i principaliideali della vita culturale ateniese, imperniata su due forme distinte, eppure correlate,di phila: lamore per il bello e lamore per la conoscenza. Per quanto riguarda questosecondo aspetto, si pu notare, sia pure in questa sede soltanto di sfuggita, chelimpiego del verbo philosophin, nel contesto di un discorso in suffragio dei caduti inguerra, conferma ci che dovrebbe essere ormai largamente acquisito, e che invece
per lo pi ignorato dagli studiosi. E cio il fatto che, fino a tutto il V secolo a.C., non cisi trova mai in presenza di una accezione tecnica di philosopha (lattribuzione aPitagora una delle tante invenzioni fantasiose di Diogene Laerzio), che ritroveremoinvece esplicitamente argomentata nei Dialoghi platonici. Ma pi importante, almeno aifini della linea di ragionamento che si sta seguendo, concentrarsi su quella parte deldiscorso, nella quale si ricorda la philokala ateniese, vale a dire lamore per ci che kals.
Lamore per il bello indissolubile dalla eutelia, da un requisito che solitamente vienetradotto con senso della misura, o espressioni equivalenti. In realt, telios (cometlos) vuol dire essenzialmente compimento, sicch eu-telia significa letteralmente
buon compimento, e dunque perfezione, integrit, pienezza. Si pu alloraaffermare che, cos come lamore per la cultura connesso alla mancanza di ognimollezza, allo stesso modo si pu parlare di amore per il bello, solo a condizione checi sia congiunto con quel buon compimento, di cui dice la eutelia. Insomma, anchein questo contesto la bellezza indica quello stato al quale non manca nulla, esattamentecome la luna cantata da Saffo klan, in quanto piena.
Ma il lgos epithphios tucidideo consente di svolgere anche unaltra argomentazione,connessa al ragionamento fin qui abbozzato. Lorgogliosa rivendicazione dellasuperiorit degli Ateniesi, rispetto ai cittadini di altre pleis greche, principalmente
fondata sul possesso di alcune virt, le quali culminano con laret, vale a dire colvalore e la gloria conseguiti mediante la morte sul campo di battaglia. Ci significa che
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
9/53
le due forme di phila, esaltate quali segni di riconoscimento inconfondibili dellagrandezza attica, rinviano a un orizzonte etico, pi che a connotazioni in senso latoestetiche. Ne consegue che, pur declinandosi in forme diverse, lamore per ilbello, e lamore del sapere, appartengono a quella stessa tipologia di valori, a cuiappartiene to andrion il coraggio, inteso come qualit fondamentale dellanr,
cos come la vir-tus pertinente al vir. Per dirla in altri termini: lamore per il bello daparte degli Ateniesi non ha nulla a che vedere con una attitudine meramenteestetizzante, che poco e male poteva convenire a coloro la cui aspirazione dominanteera il klos, la gloria, conseguita tramite la morte sul campo di battaglia. Amare il belloe il sapere non cosa diversa dallamare il combattimento per difendere la propriapatria. Luno e laltro sono espressione di un medesimo atteggiamento, rivolto allatutela dellintegrit del territorio della plis o della buona forma a cui rinvia lanozione di kals.
Si comprende meglio, in questa prospettiva, ci che altrimenti potrebbe risultaresorprendente o incomprensibile, vale a dire per quale motivo nellepitaffio di Periclelindicazione delle due forme di phila sia accompagnata da alcune precisazioni che nespecificano il significato, circoscrivendolo accuratamente. Mentre, infatti, lamore peril sapere si esprime neu malachas, e dunque senza alcuna mollezza, poich nonsarebbe consona a chi affronta con andrion la difesa della propria patria, anchelamore per il bello ricalca lo stesso modello, coerente con questo ideale. Noncoincide, dunque, con una concessione alla degustazione di forme privilegiate, ma piuttosto un amore finalizzato, che interiorizza un tlos specifico, non in contraddizione,ma piuttosto congruente con i valori severi di colui che aspira alla gloria conseguentealla morte in battaglia. Di qui limprescindibilit delle precisazioni introdotte daTucidide: proteso principalmente ad assicurarsi il klos, la luce promessa a coloro
che sono pronti a sacrificare la propria vita in difesa delle patria, il cittadino ateniese altres animato da alcune forme di amore che sia pure in termini diversi noncostituiscono divagazioni, rispetto a quel progetto, ma sono piuttosto espressionedella medesima aret.
4. Daltra parte, le precisazioni addotte da Tucidide, allo scopo di chiarire quale sia lagenuina natura degli amori attribuiti agli Ateniesi, si prestano anche a un altro, e piimportante, ordine di considerazioni. Stando alla lettera dellepitaffio, infatti, si pu direche ci che peculiare dei concittadini di Pericle che essi non amano il bello per sestesso, ma soltanto se accompagnato da una buona finalit. Dove a differenza di
ci che abitualmente si tende a sottolineare laccento posto sulla eutelia, pi chesul philokalin. Ci che infatti differenzia gli Ateniesi da altre popolazioni dellEllade, eche concorre a consacrarne la superiorit, non il fatto che essi amino la bellezza, ma piuttosto il modo specifico con cui si esprime questa phila. Un modo che, in tuttaevidenza, esclude che il bello sia qualcosa che possa essere amato per se stesso,perch, esattamente allopposto, esso implica una forma di amore che porti con slesigenza di una finalit, senza la quale cos almeno pare implicito lamore per ilbello non potrebbe essere annoverato fra i valori peculiari che caratterizzano edistinguono i cittadini di Atene.
Emerge allora, in questo contesto, uno degli aspetti costitutivi dello statuto originario
della bellezza, riassumibile nella strutturale ambivalenza con la quale esso si propone,nella tensione fra due componenti diverse. Da un lato, infatti, come gi in Saffo, anche
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
10/53
secondo le indicazioni di Tucidide kals qualcosa a cui non manca nulla, al punto taleda comprendere anche un tlos, e dunque una finalit, verso la quale esso orientato.Dallaltra parte, la subordinazione della liceit dellamore del bello al fatto che esso siaaccompagnato da una buona finalizzazione lascia intravedere un assunto di granderilievo, secondo il quale il bello tale non per se stesso, ma se e solo se congiunto
con qualcosa che sia capace di conferire un senso una finalit, appunto a ciche, diversamente, non potrebbe essere giustificato. In altre parole, affinch il bellopossa sussistere, necessario che esso rinvii ad altro da s. In particolare, perritornare al discorso pronunciato da Pericle, merito degli Ateniesi aver compresoche, cos come lamore per il sapere positivo se prescinde da ogni mollezza, allostesso modo lamore di ci che bello un valore fondante, se non si risolve in sestesso, ma implica una apertura verso altro.
5. Oltre a ci che si fin qui osservato, lepitaffio tucidideo consente di introdurre unulteriore, e decisivo, tema connesso alla concezione della bellezza nel mondo grecoantico. Come gi si accennato, le due forme di phila menzionate da Periclearticolano, specificandola, una attitudine pi generale, che trova il suo principalebaricentro nellesaltazione dellaret guerriera. A sua volta questa virt non pu essereassimilata a un abito, o comunque al possesso di una disposizione stabile. Essaemerge, infatti, nel fuoco vivo della battaglia, sul campo di combattimento. Pi ancorache con un particolare talento guerresco, o con lesibizione di una forte dose dicoraggio, essa coincide in realt col momento supremo della morte. Kal,intensivamente bella, la morte con le armi in pugno, cadere in difesa della patria.
Ci si imbatte, a questo riguardo, in una delle concezioni al tempo stesso pi tipiche, eper molti aspetti sorprendenti, della cultura greca arcaica e classica, secondo la quale
fra le molte cose alle quali possibile attribuire appropriatamente il termine kals unposto eminente va riconosciuto precisamente alla morte.
Una prima testimonianza di questa concezione proposta da Omero, in un passaggiomolto suggestivo, oltre che estremamente eloquente, dellIliade: Quando un giovanemuore, ucciso in battaglia, e giace a terra straziato dalle acute armi di bronzo, tutto a luisi addice, tutto quello che si vede di lui, anche se morto, bello (XXII, 71-73). Ma undocumento non meno significativo, ancorch apparentemente indiretto, pu essereindividuato anche in un passaggio delle Storie di Erodoto.
6. Avendo lasciato il suo paese, Solone si rec in Egitto presso Amasi e poi anche a
Sardi da Creso. Quivi giunto, fu ospitalmente accolto dal re nella reggia. Due o tregiorni dopo il suo arrivo, per ordine di Creso stesso, dei servi condussero Solone perle sale del tesoro e gli mostrarono che tutto era splendido [megla] e fastoso [lbia].Dopo che Solone ebbe visto e osservato le straordinarie ricchezze possedute daCreso, questi gli pose una domanda: Ospite di Atene, poich giunta fino a noigrande fama di te, della tua saggezza e dei tuoi viaggi, che cio per amore del sapere[philosophon] tu hai con cura visitato gran parte della terra, ora mi venuto ildesiderio di domandarti se tu hai gi visto un uomo, che sia il pi felice [olbitaton] delmondo (Storie, I, 30). Formulando questo interrogativo, il re sperava segretamente diessere indicato come il pi felice fra tutti gli uomini. Ma Solone, astenendosi da ogni
piaggeria, e restando invece aderente alla verit, rispose che s, riteneva di averincontrato luomo fra tutti pi felice, e che costui si chiamava Tello ed era di Atene.
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
11/53
Richiesto da Creso di spiegare i motivi di questa indicazione, il saggio legislatorerispose che erano essenzialmente due le ragioni che lo inducevano a ri tenere Telloluomo pi felice. La prima era che, avendo avuto dei figli belli e buoni [kali tekagathi], di tutti vide venire al mondo i figli e tutti rimanere in vita. A Tello, dunque,sarebbe stata risparmiata lesperienza che poteva essere considerata fra tutte la pidolorosa, vale a dire quella di sopravvivere alla morte di un figlio esperienza che,secondo la tradizione, avrebbero patito fra gli altri Pericle e Anassagora. Mortigli [aPericle] nel giro di appena otto giorni i figli giovinetti e belli ne sopport la perditasenza dare segno di lutto. Giacch egli perseguiva la serenit dellanimo, e ne avevagrande aiuto (Protagora, B 9 = Cons. ad Apoll. 118 E). Annunziatagli [adAnassagora] la morte del figlio, non mut volto e disse: Sapevo di averlo generatomortale (Galeno, Opinioni dIppocrate e di Platone, IV p. 392 M.).
Per ritornare a Tello, il primato a lui attribuito da Solone si spiegherebbe col fatto cheessendo gli Ateniesi impegnati in una battaglia a Eleusi contro i loro vicini, egli,
accorso sul campo e costretti i nemici alla fuga, mor nel modo pi bello [apthanekllista]. Come sottolinea Jean-Pierre Vernant, rifiutando la vita lunga, e nel contempovotandosi alla guerra, alla grande impresa e alla morte, leroe cerca di assicurarsi lostatuto di morto glorioso di morto di bella morte, dicono i Greci perch non vi altro modo, per una creatura mortale, per inscrivere per sempre il proprio nome, leproprie gesta, il corso della propria vita nella memoria dei posteri. Per leroe la vita haun unico orizzonte: la morte in combattimento. Solo questa morte gli d pieno accessoallo stato di gloria. Nella bella morte leccellenza cessa di doversi misurareindefinitamente con gli altri, di doversi provare nello scontro: si realizza di colpo e persempre nella prodezza che pone fine alla vita delleroe.
La felicit, dunque, non consiste nel possesso di ricchezze smisurate, quali quelle checon impudica vanagloria Creso aveva esibito a Solone, quanto piuttosto in due aspettialmeno in apparenza molto pi umili e molto meno significativi, quali sono il morireprima della propria discendenza, e lacquisire la bella morte, quella che possibileguadagnare per s morendo in difesa della propria patria.
Ancor prima che si consolidi la tradizione dei lgoi epitphoi, come quello di Pericleriferito da Tucidide, sono i poeti a cantare la bellezza della morte, quando essasopraggiunga in battaglia: onore splendido combattere i nemici, difendere la terra,la sposa, i figli. La morte verr allora, quando le Moire la fileranno (Callino, II, 2-4).
Pallade Atena mai rimprover il suo aspro coraggio, quando in prima fila si spingevanella lotta della guerra sanguinosa sotto i colpi acuti dei nemici. Di lui mai non vi fusoldato pi valoroso a compiere imprese nella violenta battaglia, quando ancora vivevanel raggio veloce del sole (Mimnermo, 14, 5-11). La morte bella [tethnmenai garkaln] quando il prode combatte in prima fila e cade per la patria (Tirteo, 10, 1-2). gloria comune questo, per la citt e il popolo, un uomo che resti in prima fila saldo,senza tregua, e non conosca la vergogna della fuga e offra la sua vita... Perde la vitacadendo in prima fila gloria per la citt, il popolo, il padre col petto trafitto, e loscudo umbilicato e la corazza... Mai la sua nobile gloria svanisce e il suo nome, e sottola terra immortale, se mai, primeggiando in battaglia per la terra e per i figli, violentoAres lo uccida (Tirteo, XII, 15-34).
evidente, daltra parte, quale sia il presupposto che soggiace alla tematica della
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
12/53
bella morte: non la vita in se stessa deve essere considerata comunque un bene, mapiuttosto essa pu essere ritenuta tale solo a determinate condizioni. Poich infatti come ripete unantica ghnme, e poi una ininterrotta tradizione che su di essa fa perno,meglio per luomo sarebbe non essere mai nato, la morte pu essere perfinodesiderata, e comunque si pu aspirare a che essa sia bella, evitando ci che della
morte considerato peggiore. Come sar confermato anche da Platone (Simposio,179 a-b) e da Aristotele (Retorica, I, 3, 1359 a 5), bella sar la morte conseguitacoprendosi di klos sul campo di battaglia.
Che la morte non debba essere considerata un esito negativo, o peggio ancora comeuna deprecabile punizione, ma che al contrario essa possa essere assunta come unasorta di premio, concesso a quanti abbiano benemeritato nel corso della loro vita,risulta confermato dallo sviluppo ulteriore del racconto erodoteo. Difatti, sebbenedeluso dalla prima risposta fornita da Solone, nella convinzione di poter almeno ambireal secondo posto, Creso insiste nel voler sapere chi altri, a parte Tello, debba essereannoverato come il pi felice della terra. Anche a questo proposito, tuttavia, i l saggioateniese risponde attenendosi esclusivamente a ci che egli ritiene vero, senzapreoccuparsi di compiacere il sovrano di Sardi. Felici, almeno della relativa felicitconcessa alluomo, debbono essere considerati Cleobi e Bitone.
Celebrando gli Argivi la festa di Era, la madre dei due giovani, provvisti di unastraordinaria vigoria fisica, oltre che di sufficienti mezzi per vivere, dovevaassolutamente essere condotta al tempio su un carro, bench non fossero disponibili ibuoi da aggiogare. Allora i giovani di slancio si posero essi stessi sotto il giogo,trascinando il carro per 45 stadi, fino a condurre la madre davanti al santuario. Grata epiena di gioia per questa impresa, e orgogliosa per le lodi che sentiva intorno, la
madre stando ritta davanti alla statua divina preg la dea che ai suoi figli Cleobi eBitone, che lavevano grandemente onorata, concedesse ci che un uomo puottenere di meglio. In seguito a questa preghiera... i due giovani, che seranoaddormentati nel santuario stesso, non si rialzarono pi, ma in questo modo morirono.Quale intermezzo del racconto, lo stesso Solone a indicare linsegnamento insitonellesempio citato. A Cleobi e Bitone toccata la miglior fine della vita, perch nelloro caso la divinit fece chiaramente comprendere che meglio per luomo essermorto, piuttosto che godere la vita.
7. Pnta gar kair kal (Sofocle, Edipo re, 1516). Nella sua lapidariet, questaaffermazione ricorrente talora in una forma leggermente modificata in numerosi altritesti, precedenti, coevi o successivi rispetto alla tragedia sofoclea istituisce unarelazione molto precisa fra i due termini kals e kairs. Il significato della sentenza chiaro: tutto ci che bello, tale se accade nel momento opportuno. Una sfumaturadifferente si pu cogliere in unaltra possibile traduzione ogni cosa a suo tempo nella quale tuttavia viene di fatto a mancare proprio quel kal che al centro dellanostra ricerca. Un punto fondamentale resta tuttavia assodato. La ghnme stabilisceuna stretta connessione, tale per cui lessere kals non una qualit assoluta, ma piuttosto la conseguenza di una relazione con ci che kairs. Non vi un bello ins, indipendente da ogni circostanza temporale. Affinch si possa parlare di bello, necessario che esso intervenga al momento opportuno.
Come noto, nel mondo greco antico erano in uso quattro designazioni diverse per
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
13/53
indicare il tempo. Oltre al tempo come chrnos, come misura del divenire, comesuccessione lineare e irreversibile, si parlava anche del tempo come ain, vale a direcome durata, per lo pi impiegato per riferirsi alleternit dei cieli o degli dei, il tempocome eniauts o grande anno, vale a dire un periodo di lunghezza variabile (per lopi, nove anni o multipli), al termine del quale il corso degli avvenimenti ricominciava da
capo, e infine il tempo come kairs, termine difficilmente traducibile in una linguamoderna, poich con esso si alludeva al momento buono, a ci che si pu farcoincidere con lattimo immenso, del quale parler Nietzsche. A differenza delle altredeterminazioni temporali, le quali si riferiscono pi o meno esplicitamente a unaaccezione quantitativa del tempo, il kairs evoca una dimensione eminentementequalitativa.
Ne troviamo una testimonianza particolarmente significativa, pi ancora che in testi dicarattere filosofico o letterario, nella ricca produzione iconografica antica, e poi anchein quella rinascimentale e barocca. Il kairs compare infatti come un giovane dibellaspetto, provvisto di ali o di calzari alati, per lo pi seminudo o ignudo, con unacaratteristica che lo rende inconfondibile, rispetto ad altre possibili immagini simili. Egliesibisce, infatti, un folto ciuffo di capelli che gli ornano la fronte, mentre la nuca sipresenta completamente calva. A sottolineare che, quando lo si incontra, necessarioessere lesti nellafferrarlo per la chioma fino a che ci fronteggia, perch se ciattardiamo anche di poco, e cerchiamo di afferrarlo dopo che ci ha sorpassato, nonabbiamo pi la possibilit di farlo. Di qui anche una delle possibili (per quanto sempreparziali e imprecise) traduzioni, secondo le quali il kairs indica lattimo fuggente,cos come, dopo lincontro fortuito, rapida la scomparsa del giovane dal nostroorizzonte.
In questa prospettiva, si pu allora comprendere pi adeguatamente quali siano leimplicazioni del nesso fra il kals e il kairs. La bellezza non un requisito stabile epermanente, non appartiene intrinsecamente a qualcosa un volto, un paesaggio,unopera dellarte o dellingegno ma collegata piuttosto a quella sorta di momentomagico incarnato nel kairs. Leggendo per cos dire a ritroso la sentenza sofoclea, sipotrebbe allora affermare che non vi bellezza al di fuori di quella dimensionetemporale specificamente qualitativa nominata col termine kairs.
8. Riferisce Pausania (Periegesi della Grecia, V. 14. 9), che allingresso dello stadio diOlimpia vi erano due altari. Il primo di essi era chiamato laltare di Hermes, laltrolaltare di Kairos. La statua di bronzo che raffigurava colui che era noto come il pigiovane fra i figli di Zeus era la pi bella fra tutte le statue che ornavano lo stadio, alpunto che si racconta che quanti si trovavano ad ammirarla restavano a lungo immobilie senza parole, affascinati dal suo magnetismo. In questo archetipo figurativo,compaiono alcuni tratti che ritorneranno poi regolarmente nelle raffigurazioni dellartemoderna, con un significato non equivocabile. Dotato di un corpo bellissimo, Kairos rappresentato sulla punta dei piedi in bilico su una sfera, a sottolineare laleatorietdella sua condizione. Importante soprattutto un dettaglio riguardante i capelli radi equasi assenti sulla nuca, e estremamente folti e movimentati sulla fronte. Come gi si accennato, questo particolare verr poi ulteriormente sottolineato nelliconografiarinascimentale, quando il ciuffo sulla fronte e la calvizie nella parte posteriore del cranio
diventeranno il principio di individuazione di Kairos. Quasi a dire che possiamoafferrare il momento opportuno quando ci viene incontro, ma se non siamo
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
14/53
abbastanza rapidi e lasciamo che ci sopravanzi, non abbiamo pi la possibilit diprenderlo. Infine, come gi sottolineava Callistrato (Descrizioni, 6), lo splendore dellabellezza di quella statua stava a indicare che Kairos allorigine di tutto ci che bello,mentre a lui alieno ogni segno di invecchiamento o di deterioramento.
Il campo di applicazione del kairs nella Grecia classica comprende ambiti diversi,dalla medicina alla politica, dalla strategia alla retorica. Secondo i sofisti, ad esempio,il kairs consisteva nella capacit di un oratore di cogliere le sottigliezze di unasituazione retorica, traendone vantaggio. Cos, ad esempio, il sottotitolo del trattato diGorgia sulla retorica Sul kairs, proprio perch il sofista ritiene che la parola possasprigionare una forza insospettata, se usata in circostanze e modi opportuni: Laparola una potente signora che, pur dotata di un corpo piccolissimo e invisibile,compie le opere pi divine.
Ma lattenzione alla peculiarit delle situazioni, come strumento essenziale perraggiungere i risultati ricercati, accomuna la retorica a unaltra disciplina, sviluppatapresso la scuola di Cos, vale a dire la medicina. Esercitare bene larte medica vuoldire, infatti, non proporre sempre lo stesso tipo di cura indistintamente a tutti coloro chedenunciano gli stessi sintomi, ma saper piuttosto adattare la cura a circostanze esoggetti diversi. Cos come Ulisse archetipo di una retorica fondata sul kairs pol!tropos, e cio in grado di utilizzare diversi modi di espressione intorno alla stessacosa, adattandosi a condizioni particolari, allo stesso modo pol!tropos dovr essereanche il medico che sappia cogliere il momento e la forma pi opportuni per il propriointervento terapeutico. Il kairs assume cos la forma di un sapere che si adatta allecircostanze, e assume conseguentemente forme diverse, rinunciando alla rigiditapodittica dellepistme.
Che la medicina rappresenti il campo dazione pi adatto per il kairs confermatoanche da Aristotele, a partire dal riconoscimento della singolarit e della differenza trale persone e quindi tra i casi, ognuno dei quali richiede un trattamento particolare: [...]ci che riguarda le azioni e ci che utile nella vita non ha nulla di stabile, cos comeci che riguarda la salute. Ed essendo di tal sorta la nostra trattazione in generale,ancor minor precisione pu avere la trattazione riguardante i casi particolari; essi infattinon rientrano in nessuna conoscenza tecnica e in nessuna regola fissa, ma bisognasempre che proprio chi agisce esamini lopportunit (kairs) delle circostanze, come sifa anche nella medicina e nella navigazione (Etica a Nicomaco II, 2, 1104 a).
9. Quale che sia il terreno sul quale possibile inquadrare nella maniera pi adeguatail concetto di kairs, un punto resta comunque acquisito. Ci che i Greci chiamavanokals, e dunque non soltanto il bello in senso riduttivamente estetico, ma unanozione complessa, nella quale convergono aspetti e significati diversi, eraconsiderato indissolubile dal kairs. Si potrebbe parlare, infatti, di una sorta di doppiolegame. Da un lato, affinch si possa dire di trovarsi in presenza del bello necessario che esso accada non in un tempo qualunque, quantitativamente definito,ma sia piuttosto in connessione con quella accezione qualitativa di temporappresentata dal kairs. Dallaltra parte, esplicitando le implicazioni della ghnmequale compare nellEdipo re e in altri luoghi, si pu affermare che tutto ci che
appartiene alla dimensione kairologica di per s kals. Tutto ci vale a ribadirequanto in precedenza si gi accennato, vale a dire che nel mondo greco arcaico, ma
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
15/53
anche per molti aspetti in quello dellet classica, la bellezza non si presenta come unvalore assoluto, tale da poter essere apprezzato indipendentemente da ogni altrarelazione, poich invece essa rinvia a una specifica dimensione temporale, especificamente a quel momento opportuno, di cui appunto dice il kairs. Tutto ciimplica che, in una certa misura, la bellezza non possa essere considerata come un
dato relativamente permanente, inerente a un oggetto, a un volto o a un qualunquecontenuto della visione, perch essa viceversa dipendente dal fatto che talecontenuto si offra alla visione a tempo debito. Quello stesso corpo, trafitto dalle armi dibronzo, sfuggir allorrore della decomposizione, e anzi potr apparire kals, se la suamanifestazione avverr in quella dimensione kairologica che costituita dalcombattimento per la salvezza della patria.
Anche per questa via, insomma, risulta ulteriormente confermato un aspetto gi pivolte enunciato. Per luomo greco, pi che nei termini di un requisito meramenteestetico, e per ci pertinente allambito della sensibilit, la bellezza si esprimesempre nel suo rinvio ad altro: allintegrit della forma, alle qualit morali della andria,ovvero alle opportunit di una variante qualitativa del tempo. Essa allude, quindi, aci che non c, o almeno non direttamente visibile, anzich a ci che pu essereoggetto di una visione sensibile diretta.
10. Solo nella prospettiva ora delineata si pu allora comprendere meglio il significatodi un frammento, destinato altrimenti a restare pressoch inintelligibile. Come potrebbedirsi bellissima [klliste] larmonia che risulta da cose discordanti[diaphermenon] (Heracl. B 8, Diels-Kranz), se la bellezza fosse identificata conlideale estetico dellequilibrio delle forme e della mancanza di ogni tensioneconflittuale? Mentre ci a cui Eraclito intende alludere per lappunto quella bellezza
al grado superlativo che si esprime mediante lapertura di una non ricomponibiledivergenza. Potr accadere che gli uomini non comprendano fino in fondo in qualemodo discordando da se stesso [diaphermenon] con se stesso concordi [eoutomologhin] (B 51, Diels-Kranz), e con ci non siano in grado di coglierequellarmonia che da un estremo ritorna allaltro estremo [palntropos harmone]. Ma loscarto fra lopinione dei mortali e il sapere degli dei si manifesta anche nel fatto chementre per la divinit tutte le cose sono belle [pnta kal], buone e giuste, per gliumani alcune di esse sono giuste, altre ingiuste [B 102, Diels-Kranz].
Bella anzi, bellissima larmonia. Ma essa non cancella le opposizioni e icontrasti, perch anzi di essi si alimenta, al punto che senza le divergenze neppurepotrebbe sussistere. Ma c di pi. Cos concepita, larmonia non coincide affatto conci che pu essere visto. Come esplicitamente afferma lEfesio, infatti migliore[krsson] larmonia invisibile [aphans], rispetto a quella visibile [phaners] (B 54,Diels-Kranz). A rivelarsi bellissimo, nei lacerti eraclitei giunti fino a noi, non dunqueci che cade sotto i sensi, in particolare sotto il senso della vista, ed percimanifesto. Ma qualcosa che, allopposto, resta invisibile, al punto che spesso gliuomini non sono in grado di comprenderlo. Come la natura [ph!sis] ama celarsi [B123, Diels-Kranz], allo stesso modo la bellissima armonia che consegue dallincontrofra gli opposti qualcosa che resta aphans, celato alla vista.
Ci si potrebbe spingere ad affermare che la bellezza la vera bellezza, quella che siriferisce allharmone non soltanto non coincide con alcuna qualit sensibile, ma si
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
16/53
definisce piuttosto per differenza, rispetto alla sensibilit. Bello ci che restainvisibile, mentre quanto appartiene ai sensi rappresenta il campo dellopinabile, di ciche ad alcuni appare bello e ad altri brutto.
Affiora a questo proposito una importante convergenza con ci che lOscuro scrive a
proposito del sapere. Cos come laver imparato molte cose non insegna ad avereintelligenza [B 35, Diels-Kranz] perch, al contrario, il mero sapere enciclopedico fa dicolui che lo possegga un inventore primo di inganni [B 126], allo stesso modo non nella dispersione nella molteplicit delle cose visibili che si potr ritrovare quellabellissima armonia che per la sua stessa natura deve restare non manifesta.
11. Fra lVIII e il V secolo fra Omero e Tucidide alla sua prima comparsa nellatradizione culturale dellOccidente, il concetto di bellezza, e pi specificamente iltermine col quale essa viene originariamente indicata, non coincide con requisiti pi omeno direttamente riconducibili allambito della sensibilit, non indica una qualitnettamente distinguibile, rispetto a connotati pi specificamente pertinenti allambitodella morale. Come gi si visto, la gamma di applicazioni del termine kals altempo stesso molto estesa e accentuatamente diversificata. Bello pu essere ciche integro, ci che in se stesso compiuto, ci che reca in s il proprio tlos. Mabello anche il temperamento coraggioso, latteggiamento virile del combattenteardimentoso. E bella pu essere anche la morte, ove essa ci colga nellatto didifendere la patria, battendosi per i valori in essa incarnati.
Fra tutte, laccezione forse pi pregnante della nozione arcaica di bellezza quella chene riconosce lintima appartenenza con quella dimensione qualitativa del tempo che siesprime nel momento buono del kairs. Questa connessione, infatti, revoca ogni
pretesa autonomia della bellezza, nella misura in cui la ricongiunge a una scansionetemporale che resta imprevedibile e per certi aspetti perfino insondabile. Se kalssolo ci che accade nel kairs, se la bellezza ci che balena fugacemente nel rapidopassaggio di un giovane calvo nella nuca e con la fronte ornata da un folto ciuffo dicapelli, allora essa non potr che apparire come un evento, pi che come un connotatoimmanente alle cose che si dicono belle.
Nel mondo greco antico persiste per un lungo periodo, almeno fino al IV secolo, ladistinzione fra la sfera del bello e quella che riguarda propriamente larte, nel senso cheil kals conserva un fondamento ontologico, di per s non necessariamente implicatonel contesto artistico. In particolare, resta a lungo dominante il legame fra bello e
buono, gi evidente nel termine kalokagatha che tiene insieme laspettoestetico e quello etico. Luomo in grado di esprimere la sua bellezza, oltre chenella proporzione delle forme fisiche, anche nella dignit dei comportamenti pratici, alpunto che queste due attitudini risultano essere inseparabili. Come risulta fra laltro dalfatto che nelletimologia del latino bellus, da cui deriva litaliano bello, si rileva undiminutivo di bonus (dwenos "dwenolos "benlos).
Daltra parte, i molti sensi, e le numerose intersezioni concettuali, che caratterizzano laconcezione originaria della bellezza, ne evidenziano anche un aspetto di grandeimportanza, fin qui non ancora abbastanza messo in risalto. Il fatto che kals non sia
qualcosa che stia per s, ma piuttosto ci che strutturalmente rinvia ad altro (albuono, al virtuoso, al perfetto, al tempo propizio ecc.) implica che la bellezza
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
17/53
stessa non si presenti come univoca, ma allopposto si manifesti nella sua costitutiva einsuperabile duplicit. Come si vedr pi avanti, la strutturale ambivalenza del bello, ilsuo non poter essere soltanto uno, la sua ineliminabile eccedenza, affonda le sueradici nella coalescenza di significati, con i quali esso gi presente nelle originigreche della tradizione culturale dellOccidente.
2. Amore e bellezza in Platone
1. Questo pi difficile da capire. Cos afferma Platone riferendosi al termine kaln,subito dopo aver definito il brutto to aischrn come ci che arresta il divenire(Cratilo, 415 a-b). Da notare che, a conferma del legame non occasionale nmarginale che, nel modo greco antico, connette la sfera della bellezza con quelladella bont, il ragionamento platonico sul binomio kaln-aischrn segueimmediatamente la trattazione del rapporto che intercorre fra il vizio [kaka] e lavirt [aret].
Nel dialogo che stiamo esaminando, la prima risposta fornita allinterrogativoriguardante cosa sia to kaln che esso sia quasi un soprannome del pensiero[eponyma tes dianoas]. Ci perch argomenta Platone ci che ha dato nome allecose [to kalsan] e ci che d loro il nome [to kalon] appunto il pensiero, sia esso ilpensiero degli dei, o quello degli uomini o di entrambi. E come avviene a proposito dici che adatto a costruire e con ci che si presta a curare, dai quali si ottienerispettivamente una costruzione e una cura, allo stesso modo si pu affermare che tokalon, vale a dire ci che d il nome, compie kal, e cio cose belle. Se nededuce che kaln sia una sorta di soprannome del pensiero che compie cose diquesto genere che noi abbiamo care quando diciamo che sono belle [416, d-e].
Come ormai ampiamente assodato, le etimologie proposte nel Cratilo noncorrispondono a intenti filologici, e non presumono dunque di ricostruire ltymonautentico dei termini via via considerati, essendo principalmente teoretico linteresseche alla base della ricognizione compiuta da Platone. Daltra parte, certamente nelcaso del termine kaln, ma anche in altri casi, ancorch limitati nel numero, lagenealogia suggerita dal filosofo appare meno fantasiosa di quanto si potrebbe aprima vista immaginare. Colpisce, infatti, da un lato la connessione ribadita fra ilconcetto di bello e quello di virt, trattato immediatamente prima (a confermadelloriginaria coalescenza fra lambito etico e quello che si chiamer poi estetico),e dallaltro lato lo spunto mediante il quale il kaln ricondotto al pensiero, del quale indicato come eponimo o soprannome. Kal sarebbero dunque le cose cherisultano quali prodotti del pensiero.
Ma vi un secondo, e non meno importante, ordine di considerazioni, suggerite dalbrano del Cratilo dal quale siamo partiti. La derivazione del kaln dal kalin, e dunquedal chiamare, allude a unaccezione del concetto di bellezza per molti aspetti nuova,e destinata a trovare pi ampio sviluppo in altri testi platonici. Essa si identificherebbe,infatti, con qualcosa che chiama, nel senso specifico che in-voca a s, attrae oltre iconfini di una dimensione che si tratta di superare. In questa prospettiva, per quantoappena adombrata nel Cratilo, bello ci che chiama a valicare un limite, rimanendo
nel quale lesistenza sembra priva di qualcosa dessenziale, incompleta.
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
18/53
In altre parole, siamo chiamati dal bello, da esso siamo con-vocati, e perci indotti aprocedere al di l dei confini dettati da una condizione umana intrisecamentedeficitaria. Colui che resista a questo richiamo, chi si dimostri insensibile alla voce delbello, rester inevitabilmente prigioniero di una irrimediabile parzialit, recluso in unorizzonte angusto e limitato. Gi si intravede, in questi accenni, ci che si avr modo di
cogliere in maniera pi dispiegata in seguito, e cio che la bellezza pu agire comephrmakon in grado di curare anche se non di guarire ci che affligge lesistenzaumana.
Daltra parte, il collegamento istituito nel Cratilo fra la bellezza e il pensiero essendola prima un soprannome del secondo conferma, sia pure indirettamente, ci che inprecedenza si gi argomentato, e cio che la nozione originaria di kaln non riducibile a un connotato meramente estetico, limitato dunque al piano dellaisthesis, della sensazione, ma coinvolge un livello pi elevato di rapporto con larealt, in quanto coincide, come altro nome, con la dinoia, e dunque colragionamento, o pi esattamente col pensiero discorsivo. Si comprende allora, nellaprospettiva appena delineata, per quali motivi in Platone si espliciti, e si esprima informa pi compiuta, quanto gi era balenato nel riferimento ai testi della culturaarcaica, nei quali la bellezza non mai isolabile da un pi ampio contesto di carattereetico e ontologico.
Vi , infine, un ulteriore e conclusivo aspetto, riguardante il significato originario di kaln, sul quale ha attirato in particolare lattenzione Hannah Arendt. Nel mondo grecoantico, la bellezza presuppone una dimensione che procede oltre i confini dellikos,che dunque altra rispetto a quelle mura di casa, entro cui si provvede solo alnecessario, rappresentato dalle condizioni materiali della vita. Per definizione, il
bello presuppone la libert intesa come affrancamento dai bisogni elementari, comepossibilit di accedere al centro della polis, a quello spazio politico, rappresentato dallagor, nel quale le potenzialit umane possono trovare la loro completa realizzazione.In questo senso, la bellezza fa tuttuno con una accezione della libert che comprende,come sua condizione interna, il necessario, ma al tempo stesso lo trascende, coscome la vita biologica presupposto necessario, ma non sufficiente, dellideale grecodellu zn, del vivere bene.
2. Vi dunque, immanente alla nozione stessa di kaln, qualcosa che chiama [kali] una voce, un ri-chiamo, in ogni caso un rinvio ad altro. In presenza del bello, insomma,ci sentiamo chiamati a non accontentarci di ci che ci dicono i sensi, ma siamoinvece spinti ad andare oltre, a cercare ci di cui ci che si manifesta solo un indizio.Kaln kalin, il bello chiama a non sostare sul piano della sensibilit, andando al di ldelle apparenze. Si ripropone, a questo proposito, un paradosso al quale si giaccennato in precedenza. Quella bellezza che, nellet moderna, verr indicatacome loggetto privilegiato dellestetica, e cio di ci che attiene alla isthesis, edunque alla sensazione, originariamente agisce come voce che invita alsuperamento del livello meramente sensibile, alla ricerca di un altro, e pi adeguato,piano di realt.
ancora Platone a indicare le tappe principali di questo percorso. Chi vuol giungere
a questo termine... deve cominciare fin da giovane ad andare verso i corpi belli; e,dapprima, se chi lo guida, lo guida bene, amare un corpo solo e in quello generare
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
19/53
discorsi belli; poi, venire a comprendere che la bellezza che in un qualunque corpo sorella di quella che in un altro e che, se bisogna tener dietro al bello che nelleforme visibili, sarebbe come non intendere nulla non ritenere una e identica la bellezzache in tutti i corpi (Simposio, 210 a-b). Ma quella appena descritta solo la primatappa di un processo non breve n scevro di difficolt.
Una volta compiuto il primo passo, si tratter infatti di diventare amanti di tutti i corpibelli, smorzando di conseguenza la tensione che in precedenza era concentrata su unsolo corpo, e poi comprendere che la bellezza che nelle anime degna di maggioreconsiderazione, rispetto a quella che nei corpi. Di qui sar necessario passare a ungradino ulteriore, guardando il bello che si pu ritrovare nelle varie forme dellattivitumana, e soprattutto nella legislazione, e quindi anche rendendosi conto di qualepiccola cosa sia il bello che proprio dei corpi, rispetto a quello che risplende nelleleggi.
Il cammino rivolto alla ricerca della vera bellezza prosegue lasciandosi guidare acogliere il bello che nelle scienze, rispetto al quale scoloriscono quelle formeparticolari di bellezza che sono costituite dallaspetto di un fanciullo o di un uomo. Finoa giungere alla visione di quello che si pu chiamare to pol!plagos tou kalo ilgran mare del bello, dalla cui contemplazione scaturisce lamore per una sapienzache ha come oggetto una bellezza ancora pi grande. Ci che viene delineato dunque un itinerario, un attraversamento di gradi e forme diverse di bellezza, cheprende le mosse da quella manifestazione di essa che cogliamo nei bei corpi, perascendere fino a una vera e propria scienza [epistme] di una bellezza superiore atutte quelle accessibili tramite la sensibilit.
Il punto di arrivo, che tuttavia non conclude definitivamente il dinamismo n lo arresta,ma segna la meta mai definitivamente acquisita della ricerca, un tlos capace diorientarla, pur senza estinguerne la spinta, sar una bellezza [kaln]... meravigliosa...:bellezza eterna, che mai non nasce e mai non muore n cresce n scema, che non inparte bella e in parte brutta, n ora s, ora no; n bella sotto certi rapporti e bruttasotto certi altri, n bella qui e brutta l (ibid., 210 e-211 a). Con queste caratteristiche,to kaln non raffigurabile come qualcosa che abbia un volto o altro di ci che uncorpo possa avere, perch esso piuttosto ununica forma, che in s e per s, e cheperci non nasce e non perisce, non muta n in pi n in meno.
Per far comprendere in che cosa consista la bellezza, Platone non indica un concetto
definito, ma descrive piuttosto un processo, una graduale ascesa che muove dallamolteplicit delle cose belle, per tendere ad un fine mai compiutamente n stabilmenteraggiungibile. Questo il modo giusto di procedere: cominciando dalle bellezze diqui, nella mira di quella ultima bellezza, ascendere sempre, come da un gradinoallaltro, fino a conoscere quella che codesta bellezza essa stessa in s (ibid.,221 c). Con una precisazione fra le altre fondamentale. Litinerario raccomandatonon corrisponde semplicemente al soddisfacimento di unesigenza marginale oestrinseca. Se vi un bos che possa essere considerato biots, se vi qualcosa cherenda la vita degna di essere vissuta ebbene questo theomno aut to kal,contemplare la bellezza in s (ibid., 211 d). La molla che sospinge a intraprendere
lascesa verso la bellezza non dunque la mera degustazione sensibile, i lconseguimento di un piacere limitato ed effimero, ma lo sforzo per elevarsi a ci che di
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
20/53
pi importante e di pi nobile vi sia nella nostra vita, di ci senza cui essa nonmeriterebbe neppure di essere vissuta. Ci perch, come gi si legge nellApologia,una vita senza ricerca non degna di essere vissuta (38 a).
Ma la rivelazione fatta a Socrate dalla xne di Mantinea non ancora conclusa. Il
tragitto finora delineato conduce per cos dire alle soglie dellesito finale, senza tuttaviache esso sia stato ancora esplicitamente indicato. necessario un ultimo e decisivopassaggio, attraverso il quale lascesa potr giungere al suo compimento. Non sitratter pi di contemplare metalli preziosi, vesti splendide o bei giovinetti, ma piuttostodi contemplare to kaln puro, schietto, non misto, non involto di carni umane n dicolori e daltra vana frivolezza mortale. Insomma, una bellezza divina [thion kaln](Simposio, 212 a), vista nellunit della sua forma, dalla quale mai distogliere losguardo. Solo in questo modo, solo guardando la bellezza con ci per cui essa visibile, e cio con locchio dellanima, alluomo accadr di partorire virt vera,perch virt che con la verit a contatto [tos alethos ephaptomno]. Cosfacendo, infine, si potr dire che non soltanto egli non vive una vita da nulla ma, alcontrario, che diventer caro agli dei, guadagnando una condizione assai simile aquella della immortalit.
3. Come gi si accennato, lexcursus platonico sulla bellezza contenuto nel dialogoin cui si racconta del banchetto svoltosi a casa di Agatone, e in particolare dellacerimonia simposiale alla quale parteciparono, fra gli altri, Socrate, Aristofane e Fedro.Dal simposio vero e proprio (che implica il bere-insieme, di cui dice letimologia delsyn-posion, ma non la consumazione di cibo) erano di principio escluse le donne. Cosaccade anche in quello narrato da Platone, visto che, quando si decide di dare avvioalla celebrazione del rito, le donne che erano state fin l presenti, per lo pi per
attendere a mansioni servili, o per allietare la serata con la musica eseguita col flauto,vengono allontanate.
Lesclusione delle donne dalla scena della riunione non casuale. Trattandosi di unacerimonia religiosa, di forte impronta iniziatica, nel corso della quale verranno altresaffrontati argomenti coperti dal segreto (mystria), la presenza femminile verrebbeconsiderata alla stregua di un sacrilegio. Rispetto a questa impostazione, risulta alloratanto pi significativa la scelta compiuta da Platone, quando affida proprio a una donnail compito di rivelare la verit a Socrate.
A rimarcare lo scandalo implicito in questa opzione, si pu aggiungere che Diotima
compendia in s molti tratti che la rendono in ogni senso altra, rispetto agli invitati e aidiscorsi da essi pronunciati. Ella anzitutto straniera [xne], poich di Mantinea,anzich di Atene. straniera anche perch assente dal simposio. donna, anzichuomo. Infine, sacerdotessa e avvezza a trattare argomenti preclusi ai pi, accessibilisolo per via di iniziazione. In una parola, Diotima xne, straniera, altra, perantonomasia. E proprio a questa potente figura dellalterit il filosofo attribuisce il lgosche svela che cos to kaln. Se ne deduce che non possibile dire la verit suargomenti importanti, quale la bellezza, se non mediante il confronto col discorso dichi sia estraneo alla comunit. Il rapporto con laltro risulta dunque decisivo perlaffermazione della verit.
Ma il riferimento al personaggio a cui affidato il compito di guidare Socrate nella
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
21/53
ricerca consente anche di far emergere un aspetto fin qui trascurato, riguardante lostatuto della bellezza. La radicale alterit di Diotima, e il percorso di graduale ascesa,da essa delineato, sottolineano il carattere iniziatico dellitinerario indicato, e dunquealludono al fatto che la contemplazione della bellezza in s non pu essere identificatacome un grado di pi matura conoscenza, come conquista di un livello gnoseologico
pi maturo e compiuto, rispetto alla bellezza meramente sensibile da cui prende lemosse il processo. Si tratta piuttosto di unesperienza complessa, nella quale laprogressione teoretico-conoscitiva si accompagna con una vera e propriatrasformazione di colui che compia lascesa, al termine della quale egli diventer caroagli dei, e acquisir qualcosa che molto assomiglia allimmortalit.
La ricerca del bello dunque di per s un itinerario di mutamento, una vera e propriametabol, non dissimile da quella descritta nel contesto del mito della caverna, narratonel libro VII della Politeia platonica. In entrambi i testi (e si potrebbe parlare perambedue di m!thoi, visto che il significato originario del termine greco semplicemente racconto, senza alcuna implicazione immediata di verit ofalsit) narrata la vicenda di chi, muovendo dalle tenebre della caverna, o dal bellomeramente sensibile, intenda intraprendere una ascesa che lo conduca alla visionedella realt in se stessa, e cio della bellezza e della verit.
Difatti, il richiamo allimmagine della dimora sotterranea consente di capire meglioun aspetto decisivo della concezione platonica del kaln, quale emerge soprattuttodalle pagine del Simposio. Raggiungere la contemplazione della bellezza in se stessanon vuol dire soltanto portare a compimento un percorso conoscitivo dal sensibi leallintelligibile. Vuol dire soprattutto entrare in contatto con la verit, partecipare inuna certa misura dellimmortalit propria degli dei, acquisire una aret che resterebbe
altrimenti preclusa.
In altre parole, assecondando la guida di Diotima, e attenendoci dunque alle sueraccomandazioni, saremo condotti a compiere unesperienza multiforme, che cicoinvolge totalmente, attraverso un cambiamento della nostra stessa condizione. Sicomprende, insomma, per quali motivi la contemplazione della bellezza di cui si parlanel Simposio non traducibile in una dimensione riduttivamente estetica, poichessa ha invece a che vedere con un mutamento profondo del nostro stesso modo diessere, collegato allepoptia, vale a dire alla rivelazione. Attraverso la bellezza, allaquale solo una xne pu guidarci, siamo per cos dire pro-mossi a un livello pi elevato,nel quale si fondono organicamente il bello, il vero e il virtuoso.
Rispetto allaccezione arcaica, e alla connessione comunque non lineare eproblematica con la nozione di agathn, emerge qui quale requisito intimamentecaratterizzante del concetto di kaln il legame con la verit. Come si visto, infatti,lapprodo del percorso di ascesa e di iniziazione consiste nel pervenire a scorgereuna scienza unica e cos fatta da avere per oggetto la bellezza, dove il termineimpiegato da Platone per definire questa scienza epistme lascia intendere fino ache punto visione del bello e scienza, kaln e aleths, formino un tuttuno indissolubile.Quel procedere per gradi, a cui esorta Diotima, denota quindi il passaggio dalle molte,ma imperfette, cose belle sensibili, via via verso una bellezza in s; ma segnala
insieme una approssimazione alla verit, alla quale rivolta la vera epistme.
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
22/53
4. Si detto quale sia il fine la possibilit di vedere la bellezza in s, e con cistesso, di accedere a una condizione paragonabile a quella degli dei a cui rivoltolitinerario proposto dalla straniera di Mantinea. Ma non si detto in che cosa consistalavvio del processo, donde si possa trarre la spinta necessaria a intraprenderelesplorazione del gran male del bello, quale forza possa sostenere lo svolgimento di
una esperienza cos impegnativa. Nel Simposio, Platone indugia a lungo nellarappresentazione di quello che definito il migliore collaboratore [synergos] che lanatura umana abbia per compiere il viaggio che conduce a generare vera virt. Solovalorizzando appieno la potenza e la fortezza di Amore, si potr con successoraggiungere la meta di tutto il processo.
Eros il protagonista di tutti i discorsi pronunciati da coloro che prendono parte allacerimonia. Ma, rispetto ai lgoi di puro encomio, proposti dagli altri simposiasti, duesono quelli che si differenziano, per loriginalit dellimpostazione e la pregnanzaconcettuale dellargomentazione. Prima che prenda la parola Socrate, riferendo ilcontenuto della rivelazione ricevuta da Diotima, a parlare Aristofane. Lapreoccupazione preliminare che egli dichiara quella di evitare che gli altricommensali possano non prendere sul serio ci che sta per dire. Il suo profilo, lattivitdi commediografo, sembra infatti inchiodarlo a un ruolo di mero intrattenimento, quasiche lunica cosa di cui egli sia capace sia fare dello spirito, pur su un tema di grandeimpegno, quale quello proposto da Fedro, al quale risale liniziativa di avviare unadiscussione su Amore. Ma mentre linvocazione di Aristofane a m komodses, a nonmettere in commedia i l suo discorso viene accolta dagli altri simposiasti, la stessacosa non sembra essere accaduta agli interpreti moderni, irresistibilmente attratti dallaprospettiva di interpretare il racconto proposto dal commediografo esclusivamentecome una prova del suo talento di autore comico. Mentre ci che egli dice non soltanto
non ha intenti meramente parodistici, ma intenderebbe descrivere quale sia la veranatura di ciascuno di noi.
La natura nostra dun tempo non era quella che oggi, ma ben altra. Prima cosa: isessi erano tre, non due come ora, maschio e femmina; ma ce nera di pi un terzo,che li assommava ambedue e che, oggi, tranne il nome, scomparso. Landrogino eraallora un sesso a parte e prendeva in comune dagli altri due, maschio e femmina, e laforma e il nome (Simposio, 189 d). Lesordio del discorso di Aristofane ne segnalasubito laspetto pi caratterizzante: si parler dellamore, riferendosi alla natura allaanthropne ph!sis, alla nostra antica natura [plai ph!sis] vale a dire a ci che gli
individui sono in conseguenza della loro nascita, del modo in cui sono originariamentecostituiti. Si tratter di comprendere che cosa sia lamore come costituente dellanatura umana, piuttosto che quale risultato dello sviluppo culturale, dellevoluzione delcostume o delle trasformazioni economiche e sociali.
Fin dallinizio, dunque, il discorso di Aristofane inquadra il tema specifico dellamorenel contesto di una riflessione che va ben oltre il piano circoscritto delle passioni, daun lato affrontando i l problema della distinzione fra natura e cultura, in termini cherichiamano il dibattito svoltosi ad Atene nella seconda met del V secolo, e dallaltrospostando lasse della discussione simposiale dallambito di una convenzionaleenunciazione delle qualit e delle facolt di Eros, alla ben pi impegnativa ricerca
sullorigine e i l destino del genere umano, in rapporto alla situazione presente.
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
23/53
Nessuno di noi spiega Aristofane, raccontando il mito dellandrogino attualmenteun intero, anche se crediamo di esserlo. La natura di ognuno di noi quella ph!sis allaquale dobbiamo riferirci, se vogliamo capire che cos lamore e quali sono le sueopere letteralmente dimidiata, divisa a met, incompleta, parziale. Per riprenderela stessa metafora impiegata da Aristofane nel prosieguo del racconto, a noi
accaduto come alle sogliole: suddivise longitudinalmente a met, da uno siamodiventati due. Di qui, dunque, la genetica im-perfezione della natura umana attuale, ilfatto che ogni individuo, pur apparendo uno, in realt semplicemente una frazione; diqui, la nostra incompiutezza, dipendente dal fatto di essere il frutto di un tagliooriginario, intervenuto a sanzionare linsubordinazione nei confronti della divinit.
5. Lamore si inquadra nel contesto che stato fin qui descritto, ben lontano dallaparodia, o da un intermezzo meramente comico. Poich ciascuno di noi solo uns!mbolon, una met, inevitabile che, per tutta la vita, siamo sempre alla ricercadellaltra met, con la quale ripristinare lintero da cui deriviamo. Lamore la forza checi spinge in maniera irresistibile a cercare di raggiungere la completezza che cimanca. A questa forza (ros = rhme: cos Platone spiega letimologia di ros nelFedro) non possiamo sottrarci. Impossibile resistere a ci che lamore ci impone.Perch non si tratta di un semplice sentimento fra gli altri, n ancor meno di unapassione che sia circoscritta alla sola sfera delle pulsioni istintuali o dei sensi. Ci dicui siamo in presenza, lesigenza di un risanamento che investe nel suo insieme lanostra ph!sis, alla cui forza non perci possibile cercare di opporsi. Non per unascelta, che possa essere modificata, n per assecondare un capriccio, ma percorrispondere a una primaria e insopprimibile esigenza di completezza, per guariredalla malattia di essere soltanto un s!mbolon, per riconquistare quelluno che eravamo per questi inderogabili motivi, ciascuno di noi sempre alla ricerca dellaltra mezza
tessera che lo completa.
Le inclinazioni sessuali sono perci tutte conformi a natura, tutte conseguenti allanostra condizione di un tempo, tutte dipendenti da quella originaria ph!sis che nessunodi noi ha scelto, ma che la matrice delle nostre propensioni attuali. Limperativo chetutti ci accomuna il ripristino di quellintero che eravamo. La via da seguire, perrealizzare questo scopo, quella di ritrovare, sospinti dalla forza dellamore, laltramet che combacia con la parte che ciascuno di noi attualmente. Non dipende dallanostra discrezionalit, n da una ipotetica libera scelta, a quale sesso ci indirizziamoper riformare lunit originaria. Il percorso gi segnato, ed costituito dalla nostra
antica natura, da ci che eravamo, prima che sopravvenisse il taglio. Ognicomportamento sessuale il maschio che cerca il maschio, la femmina che cerca lafemmina, il maschio e la femmina che cercano laltro sesso dunque pienamentenaturale, perch sempre si tratta di far combaciare le due parti della tessera. Ildesiderio che caratterizza ogni essere umano efficacemente rappresentato nelleparole di Aristofane: diventare luno con laltro una medesima cosa, in modo da nonlasciarsi mai n notte n giorno (ibid., 192 d).
Nella prospettiva che si appena descritta, lamore il sintomo di una condizioneumana intrinsecamente carente, la testimonianza di una costitutiva incompletezza, ladimostrazione letteralmente impressa nella carne della non autosufficienza dei
singoli, o pi esattamente del fatto che ciascuno di noi non uno, ma soltanto la metdi un intero. La relazione con laltro non coincide dunque con una scelta puramente
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
24/53
facoltativa, alla quale sia concepibile sottrarsi conservando in ogni caso la propriaidentit. Al contrario, poich non si d alcun io che possa dirsi compiuto, al di fuori delrapporto con laltra parte originariamente costitutiva dellintero, la relazione con laltronon si configura come un parziale annullamento del s nellaltro da s, bens comeconseguenza necessaria e imprescindibile del riconoscimento che propriamente solo
nella connessione con ci che apparentemente altro da s, il s pu costituirsi.
Il movimento insito nel rapporto erotico non implica affatto luscita dalla propriaidentit, in direzione dellalterit, ma al contrario un processo che conduce fuoridallalterit di un s soltanto dimidiato, verso la riconquista della identit perduta. Nelladialettica di apparenza e realt, restare immobili nella propria attuale natura, significanon conservare, ma perdere la propria vera identit, tanto quanto la ricerca dellaltroobbedisce allesigenza di restaurare, e dunque di conservare, la propria identitperduta. Lidentit individuale (individuo vuol dire indivisibile) non si afferma nellaseparatezza, ma uscendo da se stessi e cercando di ricongiungersi allaltro.
Naturale non pertanto ci che attualmente siamo, ma ci che possiamo diventare,ripristinando larchia ph!sis. La natura non la condizione di partenza, ma una meta acui tendere, spinti da quella forza risanatrice che data dallamore. Ci che sipresenta come tlos, come fine verso cui procedere, in realt il principio (arch larchia ph!sis) da cui tutti proveniamo. Colpevole non cedere allimpulsodellamore, bens persistere nella propria indigenza, frutto appunto di una colpaoriginariamente commessa. Espiazione, guarigione dai mali dellumanit, alcontrario non sottrarsi al compito di ricercare, in quanto s!mbolon, laltro s!mbolon, colquale ricomporre lhlon originario. La salvezza dalla condizione di mancanza e dimalattia, alla quale la tracotanza originaria ha condannato il genere umano, consiste
davvero nella capacit di redenzione, nel saper ritornare a ci che eravamo, nelricongiungere il futuro col passato, nel capovolgere la direzione apparente del tempo,vivendo il presente come un continuo passaggio dal futuro al passato, anzichviceversa. La pienezza dei tempi coincide, in questa prospettiva, con la pienezzadellessere: il senso di questa sorta di storia della salvezza, o se non altro del decorsoche conduce alla guarigione dal vulnus originario, potrebbe dirsi integralmenterealizzato quando ogni parte riuscisse a ritrovare laltra parte rifondendosi conessa.
Si comprende allora, in questo totale ribaltamento di ci che lapparenzasembrerebbe suggerire, per quale ragione, deviante, o contro natura, non sialassecondare la propria inclinazione sessuale verso il proprio stesso sesso [hmos],o verso laltro [teros] ma piuttosto il resistervi, o il cercare di modificare ci versocui, per natura, siamo orientati. Allo stesso modo, lattenersi a ci che lamore dettanon coincide con la follia o lirrazionalit, ma con lesercizio della ragione nella suaforma pi compiuta, identificandosi conclusivamente con la stessa filosofia. Amare,infine, non vuol dire soccombere alla malattia, bens tendere a liberarsi da essa, fino aquella condizione di completa guarigione, in cui definitivamente due formano uno,con ci ripristinando ci che era prima.
Muovendo dalla visione della bellezza nella molteplicit delle cose sensibili, la ricerca
del bello in s, nel suo indissolubile legame col vero e col virtuoso, sostenuta dallaforza incoercibile di Eros. Uscire dal limite dellessere soltanto un s!mbolon, per
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
25/53
ritornare a essere quelluno che eravamo, finisce cos per identificarsi con lanavigazione nel grande mare del bello, sospinti da una incancellabile nostalgiadellintero. Si comprende, allora, in che senso si possa dire che il kaln kali, il bellochiama. Chiama a compiere un percorso di ascesa che insieme un viaggioiniziatico, un processo di guarigione, un itinerario di approssimazione alla verit.
6. Sulla funzione della bellezza, non come oggetto di contemplazione privilegiata, macome stimolo verso un risanamento complessivo, e sulla connessione fra amore ebellezza, Platone insiste anche nel Fedro, mediante la trattazione della quarta forma didivina mana. Nel vedere la bellezza di quaggi, lanima si ricorda della verabellezza, e perci mette le ali, nello sforzo di levarsi in volo e raggiungere nuovamentequel luogo sopra il cielo, nel quale si era originariamente verificato il primo contattocon essa. Rispetto a ci che scritto nel Simposio, qui si segnala soprattutto unaspetto di grande rilievo, riguardante le modalit specifiche di manifestazione dellabellezza.
Kllos... idin lamprn (250 b) vedere la bellezza nel suo splendore; kallous...lampen (250 c), la bellezza splendeva. Nel Fedro non ci si limita a sottolinearecon quali modalit la bellezza agisca nella vita delluomo, avviandone e sostenendonelascesa e la purificazione. Si descrive anche in che modo essa si riveli, in quali formeessa si mostri. Particolarmente significativo, in questa prospettiva, il verboimpiegato, la cui valenza onomatopeica, ancorch attenuata, si avverte anche initaliano. Il bello lampen lampeggia. La comparsa della bellezza alla vista comeil balenare di un lampo. Un evento improvviso, una luce vivissima, un rischiaramentoabbagliante. In questo modo la bellezza brillava tra le cose di lass, e nello stessomodo labbiamo colta con la pi vivida delle nostre sensazioni, in quanto risplende nel
modo pi vivido (250 d).
Lintero brano del Fedro dedicato alla manifestazione della bellezza costruitosullaccentuata valorizzazione di termini e metafore che rinviano al lessico del vedere, edunque anche alluniverso semantico del conoscere, vista lequivalenza fra i due verbinella cultura greca arcaica e classica. La bellezza qualcosa che si offre alla vista, equindi oggetto della conoscenza, ma in entrambi i casi essa compare non come unfenomeno fra gli altri, ma come qualcosa che si caratterizza come un eventostraordinario, come unimprovvisa irruzione della luce, a squarciare loscuritpreesistente. La bellezza lampeggia. Si fa strada nelle tenebre, colpisce lo sguardo, siimpone in maniera irresistibile.
Anche qui, daltra parte, si coglie subito una differenza di fondo fra coloro che non sonoiniziati, ovvero sono corrotti, e quanti invece hanno di recente compiuto lesperienzadelliniziazione. Mentre i primi non possono rapidamente elevarsi da questo mondo acontemplare la bellezza in s di lass e perci si arrendono come bestie al piacere,abbandonandosi a ogni eccesso senza timore n vergogna, coloro che invece hannogoduto di una lunga contemplazione, quando scorgono un volto di apparenza divina, ouna qualche forma corporea che ben riproduca la bellezza, rimirando questa bellezzala venerano come divina (ibid., 250 e-251 a). Per costoro, colui che possiede labellezza lunico medico capace di guarire i pi grandi travagli. Il suo nome, per i
mortali Eros, mentre per i numi immortali esso si chiama Pteros, perch induce le alia crescere. (ibid., 252 a-b).
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
26/53
Ma per approfondire ulteriormente questo passaggio del Fedro, e in particolare leimplicazioni connesse al verbo impiegato da Platone, necessario riferirsi a un altrotesto, pressoch unanimemente interpretato alla stregua di una pur concisaautobiografia intellettuale da parte del filosofo. Nella Lettera VII, infatti, per illustrarequale sia la natura della scienza da lui indagata, e in che modo essa si esprima,Platone si giova di una metafora la scintilla che scaturisce dal fuoco che ricalcalimmagine dello splendore della bellezza celeste descritta nel Fedro. Ebbene, ladescrizione di questo processo accompagnata da una sottolineatura moltosignificativa, relativa alla dimensione temporale in cui si situa levento. La scintilla chebalza fuori dal fuoco e cos anche il bello che lampeggia compaiono exiphnes,improvvisamente. Come la scienza che nasce allimprovviso nellanima dopo unlungo rapporto e una convivenza assidua con largomento (Lettera VII, 341 c-d), allostesso modo la bellezza lampeggia exiphnes, allimprovviso.
Gi in Pindaro, alludendo alla grazia che propria della chris, il termine exiphnes
usato per indicarne le modalit di improvvisa manifestazione. Nellintreccio fra ipassi citati del Fedro e della Lettera VII si conferma questa caratteristica comemodalit specifica di apparizione. Come luce che allimprovviso lampeggia cossi manifesta la bellezza. Essa abita altrove, in quel luogo-non luogo denominatoyperourans (poich i luoghi sono solo gh e ourans, terra e cielo, ci che si situayper, al di l, non coincide con alcuna collocazione spaziale definita). Levento dellasua comparsa non pu essere previsto. Esso avviene exiphnes allimprovviso.Come il balenare abbagliante della luce: solo cos possibile rappresentare lepifaniadel bello e la genesi di quello straordinario mthema che la filosofia.
7. In origine, allincirca da Omero e Esiodo fino a Platone, il termine ksmos vuol direessenzialmente due cose. Anzitutto, significa ordine. Cos, ad esempio, nellIliade sitrova lespressione eu kat ksmon, che vuol dire in buon ordine, secondo un buonordine. Correlativamente, sempre nei poemi omerici, si pu leggere la frase ouksmos, che significa letteralmente non ordine, e insomma disordine. Da notareche con questo significato, vale a dire come ordine, misura, disciplina, esso ricorreanche nei tragici e, come si vedr, nello stesso Platone.
In secondo luogo, nellet arcaica ksmos sta a indicare lornamento soprattuttolornamento femminile, ma anche (si pensi a Esiodo) lornamento riferito a un cavallo oalla casa. Il termine moderno cosmetico deriva in tutta evidenza da questo secondo
significato originario, in quanto si riferisce a ci che pu ornare il volto di una donna,o che comunque corrisponde a una funzione di abbellimento.
Viceversa, ci che poi si sarebbe chiamato universo, con i suoi derivati linguistici,era detto t pn il tutto, o anche t hlon, vale a dire lintero. Si pu dire, insomma,che almeno fino a Pitagora e probabilmente anche oltre, precisamente fino a Platone per indicare luniverso si usava lespressione la totalit, lintero, sottintendendodelle cose che sono, che esistono, che si vedono.
Fino a Platone, si diceva. Vi , infatti, un passaggio storico e concettualefondamentale, che troviamo documentato in almeno tre dialoghi del filosofo, ma che
probabilmente risale a qualche decennio prima. Il passo pi significativo contenutonel Gorgia, nel quale leggiamo testualmente: Gli uomini sapienti dicono che cielo e
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
27/53
terra, dei e uomini, sono tenuti insieme in un tutto [hlon] mediante la comunanza,lamicizia, lordine, la saggezza e la giustizia, e per questa ragione questo tutto noichiamiamo ordine [ksmon] anzich disordine [akosma] o dissolutezza [akolasa] (507 e-508 a).
Commentando questo brano, si pu anzitutto osservare che cielo e terra, dei e uomini,per i greci rappresentano la totalit delle cose che sono, il tutto. Tanto vero chequando Platone deve indicare un luogo che non un luogo, che non appartiene aquello che noi chiamiamo universo, il luogo nel quale si trovano le idee, lo chiama !perourans, al di l o oltre il cielo, che vuol dire che non un luogo nel senso fisicodel termine.
Ebbene, tutto ci che , per effetto di qualit morali, pi che di leggi pertinenti allaph!sis, quali sono soprattutto la giustizia, lamicizia, e la saggezza, si tiene insieme, stainsieme, non si disperde, e perci possiamo dire che tutto ci forma un ksmos, vale adire un ordine un ordine che insieme anche un ornamento, che assomma in salcuni tratti etici (in primo luogo la giustizia), ma anche talune caratteristiche chepotremmo definire estetiche. Il tutto, lintero delle cose che sono, nel momento in cui sudi esso agisca la giustizia, assume la forma del ksmos di un bellordine. Senzadiscostarsi eccessivamente dallesplicitazione della radice etimologica del termine, sipu dunque affermare che affinch si dia un ksmos non basta affatto riferirsi allatotalit di ci che . necessario che questo tutto sia organizzato in maniera tale dapotere essere interpretato come qualcosa che governato da qualit morali. Solo cosesso sar un ksmos vale a dire qualcosa in cui si assommano ordine e bellezza.
Nel passaggio del Gorgia che si precedentemente citato, si realizza una vera e
propria svolta platonica, la cui importanza pu essere meglio apprezzata se si tengonopresente le seguenti considerazioni. Il tutto t pn, appunto intanto pu esseredetto ksmos, in quanto si concepisca che fra le cose che compongono la totalitesistano legami di amicizia, giustizia e saggezza. Tutto ci implica che il principio dicostituzione del bellordine non una legge fisica, ma un principio di ordine etico.Daltra parte, la commistione fra categorie etiche e leggi fisiche o, pi esattamente,limpiego di principi anteriori a tali distinzioni, cos come lo stesso concetto di ph!sis anteriore alla distinzione fra mente e natura, o fra spirituale e materiale , inquanto include entrambi e altri aspetti ancora si ritrova anche nel celebre frammentoB1 di Anassimandro, nel quale appunto leterna vicenda della nascita e delladissoluzione di tutte le cose rappresentato come un processo di rendersivicendevolmente giustizia dellingiustizia.
Di qui scaturisce unimplicazione di grande rilievo: sotto il profilo storico, ma anche dalpunto di vista concettuale, il problema dellorigine delluniverso pu essere posto solonel momento in cui si concepisca il tutto come qualcosa che sia governato da una sortadi legalit, o che sia comunque riconducibile a una forma di razionalit, e insieme dibellezza. In altre parole, non possibile parlare di origine, se non in riferimento a uncosmo, vale a dire non gi semplicemente a una totalit indistinta, quanto piuttosto auna totalit ordinata, e dunque bella, quale quella che compendiata nel terminegreco ksmos.
Non meno importanti sono le conseguenze della prospettiva ora descritta per quanto
-
7/22/2019 Curi l'Apparire Del Bello
28/53
riguarda quelle che possono essere chiamate le arti verbali, nelle quali, comeriferisce lo stesso Omero, il concetto di ksmos si collega allarmonia e alla coerenza.Di un cantore si pu dire che esegua un canto secondo i canoni della bellezza seprocede kat ksmon, secondo un bellordine, riproponendo cio in una coerentestruttura verbale la successione reale degli eventi. Nella lirica arcaica il testo poetico
viene inteso come un ksmos epon, cio un bellordine di parole.
8. dunque con Platone che prende forma compiuta quella concezione del bello cherester dominante in tutta la tradizione culturale dellOccidente. Da un lato, infatti, vienericonfermata la connessione arcaica fra kaln e agathn, fra bello e buono,espressa nella formula tradizionale della kalokagatha. Ma, dallaltra parte, dagli scrittidel filosofo emerge unaccezione della bellezza ancora pi comprensiva, ben oltrelorizzonte circoscritto della degustazione meramente sensibi le. In particolare, sievidenzia il legame intrinseco che connette il bello al vero, al punto da farcoincidere la filosofia come ricerca della verit con il percorso di ascesa verso labellezza in s.
La manifestazione del bello sul piano sensibile nella molteplicit delle cose belle odei volti belli si costituisce dunque come indizio e richiamo (kals kali) aintraprendere un percorso che insieme un viaggio iniziatico, un itinerarioterapeutico, un processo di graduale approssimazione alla verit. Si confermaanche per questa via ci che, seguendo altri sentieri di analisi, si dovrebbe sottolinearecon forza, vale a dire lanteriorit concettuale, e dunque anche lirriducibilit,dellapproccio platonico, rispetto alle distinzioni introdotte dal pensiero moderno.
Per dirla in termini pi espliciti, cos come palesemente abusivo parlare di una