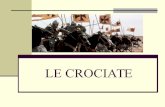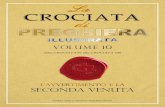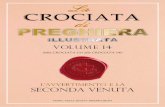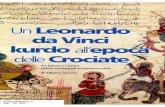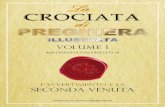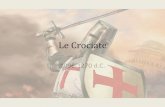CrocIate
-
Upload
mikhaeldejan -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of CrocIate

CROCIATE E CROCIATI NEL MEDIOEVO ALAIN DEMURGER
1 L’idea di crociata La crociata è stata predicata per la prima volta nel concilio di Clermont del 1095 da papa Urbano II, il quale però non utilizzò mai il termine crociata. Il papa, al termine del concilio, si rivolse ai cavalieri e disse loro di non farsi guerra inutilmente e di non colpire i più deboli, ma di indirizzare la loro forza e la loro energia verso un obiettivo più importante: liberare Gerusalemme. Foucher de Chartres ha assistito al concilio e ha preso parte alla crociata e secondo lui il papa non menzionò affatto Gerusalemme, in realtà è probabile che Foucher abbia tenuto nascosto questo fatto perché egli non partecipò alla conquista di Gerusalemme ma vi si recò solo una volta che la città era ormai in mano ai cristiani. Inoltre nei discorsi e nelle lettere che Urbano II scrisse durante il suo viaggio in Francia Gerusalemme veniva evocata senza ambiguità. Il Vicino Oriente nella seconda metà del XI secolo era diviso tra due religioni: il cristianesimo greco e l’islam, inoltre erano presenti tre gruppi politici: l’impero bizantino, il califfato fatimide (sciita) del Cairo e i turchi selgiuchidi (di recente islamizzazione, sunniti e originari dell’Asia centrale). I turchi selgiuchidi nel 1071 sconfissero i bizantini nella battaglia di Manzikert e si impadronirono dell’intera Asia Minore. Gerusalemme, fino all’arrivo dei crociati, passerà più volte dalle mani dei selgiuchidi a quelle dei fatimidi. Il pellegrinaggio a Gerusalemme conobbe nell’XI secolo un grande sviluppo (fu facilitato dalla conversione degli ungheresi al cristianesimo), i cristiani si recavano nella città santa per visitare i luoghi sacri e per andare a pregare sul Santo Sepolcro o sul Golgota, perché in tal modo potevano espiare i propri peccati. Le autorità musulmane tolleravano il pellegrinaggio e riscuotevano tributi sui pellegrini, mentre la popolazione locale lo sopportava mal volentieri e in più di un occasione si verificarono disordini. Gli scontri militari che caratterizzavano fatimidi e selgiuchidi resero necessaria una scorta armata per difendere i pellegrini cristiani, si passò così al pellegrinaggio armato e prese corpo l’idea di restituire Gerusalemme alla cristianità. Il discorso di Clermont ebbe l’effetto di lanciare sulle strade d’Europa e del Vicino Oriente una folla eterogenea di pellegrini che avevano l’obiettivo di conquistare con la forza Gerusalemme e i luoghi santi. Gli storici della crociata si dividono in due correnti: secondo la prima nel messaggio di Urbano II prevale la volontà di portare aiuto alle chiese cristiane orientali, mentre la seconda insiste sulla funzione fondamentale di Gerusalemme e del pellegrinaggio. Si è a lungo dibattuto se considerare la crociata una guerra santa o un pellegrinaggio armato, ma in entrambi i casi risulta in primo piano l’impresa militare. Nel periodo precedente alla crociata sono state combattute molte guerre sacralizzate (si pensi a quelle combattute dagli imperatori ottoniani contro i pagani o a quella combattuta dal papa contro i normanni), la guerra santa però si differenzia da queste in quanto è presente la ricompensa spirituale data a coloro che vi prendono parte (la remissione di tutti i peccati). L’imperatore bizantino Alessio Comneno chiese l’aiuto del papa per fronteggiare l’avanzata dei turchi selgiuchidi, Bisanzio faceva infatti da tempo affidamento su eserciti mercenari che però spesso facevano solo i propri interessi. L’appello lanciato a Clermont andava ben oltre le richieste di Alessio Comneno e faceva di Gerusalemme l’obiettivo principale. Papa Urbano II, che non perdeva di vista l’andamento della situazione in Spagna e Sicilia, era molto attento alla riconquista cristiana e la spedizione che progettava per la Terra Santa doveva avere carattere meritorio e santificante: il martirio per quelli che moriranno e l’indulgenza per coloro che sopravvivranno. L’impresa voluta dal papa non era priva di obiettivi politici, infatti aveva anche il fine di riunire latini e greci e ricomporre lo scisma attraverso il riconoscimento da parte dei greci della superiorità di Roma. Non solo combattenti, ma anche chierici, contadini e artigiani aderirono all’impresa papale, tutti presero la croce, simbolo dell’impegno di andare a liberare il sepolcro di Cristo. Da questo punto di vista è rintracciabile il forte legame che la crociata ha con il pellegrinaggio. Dalla primavera del 1096 i primi gruppi di crociati si misero in cammino prima che i capi dell’impresa (Raimondo di Tolosa, Goffredo di Buglione, Boemondo) avessero radunato le proprie truppe. Urbano II aveva indicato come proprio legato il vescovo Adhemar de Monteil. Un ruolo importantissimo nella I crociata lo ebbe Pietro l’Eremita, egli realizzò una predicazione parallela a quella del papa e diede il là a una crociata missionaria il cui scopo preliminare era convertire (o in alternativa sterminare) gli ebrei delle città renane. Una volta superato il Bosforo le truppe di Pietro l’Eremita non resistettero agli attacchi dei turchi e i sopravvissuti si unirono a Costantinopoli ai membri della crociata ufficiale. Meglio armati e meglio organizzati questi ultimi sconfissero i turchi in Asia Minore e raggiunsero Antiochia e, dopo una lunga marcia in cui non furono infrequenti episodi di saccheggio, distruzione e massacro della popolazione civile, conquistarono Gerusalemme nel luglio del 1099. La liberazione della città fu segnata dal massacro della maggior parte della popolazione ebrea e musulmana (una violenza peraltro già presente negli appelli pontifici). I signori crociati non esitarono a spartirsi le loro conquiste: Baldovino di Boulogne (fratello di Goffredo) fondò la contea di Edessa, mentre il normanno Boemondo si prese il principato di Antiochia (nonostante la città sarebbe dovuta essere stata

riconsegnata ai bizantini). Per quanto riguardava la Città Santa Goffredo di Buglione rifiutò il titolo reale e si accontentò di quello di difensore del Santo Sepolcro, ma alla sua morte il fratello Baldovino non si fece tanti scrupoli e divenne il primo re di Gerusalemme. Da quel momento il principale obiettivo dei crociati sarebbe stato difendere i possedimenti conquistati e portare aiuto alla Terra Santa. Il termine crocesegnato era utilizzato per indicare colui che, cucendo la croce sul proprio abito, era ormai caratterizzato da quel segno. I contemporanei della crociata utilizzavano però più frequentemente le parole pellegrinaggio e pellegrino riferendosi alla crociata e a chi vi partecipava. La difficoltà degli uomini a dargli un nome testimonia la novità del fenomeno. La crociata è un’idea nuova e servono molti elementi per renderla possibile: un contesto di riforma, un papa ispirato, l’idea di liberare le chiese d’oriente, la guerra santa, il pellegrinaggio penitenziale, la remissione dei peccati e Gerusalemme. A lungo si sono cercati antecedenti alla crociata, i chierici che parteciparono alla I crociata istituirono un parallelo con la conquista di Gerusalemme da parte di Tito. In seguito gli storici delle crociate hanno trovato punti di contatto con la grande offensiva mossa dall’imperatore bizantino Eraclio nei confronti dei persiani negli anni 622-29, che portò alla riconquista della Siria e della Palestina. Il confronto con la reconquista iberica appare però più convincente vista la presenza in molti casi di cavalieri francesi accanto a quelli spagnoli e la concessione di ricompense spirituali ai combattenti (ma manca il grande scopo della crociata: liberare Gerusalemme).
2 Il crociato A Clermont l’iniziativa papale era stata comunicata attraverso un sermone, in seguito lo strumento dell’appello del papa divenne la bolla di crociata, essa conteneva la giustificazione dell’impresa, i privilegi del crociato e le ricompense spirituali. Questa bolla era rivolta ai vescovi, responsabili della diffusione ai loro fedeli. Dopo la promulgazione vi era la predicazione. Nel XII secolo la predicazione poteva avvalersi di ottimi interpreti, come san Bernardo di Chiaravalle e i monaci cistercensi, inoltre essa era pervasa dallo spirito dell’appello di Urbano II. Con la III crociata la predicazione si fece più sistematica e i vescovi si incaricano di approntare delle missioni regionali volte a diffondere la crociata fra i fedeli. Successivamente i vescovi non disdegnarono di appoggiarsi sui nuovi ordini mendicanti, francescani e domenicani, mentre le missioni avevano sempre più lo scopo di ottenere finanziamenti. Nella storia della crociata vi furono predicazioni clandestine che non aveva l’appoggio del papa, si pensi a quella condotta da Etienne de Cloyes, che guidò la crociata dei fanciulli (1212), o al Maestro d’Ungheria che predicò la crociata dei pastorelli (1251). Il fedele risponde all’appello del predicatore con un voto che rende pubblico prendendo la croce. Abbiamo poche testimonianze scritte sul voto, perché si tratta di una promessa fatta a Dio che non deve essere resa pubblica. Per alcuni papi il voto che lega il crociato a Dio era uguale a quello che vincola il vassallo al proprio signore e non poteva essere sciolto pena la scomunica. La chiesa, però, spesso si mostrava indulgente e concedeva proroghe ai potenti (come nel caso di Federico II, poi scomunicato), vi era inoltre la possibilità di commutare il voto in denaro e conservare i benefici spirituali, oppure di portare a compimento il proprio voto in un luogo diverso dalla Terra Santa (per esempio in Spagna o contro gli eretici). Attraverso la presa della croce il fedele manifesta pubblicamente il suo impegno, spesso durante la predicazione. Dopo il sermone, infatti, il predicatore consegna agli aspiranti crociati la croce (che veniva poi cucita sulla spalla sinistra dell’abito), il bastone e la bisaccia del pellegrino, il tutto seguendo una precisa cerimonia. La I crociata fu una lunga peregrinazione terrestre che durò tre anni, la traversata dell’Asia Minore si rivelò spesso un incubo a causa dei costanti attacchi dei turchi. Federico I Barbarossa utilizzò ancora questo itinerario (che prevedeva l’attraversamento di Bisanzio) durante la III crociata, mentre i re di Francia e di Inghilterra: Filippo Augusto e Riccardo Cuor di Leone, scelsero il mare. Chi voleva intraprendere la via d’acqua doveva necessariamente trattare con Venezia, Genova e le altre città italiane. Molte spedizioni marittime convergevano sull’isola di Cipro, perché da lì raggiungere la Siria o l’Egitto richiedeva lo stesso tempo. Era indispensabile procurarsi viveri in abbondanza. Il nobile Joinville, che seguì san Luigi in crociata, cedette in pegno parte delle proprie terre per poter finanziare il viaggio e insieme ad altri cavalieri noleggiò una nave per sé e per i propri uomini. La crociata è il risultato della guerra santa e del pellegrinaggio: non appena il crociato giungeva in oriente si recava a pregare sul Santo Sepolcro e visitava i santuari della Terra Santa che custodivano reliquie. Il re di Francia Luigi VII partecipò alla II crociata per espiare le sue colpe, poiché durante una guerra il suo esercito aveva bruciato una chiesa uccidendo le persone che ivi si erano rifugiate. Durante il periodo in cui Gerusalemme appartenne alla cristianità gli obiettivi del crociato e del pellegrino coincidevano. I pellegrini, benché disarmati, potevano offrire aiuto in caso di necessità, inoltre la loro presenza giustificò l’istituzione dell’ordini religioso-militari del Tempio e dell’Ospedale, il primo aveva il compito di difenderli, mentre il secondo quello di ospitarli e curarli. Alcuni crociati-pellegrini scelsero di rimanere in Terra Santa per diventare eremiti. Dopo la conquista di Gerusalemme da parte di Saladino (1187) l’accesso alla città dipendeva dalla buona volontà dei signori musulmani, ma le buone relazioni con i successori del Saladino permisero alla città di restare aperta ai pellegrinaggi. Dopo la presa del

potere al Cairo dei mamelucchi il papato vietò il pellegrinaggio in Terra Santa e spinse i fedeli alla riconquista di Gerusalemme, ma i pellegrini restarono numerosi. In alcuni casi l’obbligo della crociata venne utilizzato come penitenza verso i colpevoli di gravi reati. A riprova dell’importanza del fenomeno del pellegrinaggio nel XIII secolo i frati francescani organizzarono peregrinazioni in Terra Santa, Venezia mise a disposizione un servizio di collegamento diretto con Jaffa e ai pellegrini venivano proposte formule di viaggio con la visita dei principali santuari della Palestina e del Sinai. A quell’epoca crociata e pellegrinaggio non coincidevano più e liberare Gerusalemme rimaneva un sogno. La crociata è una via verso la salvezza, per questo quasi tutti potevano partire (inoltre non dimentichiamo che era necessario popolare i nuovi territori conquistati), alla crociata presero parte anche delle donne: i casi più celebri furono quelli di Eleonora d’Aquitania (sposa di Luigi VII) e Margherita di Provenza (moglie di san Luigi). Nelle famiglie nobili si formò col tempo un’etica della crociata che si trasmise alle generazioni successive, i legami feudovassallatici costituivano un’ulteriore spinta a partire, poiché servitori e vassalli erano obbligati a servire i propri signori. Le motivazioni che muovevano il crociato erano sia d’ordine materiale che spirituale. Le crociate rivelarono per la prima volta in occidente l’esistenza di una spiritualità popolare, alcuni teologi avevano cercato di ricondurre la crociata all’ambito monacale ma in realtà emerse in pieno il suo carattere laico e militare. L’azione era affiancata dalla meditazione e dalla preghiera. Gli ordini religioso militari nati in Terra Santa coniugavano alcuni aspetti del monachesimo (per esempio la presa dei voti) con quelli del crociato attraverso una solida organizzazione militare. La spiritualità del crociato è legata alla volontà di Dio (Dio lo vuole!), alla croce e a Cristo, alle reliquie e alle visioni escatologiche e profetiche che avrebbero dovuto far coincidere la Gerusalemme celeste con quella terrena
3 La crociata: un’istituzione La II e la III crociata erano una risposta ai gravi avvenimenti verificatisi in oriente: la caduta di Edessa e la perdita di Gerusalemme, i papi reagirono emanando bolle per soccorrere la Terra Santa che spesso ripercorrevano le tematiche dell’appello di Urbano II. La crociata era lanciata dal papa, ma non era lui a guidarla: la III crociata aveva a capo un imperatore e due re, mentre la IV fu dirottata contrariamente al volere papale verso Costantinopoli. Innocenzo III, attraverso l’enciclica che lanciava la V crociata, espresse la volontà di riappropriarsi del suo controllo. Federico II, partito mentre era colpito da scomunica (per aver più volte rinviato l’adempimento del proprio voto), riuscì nell’obiettivo di restituire Gerusalemme ai cristiani. Egli, infatti, grazie alle sue abilità diplomatiche, ottenne dal sultano al-Kamil la restituzione della città (1229), a condizione di non fortificarla e di rendervi possibile l’accesso ai musulmani. Il successo ottenuto da Federico II era importante, ma poggiava su basi fragili, inoltre il papa non era affatto soddisfatto del modo in cui l’imperatore aveva ottenuto la città, che nel 1244 fu persa definitivamente. La crociata del re di Francia Luigi IX iniziò poco dopo la caduta di Gerusalemme e la predicazione non uscì quasi mai dall’ambito francese. Quella di Luigi IX fu una delle crociate più sincere e vicine allo spirito originario, durante l’intero periodo della crociata, dalla vittoria iniziale di Damietta fino alla prigionia, il re di Francia (poi santificato) fu un crociato ideale. Nel XIII secolo si svilupparono crociate che non avevano l’avvallo della chiesa. La crociata dei fanciulli del 1212 non ebbe esito. La crociata dei pastorelli fu invece l’effetto del clamore e della commozione suscitate in Europa dalla notizia della cattura di san Luigi. Essa fu guidata da un monaco: Jacques, detto il Maestro d’Ungheria, i saccheggi e le distruzioni che ne accompagnarono il cammino dal nord della Francia verso sud scatenarono la repressione delle autorità che dispersero il gruppo. Questi movimenti hanno in comune la critica ai potenti da parte degli umili e la possibilità solo per i secondi di riconquistare Gerusalemme, sono inoltre accompagnate da violenze contro il clero e gli ebrei. Il crociato deve farsi carico di un viaggio costoso, i grandi signori utilizzavano il proprio capitale fondiario per finanziare il viaggio, il più delle volte facendo ricorso a prestiti che ottenevano impegnando i propri beni presso gli istituti religiosi. Nel XIII secolo si rafforzò il ruolo delle compagnie bancarie italiane (cui persino san Luigi dovette ricorrere). La gente comune, invece, si organizzava in confraternite che aiutavano i propri membri a partire. Coloro i quali non partivano finanziavano con le elemosine il viaggio di quelli che si mettevano in cammino, la chiesa sollecitava le donazioni attraverso la concessione di indulgenze. Si faceva sempre più diffusa la pratica del riscatto del voto. I principi, facendo pagare delle tasse supplementari ai propri sudditi, istituirono un sistema fiscale di crociata (Filippo Augusto e Riccardo Cuor di Leone stabilirono la decima del Saladino). Innocenzo III volle che il papato partecipasse più attivamente al finanziamento della crociata, le somme riscosse dalla chiesa erano trasferite in oriente oppure messe direttamente nelle mani dei crociati. L’Ad liberandam del 1215 fu elaborata nel contesto concreto della preparazione della V crociata. Essa stabiliva la durata dell’impegno del crociato in tre anni e indicava i loro privilegi. Il crociato era infatti esente dai pagamenti in denaro imposti dai signori o dal re, non era possibile avviare cause giudiziarie contro di lui fino al suo ritorno né esercitare violenza contro di lui, i suoi parenti o i suoi beni. Ogni attacco ai privilegi del crociato era colpito con la scomunica. In ogni caso non era tutto rose e fiori per il

crociato, una volta tornato a casa, infatti, se non era in grado di riscattare i suoi beni era destinato a perderli e doveva sempre far fronte all’avidità dei prestatori (anche chierici). La crociata è un’opera di pace ed essa può compiersi solo se la cristianità è pacificata. Innocenzo III riteneva legittimo utilizzare le istituzioni di crociata contro gli eretici e coloro che si ribellavano all’autorità della chiesa
4 Crociata e guerra santa. Un ampliamento del campo d’azione della crociata? Alla fine dell’XI secolo la conquista almoravide mise i cristiani della penisola iberica sulla difensiva, Urbano II e i suoi successori accordarono agli spagnoli ricompense spirituali paragonabili a quelle concesse ai crociati di Gerusalemme. La II crociata fu determinata dalla conquista di Edessa da parte di Zengi, il papato sperava di affidare la spedizione a Luigi VII, ma egli aveva un’altra preoccupazione: quella di fare penitenza. La predicazione della crociata fu affidata a Bernardo di Chiaravalle che riuscì a evitare il ripetersi delle violenze contro gli ebrei e convinse l’imperatore germanico Corrado III a prendere la croce. San Bernardo intendeva la crociata in termini spirituali, per lui essa doveva accogliere tutti i cristiani perché era il mezzo per raggiungere la salvezza. Papa Eugenio III, invece, era più realista, ma non puntava solo sul recupero di Edessa bensì su uno sforzo concertato della cristianità contro gli infedeli su tutti i fronti: Terra Santa, Spagna e Baltico. Nella Germania orientale l’espansione verso est, che cominciò anteriormente alla I crociata, univa colonizzazione agricola e fervore missionario. Quando Corrado III prese la croce i principi sassoni furono dispensati dall’obbligo di seguirlo in Terra Santa perché impegnati a combattere la popolazione pagana dei vendi, il papa concesse loro i medesimi privilegi spirituali. I crociati renani, fiamminghi e inglesi fecero scalo in Galizia, e, sollecitati dal re di Portogallo, parteciparono alla conquista di Lisbona. Probabilmente il papato non concepì la II crociata come un’impresa globale contro gli infedeli, piuttosto è divenuta tale nei fatti. Vi sono elementi in comune tra la crociata e la reconquista: in entrambi i casi i combattenti facevano un voto e il papato concedeva indulgenze spirituali, ma queste cose non bastano a qualificare una guerra come crociata. La reconquista manca del pellegrinaggio e ha una diversa funzione e ideologia (unificatrice), tuttavia si avvale delle istituzioni di crociata ed è definibile come guerra santa. La guerra in Germania orientale, invece, è una guerra missionaria, non una crociata, nel XIII fu presa in carico dall’ordine teutonico, che si stabilì in Prussia. Venivano compiute grandi spedizioni annuali, che portarono alla formazione di importanti città (come Konigsberg). Questi casi dimostrano come il papato spesso conceda le istituzioni di crociata a quelle che, in realtà, sono imprese principesche. Qualche volta le crociate deviano dal loro iniziale obiettivo di soccorrere la Terra Santa: non sono in discussione le crociate dirette contro l’Egitto perché il loro obiettivo restava la Terra Santa, piuttosto la IV crociata che si risolse nella presa di Zara e nella conquista di Costantinopoli (vedi pag. 121-125). Per molti crociati era impensabile che una crociata attaccasse altri cristiani, che fossero cattolici fedeli (come nel caso degli abitanti di Zara) oppure scismatici (i greci), per questo molti di essi lasciarono l’esercito per raggiungere direttamente la Terra Santa. Nel 1208 Innocenzo III decise di muovere guerra contro gli eretici albigesi, stanziati nel sud della Francia, utilizzando per combatterli le istituzioni di crociata. Normalmente la chiesa ricorreva all’azione violenta affidandosi al braccio secolare (i poteri laici), ma vista la complicità con gli eretici della maggioranza dei principi del sud (in primis del conte di Tolosa) e il disinteresse di Filippo Augusto il papa decise di rivolgersi direttamente ai fedeli per sradicare l’eresia. In questo caso non mancano gli appelli del papa, la predicazione, la presa della croce (cucita sul petto) e le indulgenze, ma non si può parlare di crociata perché non si fa parola di pellegrinaggio né di penitenza. Quella scatenata da Innocenzo III è piuttosto una guerra santa. Il risultato più evidente della guerra fu però quello politico, vista la conquista da parte del re di Francia Luigi VIII dei territori meridionali. Alcuni uomini decisero di partecipare alla “crociata” contro gli albigesi perché, anche se non equivaleva a Gerusalemme, permetteva di trarne identici vantaggi con minor dispendio. Altri sono stati invece più critici e hanno visto che, sotto il mantello della crociata, il papato faceva passare tutt’altra cosa. Le crociate politiche furono il caso più evidente di utilizzo delle istituzioni di crociata per fini totalmente estranei allo spirito per cui essa era nata. Il papato si servì delle armi della crociata contro Federico II di Svevia e il suo figlio bastardo Manfredi, nelle vesti di crociato Carlo d’Angiò (fratello di san Luigi) sconfisse quest’ultimo e si impadronì della Sicilia. Il papa in seguito ricorse all’arma della crociata contro il re d’Aragona, che aveva conquistato la Sicilia dopo la rivolta dei Vespri siciliani. I concili ecumenici del XII e XIII secolo quando riservavano specifici decreti alla crociata lo facevano solo riguardo la Terra Santa e Gerusalemme, ciò rivela il legame indissolubile che il papa e i padri conciliari pensavano esistesse tra la Città Santa e la crociata. Molti storici di recente hanno sopravvalutato la componente dell’indulgenza nella definizione di crociata, essa infatti pur essendo un elemento importantissimo non è l’unico: non è possibile mettere sullo stesso piano le crociate cismarine con quelle d’oltremare poiché l’idea di crociata resta legata a Gerusalemme e nel caso di deviazione se ne impoverisce il contenuto.

5 Esperienze di crociata Al termine della I crociata furono fondati quattro stati franchi o latini in Siria e in Palestina: la contea di Edessa, il principato di Antiochia, la contea di Tripoli e il regno di Gerusalemme. Urbano II non si espresse riguardo al futuro politico dei territori conquistati, poiché morì prima di conoscere l’esito della I crociata, il suo successore aspirava alla creazione di stati teocratici dipendenti dal papato, ma i baroni rifiutarono: a Gerusalemme fu eletto re Baldovino, il quale instaurò una dinastia ereditaria. Grazie all’intervento delle flotte italiane e nordeuropee i crociati presero i porti di Acri, Tripoli, Sidone, Tiro e Ascalona. Quando Saladino, signore d’Egitto, riuscì ad estendere il suo possesso alla Siria i crociati si trovarono di fronte un nemico molto potente. Nel 1187 i crociati furono duramente sconfitti nella battaglia di Hattin e Gerusalemme fu persa, ma i franchi resistettero e trovarono rifugio a Tiro. La III crociata ricostituì un regno di Gerusalemme senza Gerusalemme, con capitale Acri, mentre le relazioni pacifiche con gli ayyubidi (i successori di Saladino) permisero agli stati franchi di riprendere il controllo della costa siropalestinese. Dopo il grande successo diplomatico ottenuto da Federico II, però, con il fallimento dell’impresa di san Luigi e la presa del potere da parte dei mamelucchi in Egitto (1250) per gli stati crociati iniziò una lunga agonia, solo provvisoriamente interrotta dalla grande avanzata mongola. Dopo la caduta di Acri nel 1291 gli stati latini in Siria e Palestina scomparvero. Nel Mediterraneo orientale furono fondati altri stati: Cipro, conquistata da Riccardo Cuor di Leone, fu meta degli esuli franchi fuggiti da Acri, mentre il regno armeno di Cilicia, o Piccola Armenia, era uno stato cristiano ma non fu fondato dalla crociata. La IV crociata e la dissoluzione dell’impero bizantino portarono alla formazione di altri regni, l’isola di Rodi, infine, fu conquistata dall’ordine religioso-militare degli ospedalieri per volere del gran maestro dell’ordine Foulques de Villaret e divenne un vero e proprio stato teocratico. Gli stati latini formavano un territorio che si estendeva dall’Asia Minore a nord fino al Sinai a sud, i latini mantennero il controllo della costa ma non riuscirono a conquistare le grandi città prossime al deserto come Damasco e Aleppo. Per la sopravvivenza degli stati crociati era essenziale la divisione interna al mondo musulmano, una volta che Siria e Egitto furono unificate per mano di Saladino per i crociati non ci fu più margine di manovra. Spessissimo i crociati sceglievano di allearsi ai musulmani, ma la presa del potere da parte dei mamelucchi negò loro anche questa possibilità. L’attività militare in Terra Santa poteva avvalersi da un lato sugli eserciti degli stati latini e dall’altro sulle armate provenienti da occidente. Il reclutamento degli eserciti degli stati latini d’oriente si basava sul sistema feudovassallatico importato da occidente. I cavalieri pesanti costituivano il nerbo dell’esercito dei crociati, ma accanto ad essi erano determinanti i sergenti d’armi a cavallo (armati alla leggera) e i contingenti di cavalleria leggera di turcopoli (combattenti cristiani di origine turca). Non è da dimenticare, infine, l’apporto di fanti, arcieri e balestrieri, reclutati per lo più come mercenari. È stato possibile calcolare il numero delle forze armate degli stati latini nelle battaglie (perse) di Hattin e La Forbie: esse non superavano le 20.000 unità, pertanto, se si volevano lanciare grandi operazioni di conquista era necessario un apporto esterno, fornito dalle crociate, cui partecipavano gli eserciti dei re. In molti casi si verificarono contrasti tra i crociati d’occidente e i latini d’oltremare, chiamati poulains, per questi ultimi erano migliori aiuti meno massicci ma più continuativi da parte dell’occidente. I crociati potevano contare su una importante rete di castelli, i quali erano efficaci mezzi di mobilitazione delle truppe, strumento di dominio di un territorio e punto d’appoggio per le incursioni contro i musulmani. I castelli dei franchi erano costruiti sui resti di quelli bizantini o musulmani, essi hanno giocato un ruolo importante dal punto di vista militare, ma anche politico e economico. Dopo il 1180 i castelli crociati avevano la finalità di proteggere un territorio e non più quello di segnare l’avanzata e le intenzioni offensiva dei franchi. Dopo il 1250 i mamelucchi fecero cadere una dopo l’altra le fortezze dell’entroterra, dopodiché poterono attaccare le città e i castelli della costa. Gli ordini religioso-militari sono nati in Terra Santa e, a parte l’ordine del Tempio, che ha scelto un profilo esclusivamente militare, gli altri hanno unito l’attività guerriera a quella di assistenza. L’ordine di San Lazzaro curava i lebbrosi, ma era anche presente sui campi di battaglia così come il piccolo ordine inglese di San Tommaso d’Acri. Il Tempio, l’Ospedale e i teutonici hanno un organizzazione simile e i fratelli dell’ordine si suddividono in tre categorie: ci sono i fratelli cappellani (i soli ad essere stati ordinati sacerdoti), i fratelli cavalieri e i fratelli sergenti (che sono artigiani o si occupano di far rendere al meglio il capitale fondiario dell’ordine). Oltre ad essi vengono reclutati un buon numero di fanti, arcieri e scudieri. Grazie alla loro abilità e alla loro disciplina gli ordini militari sono stati la punta di diamante degli eserciti latini. Nel XIII secolo re e principi cedettero i loro castelli agli ordini militari, che disponevano di uomini e risorse a sufficienza per difenderli. In Europa gli ordini disponevano di un consistente patrimonio, soprattutto di natura fondiaria, inoltre avevano spiccate doti finanziarie, le loro grandi qualità permisero agli ordini militari di svolgere un ruolo sempre più importante nella politica degli stati latini (tanto che a causa delle loro rivalità e discussioni la critica li ha considerati responsabili della caduta del regno di Gerusalemme).

Anche nella penisola iberica nacquero degli ordini religioso-militari, come quello castigliano di Calatrava o quello portoghese di Aviz, ma in linea generale la reconquista fu condotta dai re con le loro truppe e gli ordini nati in Terra Santa non vi vollero partecipare perché sarebbero stati privati dell’autonomia di cui erano usi godere. Nei territori del Baltico l’ordine teutonico si impegnò in una vasta impresa etnica e religiosa, di conquista territoriale e colonizzazione agricola. Le cose andarono bene in Prussia, meno in Livonia (le attuali repubbliche baltiche), le crociate di Prussia divennero un’occasione di parata della nobiltà occidentale. Perché le conquiste delle crociata fossero durature era necessario occuparsi del popolamento. Alla conclusione di ogni crociata sul posto rimasero degli uomini e quando non era tempo di crociate uomini e donne si stabilirono in Terra Santa. Gli stati latini, come la Spagna o la Prussia rappresentavano una nuova frontiera e ovunque si costruirono città. Fin verso gli anni ottanta del XII secolo la situazione nel regno di Gerusalemme rimase tranquilla e ciò favorì l’insediamento di coloni europei, spesso obbligati a partire dagli stessi regnanti che si impegnavano nella crociata. In Spagna, dove non vi era abbastanza gente per popolare le terre conquistate dopo l’espansione degli stati cristiani verso sud, si lasciarono sul posto musulmani e ebrei, che poterono continuare a praticare la propria religione. Genovesi, veneziani e pisani svolsero un ruolo fondamentale nella crociata, essi erano crociati, ma non dimenticavano i propri interessi e ottennero importanti privilegi commerciali. Il Mediterraneo orientale si divideva in tre settori commerciali: Costantinopoli e il mondo bizantino, Alessandria e l’Egitto e, infine, la costa siropalestinese e il suo entroterra mesopotamico. Gli scambi avvenivano principalmente a Costantinopoli e Alessandria dove gli occidentali si procuravano prodotti orientali come le spezie in cambio di lana, legno, ferro e armi. La costa siropalestinese svolgeva un ruolo commerciale di gran lunga secondario. In Egitto tutte le classi dirigenti che si succedettero favorirono il commercio con l’occidente perché li riforniva di prodotti di cui erano privi. La crociata ha avuto il pregio di creare nuove vie commerciali (ha aperto il mar Nero ai mercanti italiani) e ha sviluppato l’importanza di porti quali Tiro, Beirut, Tripoli e soprattutto Acri (descritta da un viaggiatore musulmano come il più importante porto franco) i quali avevano intense relazioni con le ricche città musulmane dell’interno. La pax mongolica favorì l’apertura di nuove rotte (come quella che collegava il mar Nero con Alessandria) e alla fine del medioevo si giunse a una spartizione degli spazi orientali: il nord ai genovesi e il sud ai veneziani. Le rivalità commerciali e politiche fra le repubbliche marinare italiane si trasferirono nelle rispettive colonie d’oriente ed ebbero ripercussioni negative sugli stati latini e sulle crociate. Diversi concili imposero il divieto totale del commercio con i musulmani per la durata prevista della crociata, ma le minacce di scomunica ebbero scarso effetto sui mercanti. I crociati si trovarono ad affrontare il problema della prigionia. Durante gli anni della crociata da ambo gli schieramenti si assisteva a uccisioni di massa dei prigionieri e a massacri della popolazione civile. I musulmani avevano l’abitudine di fare prigionieri i signori ricchi e potenti in previsione di un ricco riscatto, mentre i latini facevano prigionieri indistintamente ed essi potevano affrancarsi attraverso la conversione al cristianesimo (cosa che provocò le ire dei baroni e degli ordini perché si videro privati di manodopera). Al momento della I crociata i guerrieri non nutrivano alcuna pietà per il nemico e i latini si rifiutavano di consegnare ai musulmani un castello o una città quand’anche ci fosse di mezzo la vita di un re preso in ostaggio. Nella tradizione araba e bizantina, invece, lo scambio di prigionieri era frequente. Nel corso del XII secolo i franchi riconobbero il valore militare dell’avversario e si impose saldamente un’etica cavalleresca, i chierici si organizzarono in confraternite per la liberazione e il conforto dei prigionieri cristiani in mano ai saraceni. Nella storiografia è ricorrente il tema della critica alla crociata, perfino ai tempi di Urbano II essa fu criticata, lodi e critiche sono sempre coesistite. Valutare i sentimenti dell’opinione pubblica contemporanea alla crociata è molto difficile. I critici più assidui della crociata e del suo portato di violenza furono gli eretici albigesi e valdesi, ma non mancarono le critiche di chierici di fama, come Pietro il Venerabile, abate di Cluny. Egli era contrario alla conversione degli infedeli ottenuta con la violenza, ma non metteva in discussione il recupero di Gerusalemme. L’inglese Rodolfo il Nero era molto più radicale: “Deus non vult”, ma siamo all’epoca del disastro di Hattin e della perdita di Gerusalemme. Alcuni chierici dimostravano una visione provvidenziale della storia e ritenevano che Dio avesse inflitto la sconfitta ai crociati per punirli dei loro peccati, Saladino diveniva così espressione della volontà divina. Altre critiche pesanti erano mosse all’indirizzo della politica finanziaria del papato e alla deviazione della crociata verso obiettivi diversi da Gerusalemme.
6 I crociati e gli altri Molti storici e intellettuali hanno ampiamente sottolineato il valore negativo delle crociate (per Le Goff esse hanno portato alla civiltà occidentale solo l’albicocca), presentate come la manifestazione di un imperialismo occidentale legittimato dalla chiesa romana ai danni dell’islam e delle cristianità orientali. Questi storici ricordano i massacri avvenuti dopo la presa di Gerusalemme da parte dei crociati e il sacco di Costantinopoli e affermano che gli stati latini d’oriente, essendo nati dalla violenza, non potevano diventare luoghi di scambi e di relazioni pacifiche tra occidente e oriente. Bisogna fare attenzione, però, a evitare anacronismi: la crociata è un fatto religioso e non una guerra imperialista, inoltre la crociata ha avuto il pregio di far stringer relazioni, non tutte di matrice violenta.

Relazioni con i greci: sorpresa e disprezzo da parte dei greci verso i crociati, ritenuti barbari; i greci rifiutavano l’idea stessa di guerra santa, anche quando nel X secolo gli scontri con i musulmani alla frontiera divennero sempre più numerosi e gli imperatori auspicarono che i loro soldati ottenessero ricompense spirituali i patriarchi di Costantinopoli rifiutarono. Crociata e jihad: i musulmani siriani di fronte all’arrivo dei franchi inizialmente pensarono di avere a che fare con le abituali incursioni dei greci alla frontiera (le prime menzioni dei testi arabi parlano dei rum, solo in seguito li si identificò come franchi). Jihad e crociata hanno caratteri simili (l’obiettivo era il trionfo della propria religione e comuni erano le ricompense spirituali), ma la jihad è una componente originale dell’islam è ha un significato più ampio e spirituale. Per poter affrontare i franchi era indispensabile l’unità del mondo islamico: per questo Zengi e Saladino si servirono delle armi della jihad prima contro gli scismatici e poi contro gli infedeli. Relazioni con gli ebrei: le comunità ebraiche d’occidente furono le prime vittime della crociata, ogni movimento di crociata è stato accompagnato in occidente da manifestazioni di antigiudaismo e agli ebrei fu vietato di risiedere nella Città Santa. Con la crociata in oriente e la riconquista della Spagna importanti gruppi di musulmani sono passati sotto il governo di principi cristiani (mentre in precedenza era il contrario e i cristiani potevano continuare a praticare la propria religione e conservare i propri costumi e le proprie leggi). I primi crociati hanno ucciso senza pietà i musulmani, ma col tempo si giunse a un atteggiamento più mite (per il re di Spagna Alfonso il Saggio combattere gli infedeli per accrescere la fede cristiana non implicava il loro sterminio). Una volta soggiogati gli infedeli ad essi venne concessa la libertà di culto, ma non mancarono le discriminazioni sotto forma di abiti speciali o del divieto di matrimoni misti. Nel caso delle popolazioni pagane del Baltico valeva il principio della conversione forzata, non così per i seguaci di giudaismo e islam, religioni monoteiste. I musulmani erano sempre definiti dagli occidentali col termine di saraceni, per alcuni (Pietro il Venerabile) essi erano eretici, per altri pagani che andavano sterminati. Solo col tempo si imparò a conoscere meglio la religione musulmana, grazie soprattutto ai resoconti di viaggio di alcuni autori che si sforzarono di non demonizzare il nemico. La conversione non era uno degli obiettivi primari della crociata, a differenza di quanto accadeva in Spagna e nel Baltico, gli ordini religioso-militari non avevano fama di grandi evangelizzatori ma nonostante questo si verificarono numerose conversioni spontanee dall’islam al cristianesimo (soprattutto perché il battesimo concedeva la libertà agli schiavi). Fu necessario attendere la scoperta del grande impero multiconfessionale mongolo perché l’azione missionaria potesse prendere l’avvio, infatti in precedenza in Terra Santa non avveniva una predicazione sistematica (destò particolare impressione in occidente il tentativo di san Francesco di convertire il sultano d’Egitto durante la V crociata). Mentre le prime missioni di francescani e domenicani venivano inviate in oriente si diffuse la convinzione che se si voleva convertire l’infedele era necessario conoscere al sua fede e parlare la sua lingua. Cristiani d’oriente: nestorianesimo monofisismo vedi pag 209-212 I franchi che crearono una discendenza in oriente (poulains) adottarono i costumi e lo stile di vita dell’ambiente in cui si erano trasferiti. I crociati venuti a combattere gli infedeli accusavano i poulains di debolezza e tradimento. Nella Siria e nella Palestina occupate dai franchi vivevano popolazioni cristiane e musulmane. All’inizio della conquista vi furono massacri e espulsioni ma in seguito prevalse lo status quo e la popolazione contadina rimase sul posto e dopo aver cambiato padrone non notò un peggioramento delle proprie condizioni. A differenza di quanto accaduto in Sicilia o in Spagna nessun musulmano entrò a far parte dell’amministrazione latina: musulmani e franchi vivevano fianco a fianco ma lo facevano separatamente. Le testimonianze mostrano che in Terra Santa, spessissimo presentata come una terra di conflitto ininterrotto, vi erano lunghi periodi di tranquillità (ne sono una prova i tornei del monte Carmelo in cui i cavalieri cristiani si misuravano con quelli musulmani secondo lo spirito e l’etica cavalleresca). In occidente il tema del nobile infedele fu incarnato dalla figura del Saladino. In alcuni casi cristiani e musulmani si radunavano negli stessi oratori per pregare o si recavano negli stessi luoghi di culto ove si verificarono miracoli. Non mancarono gli scambi intellettuali: si approfondì la conoscenza della lingua e della scienza araba (soprattutto nel campo della matematica e della medicina) e città come Gerusalemme e Antiochia divennero attivi centri culturali.
7 Ideale e realtà (1250-1500) Dopo che nel 1250 i mamelucchi, schiavi di origine turca, presero il potere in Egitto il loro principale obiettivo divenne cacciare i franchi dalla Siria e dalla Palestina. L’irruzione dei mongoli, però, concesse ai crociati un momento di tregua. I mongoli avevano decretato la fine del sultanato selgiuchide e del califfato abbasside (distruzione di Baghdad), ma furono sconfitti dai mamelucchi in Palestina. Su iniziativa del papato furono stretti i primi accordi fra i mongoli e i latini e missionari e ambasciatori (come Guglielmo di Rubrouck, inviato da san Luigi) iniziarono a percorrere il vasto impero mongolico. Si diffuse l’idea di un’alleanza fra i franchi e i mongoli contro l’islam, possibilità di cui si discusse nel concilio di Lione, ma molti ostacoli rendevano questa idea difficilmente praticabile: il deserto mesopotamico e siropalestinese non offriva ai mongoli la possibilità di mantenere la loro immensa cavalleria, i latini del

regno di Gerusalemme erano diffidenti nei loro confronti e la grande distanza tra l’occidente e l’Ilkhan rendeva quasi impossibile organizzare spedizioni combinate. A causa di questi fattori il progetto iniziale di san Luigi dovette essere abbandonato e nel 1281 i mamelucchi infersero una disfatta militare ai mongoli. L’avanzata mamelucca fu a quel punto inarrestabile e i maggiori castelli e le città franche cedettero l’una dopo l’altra fino al 1291 e alla caduta di Acri. I franchi ripiegarono su Cipro e l’isola mediterranea divenne il centro dei tentativi di riconquista di Gerusalemme, ma nonostante l’importante apporto dei mongoli essi fallirono. Il regno armeno di Cilicia fu conquistato dai musulmani nel 1373, mentre Cipro sopravvisse in mano ai cristiani fino al 1570-71, quando divenne preda degli ottomani. In Europa fiorirono trattati sul tema del recupero di Gerusalemme destinati al papa o ai principi laici e scritti da chierici, maestri degli ordini religioso-militari o propagandisti e strateghi di corte. Quasi tutti questi scritti convergevano sull’idea di concentrare la propria azione sull’Egitto, da bloccare economicamente e poi da colpire con ferocia. Il tentativo di evitare, attraverso la minaccia della scomunica, il commercio con l’Egitto, però, non diede frutti anche a causa dell’opposizione di Venezia, la principale beneficiaria dei traffici con Alessandria, e il cui appoggio in vista di una crociata era indispensabile. Nei trattati sul recupero della Terra Santa il passaggio particolare (raid e incursioni) serviva a preparare un passaggio generale, ossia una crociata indetta dal papa e a cui avrebbero dovuto partecipare tutte le potenze. I testi prendono in considerazione il finanziamento dell’operazione e i mezzi di trasporto che dovevano condurre i crociati in Terra Santa, per un chierico addirittura era indispensabile prendere Bisanzio perché la crociata andasse a buon fine. Per la realizzazione di questi progetti, tuttavia, la pace e l’armonia dovevano regnare in occidente, ma nei fatti non era così: la guerra tra aragonesi e angioini si concluse solo con la pace di Caltabellotta nel 1302, mentre rimanevano vivi il conflitto tra Castiglia e Aragona, in Italia tra guelfi e ghibellini e il più importante tra Francia e Inghilterra (quest’ultimo sarebbe degenerato dando vita alla guerra dei Cent’anni). Altra condizione più volte avanzata era quella dell’unione degli ordini religioso-militari, auspicata dai chierici (che ambivano a controllarli meglio) ma naufragata a causa delle reticenze degli stessi ordini e dei monarchi europei (timorosi di rafforzarli troppo). Nel 1307 il re di Francia pose termine alla questione attaccando l’ordine del Tempio e pochi anni dopo esso fu soppresso. Tutti i progetti di riconquista rimasero però sulla carta visto anche il rifiuto dei sovrani europei a partecipare a imprese tanto incerte e dispendiose. Dopo la distruzione mongola del sultanato selgiuchide si formarono una serie di emirati turchi e uno di essi, quello ottomano, prese progressivamente il sopravvento sugli altri e si estese nell’interno anatolico in direzione delle coste del mar Nero e dell’Egeo, fino a raggiungere l’Europa. Dopo aver sconfitto i serbi nella battaglia del Kosovo (1389) e l’esercito crociato guidato dal re d’Ungheria e dal borgognone Giovanna senza Paura nella battaglia di Nicopoli (1396), l’avanzata ottomana fu momentaneamente arrestata da Tamerlano che sconfisse i turchi nella battaglia di Ankara (1402). Gli ottomani, però, ripresero presto il loro regime di conquiste e dopo aver sconfitto la crociata di Varna (ungherese e latina) guidata dal legato pontificio Cesarini (1444), decretarono la fine dell’impero bizantino con la conquista di Costantinopoli da parte del sultano Maometto II. I cristiani non solo combatterono crociate contro gli ottomani ma dovettero anche resistere alla loro pirateria. Arginare i turchi, aiutare Bisanzio e proteggere l’Europa furono gli obiettivi delle imprese sostenute dall’occidente nei secoli XIV e XV. La resistenza per mare agli ottomani venne sostenuta attraverso leghe militari legittimate dal papato. Il papa subordinava sempre l’aiuto a Bisanzio all’unione delle due chiese, ma i greci guardavano con diffidenza ai franchi, in questo contesto a prevalere non erano le grandi imprese concertate dalle maggiori potenze ma le iniziative dei singoli. A questo proposito citiamo la vittoria del maresciallo di Francia Boucicaut che obbligò il sultano a togliere l’assedio a Costantinopoli e la resistenza contro i turchi del voivoda di Transilvania Janos Hunyadi. Solo la caduta di Costantinopoli fornì agli occidentali l’occasione per coordinare i loro attacchi, ma ancora una volta senza successo, tanto che la fase espansiva dei turchi ottomani continuerà nel secolo successivo con le conquiste messe a segno da Solimano il Magnifico. L’idea di crociata continuò a esercitare il suo potente fascino durante il XIV secolo soprattutto nel regno di Francia grazie al ruolo di abile propagandista svolto da Philippe de Mézières al tempo di Carlo VI e Carlo VII. Combattendo i turchi nell’Europa dei Balcani i cristiani recuperarono una tradizione appartenuta ai loro antenati crociati. Il papa umanista Pio II (Enea Silvio Piccolomini) voleva guidare personalmente una crociata destinata a combattere gli ottomani e recuperare Gerusalemme, ma il congresso convocato a Mantova alla presenza dei principi italiani per inneggiare alla crociata non ottenne i risultati sperati. Sopravviveva la pratica del pellegrinaggio, mentre lo spirito della crociata permeava alcune imprese dei secoli XIV-XVI. Dopo la caduta di Acri l’ordine teutonico si concentrò sulla Prussia e sulla Livonia e Marienburg divenne la sede dell’ordine e la residenza del gran maestro. L’ordine trasformò la Prussia in uno stato teocratico, ma in Livonia dovette affrontare la resistenza dell’arcivescovo di Riga e delle città che, timorose di perdere i propri privilegi, denunciarono i metodi violenti e rozzi messi in pratica dall’ordine per ottenere la conversione delle popolazioni. La resistenza ostinata dei lituani e le loro incursioni militari dettero vita a una spietata guerriglia e i teutonici chiesero man forte ai cavalieri occidentali, iniziò così la tradizione delle crociate di Prussia che coinvolse molti sovrani europei. A seguito dell’unione fra i loro regni i polacco lituani sconfissero i teutonici nella battaglia di Grunwald nel 1410, il concilio di Costanza in seguito vietò

ai teutonici l’uso della forza contro i polacco lituani e affidò al re Ladislao Jagellone il compito di evangelizzazione fra i propri sudditi. A Costanza venne anche decretata la condanna al rogo di Jan Hus, teologo della Boemia, il cui riformismo religioso aveva spinto alla sollevazione le genti boeme. Il papato si scagliò contro gli hussiti boemi e lanciò contro di loro ben cinque crociate tra il 1420 e il 1431, tutte conclusesi con insuccessi. Gli eretici erano ben organizzati militarmente e guidati da capi carismatici, alla fine prevalsero gli hussiti moderati ma Pio II scomunicò il re hussita Giorgio Podebrady che rispose al papato con un progetto di crociata che doveva prevedere la pace duratura fra i regni europei. La crociata non morì col 1291, per molto tempo ancora la cristianità fu pervasa da obiettivi quali il recupero di Gerusalemme, l’aiuto alle chiese orientali e la lotta contro i turchi. La nobiltà occidentale inserì la crociata nelle proprie tradizioni familiari tanto che il vivere come nobile implicava diventare crociati.
Conclusione Gli storici della crociata si dividono in tradizionalisti e pluralisti, i primi danno maggiore importanza all’obiettivo: Gerusalemme, mentre i secondi pensano che l’origine (il papato) e le istituzioni (voto, croce, indulgenze) abbiamo maggior peso. La definizione tradizionalista limita il campo della crociata, quella pluralista lo estende considerevolmente, entrambe le visioni offrono il destro a critiche. Gli storici erano usi a prendere congedo dalla crociata al termine del XIII secolo sostenendo che essa fosse morta, ma in realtà non era affatto così se si pensa al suo collegamento con la cavalleria o al fatto che lo stato moderno continuò a servirsene per combattere i turchi. Papa Pio II nel 1464 fu forse l’ultimo a cercare seriamente di mettere in pratica la crociata, dopo di lui ne sopravvisse il mito.