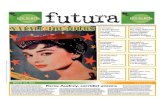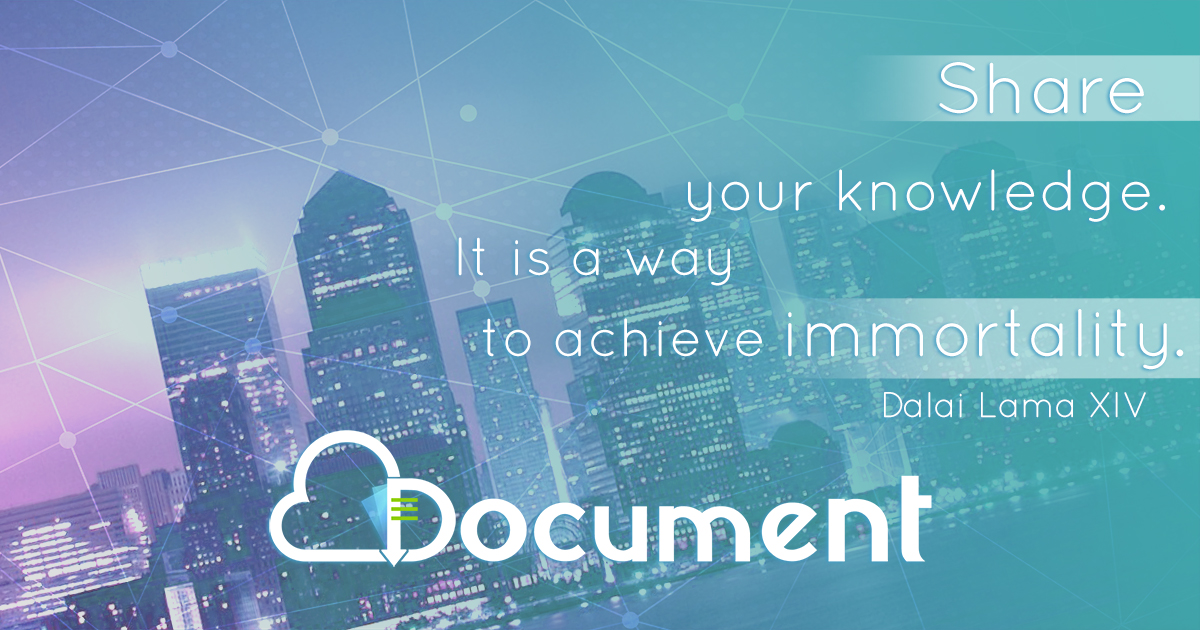Convegno Terra Futura Vicenza 17 marzo 2012.docx
-
Upload
oscar-mancini -
Category
Documents
-
view
6 -
download
2
description
Transcript of Convegno Terra Futura Vicenza 17 marzo 2012.docx

Convegno Terra Nostra. Vicenza 17 marzo 2012. Villa Lattes
Relazione di Oscar Mancini
Di fronte alla grande alluvione che ha colpito il Veneto nel novembre del 2010, il “governatore” Luca Zaia esclamò: “Quando la natura si ribella è indice di grandi cambiamenti climatici”. Le prime reazioni, anche in settori del mondo ambientalista, furono di soddisfazione: finalmente un esponente di quella maggioranza di governo, la più ostinata di tutto l’occidente nel negare questa emergenza, prendeva atto che con i cambiamenti climatici bisognava fare drammaticamente i conti.
La riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle con 10 milioni di ton./anno di emissioni di CO2 poteva ora essere rimessa in discussione e gli ambientalisti, che a loro dire “si trastullano con i mulini a vento”, non sarebbero stati più irrisi.
Ma i dati sulle precipitazioni atmosferiche, per quanto intensi, non giustificavano questa interpretazione degli eventi.
Comprendemmo subito che mettendo l’accento sui cambiamenti climatici, allarmante fenomeno planetario, Zaia allontanava da se e dalla sua maggioranza di governo le responsabilità dell’alluvione.
Oscurava cioè il fatto che l’esondazione dei fiumi è provocata innanzitutto da quel tanto decantato modello veneto della “città diffusa”, da quella crescita urbana senza forma che ha divorato i terreni agricoli con implacabile voracità per formare quella nebulosa insediativa alla quale gli americani hanno dato il nome di “sprawl town” (la città sdraiata sguaiatamente) che ha accresciuto la vulnerabilità di un territorio già di per se strutturalmente fragile.
Oscurava cioè che all’origine dei nostri guai recenti vi è anche una legge urbanistica regionale che ha lasciato briglia sciolta alla rendita immobiliare, favorendo così una dilagante cementificazione del territorio, il disboscamento lungo i fiumi e la mancanza di una manutenzione geologico-idraulica del territorio.
Un diluvio di cemento e asfalto che ha impermeabilizzato il territorio rallentando così il processo di ricarica delle falde e provocando sempre più frequenti esondazioni dei corsi d’acqua.
Questo è quanto la CGIL Vicentina denunciava inascoltata ancora nel 2003. Negli anni settanta, abitando a Caldogno, mi capitava di percorrere una bella campagna punteggiata da risorgive. Oggi quel territorio è in gran parte urbanizzato e si deve ricorrere ai bacini di laminazione per evitare di andare sott’acqua anche nel futuro.
Eppure è noto, come ci ha ricordato di recente il Prof D’Alpaos, che un terreno agricolo ha una portata di 10 litri al secondo per ettaro mentre un’area urbanizzata li fa diventare 150/200. Strana coincidenza: esattamente le stesse proporzioni della crescita della rendita immobiliare derivante dalle varianti urbanistiche!!
1

Per dare un’idea di quanto scellerata sia la politica della Regione Veneto anche in questo campo vi segnalo, tra i tanti esempi possibili, quello che sta scritto a pagina 36 del PTRC: “C’è ancora tanta campagna nel Veneto sicché il consumo di suolo non è un problema reale, poiché la percentuale di terreno rurale (SAT) è di molto superiore alle terre coltivate” (SAU).
Affermazione aberrante: come se l’attività economica del settore primario fosse l’unica ragione del salvaguardia del suolo dall’urbanizzazione, se l’obiettivo non dovesse essere quello della difesa del territorio rurale nel suo complesso e se non fosse già gigantesca l’area impermeabilizzata e sottratta al ciclo naturale.
E’ da questo scellerato approccio che nel Veneto nascono come i funghi megaoperazioni immobiliari quali:
-“Veneto City”, un colosso che cancellerà 60 ettari di campagna tra Padova e Mestre, con oltre 2 milioni di mc di cemento e vetro per costruire una città direzionale/commerciale grande quanto 17 volte la fiera di Padova ,di cui però nessuno ha ancora chiaro a cosa serve;
- “Città della moda”, denominata “Verve” a fianco delle ville palladiane che si affacciano placide sul Naviglio Brenta;
- “Tessera City”, la città del “loisir”, sulla gronda lagunare, in una zona ad altissimo rischio idralico, essendo la zona centrale a 1,75 m sotto il livello del medio mare. Il progetto del naufragato EXPO 2000 di G.De Michelis prevedeva di costruivi una laguna artificiale.
- “Motorcity” nel veronese, con quattrocento ettari da cementificare e la già realizzata base americana a Vicenza e potrei continuare con le nuove aree industriali nel Polesine, la centrale di Porto Tolle in mezzo al Parco del Delta alle prese con il “cuneo salino”, lo scavo dei canali per far entrare le grandi navi in laguna e via dicendo.
Naturalmente questi insediamenti dovranno essere serviti da nuove strade, svincoli, rotatorie e soprattutto nuove autostrade costruite in projet financing e quindi a pagamento. Un meccanismo questo, combinato con la legge obiettivo, per cui comandano i privati, pagano i contribuenti e gli utenti, guadagnano le solite imprese e di tanto in tanto si scopre pure che i profitti sono così elevati da lasciare ampi margini anche per le tangenti e per non farsi mancare nulla sono così efficienti da approfittarne per smaltire i rifiuti tossici sotto il manto stradale come nel caso della Valdastico Sud.
Mentre il SFMF rimane al palo da vent’anni si progettano la Pedemontana, la Romea commerciale, la Nogara Mare, il GRAP, la Valsugana e via dicendo. Il più stupefacente è il caso che sto per raccontarvi. Dopo la grande alluvione, il Prof D’Alpaos, uno dei più autorevoli idraulici d’Italia, spiega ai padovani , finalmente ricettivi dopo anni di prediche al vento, che se non vogliono correre il rischio di finire nuovamente sott’acqua è indispensabibile completare l’idrovia Padova/Laguna. Essa è utile anche a fini trasportistici. L’intero consiglio comunale di Padova finalmente approva.
2

Cosa fa la Regione? Insiste nel voler realizzare, ovviamente in projet financing e, spacciando l’inesistente inserimente dell’opera nella legge obiettivo per mettere fuori gioco gli enti locali, una camionabile funzionale a realizzare il polo logistico di Dogaletto che insiste su un’area di 4 milioni e 600 mila mq di gronda lagunare, sito d’interesse comunitario, tutelato dal PALAV e sottoposto a vincoli paesaggistici e ambientali.
Ancor più assurdo appare il progetto sponsorizzato da Paolo Costa se si considera che a soli tre chilometri vi è un’ampia disponibilità di aree dismesse di Porto Marghera. (Eppure l’idea ha affascinato anche settori del centro sinistra di Venezia).
Per stare a Vicenza, molti sono stati e sono i conflitti ambientali:è superfluo in questa sede ricordare il grande movimento contro la base militare Dal Molin oggi impegnato per la realizzazione del “Parco della Pace", la lotta vittoriosa contro l’impianto Wisco “ ai Ferrovieri” per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti pericolosi anche nocivi, la vittoriosa mobilitazione popolare contro la centrale termoelettrica di Montecchio, l’eroica mobilitazione dei cittadini contro il grande disastro ambientale di Tezze sul Brenta; le iniziative di Italia Nostra contro la Valdastico Sud e l’ampliamento delle cave in area berica, la mobilitazione dei cittadini di Monteviale contro il distributore in quell’area di pregio paesaggistico che è il “Biron”, le competenti iniziative dei bassanesi per il “contratto di fiume” e potrei continuare.
E’ “l’epoca dei comitati” dichiara sconsolato Silvano Vernizzi, il super commissario della Regione.
Oggi il tema più rilevante è senza alcun dubbio la Pedemontana: un’autostrada a pagamento che dovrebbe collegare Montecchio Maggiore a Spresiano in provincia di Treviso, un sepentone di cemento e asfalto lungo 95 Km di cui 50 in trincea, un’opera da 2 MDL e oltre di euro, più volte bloccata dai ricorsi dei cittadini e di alcuni Comuni (Villaverda capofila) e fortemente voluta da Zaia e dagli imprenditori. Un’autostrada, così come progettata, inutile e dannosa, come ci spiegherà l’ach. Massimo Follesa, il portavove del CoVePa, il coordinamento veneto Pedemontana alternativa.
Come scrive Paolo Feltrin, uno degli ideologi del Piano della Regione, i caselli e gli svincoli autostradali saranno l’occasione per favorire l’insediamento di “….grandi mall terziari, strutture sanitarie, auditorium, centri congressi, complessi commerciali e direzionali, aree produttive, centri logistici e simili.” Una indicazione che sembra voler nobilitare le new city della speculazione immobiliare che già si sta vigorosamente manifestando attorno al Passante di Mestre. Ecco la posta in gioco attorno alla Pedemontana.
Per la sua realizzazione va rimosso ogni ostacolo. Sino a invocare, come fa il commissario Silvano Vernizzi, la cancellazione del diritto dei comitati a ricorrere. Segretario di un’anomala e verticistica struttura amministrativa della Regione egli è contemporaneamente Commissario per la Pedemontana Veneta (lo è stato per il Passante di Mestre) nonché Amministratore Delegato della disastrata Veneto Strade.
Ne deriva un assetto gerarchico regionale che pone al vertice il Segretario che riunisce le funzioni di valutazione tecnica e di verifica di compatibilità, anche di progetti stradali, e si
3

avvale pure di due incarichi di Commissario e Amministratore. Ma non basta, perché la medesima persona è pure il Presidente delle commissioni regionali in materia di valutazione ambientale (VAS e VIA) oltre che “Autorità competente per la valutazione di incidenza ambientale” (la V.Inc.A, per la tutela della biodiversità) e “coordinatore del Comitato Tecnico per l'attuazione dell'intesa tra Regione e Ministero Beni Culturali in materia di paesaggio”.Di fronte agli autorevoli pareri espressi dalla stessa persona, come si permettono questi comitati di intralciare la realizzazione delle opere? Bonaparte dixit!
Ma non è solo la Regione a sottovalutare il rischio idraulico. I PAT/PATI dei nostri comuni, in cerca di oneri di urbanizzazione per coprire i buchi di bilancio, spesso consentono un pressoché generale via libera allo “svillettamento” che si traduce in svendita di quel bene comune che è il territorio. I PAT, anziché essere piani strutturali, diventano sempre più piani cornice, a maglie molto larghe, che rinviano ai piani degli interventi (PI), sottratti alla stessa valutazione del Consiglio Comunale perché diventati prerogativa della Giunta.
Cosa è successo dopo il grido d’allarme lanciato all’inizio degli anni 2000 dall’Accademia Olimpica? Da quando Gian Antonio Stella con mirabile capacità di sintesi denunciava che in Provincia di Vicenza negli anni novanta si era realizzata una crescita edilizia di 56 milioni di metri cubi pari a un capannone largo 10 metri, alto 10 e lungo 560 Km?
Si è finalmente compreso che il territorio è un bene comune scarso e prezioso? I dati ci dicono che è successo il contrario: se nel decennio 90/2000 abbiamo consumato nel Veneto 9.752 ettari/anno nel decennio successivo (2000/2010) sono diventati 18.230. Sono cioè quasi raddoppiati raggiungendo la cifra record di 182 milioni di mq/anno. In 8 anni si sono realizzati 164 milioni di metri cubi di edifici commerciali, direzionali, industriali pur con una diffusa presenza in tutti i comuni di capannoni abbandonati e da anni inutilmente offerti in vendita o in affitto.In 10 anni si sono ultimate 367.354 nuove abitazioni per una volumetria di 148 milioni di metri cubi per una popolazione di quasi 1 milione di abitanti mentre la crescita demografica è stata inferiore alla metà.
Cosa ci dicono questi dati? Che con la transizione postfordista i capitali prima generano la fabbrica a rete dispersa nel territorio, poi in parte delocalizzano e infine, in gran parte, si dislocano nella finanza e nell’immobiliare. Il territorio è diventato così il cantiere di produzione del valore che deriva dalla rendita fondiaria che un tempo definivamo parassitaria.Ne deriva non solo il saccheggio del territorio ma anche l’impoverimento del tessuto produttivo, la compressione dei salari e dei diritti, l’erosione del welfare.Dall’economia delle cose si passa all’economia della carta. Il Denaro non è più un mezzo per comprare Merci e produrre più Merci, ma è il Denaro in sé che diventa il fine: trasformare il Denaro in più Denaro attraverso la finanza e trasformando Beni comuni in Merci per produrre sempre più Denaro.
É una mutazione totale dell’economia capitalistica. Che trascina con sé una mutazione profonda della società. Il capitalismo industriale, che fino a quel momento aveva guardato con aristocratica diffidenza l’imprenditoria del mattone, dovette fare i conti con le regole della trasformazione per portare a termine il riuso dei grandi impianti produttivi, dal Lingotto alla Bicocca all’area Falck, fino alla trasformazione commerciale degli edifici storici com’è il caso di Benetton a Venezia che nel frattempo si era già convertito nella
4

rendita autostradale per citare i casi emblematici. Lascio a voi indicare i casi vicentini.La dismissione industriale fece scoprire ai capitalisti i vantaggi immeritati delle plusvalenze immobiliari, un modo più semplice di arricchirsi, senza dover fare i conti con l’organizzazione del ciclo produttivo.A quel punto terminarono i dibattiti sull’improbabile patto tra i produttori, venne messa in soffitta qualsiasi ipotesi di separazione tra rendita e profitto e non se ne parlò più. Il suo posto è stato preso dall’attacco all’articolo 18, causa di tutti i mali. E' stata proprio la rendita la vera responsabile della bassa crescita dell’Italia, poiché ha sottratto risorse importanti agli impieghi produttivi per destinarle a finalità speculative.
A forza di creare valore spostando risorse dall’industria al cemento alla fine si ottiene bassa produttività del sistema. La rendita deprime l’economia mentre si vanta di salvarla. Qui risiede la sua forza ideologica, la sua intrinseca capacità di mistificare la realtà. Gli effetti delle nuove lottizzazioni e delle nuove infrastrutture viarie sul territorio, sull’agricoltura e sul paesaggio veneto sono stati devastanti, anche perché è mancato un disegno coerente di piano a scala vasta e sono mancati indirizzi e regole certe da parte della Regione e degli enti locali.E’ prevalsa la filosofia dell’urbanistica contrattata (tra enti pubblici, proprietari di aree e società immobiliari), del caso per caso e del giorno per giorno. Ai piani sono state apportate innumerevoli varianti e deroghe. Ogni Comune si è sentito in dovere di sovra-dimensionare il proprio fabbisogno di edilizia residenziale, di centri commerciali e di capannoni industriali.
Come scrive il nostro amico e compagno Sergio Lironi la città tentacolare si è sparpagliata nel territorio trasformandosi in una nebulosa urbana, cancellando luoghi identitari, beni ambientali e culturali, banalizzando e omologando il paesaggio, degradando la qualità del vivere quotidiano di ognuno di noi. Sono stati distrutti alcuni fondamentali ecosistemi e la biodiversità, essenziali per la regolazione del clima, per il sostegno di processi vitali quali la formazione del suolo fertile, la fotosintesi ed il ciclo alimentare; si sono compromessi il ciclo delle acque e la loro qualità e si è incrementato il rischio idro-geologico; si è aumentata la nostra dipendenza da risorse esterne (in particolare alimentari, ma non solo); si sono inquinati i terreni, l’aria e l’acqua; si è distrutto un paesaggio celebrato nel passato come uno dei più significativi e preziosi a livello europeo.
Un processo di tale evidente negatività da essere denunciato negli stessi documenti ufficiali della Regione Veneto propedeutici alla nuova Legge urbanistica regionale del 2004 e del nuovo PTRC del 2009, anche se poi nulle sono state le conseguenze sul piano operativo.
E’ giunto il momento di cambiare!Per mettere un freno al consumo di suolo in Italia e nel Veneto occorre probabilmente prendere lo spunto da quanto già si sta facendo in altri Paesi europei e occorre avere la forza di rivendicare un diverso modello di sviluppo economico e di organizzazione del territorio.
A livello di legislazione nazionale si può seguire l’esempio della Germania che nel 1998 si è posta l’obiettivo di ridurre entro il 2020 il consumo di suolo da 129 a 30 ettari/giorno, anche tassando maggiormente chi consuma suolo rispetto a chi recupera aree dismesse.Una misura che potrebbe rivelarsi utile per recuperare, bonificandole, le aree di Porto Marghera o i grandi stabilimenti dismessi dalla Marzotto.
5

La Comunità europea lo scorso anno ha posto agli stati membri l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo entro il 2050.
In Gran Bretagna dal 1955 si è prevista l’istituzione di ampie cinture verdi (green belts) intorno ai principali centri abitati: spazi verdi e territori agricoli che costituiscono una “tutela attiva” contro la crescita indiscriminata dell’edificato e che raggiungono attualmente un’estensione di quasi 1,7 milioni di ettari.Sempre in Gran Bretagna si è recentemente stabilito l’obbligo per i Comuni di localizzare almeno il 60% dei nuovi interventi di edilizia residenziale in aree di recupero già urbanizzate, richiedendo a tal fine anche la revisione dei piani e dei programmi già approvati.
In Francia le nuove leggi della fine degli anni Novanta incentivano l’associazione di più Comuni per l’elaborazione di piani d’area vasta nei quali sia prevista una gestione unitaria degli spazi urbani e degli spazi rurali, con particolare attenzione per le attività agricole, la silvicoltura, la tutela degli spazi naturali e del paesaggio.
Esempi, quelli delle green belts inglesi e dei piani d’area vasta francesi, cui esplicitamente si rifà la proposta, sottoscritta a Padova da una ventina di associazioni ambientaliste e di associazioni degli agricoltori, di formazione di un Parco agro-paesaggistico esteso a tutti i 18 Comuni della Comunità metropolitana, dalla Brenta al Bacchiglione.
Perché non pensare qualcosa di analogo anche per Vicenza? . Il suolo urbano libero da costruzioni e quello periurbano possono essere valorizzati da un grande progetto di integrazione tra città e campagna, tra agricoltura e agglomerati residenziali. I Comuni hanno molti strumenti (alcuni a costo zero) per promuovere una riconversione di questo rapporto: orti urbani, disseminazione dei Gas, farmer's markets, mense scolastiche e aziendali, marchi di qualità ecologica per la distribuzione, gestione dei mercati ortofrutticoli: quanto basterebbe per cambiare l'assetto dell'agricoltura periurbana e per ri-orientare l'alimentazione della cittadinanza con filiere corte
AltroVe, l’associazione che tiene in rete una serie di comitati e associazioni per un altro Veneto, sta elaborando una serie di proposte (che per ragioni di tempo non illustro) che potrebbero essere oggetto di appositi progetti di legge o proposte referendarie e aderisce alla campagna avviata in questi giorni dal Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio” per un Censimento del patrimonio sfitto e/o sottoutilizzato e delle aree minacciate da nuove espansioni urbane.
L’obiettivo è quello di coniugare politica della casa e politiche per l’inclusione sociale. Abitare ha un significato molto più ampio che non si esaurisce nella mera disponibilità di un alloggio ma comprende la possibilità di fruire di servizi pubblici, di spazi e di occasioni d’incontro, d’iniziative culturali.
L’obiettivo è quello di avviare la vera “grande opera” di cui il nostro paese ha bisogno: la protezione e la cura del territorio. Il sindaco Variati potrà dirci se finalmente, a oltre un anno dall’alluvione, la Regione ha deliberato le risorse necessarie per il riassetto idrogeologico del territorio vicentino a partire dai bacini di laminazione, alcuni dei quali già previsti dalla commissione De Marchi, istituita dopo la grande alluvione del ’66, ma mai realizzati.
6

Di fronte alla drammatica crisi strutturale che investe l’intera Europa e particolarmente il nostro paese una proposta di sinistra dovrebbe indirizzarsi verso una prima riforma di quel modello di sviluppo che ha generato la crisi attuale per andare nella direzione di un modello alternativo di economia più equa, più ecologica, meno instabile.
Serve un piano di manutenzione del territorio, di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, di riqualificazione energetica degli edifici, di investimenti sulle energie rinnovabili e distribuite, sulle reti intelligenti (smart gride); sull’agricoltura biologica riscoprendo varietà antiche e preziose. Altro che gli OGM delle multinazionali di cui parla il Ministro Clini. E poi una più generale riconversione ecologica dell’apparato industriale che punti sull’efficienza energetica dei processi produttivi e dei prodotti orientati ai bisogni collettivi.
La sfida che si ripropone è sul cosa, come, dove e per chi produrre. E’ il tema della riconversione/conversione ecologica dell’economia.Abbiamo bisogno di nuova crescita economica ma questa non può che essere una crescita “nuova”, anche in direzione di un’economia della conoscenza e di un’economia sostenibile in termini ambientali, distributivi e sociali. Oggi più che mai “cosa produrre” è importante almeno quanto “come produrre”. Ci vuole un nuovo modello in cui lo Stato e le istituzioni sovranazionali orientino i risparmi, gli investimenti e lo sviluppo. È necessaria dunque una nuova politica economica, ispirata da una nuova idea di sostenibilità di lungo periodo, economica, sociale, ambientale e intergenerazionale.
Questo potrebbe essere il tema del prossimo convegno.
7