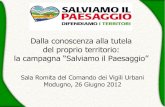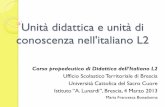Biblioteche: accesso alla conoscenza tra dimensione locale e globale
Contributi alla conoscenza dell'innervazione delle glandule tireoidea e paratireoidee
-
Upload
ferdinando-rossi -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Contributi alla conoscenza dell'innervazione delle glandule tireoidea e paratireoidee
(Istituto di Anatomia umana normale ed Istologia della l~. Universitk di Pavia [Direttore: Prof. ANTONIO PENSA].)
CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELL ' INNERVAZIONE DELLE GLANDULE TIREOIDEA E PARATIREOIDEE.
Dott. FEI~DINANDO ~OSSI, e FRA1WCESCO LANTI, aiuto libero docente allievo interno.
Con 6 figure nel testo.
(Eingegangen am 7. Novembcr 1934.)
Le nuove conoscenze derivate dall'indagine sperimentale e dalla patologia sul vasto campo d'azione degli ormoni tireoidei e paratireoidei e sulla squisita sensibilit~ dei relativi apparati glandulari, ei portarono a pensare che le strutture nervose sotto il dominio delle quali si svolge l 'attivits delle rispettive glandule non siano state rivelate completamente e che, in realt&, la distribuzione delle fibre nervose debba essere pifi fine e pifi estesa di quella ehe sino ad oggi & stata dimostrata. Influenzarono questa nostra supposizione anehe i discussi reperti di nervi secretori i quali, emanazione o no di nervi perivasali, contrarebbero intimi rapporti non solo con le vescicole o con i eordoni cellulari glandulari, ma addi- rittura con le singole cellule secernenti. Ci parve poi degna di interessa- mento la discussione sulla esistenza o meno di cellule nervose simpatiche sparse nel parenchima.
Queste considerazioni ci portarono a compiere le ricerche i cui risultati riferiamo in questa memoria.
I metodi finora pih sfruttati per questo genere d'indagine furono quello della reazione cromoargentiea del GoLoI, quelli all'argento ridotto del CAJ~_L, BIELSCHOWSKY, ecc. e quelli col blu di metilene. I1 metodo a preferenza da noi usato 8 stato quello del GOLOI, che applicammo su materiale asportato da comuni animali di laboratorio, particolarmente cani, gatti e capretti.
L applicazione dei metodi d'indagine ~ stata/atta da F~A~CESCO LA~TI, sotto la guida de F]~RI)INANDO Ross1; al RossI spetta inoltre la lettura ed interpretazione dei preparati nonch~ l'esposizione dei rilievi istologici.
I. L'innervazione della glandula tiroide. La glandula tiroide ~ stata molto investigata per quanto concerne
la sua innervazione. Da PEREMESCHKO (1867), che sembra essere stato il primo a descrivere la distribuzione delle fibre nervose nel parenchima glandulare, a PoPow (1927 e 1928), che, a quanto ci consta, fu l'ultimo, numerosi ricercatori si sono l'un l'altro succeduti nel medesimo intento. Ci6 malgrado non molto si @ avanzato in realt~ nella conoscenza del
660 Ferdinando Rossi e Francesco Lanti: Contributi alia Conoscenza
patrimonio nervoso tireoideo. A convalidare questa nostra osservazione basters ehe si ricordi come PEREMESCHKO, pur non usando di metodi elettivi per lo studio del sistema nervoso, aveva gi~ veduto nel vitello che, se una parte dei numerosissimi nervi della tiroide accompagna i vasi sanguiferi, altri nervi decorrono indipendenti; pot~ anche seguire questi ultimi sino nel connettivo intervescicolare dove, ridotti a sottili filamenti, si perdono attorno alle vescicole. Lungo i tronchi nervosi l 'autore notb cellule nervose isolate o riunite a gruppi di 2 sino a 5 i cui prolungamenti si accompagnano alle fibre nervose dei tronchi stessi. Orbene il PoPow, 60 anni dopo, avendo a disposizione metodi ben pifl fini ed elettivi d'indagine quali quelli del CAJAL e del GOLOI, dichiarb di esser convinto dell'esistenza di nervi secretori (oltre che vasomotori), ma non pots seguirli oltre la superficie esterna de]le vescieole e non gli fu possibile quindi dimostrare rapporti pill intimi deUe fibrille nervose con i singoli elementi cellulari. I1 Po row non eonferm6 l'esistenza di cellule nervose intratireoidee, ma deserisse invece apparati nervosi terminali sempliei (bottoniformi) e complessi (elaviformi) i quali o eontraggono intimi rapporti con le formazioni parenchimatose (termi- nazioni peri/ollicolari) oppure giacciono liberi nel connettivo interfolli- colare (apparati recettori di senso). A proposito degli apparati recettori di senso il PoPow fa l'ipotesi che essi, stimolati meccanicamente per il dilatarsi dei follicoli in seguito all'accumularsi in essi della eolloide, trasmettano ai centri corrispondenti vegetativi l'impulso che per via riflessa regola la secrezione. Con cib l'autore tuttavia non esclude che la stimolazione a tali apparati possa anche essere di natura chimica, dovuta cio~ all'azione chimica della colloide che passa nel tessuto inter- stiziale dalla cavit~ della vescicola. I1 reperto negativo di fibrille nervose intraveseicolari ed intercellulari, secondo il PoPow, non pub sorprendere o lasciare dei dubbi sulla sua autenticit~ perch~ esso ~ comune a tutte le glandule a seerezione interna.
Riunendo tutti i ricercatori precedenti a PoPow, ne possiamo formare due gruppi e cio~: 1 ~ quelli che riconoscono nella tiroide pih o meno esplicitamente solo nervi perivasali (ZEIsS, SACERDOTTI, LIVINI, VERSON) e 20 quelli che ammettono oltre ai nervi perivasali anche nervi secretori (PEREMESCHKO, POINCAR]~, CRISAFULLI, ANDERSSON, BERKLEY, TRAUT- MANN, JACQUES, CIVALLERI, RHINEHART). Per quanto si riferisce poi alle cellule nervose, se diversi sono gli asserti a sostegno dell'esistenza di esse (e questi sono di PEREMESCHKO, POINCAR]~, ZEISS, CRISAEULLI, SACERDOTTI, NONIDEZ), non pochi sono quelli che escludono o non ricordano tali cellule; e questi sono ANDERSSON, BERKLEu JACQUES, LMNI, CIVALLERI, VERSON, RHINEHART. TRAUTMANI~ ammette solo le cellule delle guaine nervose.
Nel 1929 il PINES fete un'interessante analisi critiea delle prineipali indagini sia morfologiche ehe sperimentali riferentisi all'innervazione
dell'Innervazione delle Glandule Tireoidea e Paratireoidee. 661
tireoidea ed al meccanismo della secrezione, analisi che ci spiace di non poter riferire qui estesamente come meriterebbe, a causa del carattere suceinto che vogliamo eonservare alla nostra pubblicazione. L'autore ricorda come i dati elinici accordino nel considerare la glandula tireoidea sotto la dipendenza del sistema nervoso autonomo; come i metodi di fisiologia sperimentale non offrano ehe risultati contradditori; come soltanto le ricerche moffologiche, bench~ lascino ancora varie questioni insotute, abbiano consentito di spiegare il meccanismo della secrezione tireoidea. I1 PrNES poi afferma che particolarmente il PoPow ~, giunto a preziosi risultati sulla conoscenza dell'innervazione della glandula tiroide con la dimostrazione soprattutto di apparati terminali inter- vescicolari che funzionerebbero come recettori. Apparati simili furono del resto visti dallo stesso PINES in altre glandule a secrezione interna (testicolo, timo). Lo stimolo a tali apparati recettori verrebbe determinato, come s'b gi~ scritto, con probabilit& meccanicamente e la sccrezione ver- rebbe regolata per via riflessa. Circa la natura delle fibre nervose tireoidee, il PINES sostiene chese per la massima parte (quelle amidollate, sottili, varicose) si debbono ritenere di natura simpatica, le altre sono con probabilit~ dipendenti dalle cellule sentive del ganglio nodoso del vago e quindi appartenenti al vago stesso. Egli dichiara tut tavia che tale ultima questione non pus indubbiamente ritenersi risolta!
Di recente il NO~IDEZ (1931) dimostrb con l'uso del metodo del CAJAL all'argento ridotto, la sicura presenza di ganglietti nella tiroide del cane neonato o assai giovane. I1 numero, il volume di questi ganglietti sono variabilissimi, il che spiega, secondo l'autore, come queste for- mazioni possano sfuggire talvolta con facilit~ all'indagine microscopica e fa supporre inoltre che esse siano non tanto in relazione diretta con l 'attivits secretoria dell'organo quanto adibite piuttosto a regolare la circolazione sanguifera della tiroide la quale differisce pure spesso da soggetto a soggetto. I1 numero dei ganglietti, per lobo, varierebbe fra I e 7 e le cellule che costituiscono i gangli maggiori pare osciJlino fra 10 e 18. Pure le cellule hanno varie grandezze; le pifi grandi assomiglie- rebbero secondo l'autore a quelle monopolari dei gangli cerebrospinali. Ma, oltre a tali raccolte gangliari, il NO~IDEZ vide anche cellule nervose isolate e poste nello stroma interfollicolare, di solito indipendenti dai vasi, di rado incluse nell'avventizia. Per cib egli distingue due tipi di neuroni: quelli posti nel parenchima (neuroni interstiziali) e quelli posti lungo la parete delle arterie (neuroni periarteriosi). In un lavoro successivo il NO~ID~,z considera l'assenza di elementi gangliari nervosi nella tiroide ammessa da diversi autori in alcuni animali come possibile, perch~ ad essa supplirebbero i neuroni parasimpatici sparsi lungo il laringeo superiore. I1 NO~CID~.Z propende ad ammettere che la presenza di ele- menti gangliari nervosi nella tiroide sia forse dovuta ad immigrazione delle cellule annesse al nervo laringeo superiore.
Z. f. Zel l forschung u. m ik r . A n a t o m i e . Bd. 22. 44
662 Ferdinando Rossi e Francesco Lanti: Contributi alla Conoscenza
Riguardo ai pifl fini rapporti delle espansioni nervose terminali con gli elementi secretori, la maggior parte di coloro che s'interessarono a questo argomento videro e descrissero soltanto relazioni delle fibre pifl sottili col contorno delle singole vescicole tiroidee e con la base delle cellule epiteliali. Queste fibrille terminerebbero semplicemente assoti- gliate oppure presenterebbero l'estremit~ bottonuta o addirittura rigon- fiata a clara. Soltanto BERKLEY aveva potuto seguire alcune fibrille nervose anche entro la parete della vescicola, fra le cellule epitelia]i, m a i l reperto, che risale al 1895, non ebbe conferma dalle successive ricerehe.
Le nostre indagini ci consentono di mettere in luce un fatto fonda- mentale, quello cio~ dell'indiscutibile esistenza nella tiroide oltre che di nervi perivasali, anche di nervi che, per i pih diretti rapporti con gli elementi proprii della glandula, denomineremo nervi parenchimali. Per questo fatto le affermazioni in contrario ed i dubbi di alcuni osservatori precedenti devono ritenersi superati.
Se si esaminano sezioni di glandule nelle quali l'impregnazione dei nervi ~ avvenuta in modo pressoch~ eompleto, si nota che conformemente a quanto videro anche altri indagatori, le fibre nervose, per la massima parte, penetrano disposte in fasci ed in plessi nell'organo seguendo preferibilmente i vasi sanguiferi; ma vedemm~) altresl un certo quanti- tativo di fibre nervose, costituito per lo pifl da piccoli fascetti o da fibre isolate, penetrare nella glandula qua e l~ in corrispondenza della superficie, attraverso alla capsula propria, indipendentemente dai vasi.
Nell'interno dell'organo le fibre nervose costituiseono cospicui fasci a carattere spiccatamente plessiforme disposti e ramificati in modo da eomporre aree po]igonali che includono gruppi di vescicole {Fig'. 1). Si t ra t ta di plessi perivasali che proponiamo di denominare plessi di primo ordine per distinguerli da fasci o plessi dipendenti da quelli, ma pifl modesti, che abbracciano le singole vescicole. Denomineremo questi ultimi, plessi di secondo ordine o perivescicolari. I plessi di secondo ordine non sono evidentemente tu t t i perivasali; lo si stabilisce con facitit~ sia con l'esame diretto di preparati nei quali con l'impregnazione delle fibre nervose ~ avvenuta anche l'impregnazione del lume vasale, sia nei pre- parati in cui abbiamo praticato iniezioni vascolari. Le ]oro fibre poco numerose si dispongono lassamente in superfice, adattandosi al contorno de]le vescicole glandulari e non formano quei grovigli complicati che avvolgono i vasi sanguiferi riproducendone la forma cilindrica. Del resto, questi plessi perivescicolari sono stati descritti un pb da tutti gli autori che abbiamo citato; ~ da essi che hanno origine rametti e filuzzi i quali si recano sulla parete esterna delle veseicole, dove finiscono indivisi ed assotigliati oppure biforcati e con l'estremit~ rigonfiata a guisa di bottone (Fig. 2). Si t ra t ta in realts di fibrille aventi talora un decorso ricorrente
664 Ferdinando Rossi e Francesco Lanti: Contributi alla Conoscenza
ma pifl spesso obliquo e perpendicolare a quello del t ronco da cui derivano, di finezza estrema, largamente ondulate e varicose. Solo assai di rado ci ~ capitato di osservare arborizzazioni terminali isolate e precisamente arborizzazioni che, invece di essere in rapporto con la superficie esterna della vescicola, sono verosimilmente libere nel connet t ivo intervescicolare.
Fig. 2. Fibrille nervose dei plessi t i reoidei perifollicolari ehe m a n d a n o filuzzi alla pare te do! follicoli. Terminaz ioni nervose intrafollicolari nella t i roide dt capret to . Metodo GOL~I.
Ingr . 400 •
Queste nostre osservazioni riehiamano alla memoria i reperti del PoPow il quale descrisse appunto appareeehi nervosi terminali liberi nel connet t ivo interstiziale della tiroide e che egli considerb come appa- recchi di senso in rapporto con la funzione secretrice. I1 PoPow ebbe a dichiarare che le fibre nervose che decorrono fra le vescicole presentano spesso all'estremit& voluminosi ringonfiamenti a clava o fusiformi oppure piccoli e bot tonuti . Secondo le nostre ricerche perb, se non possiamo negare l 'esistenza d ' ingrossamenti di forma e volume differenti lungo le fibre nervose, specialmente nei punt i di suddivisione e d'inflessione, non po temmo con sicurezza stabilire che si trat tasse di forme terminali
dell'Innervazione delle Glandule Tireoidea e Paratireoidee. 665
se non nei casi nei quali tali ingrossamenti erano piccoli e del tipo a bottone. I pifi grossi, quelli cio~ denominati dal PoPow complessi e che vedemmo occasionalmente, non ci convinsero soprattut to perch~ sembravano posti all 'estremit~ di fibre nervose di considerevole spessore, e ci lasciarono il sospetto che, oltre l 'ingrossamento, la fibra nervosa si continuasse in altro piano o in altra direzione. Riteniamo probabile quindi che queste immagini siano dovute ad impregnazioni parziali e difettose; perci6 crediamo che anche le considerazioni del PoPow sul loro significato ai fini della funzione seeretiva, non possono essere accettate se non con molta riserva. Invece po- temmo stabilire che le fibrille nervose assumono con gli elementi della ve- scicola rapporti assai pift intimi di quelli osservat~ dal PoPow e che con- sentono di ammettere un intervento del sistema nervoso nella regolazione dell 'attivitk glandulare pifi diretto e pifi semplice di quello architettato dal PoPow stesso.
Abbiamo visto che dai plessi perivescicolari o di secondo ordine si staecano filamenti finissimi ondulati
i quali si svolgono anastomizzandosi Fig. 3. F ib r i l l a ne rvosa che t e r m i n a a
o formando plessi minori (di terzo fioechetto a ridosso degli elementi epi- t e l i a l i d i un follicolo. T i ro ide di capre t to . ordine) attorno alla parete stessa delle Metodi GOLGL Ingr. 465 •
veseicole {Fig. 2) cosl che il contorno di una cellula o di pifi ccllule vicine ne viene incorniciato. Questi fila- menti terminano o esaurendosi con estrema sottigliezza oppure con un piccolo rigonfiamento bottoniforme in rapporto con la superficie basale di qualcuna delle cellule epiteliali oppure anche sfioccandosi in un ciuffo di filuzzi minuti (Fig. 3). Ma dagli stessi plessi di secondo ordine si staccano inoltre ad intervalli abbastanza regolari brevi filuzzi ehe, quasi perpendicolarmente alla direzione delle fibre dalle quali provengono, penetrano fra cellula e cellula della vescicola. Quivi, negli spazii intereellulari, cessano rigonfiandosi all 'estremit~ e questa estremit~ si t rova o hello spessore dello strato epiteliale oppure pifi o meno vicina alia superficie interna o a quella esterna delia vescicola (Fig. 2). Tall formazioni in alcuni preparati ci appari- rono assai abbondanti e ci convincemmo che ogni unit~ glandulare ne possiede un certo numero. Per quanto riguarda la loro situazione intravescicolare l 'abbiamo potuta stabilire soprattut to osservando il decorso quasi rettilineo e brevissimo delle fibrille che ben si distin- gue da quello ondulato, serpiginoso e lungo degli altri filamenti i quali
666 Ferdinando l~ossi e Francesco Lanti: Contributi alla Conoscenza
sono perivescicolari. Non abbiamo t rovato terminazioni intravescicolari pifi complesse.
Se si osservano le vescicole sezionale trasversalmente ci si accorge inoltre che alcune delle fibre nervose intervescicolari assai fini, at tra- versato quello straterello connet t ivo che avvolge la vescicola, decorrono per un breve t ra t to parallelamente alla superficie basale o esterna delle cellule epiteliali; si suddividono in rami che decorrono pur essi nello stesso senso. Ma qualche ramo assai delicato si stacca da queste fibre e si por ta verso i l l u m e glandulare scorrendo fra cellula e cellula. Tali rami assai brevi e sottili talvolta terminano presso i l lume della vescicola, ta l 'a l t ra r i tornano su loro stessi per portarsi di nuovo a ridosso della superficie esterna.
Non possiamo escludere, solo per il fa t to di non averli potut i noi dire t tamente osservare negli animali che abbiamo presi in esame, la presenza di gruppi di cellule gangliari o di piccoli gangli quali ha messo in evidenza il NONIDEZ. Anzi i reperti del NO~IDF, Z sono convincenti. Ma ~ fuor di dubbio che le raccolte di cellule nervose intratireoidee non devono essere considerate come essenziali per la funzionalit~ dell 'organo se si tien conto della loro incostanza o forse meglio della loro rara presenza e della variabile quanti t~ e grandezza.
Per quanto poi si riferisce ad elementi cellulari isolati chc poterono essere definiti come cellule nervose, sono da distinguere e da considerare separatamente quelle formazioni che furono viste anche dall'A~DE~SSO~ fra mezzo alle cellule vescicolari, da quelle annesse ai fasci di fibrille decor- renti fra le vescicole tireoidee e che vennero ricordate anche dal NO~IDEZ. Le prime, che sono in gran numero, si presentano come celtule roton- deggianti, qualche volta ovalari, con una zona nel mezzo del corpo che assume meno i sali d 'a rgento e che raffigura un nucleo, con prolungamenti brevi e muschiosi i quali non sembrano aver relazione con le fibre nervose. Esse assomigliano alle ccllule disegnate dall'A~DE~SSO~, ma non ci sembrarono per5 sempre in rapporto con l'epitelio, anzi prevalentemente poste nello stroma. Escludiamo che siano di na tura nervosa.
Se si prendono in esame invece quegli ingrossamenti ovalari, poli- gonali, stellati che s ' incontrano negli interstizii connett ivi lungo il decorso dci fasci fibrillari nervosi di primo ed anche di secondo ordine, in continuit~ con fibre nervose, dobbiamo dichiarare che alcuni di essi hanno tu t t i i caratteri di quelle formazioni che in generale vennero descritte anche in altri organi come cellule del simpatico del t ipo cellule interstiziali. Non possiamo per6 fornire la documentazione sicura che siano cellule nervose.
E ' doveroso rilevare del resto c h e l a massima parte dei ricercatori ha negato la presenza di cellule nervose in gangli e sparse nella glandula e fra questi sono anche alcuni dei pifl recenti. Sulle cellule nervose dimostrate da PEREM~SCnXO nella tiroide del vitello usando una tecnica
dell'Innervazione delle Glandule Tireoidea e Paratireoidee. 667
quanto mai primitiva e, come scrisse LIVlNI, poco attendibile, non vale la pena di soffermarci; d 'al t ra parte nessuno di coloro che in questi ultimi anni si occuparono dell 'argomento vi diede molta importanza. Anche le affermazioni di ZEISS, CRISAFULLI, SAC~RDOTTI che, usando del meted0 di GOLOI, misero in evidenza cellule ritenute nervose, ci sembrano troppo vaghe; poco o nulla ci fecero sapere infatti tali autori sul tipo e sulla distribuzione di queste cellule nella tiroide. Se confrontiamo invece il lavoro del 1875 di POINCXR~ con quello del 1931 di NONIDEZ possiamo credere che quest 'ultimo abbia visto gli stessi gangli e le stesse cellule nervose del primo autore, bench~ sembri che POINCARr abbia considerate come gangli anche cellule nervose isolate.
Abbiamo gi~ fat to cenno degli apparecchi nervosi terminali di ripe complesso, liberi nel connettivo interstiziale, descritti dal PoPow ed in quell'occasione ci dichiarammo disposti a considerarli, se non tutti , almeno per la maggior parte come imagini dovute ad impregnazione parziale e difettosa. Del resto gi~ I'ANDERSSON aveva espresso il parere che le grosse varieosit~ e certi ,,Kolben" i quali appariscono anche su fibre terminali, altro non fossero che precipitazioni d 'argento senza signi- ficato, ar tefat t i di varia natura. ]nvece quest 'autore, come gis il CRISA- FULLI e~l il TRAUTMA~, deserisse fibrille nervose indipendenti dai vasi che prendono rapporto pifi o meno diretto con la superficie epiteliale esterna della vescicola a ridosso della quale terminano, secondo A~- DERSSON: e TRAUTMA~ con l 'estremit~ rigonfiata a bottone. JACQUES vide apparecchi moniliformi intervescieolari che considerb come sensitivi. Orbene noi siamo d'accordo col JACQVES sulla presenza di apparecchi moniliformi nello stroma intervescicolare, tu t tavia li consideriamo rari, e siamo d'accordo nell 'ammettere anche l'esistenza di terminazioni bottoniformi nel connettivo. Ma queste nostre ricerche danno soprattut to sicura conferma ai rilievi ancora del 1895 del BERKLEY il quale pot~ seguire le estremitK terminali rigonfiate a bottone sine entre lo strato epiteliale delle vescicole. Sono appunto queste ultime terminazioni quelle che per nostro conto hanno valore funzionale, di regolazione cio~ delia secrezione, per il fat to che sono molte (come appare nei preparat i ben riusciti), distribuite con una certa regola quasi ad intervalli regolari e che si spingono, almeno talune, sine alia superficie delimitante il lume della vescicola. L'esistenza di queste terminazioni intravescicolari da noi accertata in gran numero di preparati, fa supporre che il mecca- nismo della secrezione sia regolato da questo intimo rapporto fra fibre nervose e cellule secretrici.
Nell 'esame di tiroidi appartenenti ad animali di eta avanzata, no- t ammo ehe, conseguentemente al muta te aspetto strutturale del pa- renchima, anche l'innervazione si mostra diversa. I tronchi ed i filuzzi nervosi, ad esempio, hanno assunto un deeorso pifi rettilineo e le inflessioni sono rarissime. In tall condizioni inoltre non ci riusci di mettere in evidenza
668 Ferdinando Rossi e Francesco Lanti: Contributi alla Conoscenza
terminazioni intravescicolari quantunque i plessi sia di primo che di secondo e di terzo ordine fossero bene impregnati, abbondanti e chiara- mente differenziabili. Noi crediamo che il comportamento delle fibre nervose nei varii stadii funzionali della glandula tiroide come nelle diverse ets della v i t a e soprattutto nei processi morbosi che colpiscono l'organo, meriti non meno attenzione di quella chc si dove rivolgere al parenchima.
II. L'innervazione delle glandule paratireoidee. A differenza di quanto ~ avvenuto per la glandula tireoidea, l'inner-
vazione delle paratiroidi ~ stata relativamente poco indagata. L'ANDERS- SON, l 'anno dopo che il SACERDOTTI a v e v a scritto che (~... la reazione mise in evidenza i nervi che presso a poco si distribui~cono come nella fflandula princiTale (la tiroide), cioe seguendo gli scarsi vasi e diramandosi nel connettivo intragIandulare~>, fece un'affermazione importante ma che non fu pifi tardi confermata da nessuno. Egli sostenne cio~ di aver potuto seguire nelle paratiroidi non solo i nervi perivasali, ma anche i rami che da questi si staccano pe~ recarsi fra le cellule epiteliali, accer- tando chc dopo varie divisioni dicotomiche, essi terminano con una estremit~ assotigliata e bottonuta; aggiunse di essere sicuro dell'esistenza di terminazioni anche intraepiteliali. Venne perb subito il TRAUTMANN a smentirlo dichiarando di aver messo in evidcnza sia nervi perivasali che parenchimali, ma mai terminazioni intraepiteliali; nello stesso senso si espresse pifi tardi il V~Rso>r. II RHINEHART, che ottenne ottimi pre- parati con la doppia impregnazione argentica secondo CAJAL, ammet te addirittura soltanto nervi perivasMi. Recentemente infine ~ apparso un lavoro di PoPow il quale fa seguito ai due dello stesso autore sulla innervazione tireoidca che abbiamo gi~ ricordato ncl primo capitolo, lavoro che ~ come quelli, chiaro e minuzioso. Sembra che P o r o w abbia fat to le migliori osservazioni in paratiroidi umane t ra t ta te sia col metodo rapido di GOLGT che con quello del CAJAL. L'autore descrisse nervi perivasali e parenchimali. I primi sarebbero in genet-ale rappresentati da fibre mieliniehe riunite in grossi fasci decorrenti nel connettivo inter- stiziale e che, pur ramifieandosi, non formano veri plessi attorno ai vasi; esse manderebbero invece qualche fibrilla lateralmente a proiettarsi sugli ammassi epiteliali, addosso ai quali terminerebbero, talora eon un ingrossamento a guisa di piccolo bottone. Del resto Fautore diehiara di aver ricevuto l'impressione ehe taluna delle terminazioni bottoniformi si trovi anehe nello spessore della tuniea avventiziale dei vasi sanguiferi. I nervi parenchimali invece (nervi la cui assoluta indipendenza dal l 'apparecchio sanguifero fu aeeertata soprattut to nei preparati ottenuti secondo il metodo di CAJAL), costituiti per lo pifi da fibre amieliniche, avvolgono ramificandosi ed intrecciandosi fra loro i grossi gruppi di eellule epiteliali senza tut, tavia eontrarre rapporti pih intimi con i singoli
dell'Innervazione delle Glandule Tireoidea e Paratireoidee. 669
elementi. Pure i nervi glandulari terminano con l'estremit~ rigonfiata e di varia grossezza.
In conclusione anche il PoPow, bench~ faccia qualche riserva a causa dei metodi impiegati che non mettono in evidenza con ehiarezza il pa- renehima glandulare e pur ammettendo che le fibrille nervose contraggono intimi rapporti con le cellule mantenendosi soltanto addossate alla super- ficie esterna degli ammassi epiteliali, afferma di non poter convalidare l'asserto dell'A~DERsso~ di penetrazione di fibre fra le cellule. A1 PoPow apparve nel complesso assai chiara la somiglianza dell'innervazione tireoidea con quella paratireoidea, tanto pifl ehe egli vide anche nel connettivo interstiziale di quest'organo, terminazioni nervose Iibere di una certa grandezza ed analoghe a quelle che furono descritte sia per la tiroide sia per il testicolo.
Vogliamo ricordare pure il W:NIW~a~TER il quale, valendosi di metodi comuni di eolorazione, dimostrb nelle paratiroidi della cavia veri corpu- scoli nervosi di senso specifieo del tipo di PAc:~I; tall corpuscoli si tro- verebbero sia applicati in nicchie della superficie esterna paratireoidea come anche nello spessore del parenchima.
Per quanto concerne l'identificazione dei nervi destinati alle para- tiroidi, secondo il BI~EUCKER., nell'uomo tall nervi sono di provenienza assiale e simpatica, sono soprattutto rami del vago e del simpatico e, attraverso il plesso faringeo e quello eapsulare tireoideo, anehe del glosso-faringeo e dell'ipoglosso.
I nervi paratireoidei, secondo il BgA~UCK~R, non si corrispondono nei due lati e sembra che, se per la maggior parte penetrano nella glandula seguendo i vasi sanguiferi, un eerto quantitativo vi giunga indipenden- temente da questi.
Le nostre indagini ci eonsentono di confermare aleuni dei precedenti reperti e di contestarne qualche altro. L'innervazione delle paratiroidi
abbondante, quasi quanto quella della tiroide. La fig. 1, nella quale riprodotta una sezione di tut te e due le glandule, mostra ehiaramente
come la struttura nervosa sia in realts pifi complessa di quello che era apparso al SACERDOTT:. Vediamo che i nervi non seguono soltanto i vasi sanguiferi paratireoidei (come ammise fl RHrNEHA:~T), ma prendono anche stretti rapporti con il parenchima dell'organo.
Esistono 'grossi fasci di fibre disposti a formare larghe maglie nel tessuto e fasci minori, dipendenti dai primi, i quali eircoscrivono porzioni pifl ristrette di parenehima ed anehe i singoli cordoni di cellule glandulari. Come videro tutt i eoloro the ci precedettero in questa indagine, i grossi fasci nervosi o primari sono annessi ai vasi assieme ai qua]i entrano nelle glandule ; ma questi nervi non hanno una distribuzione cosl regolare come nella tiroide e neppure presentano evidenti le earatteristiehe fonda- mentali dei plessi perivasali (Fig. 1). Attentamente considerati si mostrano costituiti da fibre che decorrono poco ondulate, vicine l 'una all'altra
670 Ferdinando Rossi e Francesco Lanti: Contributi alla Conoscenza
quasi parallelamente, scambiandosi anastomosi e mandando frequenti ramificazioni sia lungo i rami dello stesso vaso che perseguono, sia lungi da quello, nel parenchima.
Fig. 4. Plessi nc rvos i per icordonal i pa ra t i reo ide i . P a r a t i r o i d e di cane. l~Ietodo GOLOL Ing r . 210 X,
Non solo dai fasci nervosi annessi ai vasi hanno origine i nervi destinati ai eordoni epiteliali, ma nervi secretori giungono alle glandule anche indipendentemente dal sistema sanguifero, at traverso alla capsula,
Fig. 5. Dai plessi ncrvos i per icordonal i delle p a r a t i r o i d i si s taccano fibri l le che si p ro ie t t ano sulle fo rmaz ion i epi tel ial i . P a r a t i r o i d e di cane. Metodo GOLGI, Ingr . 500 x .
dall'esterno. Sia gli uni che gli altri son formati da fibre amieliniche poehissimo varicose, non aventi andamento flessuoso e serpiginoso e ehe, nel mutar di direzione, pig ehe ineurvarsi si pieg~no ad angoli di diverso grado. I eordoni epiteliali vengono eireoscritti da tall fibre
dell'Innervazione delle Glandule Tireoidea e Paratireoidee. 671
(Fig. 4), le quali vi formano attorno reti secondarie a maglie pure larghe, lasse ed irregolari che ripetono tu t tavia fedelmente il disegno della trabe- cole del connettivo interstiziale. Si stabilisce in tal modo un vero rapporto di superficie fra t ravate di epitelio e fascetti nervosi. Assai scarsa invece si rivel5 la penetrazione di fibrille t ra i singoli elementi glandulari.
Ricordiamo che fl Porow, sebbene si sia preoccupato di verificare l 'asserto di A~DE~SSO~ sull'esistenza di nervi intraepiteliali ed abbia quindi fat to ricerche accurate, riuscl solo a stabilire che le fibrille nervose si addossano alle formazioni epiteliali, sulle quali si esauriscono o sfioecandosi o rigon- fiandosi all'estremit~. Cib vedemmo noi pure (Fi. 5) ; ma ottenemmo anche reperti pifi fini, perchb in alcuni casi, a dir vero per5 molto rari volendoci limitare a quelli accertati, ab- biamo seguito esili fibre oltre i setti con- nettivi sino entro i cordoni e le abbiamo viste terminare brevemente arborizzate o con ciuffi e filuzzi bottonuti (Fig. 6), i quali prendevano rapporto con le singole cellule dei cordoni.
Noi pensiamo che l 'affermazione dell 'AN- D~,RSSO~ di aver visto fibrflle nervose penetrate nell'epitelio, si riferisca al fatto osservato anche da noi ed ora descritto. Se l 'autore avesse voluto riferirsi ad un rapporto pifi intimo (di compenetrazione), questo dovremmo escluderlo in via assoluta.
Non possiamo confermare l'esistenza di terminazioni nervose inter- cordonali eomplesse del tipo intervescieolare tireoideo, ammesse dal Porow. Del resto anche il P o r o w si tenne a questo riguardo tanto riser- vato quanto era stato invece esplicito e minuzioso nel caso della tiroide. Nel conncttivo fra i cordoni epiteliali esistono solo fibrille terminanti semplicemente assotigliate oppure aventi l 'estremit~ a bottone.
Se nel complesso le due innervazioni, tireoidea e paratireoidea, pre- sentano qualche rassomiglianza, mostrano all'indagine minuta caratte- ristiehe net tamente differenziali. Lo stesso P o r o w apprezz5 una certa diversit~ Ira tiroide e paratiroidi per ci5 che riguarda i nervi perivasali consistente nel caratterc non plessiforme di quelli paratireoidei. Vi infatti una manifesta differen~a fra i nervi perivasali dei due tipi di glandule; tu t tavia ci sembra un p5 esagerata l 'affermazione di questo autore perchb formazioni a plesso non mancano del tu t to attorno ai vasi sanguiferi paratireoidei maggiori, per quanto esse siano pifi semplici e meno variate di quelle che si t rovano nella tiroide. In realt~ per5 mancano attorno ai vasi minori. Non ci sembra neppure esatto sostenere che l'innervazione perivascolare paratireoidea appaia pifi grossolana dell'omologa tireoidea (Porow); sono puramente due innervazioni di
672 Ferdinando Rossi e Francesco Lanti: Contributi alla Conoscenza
carattere diverso, ma non solo per quanto riguarda i nervi perivasali, ma anche per quanto si riferisce a quelli propri del parenchima. L ' intera innervazione delle paratiroidi si caratterizza per la semplicitk sia di decorso sia di rapport i delle fibrille.
E ' certo che nelle paratiroidi il sistema nervoso bench~ riccamente rappresentato da fibre numerose e fini, mostra un' intimit~ meno pro- fonda tanto con la parete dei vasi che con le cellule secernenti. E ' probabile quindi che la regolazione dell 'attivits glandulare avvenga non tanto per stimoli diretti sui singoli elementi del parenchima (troppo scarse essendo le terminazioni intraepiteliali) quanto per stimolazione delle pareti dei vasi e delle masse cordonali.
IlL {3onclusioni generali. 1. Nelle glandule tireoidea e paratireoidee i nervi in massima parte
penetrano coi vasi sanguiferi raccolti in grossi fasci, in parte in forma di piccoli fascetti o di fibre singole anche isolatamente attraverso alla capsula.
2. Nell 'interno della glandula tireoidea i fasci nervosi maggiori o di primo ordine sono tut t i perivasali e plessiformi.
3. Dai plessi nervosi di primo ordine e perivasali si staccano plessi minori o di secondo ordine che si fanno intervescicolari e perivescicolari.
4. Alcune delle fibre dei plessi di secondo ordine si esauriscono terminando a bottoncino intorno alle vescicole; altre finissime penetrano fra le cellule secernenti e vi terminano rigonfiate all 'estremit~.
5. Esistono anche terminazioni bottoniformi libere nel connettivo interstiziale, ma non furono da noi messi in evidenza gli apparat i terminali pill complessi descritti dal Porow.
6. La presenza di ganglietti simpatici nella glandula tireoidea, benchb non possano essere messi in dubbio i reperti positivi e dimostrativi del NO~IDEZ, non ~ confermata dalle nostre ricerche per gli animali da noi usati. L'esistenza di cellule interstiziali simpatiche ~ dubbia.
7. L'innervazione delle paratiroidi ~ abbondante quasi come quella della tiroide.
8. Anche nelle paratiroidi i fasci di primo ordine e la maggior parte di quelli di secondo ordine sono perivasali, ma la loro disposizione ed il loro aspetto appaiono alquanto diversi. Sono pifi rettilinei, pih esili ed assai meno plessiformi di quelli della tiroide.
9. I nervi secretori, destinati cio~ ai cordoni ed alle cellule secretrici paratireoidee, provengono in parte dai fasci di secondo ordine in parte diret tamente dall'esterno, attraverso la capsula. Sono, almeno per quello the la tecnica permise di dimostrare, assai meno numerosi e meno ricchi di varicosit~ di quelh della glandula tireoidea.
10. Intorno ai cordoni, le fibre poco flessuose formano reCi a maglie larghe. Scarsissima b la penetrazione dimostrabile di fibre fini terminali fra le cellule glandulari. Quelle poche che abbiamo potuto dimostrare
deWInnervazione delle Glandule Tireoidea e Paratireoidee. 673
le vedemmo finire con piecoli ciuffetti di filamenti bottonuti o brevemente ramificati.
11. Neppure nelle paratiroidi abbiamo visto gll apparati nervosi complessi terminali di PoPow.
12. Non potemmo osservare nelle paratiroidi n~ ganglietti ner~osi n~ cellule nervose isolate del tipo interstiziale.
Zusammenfassung. Wir haben die Verteilung der Nervenfasern in der Glandula thyreoidea
und parathyreoidea gewShn]ieher Laboratoriumstiere (Hund, Katze, Ziege usw.) besonders mit der GoLGI-Methode untersueht. Die erhaltenen Ergebnisse lassen sieh folgendermaBen zusammenfassen:
1. In die Glandula thyreoidea und parathyreoidea treten die Nerven meistens zusammen mit den Blutgef~Ben in dieken Biindeln ein, zum Teil durehsetzen sie auch isoliert in Form kleiner Biindelchen oder einzelnor Fasern die Kapseln.
2. Im Inneren der Glandula thyreoidea sind die gr50eren Nerven- bfindeln (I. Ordnung) s~mtlich um die Gef~l]e herum plexusartig ange- ordnet.
3. Von den perivasalen Nervenplexus I. Ordnung zweigen sich kleinere Plexus (II. Ordnung) ab, die zwisehen den Driisenbl~sehen und um ~':e herum gelagert sind.
4. Einige Fasern aus dem Plexus II. Ordnung endigen mit KnSpfehen an den Driisenbl~schen, andere sehr dtinne Fasern dringen zwischen die sezernierenden Zellen ein, wo sie mit Anschwellungen enden.
5. Im interstitiellen Bindegewebe gibt es ferner freie knSpfchen- fSrmige Endigungen, aber die von Po~ow beschriebenen grSBeren End- apparate wurden von uns nicht gefunden.
6. Das Vorkommen kleiner sympathischer Ganglien in der Glandula thyreoidea wurde ffir die von uns benutzten Tiere dureh unsere Unter- suchungen nicht best~tigt, obwohl an den positiven, beweisenden Be- funden yon NO~IDEZ ~icht zu zweifeln ist. Das Vorhandensein inter- stitieller sympathischel ellen ist zweifelhaft.
7. Die Innervation der Glandulae parathyreoidea ist ebenso reichlich wie die der Glandula thyreoidea.
8. Auch in der Glandulae parathyreoideae liegen die Biindel I. Ord- hung und der gr56te Teil derjenigen II . Ordnung um die Gefs herum, jedoch erscheinen ihre Anordnung und ihr Aussehen etwas verschieden. Sie verlaufen geradliniger, sind diinner und bilden weniger Geflechte als die Fasern der Thyreoidea.
9. Die sekretorisehen Nerven, d. h. die fiir die Zellstr~nge und sekre- torischen Elemente der Parathyreoidea bestimmten Fasern, zweigen teils von den Biindeln II. Ordnung ab, toils kommen sie unmittelbar von aui~en dureh die Kapseln hindurch. Sie sind - - wenigstens soweit die Technik
674 [Ferdinando Rossi e Francesco Lanti.
es zu zeigen e r l a u b t - - b e d e u t e n d weniger zahlre ich u n d firmer a n K n 6 p f c h e n b i l d u n g e n als die N e r v e n der G l a n d u l a thyreo idea .
10. U m die Zel ls t r / inge b i lden die s c h w a c h g e w u n d e n e n F a s e r n weit- masch ige Netze . Se l t en l/~Bt sich das E i n d r i n g e n df inner Endf / i se rchen zwischen die Dr t i senze l len nachweisen . Diese wenigen , die wi t b e o b a c h t e n k o n n t e n , sahen wir m i t k le inen , m i t K n 6 p f c h e n ve r sehenen oder kurz ve rzwe ig ten H/ i r chen endigen .
11. A u c h in der P a r a t h y r e o i d e a h a b e n wir die kr / i f t igen n e r v 6 s e n E n d a p p a r a t e y o n P o P o w n i c h t beobach te t .
12. :In d e n P a r a t h y r e o i d e a w u r d e n weder k le inere Gang l i en noch isol ierte N e r v e n z e l l e n v o m in te r s t i t i e l l en T y p u s ge funden .
Autor i citati . Andersson, 0. A.: Zur Kenntnis der Morphologie der Schilddrfise. Arch. f.
Anat., 177 (1894). - - Berkley~ H.: Nerves of the Thyroid Gland of the Dog. Hopkins I-Iosp. Rep. 4, 113 (1895). - - Braeueker~ W.: Die Nerven der Sehflddrfise und der EpithclkSrperchen. Anat. Anz. 56, 225 (1923). - - Civalleri, A.: Terminazioni nervose nella glandula tiroide. Giorn. Accad. Torino 64, No 7, 523 (1900). - - Crisafulli, E.: I nervi della glandula tiroide. Nota preliminare. Bull. mens. accad. gioenia sci. natur. Cat~nia 25 (1892). - - Engel, W.: Zur Innervation der Schild- driise. Pflfigers Arch. 211, 433 (1926). - - Horsley, V.: Innervation of the thyroid gland. Lancet 2, 1164 (1886). - - Jacques, P.: De r innervat ion s6crctoire de la glande Thyroidc. Bibliogr. anat. 5, 189 (1897). - - Lindemann, W.: Zur Frage fiber die Innervation der Schilddrfise. Zbl. Path. 2, 321 (1891). - - Livini, F.: Della terminazione dei nervi nclla tiroide e delle fessure pericelluiari nelle vescicole tiroidee. Arch. sper. Biol. 53, fase. 3, 261 (1899). - - Nonidez, J. F.: Inner- vation of the thyroid gland. I. The presence of ganglia in the thyroid of the dog. Arch. of Ncur. 25, 1175 {1931). - - Inaervation of the thyroid gland. IL Origin and course of the thyroid nerves in the dog. Amer. J. Anat. 48, 299 (1931). - - Peraeehia, G.: Simpatico addominale e paratiroidi. Riv. Biol. 19, 681 (1927). - - Peremesehko: Ein Beitrag zum Bau dcr Schilddrfise. Z. Zool. 17, 279 (1867). - - Pines~ L.: ~ber die Inncrvation der Schilddrfise. Z. Near. 118, 552 (1929). - - Poinear~, M.: Note sur l 'irmervation de la glande Thyroide. J. de Anat. 11, 477 (1875). - - Popow~ N. A.: ~ber die Inner- ra t ion der Glandula thyreoidea. Z. Near. 110, 383 (1927). - - ]~ber die Innervation der Glandula Thyreoidca beim 1Y[enschen und bei S/~ugetieren. Z. Neur. 115, 131 (1928). - - l~be r die ]nnervation der Parathyreoiddrfisen beim iYlenschen. Z. Near. 122, 337 (1929). - - Rhinehart~ D.A.: The nerves of the thyroid and parathyroid bodies. Amer. J. Anat. 13, 91 ( 1 9 1 2 ) . - Saeerdotti, C.: Sui nervi della tiroide. Atti Aec~d. Seien. Torino 29, 16 (1893/94). - - Trautmann~ M.: ~ber die Nerven der Schilddrfise. Inaug.-Diss. Halle 1895. - - Verson, S.: Contributo allo studio della glandula tiroide e suoi anncssi. Arch. Sci. med. 31, 477 (1907). - - Winiwarter, H. de: Terminaisons sensibles dans les l~rathyroides. C. r. Soc. Biol. 107, 118 (1930). - - ZeiB, 0.: Mikroskopische Untersuchungen fiber den Bau der Schild- drfise. Inaug.-Diss. StraBburg 1877.