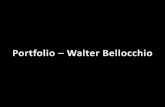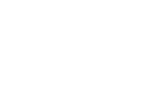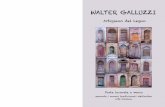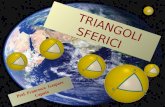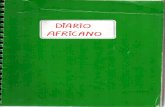Contabilità - Walter Caputo - 2010
-
Upload
taliuccia2010 -
Category
Documents
-
view
158 -
download
5
description
Transcript of Contabilità - Walter Caputo - 2010

1
COLLANA: Contabilità AUTORE: Walter Caputo CODICE: Eco Contabilità n. 1 aggiornata al 22-9-2010 TITOLO: Contabilità e bilancio: teoria e pratica a livello base SOTTOTITOLO: Esercizi svolti e da svolgere, quiz con soluzioni, software excel per elaborare il bilancio d’esercizio e glossario essenziale dei termini tecnici FORMATO: PDF per il testo ed EXCEL per il software EDIZIONE: 1^ edizione 2010 – aggiornata al 22-9-2010 DIFFUSIONE: Associazione E.C.O. PREZZO: 20 euro IL LIBRO: Questo volume, che illustra i fondamenti della Partita Doppia e si caratterizza per l’estrema semplicità, è suddiviso in due parti: una teorica e una pratica. In quella teorica si richiamano i concetti base della P.D. e si forniscono gli “strumenti del contabile”: schema di funzionamento del metodo, piano dei conti, strutture contabili, schemi delle scritture di assestamento e procedure di bilancio. La parte pratica, invece, descrive – tramite casi svolti – la metodologia contabile, sia nell’aspetto di analisi dei documenti aziendali e di redazione delle scritture, sia in quello di elaborazione del bilancio d’esercizio. Di grande aiuto può risultare la struttura “narrativa” del terzo capitolo, che permette di calarsi in maniera ottimale nel mestiere: fra le righe, infatti, vengono evidenziati gli aspetti positivi e negativi della professione, così da rendere un’idea di cosa significhi esattamente “fare il contabile”. Un capitolo apposito è poi dedicato alla spiegazione del contenuto e dell’utilizzo del file excel allegato a questo testo: si tratta di una simulazione excel che consente di redigere il bilancio d’esercizio a partire dalla situazione contabile. Il programma si giova di una serie di automatismi grazie ai quali l’utente può verificare la correttezza delle risposte alle varie domande formulate. A fine testo, un capitolo contiene esclusivamente utilissimi esercizi da svolgere: compilazione della Prima Nota di cassa e banca, rilevazioni in Partita Doppia e scritture contabili da effettuare a partire da documenti aziendali. Il testo si indirizza agli studenti dei corsi IGEA, agli studenti universitari che devono affrontare l’esame di Economia Aziendale e, per la pratica della Partita Doppia, a tutti i giovani professionisti e agli operatori d’azienda. A tal fine, ogni capitolo è corredato di un questionario le cui soluzioni sono riportate a fine volume. Chiude il lavoro un utile glossario contenente quasi 90 termini tecnici. A lettura ultimata, è possibile continuare il dialogo con l’autore, tramite il blog: “Paghe e Contabilità – Scienze naturali ed economiche”, raggiungibile all’indirizzo http://blog.libero.it/paghecontributi/ , che ospita, oltre ad informazioni ed approfondimenti sui temi della contabilità e del calcolo della busta paga, anche articoli di divulgazione scientifica. IL BLOG DI SUPPORTO AI LETTORI: Il lettore, inoltre, avrà la possibilità di “dialogare” con l’autore tramite un blog, consultabile all’indirizzo http://blog.libero.it/paghecontributi/ . Esso ospita, oltre ad informazioni ed approfondimenti sui temi della contabilità e del calcolo della busta paga, anche articoli di divulgazione scientifica.

2
L’AUTORE: Walter Caputo ha un diploma universitario in Amministrazione Aziendale ed è laureato in Economia e in Scienze Statistiche. Si occupa di divulgazione scientifica nonché di assistenza didattica, formazione e consulenza su tematiche del lavoro, contabili, fiscali e matematico-statistiche per scuole, aziende e liberi professionisti. Per Finanze & Lavoro ha pubblicato: “TFR 2007 – Cosa cambia e cosa fare” (1° edizione 2007); “Casi svolti di contabilità e bilancio” (1° edizione 2007); “Casi svolti di paghe e contributi” (3° edizione 2008); “Paghe e contributi” (5° edizione 2009); “Corso base controllo di gestione” (2° edizione 2009); “L’analisi per flussi e il rendiconto finanziario” (1° edizione 2009); “Corso base di contabilità e bilancio” (5° edizione 2010). RINGRAZIAMENTI: Un doveroso ringraziamento va:
- a mia moglie, perché sorride felice ogni volta che riesco a concludere un nuovo libro; - ai miei studenti, perché restano i miei punti di riferimento per decidere come scrivere
e come spiegare; - all’Associazione E.C.O., perché diffonderà questo libro tramite il suo blog,
raggiungibile all’indirizzo http://ecoassociazione.blogspot.com ; - al Dott. Claudio Pasqua, fondatore di Gravità Zero, blog di divulgazione scientifica
(http://www.gravita-zero.org/): è grazie a lui che sono diventato un blogger scientifico (http://www.gravita-zero.org/search/label/walter%20caputo).
DEDICA: A mio figlio Rossano che, a due anni, classifica ed ordina gli oggetti come se fosse un piccolo contabile CITAZIONE: “Pitagora, l’insegnante, pagava allo studente tre oboli per ogni lezione frequentata e si accorse che, con il passare delle settimane, l’iniziale riluttanza del ragazzo ad apprendere si era trasformata in entusiasmo per il sapere. Per misurare il proprio successo Pitagora finse di non poter più permettersi di pagare lo studente e che le lezioni dovevano cessare; allora lo studente, per non dover interrompere la propria istruzione, si offrì di pagare lui il maestro”. Tratto da “L’ultimo Teorema di Fermat” di Simon Singh – Bur Rizzoli, 16° edizione 2009
INDICE PARTE PRIMA: TEORIA Capitolo I – Le regole della contabilità
1. Principi contabili……………………………………………………………….Pag. 5 2. Sistemi contabili……………………………………………………………………..5 3. Metodi contabili……………………………………………………………………...6 3.1. Metodo della partita semplice………………………………………………………6 3.2. Metodo della partita doppia………………………………………………………...6 3.2.1. Rilevazioni aziendali e rilevazioni contabili……………………………………..8 3.2.2. Principi e regole della partita doppia…………………………………………….9 4. I conti e le causali contabili………………………………………………………...13 5. Il piano dei conti……………………………………………………………………13 5.1. Struttura e formazione…………………………………………………………….14 5.2. Classificazione e codificazione…………………………………………………...14 5.3. Modelli di piano dei conti…………………………………………………………14 6. Quiz sul capitolo I…………………………………………………………………...15

3
Capitolo II – Gli strumenti della contabilità
1. Schema di funzionamento del metodo della Partita Doppia………………………17 2. Un piano dei conti esemplificativo………………………………………………..18 3. Strutture contabili delle operazioni aziendali di base……………………………..21 3.1 Struttura contabile dell’operazione di acquisto…………………………………...21 3.2 Struttura contabile dell’operazione di pagamento………………………………...21 3.3 Struttura contabile dell’operazione di vendita……………………………………22 3.4 Struttura contabile dell’operazione di incasso……………………………………22 4. Schema di sintesi delle scritture contabili di rettifica……………………………..22 5. Schema per la realizzazione di un caso completo di contabilità generale: dalle
scritture contabili d’esercizio al bilancio………………………………………….23 5.1 Procedura di redazione della bozza di bilancio…………………………………..23 5.2 Procedura di redazione del bilancio definitivo…………………………………...25 6. Il conto economico………………………………………………………………..27 7. Lo stato patrimoniale……………………………………………………………...29 8. La nota integrativa………………………………………………………………..32 9. Quiz sul capitolo II……………………………………………………………….33
PARTE SECONDA: PRATICA Capitolo III – Registrazione contabile di documenti aziendali
1. Ricevuta del versamento postale di un premio assicurativo……………………..35 2. Parcella di un avvocato non soggetto a ritenuta d’acconto……………………...37 3. Parcella di un notaio soggetto a ritenuta d’acconto……………………………...39 4. Fattura di una società di consulenza del lavoro………………………………….40 5. Prospetto contabilizzazione retribuz. dipend. inviato dal consulente del lavoro..42 6. Prospetto contabilizzazione retribuzioni collaboratori a progetto, inviato dal
consulente del lavoro…………………………………………………………….45 7. Quiz sul capitolo III……………………………………………………………...46
Capitolo IV – Un caso completo di esercitazione svolta: dalla situazione contabile al bilancio d’esercizio
1. Situazione contabile di partenza…………………………………………………48 2. Scritture contabili d’esercizio……………………………………………………49 3. Mastrini originati dalle scritture contabili d’esercizio…………………………...52 4. Primo bilancio di verifica………………………………………………………..53 5. Scritture di assestamento al 31/12……………………………………………….54 6. Secondo bilancio di verifica……………………………………………………..55 7. Bozza di Conto Economico al 31/12/2010………………………………………56 8. Bozza di Stato Patrimoniale al 31/12/2010………………………………………57 9. Conto Economico al 31/12/2010…………………………………………………57 10. Stato Patrimoniale al 31/12/2010………………………………………………..59 11. Quiz sul capitolo IV……………………………………………………………..62

4
Capitolo V - CD-ROM: Contenuto e istruzioni
1. Situazione contabile Metodologica S.p.a……………………………………….64 2. Bozza di bilancio Metodologica S.p.a………………………………………….67 3. Bilancio d’esercizio Metodologica S.p.a……………………………………….70
Capitolo VI – Esercizi da svolgere
1. Analisi S.r.l……………………………………………………………………..75 2. Congettura S.r.l…………………………………………………………………76 3. L’Ultimo Teorema di Fermat S.p.a……………………………………………..77 4. Big Bang S.r.l…………………………………………………………………...77
Glossario essenziale……………………………………………………………………79 Quiz di verifica finale………………………………………………………………….92 Soluzioni……………………………………………………………………………….93 Bibliografia…………………………………………………………………………….95

5
PARTE PRIMA: TEORIA Capitolo I – Le regole della contabilità 1. Principi contabili I principi contabili sono le regole tecnico-ragionieristiche che governano l’intero processo di formazione del bilancio d’esercizio, dalla fase della rilevazione contabile delle operazioni di gestione a quella della redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, fino alla valutazione delle attività e passività componenti il patrimonio aziendale. I principi contabili integrano (e quindi rispettano) le norme giuridiche vigenti quando queste risultano insufficienti, dal punto di vista applicativo o comunque operativo, nell’elaborazione della pratica contabile. Essi si distinguono in:
- principi contabili nazionali -> emanati dalle categorie professionali (Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ora unificati nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in seguito alla legge 34/2005 e al successivo decreto legislativo istitutivo dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Tale nuovo albo unico ha iniziato a tutti gli effetti il suo corso dal 1^ gennaio 2008), le quali hanno dato vita all’O.I.C., Organismo Italiano di Contabilità;
- principi contabili internazionali -> emanati dallo I.A.S.B. (International Accounting Standards Board), con lo scopo di contribuire al processo di armonizzazione delle modalità di redazione del bilancio d’esercizio e delle informazioni economico-finanziarie in genere, soprattutto attraverso l’elaborazione di regole contabili internazionali. Tali principi, denominati I.F.R.S. (International Financial Reporting Standards) sono obbligatori per la redazione del bilancio consolidato di tutte le società dell’Unione Europea quotate in un mercato regolamentato.
2. Sistemi contabili I sistemi di rilevazione che si avvalgono di un insieme di conti, tra loro collegati e costituiti in sistema, assumono la denominazione di “sistemi contabili”. I sistemi contabili si suddividono in:
- principali, se hanno come oggetto il patrimonio, il reddito o entrambi; - supplementari, se sono “minori” (in quanto rilevano accadimenti di impresa
mediante scritture elementari semplici) o “impropri” (in quanto rilevano, mediante scritture doppie in “conti d’ordine”, l’assunzione di impegni, o di rischi, o di garanzie, da parte di terzi ovvero verso terzi o anche semplicemente la consegna di beni propri presso terzi in conto deposito, lavorazione o garanzia, ed il ricevimento di beni di terzi per le stesse ragioni).

6
3. Metodi contabili Le scritture contabili, dal punto di vista del metodo, si distinguono in:
- scritture semplici: coinvolgono una sola serie di conti e danno luogo, per ogni fatto di gestione, ad una sola registrazione;
- scritture doppie: coinvolgono contemporaneamente due serie di conti e registrano ciascun fatto aziendale sotto due aspetti.
I soggetti tenuti alla contabilità, al fine di rilevare i fatti aziendali, possono adottare quindi due distinte tecniche contabili:
- metodo della partita semplice -> per soggetti che non necessitano di riscontro contabile con movimentazioni di tipo finanziario (soggetti in contabilità semplificata);
- metodo della partita doppia -> per soggetti che devono annotare anche le movimentazioni di tipo finanziario (soggetti in contabilità ordinaria).
3.1. Metodo della partita semplice È un metodo di rilevazione contabile che consente la sola rilevazione dei fatti di gestione effettuando la loro registrazione esclusivamente nella sezione dare o avere di un registro contabile. Di conseguenza tale metodo priva gli utilizzatori di molti elementi di verifica e controllo. Per ogni registrazione la rilevazione è, dunque, unica, in quanto non viene richiesta la doppia scrittura. Il metodo della partita semplice:
- è veloce; - è di facile applicazione; - riduce il numero di rilevazioni contabili da effettuare; - complica le fasi di verifica; - non consente l’individuazione immediata di componenti positivi e negativi di
reddito; - rende difficile reperire i dati per compilare la dichiarazione dei redditi.
Tale metodo viene utilizzato dai soggetti in contabilità semplificata, tramite l’annotazione delle operazioni:
- nel registro IVA delle vendite - oppure in quello degli acquisti (a seconda del tipo di operazione).
3.2. Metodo della partita doppia La storia della contabilità, l’evoluzione della sua tecnica e dei suoi obiettivi sono legati allo sviluppo del commercio ed alla necessità di rappresentare i progressivi mutamenti della realtà economica. Da quando l’uomo ha iniziato a scambiarsi dei beni, ha cercato di conservare traccia delle operazioni svolte e dei risultati ottenuti. L’introduzione della moneta è stato un passo importante per lo sviluppo della contabilità; senza dubbio, un’economia basata sul solo baratto non avrebbe permesso l’evolversi della contabilità.

7
All’inizio si trattava di una contabilità semplice, che registrava le entrate e le uscite di denaro e permetteva di determinare, per differenza, il risultato della gestione, rappresentato dal denaro contante. Successivamente, con l’aumento degli scambi e del numero di intermediari, nasceva per i commercianti la necessità di tenere conti differenziati (ad es. per conoscere i crediti verso i singoli clienti e i debiti verso i singoli fornitori), e di gestire i beni posseduti analizzando i guadagni o le perdite realizzate. Questo insieme di bisogni ha portato all’evoluzione della contabilità e all’elaborazione del metodo detto della partita doppia. Gli storici ritengono che la contabilità tenuta con il metodo della partita doppia sia apparsa verso il 1340 a Genova. Lo sviluppo della stampa ha permesso di generalizzare questo metodo attraverso i trattati di Fra Luca Pacioli, la cui prima opera, pubblicata nel 1494 con il titolo di “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità”, ne ha enunciato i principi fondamentali nel capitolo sulle operazioni commerciali e le scritture. Dopo questa data la contabilità in partita doppia non ha subito modifiche fondamentali. Solo con l’espansione dell’attività creditizia e l’utilizzo di capitali esterni da parte delle imprese, è sorta la necessità di individuare correttamente il capitale e il reddito, in base a principi di determinazione del reddito che permettessero di mantenere integro il capitale prima di procedere alla sua remunerazione. È stato necessario che la fase puramente meccanica di tenuta dei conti, consistente nella gestione dei fatti correnti, fosse seguita dalla fase di chiusura dei conti, consistente nell’intervento del responsabile della gestione di impresa per introdurre nei conti, al fine di determinare correttamente il reddito, i necessari elementi di previsione, apprezzamento e valutazione riferiti all’evoluzione del valore dei beni, alla necessità di rinnovarli periodicamente, per assicurare la continuità dell’impresa, ed infine di far fronte ai rischi. Il metodo della partita doppia è il metodo più diffuso al fine di effettuare rilevazioni contabili. Tale metodo richiede la tenuta del:
- libro giornale; - libro mastro.
Esso si basa sulla rilevazione doppia, tramite l’utilizzo di due serie di conti, di ogni singolo accadimento aziendale, all’interno del libro giornale. I valori attribuiti ai conti vengono poi riportati nei singoli “mastrini” (cioè conti a sezioni contrapposte con forma a “T”). Il metodo della partita doppia:
- richiede determinate conoscenze ai fini della sua corretta applicazione; - agevola le fasi di verifica, fornendo efficaci strumenti di controllo; - consente l’individuazione immediata di componenti positivi e negativi di
reddito, in quanto rileva sia l’aspetto numerario che quello economico, cioè di costo o di ricavo;
- agevola il reperimento dei dati per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

8
3.2.1 Rilevazioni aziendali e rilevazioni contabili: contabilità generale e contabilità speciale
Le rilevazioni aziendali possono essere classificate sotto diversi aspetti:
- sono interne, se riguardano dati aziendali come ad es. il fatturato, oppure esterne se sono relative a dati di mercato;
- sono elementari se riguardano singoli elementi come ad es. il registro di prima nota, oppure complesse se sono relative alla determinazione del reddito e del patrimonio;
- sono cronologiche se vengono effettuate esclusivamente secondo l’ordine di data come ad es. il libro giornale, oppure sistematiche se privilegiano il riferimento a determinati oggetti, come ad es. il libro mastro;
- sono obbligatorie se vengono richieste dalla legge, mentre sono facoltative se vengono liberamente tenute dagli organi aziendali;
- sono sintetiche quando rilevano fenomeni raggruppati in categorie omogenee, mentre sono analitiche quando rilevano singoli elementi;
- sono a quantità se si limitano a rilevare solo le quantità fisiche, mentre sono a valore se indicano anche entrate e uscite, ricavi e costi;
- sono contabili se utilizzano come strumento il conto, sono invece extracontabili se utilizzano altri tipi di strumenti, come ad es. tabelle o grafici.
Oggetto del metodo della partita doppia sono le rilevazioni contabili. Esse rappresentano il nucleo fondamentale della contabilità generale. Quest’ultima, che si configura come elemento essenziale del sistema informativo aziendale, può essere definita come un preordinato processo organico e continuo di rilevazioni quantitative, con specifiche funzioni di accertamento amministrativo. I dati che la contabilità generale (spesso abbreviata con l’acronimo CO.GE.) tipicamente rileva in “moneta nominale di conto” sono dotati di certezza quantitativa; per questo motivo essi sono valori oggettivi, o quantità monetarie suscettibili di accertamento, in quanto oggettivamente misurabili. Tali dati devono essere valori rilevabili da documenti che ne attestino il verificarsi come fatti amministrativi (ad es. fatture commerciali, atti di acquisto o di vendita, note di addebito o di accredito, ecc.). Come organica rilevazione quantitativa, la contabilità generale trova il suo originario fondamento in tali documenti, la cui raccolta ordinata serve per costituire una primaria fonte di dati. Le funzioni amministrative di accertamento proprie della contabilità generale possono essere così riassunte:
la registrazione in ordine cronologico delle quantità oggettive contenute nei documenti emessi e ricevuti dall’impresa, al fine di evidenziare possibili errori di omissione o duplicazione: dette registrazioni in ordine cronologico sono effettuate su un apposito libro, che è il libro giornale;
la registrazione di tipo sistematico dei valori oggettivi contenuti nei documenti al fine di classificare le informazioni contabili per categorie omogenee di valori: tali registrazioni di tipo sistematico sono effettuate in appositi conti di mastro (o “mastrini”), che consentono la classificazione di dati omogenei riferiti ad un determinato oggetto (ad es. cassa, crediti, debiti, ecc.).

9
Gli obiettivi della contabilità generale possono così suddividersi: obiettivi fondamentali: redazione del bilancio d’esercizio, tramite determinazione
periodica del reddito e del connesso capitale dell’impresa in funzionamento. La determinazione del reddito richiede la rilevazione di costi e ricavi relativi ad un determinato periodo di gestione aziendale (definito “esercizio”), e il calcolo della differenza fra ricavi e costi, dal quale può scaturire un utile d’esercizio (se i ricavi sono maggiori dei costi) oppure una perdita d’esercizio (se i ricavi sono minori dei costi);
obiettivi subordinati: raccolta di dati grezzi per successive elaborazioni che sono effettuate dalle contabilità speciali, le quali – rispetto alla contabilità generale – hanno un oggetto più limitato.
Esempi di contabilità speciali sono:
- contabilità di magazzino, volta ad aggiornare continuamente la situazione delle giacenze di materie e prodotti;
- contabilità della manodopera, volta alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (= L.U.L.) o di altre rilevazioni necessarie per la gestione del personale;
- contabilità industriale, volta a determinare i costi dei prodotti; - contabilità direzionale, volta a fornire al management (= direzione aziendale)
un quadro degli indicatori per l’amministrazione dell’impresa. 3.2.2 Principi e regole della partita doppia I requisiti generali che un’operazione aziendale deve possedere affinché venga contabilizzata secondo il metodo della partita doppia sono i seguenti:
a) deve essersi verificata un’operazione aziendale che abbia coinvolto un soggetto all’interno ed uno all’esterno dell’azienda. Ad es. deve essere contabilizzata un’operazione di acquisto di merci presso un fornitore, perché essa coinvolge un soggetto esterno (il fornitore) ed uno interno (un dipendente dell’azienda che lavora nell’ufficio acquisti). Non deve essere invece contabilizzata un’operazione di spostamento merci da un magazzino all’altro dell’azienda, effettuata da un dipendente dell’azienda stessa (magazziniere), in quanto essa non coinvolge soggetti esterni;
b) l’operazione di cui al punto a) deve essere supportata da un documento giustificativo. Ad es. l’operazione di acquisto merci presso un fornitore viene contabilizzata in quanto è documentata da una fattura;
c) l’operazione di cui ai punti a) e b) deve generare una variazione, cioè un aumento o una diminuzione, di cassa o banca o crediti o debiti.
Tali requisiti sono generali, nel senso che ammettono comunque eccezioni in casi particolari. Ad es. la contabilizzazione degli stipendi dei dipendenti deriva da un’operazione di remunerazione di fattori produttivi. I dipendenti offrono il fattore produttivo lavoro e l’imprenditore li remunera con la corresponsione dello stipendio. Tale operazione non coinvolge soggetti esterni (in quanto sia l’imprenditore che i dipendenti sono soggetti interni), eppure va contabilizzata.

10
Inoltre i tre requisiti generali sopra esposti funzionano abbastanza bene per la rilevazione di fatti aziendali che si verificano durante l’esercizio, cioè – in generale – durante l’anno solare, ma non sono completamente applicabili nel caso degli eventi che richiedono le cosiddette scritture di rettifica o assestamento. Queste ultime infatti sono rilevazioni contabili, effettuate al 31/12 di ogni esercizio:
- in generale non supportate da documenti giustificativi: ad es. la rilevazione delle fatture da ricevere da fornitori è basata su una stima, non su una cifra oggettiva rilevabile da un documento (che, trattandosi di fattura, non è stato ancora emesso al 31/12);
- non sempre generate da un’operazione che coinvolge soggetti esterni: ad es. la rilevazione contabile della quota annua di trattamento di fine rapporto per ogni dipendente, coinvolge soltanto l’imprenditore e i dipendenti;
- mai generate da variazioni di cassa, banca, crediti, debiti, in quanto le scritture di assestamento trovano la loro origine in un aspetto puramente economico: ad esempio se il 1/10/2010 l’imprenditore ha pagato in anticipo 6 mesi di assicurazione dell’autocarro aziendale, occorrerà effettuare una rettifica di storno del costo, eliminando la parte di costo del 2011 che, quindi non è di competenza del 2010. Tale scrittura di rettifica è appunto originata da un aspetto economico: lo storno di un costo. L’utilità di tale tipo di scrittura contabile risiede nella necessità di chiudere correttamente il bilancio, determinando il reddito dell’esercizio 2010, composto cioè da ricavi e costi di competenza dell’anno 2010.
Qui di seguito si riporta lo schema di funzionamento del metodo della partita doppia.
Conti numerari Sono conti interessati da variazioni numerarie attive (collocate nella sezione DARE) o passive (collocate nella sezione AVERE). Le variazioni numerarie attive possono essere originate da: Entrata di cassa / banca; Sorgere di crediti; Diminuzione di debiti.
Le variazioni numerarie passive possono essere originate da: Uscita di cassa / banca; Sorgere di debiti; Diminuzione di crediti.
Conti economici di reddito Sono conti interessati da variazioni economiche negative di reddito o componenti negativi di reddito (collocate nella sezione DARE) oppure da variazioni economiche positive di reddito o componenti positivi di reddito (collocate nella sezione AVERE). I componenti negativi di reddito sono: Sorgere di costi; Storno di ricavi.

11
I componenti positivi di reddito sono: Sorgere di ricavi; Storno di costi.
Conti economici di capitale Sono conti interessati da: Variazioni economiche passive di capitale (collocate nella sezione DARE), originate da
diminuzioni di capitale netto; Variazioni economiche attive di capitale (collocate nella sezione AVERE), originate da
aumento di capitale netto. Conti economici pluriennali Sono conti interessati da: Variazioni economiche negative (collocate nella sezione DARE), originate dal sorgere di
costi pluriennali; Variazioni economiche positive (collocate nella sezione AVERE), originate dallo storno
di costi pluriennali. La scrittura contabile in partita doppia può essere redatta secondo due forme grafiche:
- quella della tradizionale contabilità manuale; - quella della contabilità automatizzata (che verrà utilizzata nel corso del testo
perché è più semplice ed anche più utile, in quanto la contabilità viene gestita ormai solo tramite applicativi software dedicati).
Forma grafica scrittura in P.D. (contabilità manuale): data
codice codice sezione a sezione cifre cifre DARE AVERE DARE AVERE PARZIALI TOTALI
27/09/10 14/001 diversi a debiti vs. 1200 fornitori
51/002 materie c/ 1000 acquisti
10/001 Iva a 200 credito
Forma grafica scrittura in P.D. (contabilità informatizzata):
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE 27/09/10 14/001 debiti verso fornitori 1200
51/002 materie conto acquisti 1000 10/001 IVA a credito 200

12
Le due scritture contabili sopra rappresentate si riferiscono ad un unico accadimento aziendale: acquisto, in data 27/09/2010, di materie presso un fornitore per 1000 euro più IVA 20%. Regolamento dilazionato a 60 giorni data fattura. Tale operazione:
- coinvolge un soggetto esterno (fornitore) ed uno interno (dipendente ufficio acquisti);
- è supportata da un documento giustificativo: una fattura per acquisto di materie per 1000 euro + IVA 20%;
- genera una variazione di debiti, in quanto il regolamento della fattura non è immediato, ma dilazionato.
Dall’applicazione dello schema di funzionamento del metodo della partita doppia sopra riportato risulta:
- sotto l’aspetto numerario, un sorgere di debiti verso il fornitore (perché la fattura non viene pagata subito): variazione numeraria passiva -> AVERE. Tale variazione viene registrata nel conto “debiti verso fornitori” per l’importo del costo più l’IVA, cioè 1200 euro;
- sotto l’aspetto economico, un sorgere di costo (dovuto all’acquisto delle materie): componente negativo di reddito -> DARE. Tale variazione viene registrata nel conto “materie conto acquisti” per 1000 euro;
- sotto l’aspetto fiscale (che rientra in quello numerario), un sorgere di credito nei confronti dello Stato (a causa dell’IVA pagata al fornitore): variazione numeraria attiva -> DARE. Tale variazione viene registrata nel conto “IVA a credito” per 200 euro.
I codici e i relativi conti fanno riferimento al cosiddetto piano dei conti (si veda il capitolo 2, paragrafo 2). Il metodo della partita doppia è costruito in modo che ogni scrittura contabile si chiuda con un totale DARE esattamente pari al totale dell’AVERE. Nel nostro esempio, infatti, il totale dare è pari a 1000 + 200 = 1200, cifra che corrisponde al totale avere (1200). Se tale quadratura non si verifica al termine della scrittura contabile, significa che sono stati commessi degli errori. Nella contabilità informatizzata è possibile inserire, generalmente, una descrizione per ogni conto utilizzato: ad es., nel nostro caso, si poteva aggiungere
- il riferimento alla data e al numero di fattura (come descrizione del conto “debiti verso fornitori”, in quanto il nome del fornitore risulta già dal conto, che nella realtà aziendale non è mai un generico “debiti vs fornitori” ma è “debiti verso Tizio o verso Caio”);
- il riferimento alla data, al numero di fattura e al nome del fornitore (come descrizione del conto “materie c/acquisti”);
- il riferimento alla data e al numero di fattura (come descrizione del conto “IVA a credito”).
Questo modo di procedere nell’inserimento delle descrizioni consente più facili verifiche e maggiori controlli incrociati nell’elaborazione delle scritture in P.D.

13
Infine occorre notare che la scrittura contabile sopra riportata e' una registrazione nel libro giornale. Nel libro mastro, il software di contabilità aggiornerà in automatico il valore dei mastrini per ogni conto utilizzato, secondo la seguente struttura:
nome del conto importi importi DARE AVERE
e con il seguente risultato, nel caso del nostro esempio:
debiti vs. fornitori materie c/acquisti IVA a credito 1200 1000 200
4. I conti e le causali contabili Si riporta qui di seguito un’utile terminologia tipica usata per i conti:
- intestare un conto: attribuire al conto titolo e codice; - aprire un conto: intestare un conto ed effettuare la prima registrazione del
conto stesso; - accreditare: registrare nella sezione avere di un conto; - addebitare: registrare nella sezione dare di un conto; - chiudere un conto: determinare i totali dare e avere e, tramite differenza,
ottenere il saldo. Il saldo ottenuto viene iscritto nella sezione opposta (quella con importo minore);
- epilogare un conto: trasferire il contenuto di più conti in un solo conto di sintesi (o di riepilogo). Tale integrazione si ottiene mediante un semplice riporto di valori. Tipici i casi dei conti “banche c/c attivi” e “banche c/c passivi”, i cui saldi vengono riportati in un conto “banche c/c”.
Le causali contabili sono codici attribuiti, dall’operatore tramite software di contabilità, ad ogni descrizione. L’utilità consiste nel velocizzare le operazioni di caricamento delle scritture contabili: ad es. se alla descrizione “fattura di vendita” è stato attribuito il codice 4, per inserire la descrizione sarà sufficiente digitare 4. Può sembrare strano che un operatore contabile ricordi a memoria i codici delle causali contabili (ed anche quelli dei conti), ma posso garantire al lettore che ciò accade, avendolo sperimentato di persona. 5. Il piano dei conti Il piano dei conti (si veda il capitolo 2, paragrafo 2) è un elenco dei conti personalizzato in base alle esigenze informative della singola azienda. Di conseguenza può essere più meno articolato, ma deve comunque consentire la redazione del bilancio d’esercizio. A tal fine, il piano dei conti presenta una struttura molto simile a quella del bilancio (stato patrimoniale e conto economico).

14
5.1 Struttura e formazione La struttura del piano dei conti viene articolata in più documenti:
- piano dei conti in senso stretto: è un’elencazione ordinata di conti e sottoconti con i corrispondenti codici;
- manuale interno di contabilità: è un prospetto che definisce il funzionamento dei singoli conti a diversi livelli di classificazione, specificando per ciascun conto il contenuto e le regole da seguire nelle registrazioni in P.D.;
- manuale procedurale: è una guida che definisce i criteri per implementare il piano dei conti, ed eventualmente modificarlo ed integrarlo.
Formare un piano dei conti è il lavoro più delicato ed importante nella costruzione dell’”edificio” contabile: se ben studiato ed impostato, può offrire grandi vantaggi; se mal progettato, rende vane le funzioni informative del sistema contabile. Il piano dei conti si dimensiona e si articola tenendo presenti le esigenze di analiticità e dettaglio richieste dalla singola azienda. L’analiticità e il dettaglio si strutturano nella cosiddetta classificazione a più stadi, dove le classi diventano sempre più numerose e ristrette nel passaggio a successive dimensioni contabili. 5.2 Classificazione e codificazione Per classificazione si intende l’operazione diretta ad ordinare sistematicamente i conti per classi, secondo criteri prestabiliti. La classificazione avviene in base alla natura dei conti, su più livelli:
- raggruppamenti di base: ad es. attività; - conti di mastro: ad es. crediti commerciali; - sottoconti di mastro: ad es. crediti verso clienti; - conti analitici (di partitario): ad es. crediti verso società Alfa S.r.l.
Ad ogni livello viene attribuito un codice, numerico o alfanumerico, solitamente progressivo. 5.3 Modelli di piano dei conti Fermo restando che i piani dei conti sono personalizzati per ogni singola azienda, esistono modelli standardizzati di piani dei conti per determinate categorie di aziende. Si riportano qui di seguito alcune indicazioni, a titolo puramente esemplificativo:
- aziende industriali: tra le specificità, si rilevano, nei conti di magazzino, quelli relativi a materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- aziende di servizi: tra le specificità, si rileva una fitta articolazione dei conti relativi alle consulenze, ed una mancanza dei conti relativi al magazzino (in quanto un’azienda di servizi non produce beni fisici);
- aziende in forma di società per azioni: tra le specificità, si rileva una serie di conti relativi alle azioni e la mancanza di conti intestati ai singoli soci;
- aziende in forma di società di persone: tra le specificità si rileva una serie di conti intestati ai singoli soci, e nessun conto relativo alle azioni (in quanto il capitale di una società di persone è suddiviso in quote e non in azioni).

15
6. Quiz sul capitolo I 1) Che cosa sono i principi contabili ?
a) leggi b) regole contenute nel codice civile c) regole che integrano e rispettano le norme giuridiche vigenti
2) Che differenza intercorre fra sistemi e metodi contabili ?
a) i sistemi possono essere principali o supplementari, mentre i metodi possono essere la partita semplice oppure quella doppia
b) non c’è alcuna differenza c) i sistemi possono essere la partita semplice oppure quella doppia mentre i
metodi possono essere principali o supplementari
3) Il metodo della partita semplice: a) viene utilizzato dai soggetti in contabilità ordinaria b) viene utilizzato dai soggetti in contabilità semplificata c) può essere utilizzato da chiunque
4) Le rilevazioni contabili cronologiche caratterizzano:
a) il libro mastro b) il libro degli inventari c) il libro giornale
5) L’obiettivo principale della contabilità generale è:
a) conoscere l’utile d’esercizio b) pervenire alla redazione del bilancio d’esercizio c) determinare l’ammontare del patrimonio aziendale ad una certa data
6) Una variazione di cassa, banca, crediti o debiti corrisponde ad una:
a) variazione numeraria b) variazione economica c) variazione di capitale
7) Un sorgere di costi o di ricavi è:
a) una variazione numeraria b) un evento che non va contabilizzato c) una variazione economica
8) I conti sono caratterizzati:
a) da un’unica sezione b) da due sezioni c) da tre sezioni
9) In ogni scrittura contabile:
a) il totale dare e il totale avere possono coincidere b) il totale dare e il totale avere devono essere necessariamente diversi c) il totale dare e il totale avere devono coincidere

16
10) Il piano dei conti: a) è uguale per tutte le aziende b) è un elenco di conti personalizzato c) è una pura formalità burocratica

17
Capitolo II – Gli strumenti della contabilità 1. Schema di funzionamento del metodo della Partita Doppia SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL METODO DELLA PARTITA DOPPIA (con
collocazione in bilancio delle diverse categorie di conti)
SEZIONE DARE SEZIONE AVERE TIPO DI CONTI
Tipo di variazione
Variazione (aumento o diminuzione)
Tipo di variazione
Variazione (aumento o
diminuzione) Conti numerari (stato patrimoniale)
Variazioni numerarie attive
Entrata di cassa o bancaSorgere di crediti Diminuzione di debiti
Variazioni numerarie passive
Uscita di cassa o banca Sorgere di debiti Diminuzione di crediti
di reddito (conto economico)
Componenti negativi di reddito
Sorgere di costi Storno di ricavi
Componenti positivi di reddito
Sorgere di ricavi Storno di costi
di capitale (stato patrimoniale)
Variazioni economiche passive di capitale
Diminuzione di capitale netto
Variazioni economiche attive di capitale
Aumento di capitale netto
Conti economici
pluriennali (stato patrimoniale)
Variazioni economiche negative
Sorgere di costi pluriennali
Variazioni economiche positive
Storno di costi pluriennali

18
2. Un piano dei conti esemplificativo PIANO DEI CONTI ESEMPLIFICATIVO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
40/000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 40/001 macchinari 40/002 fondo ammortamento macchinari 40/003 fondo amm.to fabbricati 40/004 fondo amm.to attrezz. comm.li 40/005 fondo amm.to arredamento
44/000 RIMANENZE 44/001 rimanenze di prodotti finiti
45/000 CREDITI COMMERCIALI 45/001 crediti verso clienti
45/001/1 crediti vs Comune di Torino 45/002 clienti c/spese anticipate 45/003 crediti insoluti 45/004 fondo svalutazione crediti 45/005 cambiali attive 45/006 fondo rischi su crediti 45/007 fatture da emettere
10/000 CREDITI DIVERSI 10/001 IVA a credito 10/002 carburanti c/anticipi 10/003 anticipi a fornitori 10/004 erario c/ritenute subite
20/000 DISPONIBILITA' LIQUIDE 20/001 banca X c/c
20/001/1 banca mediolanum c/c 20/001/2 Unicredit Banca c/c 20/002 cassa
21/000 RATEI E RISCONTI ATTIVI 21/001 risconti attivi
30/000 CONTI DEI SISTEMI MINORI 30/001 macchinari della società Alfa in leasing 30/002 società Alfa c/macchinari in leasing
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
31/000 PATRIMONIO NETTO 31/001 utile d'esercizio 31/002 perdita d'esercizio
11/000 FONDO PER RISCHI E ONERI 11/001 fondo rischi di garanzia
12/000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

19
12/001 TFR
13/000 DEBITI FINANZIARI 13/001 mutui passivi
14/000 DEBITI COMMERCIALI 14/001 debiti verso fornitori
14/001/1 debiti vs Avvoc. Normanni 14/001/2 debiti vs Notai Gas - Plasma 14/001/3 debiti vs Consul. Lavoro Transi.To. 14/002 fatture da ricevere 14/003 debiti vs fornitori esteri
15/000 DEBITI DIVERSI 15/001 IVA a debito 15/002 erario c/ritenute su redditi di lavoro autonomo 15/003 anticipi da clienti 15/004 erario c/IVA 15/005 dipendenti c/retribuzioni 15/006 INPS 15/007 erario c/ritenute su redditi di lavoro dipendente 15/008 debiti tributari 15/009 collaboratori c/compensi 15/010 er. c/rit. su redd. assimil. lav. dip. 15/011 IVA a deb. ad esigib. differita 15/012 Unicredit Banca c/cambiali all'incasso 15/013 Unicredit c/inter. pass. da liquidare
16/000 RATEI E RISCONTI PASSIVI 16/001 ratei passivi
CONTO ECONOMICO
49/000 VALORE DELLA PRODUZIONE 49/001 prodotti finiti c/vendite 49/002 rimborso spese 49/003 resi su vendite 49/004 merci c/vendite 49/005 incremento macchinari per lavori interni 49/006 variazione rimanenze di prodotti finiti
51/000 COSTI DELLE MATERIE 51/001 merci c/ acquisti 51/002 materie c/ acquisti 51/005 resi su acquisti
52/000 COSTI PER SERVIZI 52/001 spese postali 52/002 assicurazioni 52/003 spese di energia elettrica 52/004 spese telefoniche 52/005 consulenze fiscali 52/006 carburanti 52/007 spese di trasporto 52/008 oneri bancari

20
52/009 consulenze legali 52/010 consulenze notarili 52/011 imposta di bollo 52/012 costi elaborazione buste paga 52/013 consulenze lavoro 52/014 commissioni bancarie
53/000 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 53/001 fitti passivi 53/002 canoni di leasing
54/000 COSTI PER IL PERSONALE 54/001 salari e stipendi 54/002 oneri sociali 54/003 dipend. c/arrotondamenti 54/004 compensi a collaboratori a progetto
55/000 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 55/001 ammortamento macchinari 55/002 ammortamento fabbricati 55/003 amm.to attrezzature comm.li 55/004 amm.to arredamento
57/000 ACCANTONAMENTI 57/001 accantonamento TFR 57/002 accantonamento rischi di garanzia
56/000 SVALUTAZIONI 56/001 svalutazione crediti
58/000 ONERI DIVERSI 58/001 perdite su crediti
59/000 PROVENTI FINANZIARI 59/001 interessi attivi di mora 59/002 interessi attivi bancari
60/000 ONERI FINANZIARI 60/001 interessi passivi bancari 60/002 interessi passivi su mutui
70/000 PROVENTI STRAORDINARI 70/001 Plusvalenze (da alienazione)
71/000 ONERI STRAORDINARI 71/001 Sopravvenienze passive
72/000 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 72/001 imposte sul reddito
73/000 CONTI DI RISULTATO 73/001 conto economico

21
3. Strutture contabili delle operazioni aziendali di base Si riportano qui di seguito le strutture delle operazioni aziendali di base:
- acquisto di beni o servizi; - pagamento; - vendita di beni o servizi; - incasso.
3.1 Struttura contabile dell’operazione di acquisto Un’operazione di acquisto (sia di beni che di servizi) genera:
- sotto l’aspetto numerario, un sorgere di debito verso il fornitore (in quanto generalmente si tende a pagare in modo dilazionato): secondo lo schema di funzionamento della P.D. (si veda il paragrafo 1 del capitolo 2) tale variazione va registrata in Avere. Se si consulta un piano dei conti (si veda il paragrafo 2 del capitolo 2), sotto la categoria “debiti commerciali” generalmente si trova “debiti verso fornitori”. Questo è il conto che va usato. Nella realtà aziendale verrà impiegato un conto specifico: “debito verso Tizio”, cioè un conto intestato al singolo fornitore;
- sotto l’aspetto economico, un sorgere di costo dovuto all’acquisto di beni o servizi: tale variazione va registrata in Dare. Il conto da usare dipende da cosa l’azienda ha acquistato. In generale, sotto la categoria “costi delle materie” (nel piano dei conti) si trova “materie prime conto acquisti”, che può essere usato se, appunto, si tratta di un acquisto di materie prime; altrimenti potrebbe essere usato il conto, situato sotto la stessa categoria, denominato “materiali di consumo c/acquisti”, se si è trattato di un acquisto, ad es. di un toner per stampante. Se invece si tratta dell’acquisto di un servizio, è opportuno cercare sotto la categoria “costi per servizi”: qui si trova ad es. “costi telefonici” (per contabilizzare la bolletta telefonica) oppure “costi di trasporto” (per il servizio fornito dalla DHL) o anche “consulenze” (per il servizio fornito dal commercialista, o dall’avvocato o anche dal consulente del lavoro);
- sotto l’aspetto fiscale (che in generale rientra nell’aspetto numerario, trattandosi di un credito o debito nei confronti dello Stato), un sorgere di credito verso lo Stato, dovuto all’IVA: tale variazione va registrata in Dare. Il conto da utilizzare, generalmente localizzato all’interno della categoria “crediti diversi” o della più specifica “crediti verso Erario”, è IVA a credito.
3.2 Struttura contabile dell’operazione di pagamento In linea di massima, un’operazione di pagamento comporta:
- una estinzione (se il pagamento è pari all’importo dell’intero debito) oppure una riduzione (se il pagamento è parziale) di un debito verso fornitori, sorto in precedenza. Tale variazione numeraria va collocata in Dare del conto debiti verso fornitori;
- un’uscita di denaro, dovuta al pagamento (sia parziale che totale) del debito. Tale variazione numeraria va collocata in Avere del conto cassa (se si paga in

22
contanti) oppure banca X c/c (se si paga tramite bonifico bancario, oppure assegno bancario o anche assegno circolare).
3.3 Struttura contabile dell’operazione di vendita In linea di massima, un’operazione di vendita comporta:
- il sorgere di un credito nei confronti del cliente, al quale l’azienda ha venduto dei prodotti finiti, pattuendo un regolamento dilazionato. Tale variazione numeraria va registrata in Dare del conto crediti verso clienti;
- il sorgere di un ricavo, dovuto alla vendita dei prodotti, fatturati dall’azienda venditrice. Tale componente positivo di reddito va registrato in Avere del conto prodotti finiti c/vendite;
- il sorgere di un debito verso lo Stato, in quanto l’azienda venditrice incassa l’IVA dal cliente, ma diventa debitrice di IVA nei confronti dell’erario. Tale variazione numeraria va registrata in Avere del conto IVA a debito.
3.4 Struttura contabile dell’operazione di incasso In linea di massima, un’operazione di incasso comporta:
- una estinzione (se l’incasso è pari all’importo dell’intero credito) oppure una riduzione (se l’incasso è parziale) di un credito verso clienti, sorto in precedenza. Tale variazione numeraria va collocata in Avere del conto crediti verso clienti;
- un’entrata di denaro, dovuta all’incasso (sia parziale che totale) del credito. Tale variazione numeraria va collocata in Dare del conto cassa (se si incassa in contanti) oppure banca X c/c (se si incassa tramite bonifico bancario, oppure assegno bancario o anche assegno circolare).
4. Schema di sintesi delle scritture contabili di rettifica RETTIFICHE DI CHIUSURA Quote di costi e quote di ricavi : Ratei attivi e passivi
Rettifiche di imputazione
Costi e ricavi : Partite da liquidare TFR Imposte sul reddito Quote di costi e quote di ricavi : Risconti attivi e passivi
Rettifiche di storno Costi e ricavi : Capitalizzazione di costi Variazione rimanenze Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali
Rettifiche di valore di Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali elementi patrimoniali Svalutazione di partecipazioni e titoli a reddito fisso
attivi Svalutazione di crediti Rischi di garanzia e rischi di collaudo
Accantonamenti Rischi su cambi per rischi e oneri Operazioni e concorsi a premio
Manutenzione Tabella 1 - Schema di sintesi delle rettifiche di chiusura

23
5. Schema per la realizzazione di un caso completo di contabilità generale: dalle scritture contabili d’esercizio al bilancio
Si propone qui di seguito uno schema che comprende le fasi contabili tipiche di un anno di lavoro all’interno dell’ufficio amministrativo di un’impresa in regime di contabilità ordinaria:
- scritture contabili d’esercizio (dall’1/1 al 31/12); - primo bilancio di verifica (non comprende le scritture di rettifica); - scritture contabili di rettifica al 31/12 (schema paragrafo 4); - secondo bilancio di verifica (comprende le scritture di rettifica); - scritture contabili di chiusura dei conti:
• chiusura costi; • chiusura ricavi; • determinazione dell’utile o della perdita d’esercizio; • chiusura attività; • chiusura passività.
- bilancio d’esercizio: • conto economico; • stato patrimoniale; • nota integrativa.
- riapertura dei conti: • riapertura attività; • riapertura passività; • eventuali scritture contabili di riapertura richieste.
5.1 Procedura di redazione della bozza di bilancio Si ha a disposizione una situazione contabile, cioè un elenco di conti (spesso in ordine alfabetico) con i relativi saldi, collocati in Dare oppure in Avere. Occorre prima di tutto codificare tutti i conti nel modo seguente:
- C = Costo; - R = Ricavo; - A = Attività; - P = Passività o Patrimonio Netto
facendo attenzione: - ai conti d’ordine, che vanno collocati in Stato patrimoniale, ma sotto la riga
del totale attività e sotto quella del totale passività; - alla seguente regola:
• conti con saldo Dare = costi o attività; • conti con saldo Avere = ricavi o passività (o conti del Patrimonio
Netto). La bozza di bilancio comprende:
- la bozza di conto economico; - la bozza di stato patrimoniale.

24
La bozza di conto economico ha la seguente forma:
CONTO ECONOMICOCOSTI RICAVI
All’interno della bozza di conto economico occorre inserire tutti i costi (nella sezione di sinistra) e tutti i ricavi (nella sezione di destra). Fatto ciò, è possibile:
- calcolare la somma dei costi e quella dei ricavi, ed iscriverle nelle rispettive sezioni della bozza di conto economico;
- calcolare la differenza fra totale ricavi e totale costi: • se il totale dei ricavi supera il totale dei costi, la differenza è l’utile
d’esercizio; • se il totale dei ricavi è inferiore al totale dei costi, la differenza è la
perdita d’esercizio. A questo punto è possibile ottenere una delle due seguenti quadrature contabili. In caso di utile d’esercizio:
CONTO ECONOMICO COSTI RICAVI
Totale costi più utile d'esercizio Totale ricavi
Totale a pareggio Totale ricavi In caso di perdita d’esercizio:
CONTO ECONOMICO COSTI RICAVI
Totale costi Totale ricavi più perdita
d'esercizio Totale costi Totale a pareggio
Terminata la bozza di conto economico, è possibile elaborare la bozza di stato patrimoniale, che assume la seguente forma:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' PASSIVITA' E PATRIMONIO
NETTO Conti dell'attivo Conti del passivo e del P.N. Totale attività Totale passività e P.N. Conti d'ordine Conti d'ordine
Occorre quindi inserire nella bozza di stato patrimoniale, ciascuno nella sezione di appartenenza:
- i conti dell’attivo; - i conti del passivo; - i conti del patrimonio netto;

25
- l’utile netto con il segno positivo fra le “passività e p.n.”, oppure – sempre fra le passività e p.n. – la perdita d’esercizio con il segno negativo (il meno).
A questo punto è possibile:
- verificare che il totale delle attività meno il totale delle passività sia proprio pari all’utile;
- ottenere la quadratura contabile fra: • totale attività; • totale passività e patrimonio netto (compreso l’utile o la perdita).
La bozza di bilancio è terminata. È possibile passare ora alla redazione del bilancio d’esercizio civilistico definitivo. 5.2 Procedura di redazione del bilancio definitivo Occorre prendere – dalla bozza di stato patrimoniale – tutte le attività, le passività e i conti del patrimonio netto per collocarle nello schema di stato patrimoniale civilistico (si veda il paragrafo 7), tenendo presente che:
- le immobilizzazioni dotate di fondo ammortamento (ad es. macchinari, attrezzature e simili) devono essere iscritte come: costo storico meno fondo ammortamento;
- i crediti verso clienti vanno iscritti al netto del relativo fondo svalutazione crediti;
- le partecipazioni vanno iscritte al netto del fondo svalutazione partecipazioni; - in conseguenza di quanto sopra scritto, fra le passività dello stato patrimoniale
civilistico, non saranno compresi né i fondi ammortamento, né i fondi svalutazione (sia crediti che partecipazioni);
- tra i debiti, se non ci sono indicazioni specifiche, si intende che essi sono a breve termine, cioè scadranno entro 12 mesi. Se invece esistono debiti a lungo termine (con scadenza quindi oltre 12 mesi), occorre distinguerli da quelli a breve termine.
Fatto ciò, è necessario verificare che:
- l’utile d’esercizio risultante dallo stato patrimoniale civilistico sia pari a quello iscritto nella bozza di stato patrimoniale;
- nello stato patrimoniale civilistico si ottenga la quadratura fra totale attività e totale passività (ma i totali non saranno identici a quelli ottenuti nella bozza di stato patrimoniale).
Terminata la redazione dello stato patrimoniale civilistico, è possibile passare al conto economico definitivo. A tal fine occorre prendere i conti dalla bozza di conto economico e collocarli nello schema di conto economico civilistico (si veda il paragrafo 6), tenendo presente che:
- le “variazioni rimanenze” di materie prime vanno collocate fra i costi della produzione [ B) 11) ], mentre quelle di prodotti finiti vanno inserite nel valore della produzione [ A) 2) ];

26
- se, nel secondo bilancio di verifica, la variazione rimanenze ha saldo Dare, essa è un costo; se invece ha saldo Avere, essa è un ricavo;
- variazione rimanenze va collocata nel conto economico civilistico a seconda del segno. A tal proposito si ricorda che la “scatola A)”, cioè il valore della produzione, è un contenitore di ricavi; invece la “scatola B)”, cioè i costi della produzione, è un contenitore di costi. Di conseguenza:
• se la variazione rimanenze di materie prime è un costo, va in B) 11) senza alcun segno algebrico; se è un ricavo, va in B) 11) con segno negativo (in quanto si tratta di un ricavo che va a diminuire i costi);
• se la variazione rimanenze di prodotti finiti è un costo, va in A) 2) con il segno negativo (in quanto si tratta di un costo che va a ridurre i ricavi); se è un ricavo, va in A) 2) senza alcun segno algebrico.
- i “costi per servizi” [ B) 7) ] sono ad esempio le bollette Telecom, Aem, Italgas, le spese di manutenzione e di assicurazione e simili;
- i “costi per godimento beni di terzi” [ B) 8) ] sono ad esempio i canoni di leasing e gli affitti passivi;
- non bisogna confondere il conto “TFR” oppure “Fondo TFR” con saldo avere, che rappresenta il debito per trattamento di fine rapporto (e va collocato fra le passività dello stato patrimoniale) con il conto “Accantonamento TFR” che ha saldo Dare e rappresenta la quota di costo di TFR maturata nell’anno [e va inserita nel conto economico in posizione B) 9) c) ];
- gli interessi passivi su mutui e su conti correnti bancari vanno inseriti in posizione C) 17), mentre gli interessi attivi devono essere collocati in C) 16) nell’ulteriore sottocategoria di appartenenza. I dividendi vanno invece in C) 15);
- le plusvalenze da alienazione cespiti vanno in E) 20), mentre le minusvalenze da alienazione cespiti vanno in E) 21).
Fatto ciò, occorre verificare che l’utile ottenuto dal conto economico civilistico sia pari a quello ottenuto dalla bozza di conto economico.

27
6. Il conto economico cifre parziali cifre totali cifre totali CONTO ECONOMICO esercizio in esercizio in esercizio corso corso precedenteA) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) Per servizi 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali. c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. 12) Accantonamenti per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione Totale costi di produzione Differenza fra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni, che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese

28
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
17-bis) Utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + o - 17-bis) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni
19) Svalutazioni a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)
21) Oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) Risultato prima delle imposte (A - B + o - C + o - D + o - E) 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate. 23) Utile (perdita) dell'esercizio

29
7. Lo stato patrimoniale cifre parziali cifre totali cifre totali STATO PATRIMONIALE - ATTIVO esercizio in esercizio in esercizio corso corso precedenteA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria. I - Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili. 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre Totale II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati meno fondi di ammortamento. 2) Impianti e macchinario meno fondi di ammortamento. 3) Attrezzature industriali e commerciali meno fondi di ammortamento. 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese meno fondo svalutazione partecipazioni 2) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri 3) Altri titoli 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

30
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati. 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti Totale II – Crediti (*) 1) Verso clienti meno fondo svalutazione crediti 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 4-bis) crediti tributari 4-ter) imposte anticipate 5) Verso altri Totale III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. 6) Altri titoli Totale IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa Totale Totale Attivo circolante D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Ratei attivi Risconti attivi Totale Attivo (*) con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.

31
cifre parziali cifre totali cifre totali STATO PATRIMONIALE - PASSIVO esercizio in esercizio in esercizio corso corso precedenteA) Patrimonio netto I. Capitale II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserve di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) d'esercizio Totale B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili. 2) Fondi per imposte, anche differite 3) Altri Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti (*) 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti versi banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale. 14) Altri debiti Totale E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Ratei passivi Risconti passivi Totale passivo e netto (*) con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.

32
8. La nota integrativa La nota integrativa è parte integrante del bilancio e concorre a conseguire l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Infatti lo stato patrimoniale e il conto economico hanno una forma quantitativo – tabellare, in quanto sono composti essenzialmente da tabelle di numeri, mentre invece la nota integrativa ha una forma qualitativo – descrittiva, poiché è composta da informazioni che integrano i due prospetti di bilancio. La nota integrativa è disciplinata:
- dall’art. 2427 cod. civ., che ne stabilisce il contenuto; - da altri articoli del codice civile che contengono prescrizioni atte a completare
le richieste di informazioni (artt. 2361, 2423, 2423 bis, 2424, 2426); - dalla legge 72/1983; - dal D.Lgs 127/1991 (bilancio consolidato); - D.Lgs 6/2003 (riforma diritto societario); - D.Lgs 344/2003 (riforma sull’imposizione del reddito delle società); - Dalla normativa fiscale in riferimento alle categorie di riserva e di fondi aventi
analoga natura. Sotto il profilo del contenuto, la nota integrativa si compone di:
- considerazioni descrittive relative a metodologie applicate nella redazione del bilancio e nei metodi di valutazione;
- elencazioni analitiche di voci componenti singoli conti di bilancio; - prospetti dimostrativi di movimenti relativi alle voci di bilancio, patrimoniali
ed economiche. Gli argomenti specificati dalla nota integrativa possono essere riuniti in alcuni gruppi omogenei, di ciascuno dei quali si riportano i principali elementi:
- informazioni sulle valutazioni e sui principi di redazione del bilancio: • criteri di conversione di valori di bilancio non in euro; • modifiche ai criteri di ammortamento delle immobilizzazioni; • deroghe a norme specifiche di legge per rispettare la
rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale; • modifiche nei criteri di valutazione delle voci di bilancio.
- informazioni sui contenuti e sulla classificazione delle voci: • composizione costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo,
pubblicità; • delle voci del patrimonio netto: origine, possibilità di utilizzazione,
avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti; • deroghe ai principi di classificazione delle voci di bilancio.
- informazioni sulle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria: • movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni; • variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e
del passivo. - informazioni sulla gestione finanziaria:

33
• ammontare debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni; • impegni non risultanti dallo stato patrimoniale • strumenti finanziari diversi da azioni ed obbligazioni; • finanziamenti effettuati dai soci.
- informazioni sulle partecipazioni in altre società: • elenco delle partecipazioni; • ragioni dell’esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato; • sintesi del bilancio della società dalla quale si viene diretti e
coordinati. - informazioni atte ad ampliare le conoscenze sulla situazione economica:
• numero medio di dipendenti; • compensi spettanti ad amministratori e sindaci; • operazioni di locazione finanziaria; • riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali.
- informazioni sui titoli emessi dalla società: • azioni ordinarie; • azioni di godimento.
- informazioni richieste dalla Legge 72/1983 (in merito alla rivalutazione monetaria dei beni;
- informazioni richieste dal D.Lgs 344/2003 (sul trattamento fiscale di riserve e fondi simili a riserve).
9. Quiz sul capitolo II
1) La nota integrativa: a) è parte integrante del bilancio b) non è obbligatoria c) contiene dettagli sui costi e sui ricavi
2) Lo stato patrimoniale:
a) è uno schema libero b) è uno schema a sezioni contrapposte c) è uno schema in forma scalare
3) Il conto economico contiene:
a) attività e passività b) attività e ricavi c) costi e ricavi
4) La bozza di bilancio:
a) è obbligatoria per legge b) è un passaggio utile, ma non necessario per giungere al bilancio c) è un passaggio tecnico della procedura di bilancio

34
5) Il bilancio d’esercizio è composto da: a) conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa b) conto economico e stato patrimoniale c) conto economico, stato patrimoniale e bozza di bilancio
6) Le scritture di rettifica:
a) servono per rettificare errori commessi nelle scritture contabili b) sono originate da una variazione numeraria c) sono originate da una variazione economica
7) Partita Doppia significa:
a) rilevare ogni evento aziendale due volte b) rilevare gli eventi aziendali una sola volta sotto due aspetti: quello numerario
e quello economico c) che il bilancio è doppio: conto economico più stato patrimoniale
8) Un rateo passivo è:
a) una rettifica di imputazione di costo b) una rettifica di storno di quota di costi c) una rettifica di imputazione di una quota di costi
9) L’ammortamento dei macchinari:
a) è una rettifica di valore di elementi patrimoniali attivi b) è una rettifica di storno di una quota di costi c) è una rettifica di accantonamento per rischi e oneri
10) Una variazione economica è:
a) una variazione di cassa, banca, crediti, debiti b) una variazione di costi o di ricavi c) una variazione di conti di reddito, di capitale, pluriennali

35
PARTE SECONDA: PRATICA Capitolo III – Registrazione contabile di documenti aziendali Questo capitolo contiene applicazioni pratiche svolte inerenti la registrazione contabile di alcuni – significativi – documenti aziendali. Il lettore “apprendista contabile” potrà vedere i documenti riportati (che sono veri e modificati soltanto nei dati sensibili) e seguire – grazie alla struttura teorica fornita nel primo capitolo – il ragionamento per effettuarne la corretta registrazione in contabilità. Ciò è proprio quanto viene richiesto al neo-assunto in contabilità: innanzitutto saper distinguere, fra i documenti aziendali, quali vanno registrati in contabilità (quelli che generano una variazione di cassa, banca, crediti o debiti) e quali invece sono irrilevanti; successivamente, applicare correttamente il metodo della Partita Doppia (descritto nel primo capitolo, a partire dal paragrafo 3.2) per pervenire alla registrazione contabile degli stessi. I casi svolti che verranno esaminati nei prossimi paragrafi sono:
- ricevuta del versamento postale di un premio assicurativo; - parcella di un avvocato non soggetto a ritenuta d’acconto; - parcella di un notaio soggetto a ritenuta d’acconto; - fattura di una società di consulenza del lavoro; - prospetto contabilizzazione retribuzioni dipendenti inviato dal consulente del
lavoro; - prospetto contabilizzazione retribuzioni collaboratori a progetto, inviato dal
consulente del lavoro.
1. Ricevuta del versamento postale di un premio assicurativo In data 11/01/2010 la Big Bang S.r.l. ha pagato – tramite bollettino postale (con addebito quindi di 1,10 euro di spese postali) – il premio assicurativo semestrale per l’autovettura aziendale, pari a 405 euro. Antonio Zappa, apprendista contabile della Big Bang S.r.l., trova sulla sua scrivania la ricevuta di versamento postale sotto riportata (si veda la pagina seguente).

36
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento - Banco Posta sul C/C n. 63985501 di Euro 405,00 intestato a: ASSICURANDOLA S.P.A. Viale delle stelle, 3 20154 MILANO eseguito da: BIG BANG S.R.L. Via dell'Universo, 27 10131 TORINO causale: Contratto n. 288634427 11/01/2010 Autovettura targata CT452EL euro 405,00 Periodo di copertura: euro 1,10 dalle ore 24:00 del 13/01/2010 alle ore 24:00 del 13/07/2010 Il premio è stato pagato il (vedi timbro postale) Bollo dell'uff. postale Poste
Il suo ragionamento è il seguente: “Se questo bollettino è stato depositato sulla mia scrivania significa che probabilmente devo occuparmene, ma potrebbe anche trattarsi di un errore. Un bollettino pagato significa che c’è stata un’uscita di cassa, quindi, dato che qualunque fatto che generi una variazione di cassa, banca, crediti o debiti va contabilizzato, allora anche questo bollettino deve essere registrato in contabilità. Però potrei benissimo averlo già registrato e poi magari mi sono dimenticato di archiviare il documento giustificativo (cioè il bollettino). Considerando quante volte vengo interrotto mentre lavoro, magari…”. Antonio fa un controllo sul software di contabilità, richiamando il conto “Assicurazioni”, per verificare quando è stato movimentato l’ultima volta. Scopre che la registrazione contabile non è ancora stata effettuata. Quindi comincia a ragionare sul come va fatta la registrazione: “Devo partire dall’aspetto numerario, cioè cassa, banca, crediti o debiti. La cassa ! Si è verificata un’uscita di cassa per l’ammontare del premio di 405 euro, no, c’è 1,10 euro di spese postali, quindi l’uscita di cassa ammonta a 406,10 euro”. Successivamente Antonio fissa lo sguardo su un post-it attaccato al monitor del computer, il cui titolo è “schema di funzionamento del metodo della Partita Doppia” (si veda il primo paragrafo del secondo capitolo) ed esclama: “Uscita di cassa: Avere !”. Poi cerca un’ispirazione per la contropartita contabile, in quanto riflette che una scrittura in P.D. deve esporre un totale Dare pari al totale Avere. Attualmente ha trovato soltanto un Avere da 406,10 euro da collocare sotto il conto “Cassa”. Dal post-it legge “sorgere di costi” e capisce quindi come chiudere la scrittura contabile. “L’assicurazione è un costo e le spese postali pure, quindi si tratta di un sorgere di costo che va collocato in Dare”. A questo punto conclude il suo lavoro inserendo nel software la seguente scrittura in P.D.:

37
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
11/01/10 20/002 cassa 406,10 52/002 assicurazioni 405
52/001 spese postali 1,10 2. Parcella di un avvocato non soggetto a ritenuta d’acconto Il 12 marzo 2010 Antonio Zappa giunge in ufficio alle 9:00 anziché alle 8:30 ed entra imprecando contro il traffico anziché salutando i colleghi. È piuttosto preoccupato per il solito sovraccarico di lavoro da cui presto sarà sommerso, perché il 16 del mese è vicino e le scadenze fiscali incombono. Non sono ammessi ritardi, né errori: il titolare della Big Bang non ha alcuna intenzione di pagare multe o interessi di mora. Mentre il suo sguardo viene attratto da una busta chiusa sulla sua scrivania, Antonio pensa che il 13 e il 14 marzo cadono di sabato e domenica, quindi ha due giorni in meno per sbrigare tutte le scadenze. Accende il computer e – nell’attesa – legge, sull’esterno della busta chiusa, “Giovanna Santorini Normanni – Avvocato” e – scritto a matita da qualche collega – “guarda che è stata già pagata”. Non ha mai sentito quel nome, ma di avvocati la Big Bang ne assolda spesso perché ha un certo numero di clienti che tendono a non pagare le fatture. “Sarà la solita parcella di un professionista, dovrò registrare la fattura e poi il pagamento, trattenendo il solito 20% a titolo di ritenuta d’acconto” pensa Antonio. Una volta aperta la busta, legge quanto sotto riportato.
Giovanna Santorini Normanni AVVOCATO Via Tesla, 1 10141 TORINO (ITALIA) Tel.: +39.011484550 Fax: +39.011484580 [email protected] Torino, 5 marzo 2010 Spett.le BIG BANG S.r.l. Via dell' Universo, 27 10131 TORINO P.IVA 08024250016 Fattura n. 6 Oggetto: spese assistenza legale per recupero crediti Diritti ed onorari euro 400,00C.P.A. 2% euro 8,00I.V.A. 20% euro 81,6TOTALE A SUO DARE 489,60 La sottoscritta, Avv. Giovanna Santorini Normanni, dichiara che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto. P.I. 09233700031 C.F. NRNGVS70P52L219O

38
Mentre legge, dà un’occhiata al post-it sul monitor del pc, per capire come effettuare la registrazione contabile. “Sicuramente”, pensa “occorre contabilizzare: il ricevimento di una fattura – finché non viene pagata – comporta il sorgere di un debito. Inoltre questa è stata anche pagata, dunque deve essersi verificata una diminuzione di cassa, o – più probabilmente – una riduzione del conto corrente bancario”. Antonio ha individuato le due variazioni numerarie che originano le due scritture contabili da effettuare: sorgere di debiti in Avere e uscita di cassa o banca in Avere. Carica nel programma quindi la prima scrittura contabile, realizzando che la contropartita del sorgere del debito verso l’avvocato Normanni non può che essere un sorgere di costi, in quanto le consulenze legali non sono altro che costi. Si ferma un istante sulle cifre della fattura, ma subito capisce che gli 8 euro sono il contributo della Big Bang alla pensione della Normanni e che quindi, per la Big Bang, sono semplicemente un costo. L’IVA (che è un sorgere di credito e va quindi collocata in Dare) è evidentemente calcolata nella misura del 20% di 408 euro e quindi il totale da pagare è 489,60 euro. “Cosa significa totale a suo dare ?” si domanda Antonio. “Dovrebbe essere totale a suo debito, che in Partita Doppia corrisponde all’Avere non al Dare ! Evidentemente gli avvocati non conoscono il significato del Dare e dell’Avere, credono che Dare significhi dare qualcosa. Il Dare e l’Avere hanno significati precisi, nel senso matematico del termine”. Antonio non può far altro che guardare ancora una volta quel post-it, così chiaro nel definire le due sezioni opposte della contabilità. Pensa poi a Luca Pacioli, il frate matematico inventore della Partita Doppia e dai più dimenticato, a tal punto da non essere nemmeno citato nelle enciclopedie di economia. Ecco quindi la prima scrittura contabile:
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
12/03/10 14/001/1 debiti vs Avvoc. Normanni 489,6 52/009 consulenze legali 408 10/001 IVA a credito 81,6
“Ora devo registrare il pagamento della parcella: sicuramente occorre considerare un’uscita di cassa da collocare in Avere ed una diminuzione di debito da collocare in Dare” pensa Antonio. Prima di procedere egli verifica quale modalità di pagamento sia stata scelta, scoprendo che quella mattina alle 8:45 è stato fatto un bonifico bancario tramite remote-banking a favore dell’Avvocato Normanni. Inoltre chiede alla propria responsabile amministrativa come mai a tale soggetto non debba applicarsi la ritenuta fiscale d’acconto. Gli viene spiegato che l’avvocato in questione gode di un regime fiscale agevolato, secondo il quale non è tenuto a pagare l’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) in acconto in quanto – in sostituzione dell’IRPEF – verserà, in sede di dichiarazione dei redditi, una ridotta imposta sostitutiva. A questo punto Antonio procede con la seconda scrittura contabile:
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
12/03/10 14/001/1 debiti vs Avvoc. Normanni 489,6 20/001/1 banca mediolanum c/c 489,6

39
3. Parcella di un notaio soggetto a ritenuta d’acconto È la mattina del 10 maggio 2010 ed Antonio Zappa non può apprezzare l’esplosione primaverile che lo circonda. Non tanto perché è in ufficio, piuttosto perché è allergico al polline e – per il suo tipo di allergia – maggio è il mese peggiore. Tuttavia, è ben consapevole di essere pagato per fare il contabile, dunque si mette al lavoro. Dalla sua cartellina “Lavoro da fare” estrae la fattura dello studio notarile Gas – Plasma (sotto riportata) e si mette a leggere.
STUDIO NOTARILE Geronimo Gas - Gioacchino Plasma - Notai associati P.IVA 09035240016 Via Perseidi n. 5 10189 TORINO Tel.: 011.5615181 - 011.5349110 Spett.le BIG BANG S.r.l. Via dell' Universo, 27 10131 TORINO P.IVA 08024250016 Fattura n. 629 del 4 maggio 2010 Oggetto: estratto dal libro Giornale di Contabilità Generale (pag. 110/2009) Anticipazioni (art. 15 n. 3 - DPR 633/72) - Bolli (non imponibili) euro 14,62Onorari, compensi ed altre spese soggette ad IVA euro 50,00I.V.A. 20% su onorari euro 10Totale fattura 74,62Detratta ritenuta d'acconto (20% su onorari) euro 10,00Totale a Vostro debito euro 64,62 N.B.: La ritenuta d'acconto dovrà essere versata all'esattoria nella cui circoscrizione trovasi il soggetto che esegue la ritenuta. Al Notaio dovrà poi essere trasmessa l'attestazione del versamento. Codice IBAN: IT37B0102001004000000305281
Non sa se sia stata pagata, ma prova a ragionarci. “Qui c’è scritto fattura, dunque non si tratta di una proposta di parcella ma di una fattura definitiva. I professionisti generalmente inviano la fattura definitiva solo dopo aver ricevuto il proprio compenso. Dunque questa fattura è stata pagata”. Un controllo dei movimenti on-line del conto corrente di Big Bang presso Banca Mediolanum fornisce ad Antonio la certezza della sua deduzione (oltre ad un improvviso spunto di riflessione: un notaio guadagna certo più di lui, e comunque molto per poter rientrare in qualunque regime fiscale agevolato, di conseguenza sarà necessariamente soggetto alla ritenuta d’acconto). “L’aspetto numerario, che origina la prima scrittura contabile – relativa al ricevimento della fattura – è un sorgere di debito verso i Notai Gas – Plasma” pensa Antonio “quindi un Avere pari a 74,62 euro. La contropartita è un sorgere di costo: 50 euro di consulenze notarili e 14,62 di imposta di bollo. Infine devo considerare un sorgere di credito verso lo stato: l’IVA di 10 euro”.

40
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
10/05/10 14/001/2 debiti vs Notai Gas - Plasma 74,62 52/010 consulenze notarili 50 52/011 imposta di bollo 14,62 10/001 IVA a credito 10
“A questo punto posso procedere con la registrazione contabile del pagamento” riflette Antonio “parto da una diminuzione di debito verso i Gas Plasma, un Dare di 74,62. Poi…. l’uscita di banca, in Avere, ma non per 74,62 perché la cifra pagata è solo 64,62, i restanti 10 euro sono la ritenuta d’acconto, che andrà versata…. il 16 giugno. Ma intanto sorge necessariamente un debito verso lo Stato, in Avere, per l’impegno di pagamento della ritenuta stessa”.
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
10/05/10 14/001/2 debiti vs Notai Gas - Plasma 74,62 15/002 erario c/ritenute su redditi di lavoro autonomo 10 20/001/1 banca mediolanum c/c 64,62
4. Fattura di una società di consulenza del lavoro Sono le 11 di lunedì 5 luglio dell’anno di grazia 2010 ed Antonio fa sempre il contabile per la Big Bang S.r.l.. Dunque è sempre nel suo ufficio, perché non sopporta i colleghi al punto da evitare qualunque interazione verbale (e non verbale) che non sia strettamente necessaria per lavoro. Non ha quindi alcuna intenzione di alzarsi, nemmeno per un caffè. Come ogni anno, anche questo inizio del mese è splendidamente soleggiato ed Antonio pensa che sarebbe davvero magnifico fare le vacanze a luglio: finalmente potrebbe spendere meno e fare meno code. Ma sa benissimo che si tratta di un sogno impossibile, almeno finché farà il contabile per una piccola ditta. Occorre infatti provvedere alle scadenze fiscali di metà mese, di qualunque metà mese, quindi anche quelle del 16 agosto, di conseguenza lui dovrà fare l’impossibile per poter concludere tutto entro il 5 o 6 agosto. Anche quest’anno partirà insieme ad una massa biblica di vacanzieri. “L’ennesima fattura da registrare” esclama Antonio “ma quante ne avrò registrate da quando sono stato assunto ? … Si tratta del consulente del lavoro, quindi libero professionista e dunque ritenuta d’acconto… No, è una S.a.S., Società in Accomandita Semplice, allora è una normalissima fattura” (si veda il documento nella pagina seguente).

41
TRANSI.TO. - S.A.S. di Transicci L. & C. Elaborazione dati aziendali Corso Newton, 2 10171 TORINO Tel.: (011) 515669 - 521893 Fax: (011) 5658889 [email protected] Spett.le BIG BANG S.r.l. Via dell' Universo, 27 10131 TORINO P.IVA 08024250016 Fattura n. 141 del 29 giugno 2010 Oggetto: elaborazione cedolini e consulenza TOTALE Prestazioni Spese Elaborazione n. 10 cedolini paga mese di maggio 2010 450,00 Elaborazione n. 5 cedolini collaboratori a progetto 150,00 Consulenza: 400,00 32,00- Verifica inquadramento soci - Ipotesi di lordo / netto / costo - Contratto di apprendistato Rimborso spese 38,50IMPONIBILE 1070,50 1000,00 70,50I.V.A. 20% 214,1 TOTALE FATTURA 1284,60 P.I. 08233800038
Poi ad Antonio sembra di sentire una delle principali ossessioni della sua responsabile amministrativa: “Devi controllare sempre le fatture ! Che contabile sei se non controlli le fatture !”. Antonio pensa che forse qualunque altro documento potrebbe essere più interessante di quella fattura o forse no, ma un buon libro di astronomia sarebbe un modo migliore per passare il tempo. Senza dubbio. Magari una lunga notte trascorsa ad osservare le stelle… “Non sono pagato per guardare le stelle, ma per caricare registrazioni in Partita Doppia, fino alle 17:30 di oggi. Alle 17:31 posso dimenticare tutto. Ci sono lavori ben peggiori” pensa. Prende in mano la fattura e verifica che i conti tornino. “La ditta ha dieci dipendenti, quindi dieci buste paga più cinque collaboratori a progetto, perfetto. Quanto ci fanno pagare a cedolino ? 45 euro per i dipendenti e 30 per ogni collaboratore, bene”. Si ricorda anche delle consulenze richieste, piuttosto care, ma tant’è. Si ricorda soprattutto del giorno in cui venne assunto: “Imparerai i codici dei conti a memoria” gli aveva detto la responsabile. “Non è possibile anche perché non serve a nulla” aveva risposto lui. Antonio conosce già parecchi codici a memoria, soprattutto quelli utilizzati più frequentemente. E ha capito che conoscerli serve. Serve a velocizzare il caricamento delle scritture contabili. Si fa più in fretta, si è più efficienti e quindi si costa meno. “Allora, ricevimento fattura: sorgere di debito, Avere. Contropartita: sorgere di costo, Dare. Distinguo i costi di elaborazione buste paga dai costi inerenti la pura consulenza. IVA: a credito, Dare” pensa. Al termine della riflessione ha già caricato la scrittura.

42
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
05/07/10 14/001/3 debiti vs Consul. Lavoro Transi.To. 1070,5 52/012 costi elaborazione buste paga 600 52/013 consulenze lavoro 470,5 10/001 IVA a credito 214,1
Poi ha caricato la scrittura relativa al pagamento, senza nemmeno pensarci. Ha la netta impressione di cominciare a lavorare come una macchina.
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
05/07/10 14/001/3 debiti vs Consul. Lavoro Transi.To. 1070,5 20/001/1 banca mediolanum c/c 1070,5
5. Prospetto contabilizzazione retribuzioni dipendenti inviato dal consulente del lavoro È la mattina del 26 luglio ed Antonio si è svegliato completamente sudato. “La giornata inizia già male…” pensa. In ufficio finalmente c’è qualcosa di più impegnativo da fare: decifrare il prospetto retribuzioni del consulente del lavoro, appena giunto via fax, e registrare in contabilità gli stipendi di luglio. Poi a fine mese ci saranno da contabilizzare i bonifici ai dipendenti e il 16 agosto bisognerà versare i contributi previdenziali all’INPS e l’IRPEF allo Stato e – naturalmente - contabilizzare il tutto. “Quest’anno voglio finire il 6 agosto, che è un venerdì” dice Antonio “mi conviene già portarmi avanti ora”. Apre quindi un nuovo file excel, che nomina “16 agosto 2010” e lascia aperto nella barra in fondo al monitor del suo pc, in modo da poter inserire informazioni e cifre mentre lavorerà sulle retribuzioni.
PROSPETTO CONTABILIZZAZIONE RETRIBUZIONI Data 26/07/10 Dipendenti C.D.C. n. 37 Periodo Luglio 2010
Ditta 6691 Big Bang S.r.l. Classificazione contabile PARZIALI DARE AVERE Contributi INPS c/dipendenti 211,08 Retribuzioni lorde (competenze) 2988,61 Debito per contrib. lordi previdenz. 716,87 Contributi lordi previdenziali 716,87 Impiegati 416,06 Apprendisti 300,81 IRPEF 1001 277,28 Arrotondamento precedente 0,97 Arrotondamento attuale 0,72 Retribuzioni c/Dipend. (netto in busta) 2500,00 TOTALI 3706,2 3706,2
“Innanzitutto questo prospetto riguarda solo i dipendenti, ciò significa che il prossimo fax riguarderà i collaboratori a progetto” ragiona Antonio ad alta voce, quasi volesse pronunciare un discorso filosofico. “No, non riguarda nemmeno tutti i dipendenti della Big

43
Bang, perché il netto complessivo di 2500 euro è troppo basso. Sì, questo è solo il centro di costo n. 37, del quale anch’io faccio parte, infatti ci sono i contributi per gli apprendisti”. Nel frattempo è giunta, tramite pony express, la busta contenente i cedolini. La prima cosa che fa Antonio è controllare il proprio stipendio, sperando in un aumento dovuto a qualunque causa, anche un rinnovo del contratto collettivo o una tantum o qualche cifra arretrata o una festività non goduta. Purtroppo la cifra è identica a quella del mese precedente (escludendo la quattordicesima che ha ricevuto insieme allo stipendio di giugno). Antonio comincia ad identificare tutte le cifre per essere certo di contabilizzarle nel modo corretto: “211,08 sono i contributi previdenziali a carico dei dipendenti; 2988,61 è il totale degli stipendi lordi; 716,87 sono i contributi previdenziali a carico della ditta, suddivisi fra quelli relativi agli impiegati e quelli inerenti gli apprendisti, minori, in quanto il contratto di apprendistato è caratterizzato da notevoli sgravi contributivi; 277,28 sono le ritenute IRPEF a carico dei dipendenti; 0,97 e 0,72 sono due arrotondamenti di segno opposto: 0,97 è un ricavo, mentre 0,72 è un costo, in realtà posso contabilizzare solo la differenza fra i due; 2500 euro è il totale degli stipendi netti”. Innanzitutto Antonio contabilizza gli stipendi lordi, pari a 2988,61 euro, che sono – per la Big Bang – un debito nei confronti dei dipendenti (sorgere di debito -> Avere: dipendenti c/retribuzioni) e un costo dal punto di vista economico (sorgere di costo -> Dare: salari e stipendi).
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
26/07/10 54/001 salari e stipendi 2988,61 15/005 dipendenti c/retribuzioni 2988,61
Poi procede con i contributi previdenziali a carico dei dipendenti, pari a 211,08 euro, che sono una diminuzione di debiti verso i dipendenti (Dare), in quanto vengono detratti dalla busta paga, e – come contropartita – un sorgere di debito della Big Bang verso l’INPS (Avere del conto INPS), poiché la ditta non tiene per sé quanto ha trattenuto, ma lo versa all’INPS.
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
26/07/10 15/005 dipendenti c/retribuzioni 211,08 15/006 INPS 211,08
Successivamente Antonio contabilizza le ritenute fiscali (IRPEF) a carico dei dipendenti, pari a 277,28 euro, che sono anch’esse una diminuzione di debito verso i dipendenti, in quanto – come i contributi previdenziali – vengono detratte nel cedolino. Come contropartita anche questa volta un sorgere di debito (Avere) ma non nei confronti dell’INPS, bensì verso lo Stato (erario c/ ritenute su redditi di lavoro dipendente).
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
26/07/10 15/005 dipendenti c/retribuzioni 277,28 15/007 er. c/rit. su redd. di lav. dip. 277,28

44
Il nostro apprendista contabile (preferito) conclude le sue registrazioni, occupandosi dei contributi previdenziali a carico ditta, pari a 716,87 euro. Risolve la scrittura con un sorgere di debito verso l’INPS (Avere), poiché la Big Bang dovrà versare all’ente previdenziale i contributi a proprio carico. Come contropartita sceglie necessariamente un sorgere di costo (Dare), poiché questi contributi – denominati oneri sociali – sono, appunto, a carico della ditta. Tirando poi un sospiro di sollievo ringrazia i Queen per essere esistiti, in quanto sta ascoltando un loro magnifico album del 1978, “Jazz”. E così trova la forza per continuare a lavorare.
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
26/07/10 54/002 oneri sociali 716,87 15/006 INPS 716,87
Per verificare che tutto quadri ed anche per portarsi avanti con il lavoro, Antonio redige – su un apposito file excel - la scrittura dei pagamenti ai dipendenti (da fare poi a fine mese) e quella dei pagamenti all’INPS e allo Stato (da fare il 16 o meglio il 6 agosto). Nella prima considera una diminuzione di debito verso i dipendenti (Dare), pari a 2500,25 euro, che ricava dal saldo del conto “dipendenti c/retribuzioni” (2988,61 – 211,08 – 277,28 = 2500,25). Come contropartita utilizza una diminuzione di c/c bancario (Avere) per l’importo del totale dei bonifici che verranno eseguiti, pari a 2500 euro. La differenza, pari a 0,25 euro (= 0,97 – 0,72), risulta essere un componente positivo di reddito cioè un ricavo (sorgere di ricavi -> Avere).
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
30/07/10 15/005 dipendenti c/retribuzioni 2500,25 54/003 dipend. c/arrotondamenti 0,25 20/001/1 banca mediolanum c/c 2500,00
Anche nella seconda scrittura Antonio considera una diminuzione di debiti (Dare), sia verso l’INPS (conto INPS: 211,08 + 716,87 = 927,95) che verso lo Stato (erario c/ ritenute su redditi di lavoro dipendente). La contropartita è nuovamente una diminuzione di c/c bancario.
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
16/08/10 15/006 INPS 927,95 15/007 er. c/rit. su redd. di lav. dip. 277,28 20/001/1 banca mediolanum c/c 1205,23
Dopo aver finito, Antonio decide che – una volta a casa, cioè alle 18 in punto – si dedicherà a qualcosa di molto più interessante. Risolverà equazioni differenziali. Perché la matematica non annoia mai. E può essere quindi una buona ragione di vita.

45
6. Prospetto contabilizzazione retribuzioni collaboratori a progetto, inviato dal consulente del lavoro Immancabilmente giunge il fax dei compensi dei collaboratori. Antonio sa che sostanzialmente il lavoro che deve compiere per la registrazione contabile è identico a quello dei dipendenti. Ed infatti procede ricalcando la precedente procedura. Fa soltanto una riflessione sulle differenze formali fra i due tipi di procedimenti. “Questo è il prospetto di tutti i collaboratori a progetto della Big Bang, in quanto non viene citato alcun centro di costo. 445,33 sono i contributi previdenziali a carico dei collaboratori a progetto, che sono tenuti ad iscriversi presso la “Gestione Separata INPS”. 5000 euro sono i compensi lordi spettanti ai collaboratori, calcolati come prodotto fra una tariffa oraria e un determinato numero di ore lavorate nel mese di luglio. 1336 euro sono i contributi previdenziali totali (si tratta, nel 2010 e 2011, del 26,72% di 5000): 1/3 di questa cifra è a carico dei collaboratori (445,33), 2/3 è la parte a carico della ditta (890,67). La cifra di 1336 viene riportata 2 volte: in Avere rappresenta il debito, mentre in Dare costituisce il costo. 900 euro sono le ritenute IRPEF a carico dei collaboratori, il cui reddito viene definito come “assimilato a quello di lavoro dipendente”. 3655 euro sono i compensi netti spettanti. Questa volta c’è un arrotondamento negativo, collocato in Dare, quindi si tratta di un costo: l’ammontare dei compensi spettanti è 3654,67 (= 5000 – 445,33 – 900), mentre l’ammontare pagato è 3655 (esattamente 0,33 euro in più)”. PROSPETTO CONTABILIZZAZIONE RETRIBUZIONI Data 26/07/10 Collaboratori a progetto Periodo Luglio 2010 Ditta 6691 Big Bang S.r.l. Classificazione contabile PARZIALI DARE AVERE Contributi INPS Gest. Sep. c/collaboratori 445,33 Emolumenti lordi (competenze) 5000 Contributi INPS Gest. Sep. a Debito 1336 Contributi INPS Gestione Separata 1336 IRPEF 1001 (Redditi assimil. lav. dip.) 900 Arrotondamento attuale 0,33 Emolumenti c/collab. (netto in busta) 3655 TOTALI 6336,33 6336,33
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
26/07/10 54/004 compensi a collaboratori a progetto 5000 15/009 collaboratori c/compensi 5000
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 26/07/10 15/009 collaboratori c/compensi 445,33
15/006 INPS 445,33

46
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 26/07/10 15/009 collaboratori c/compensi 900
15/010 er. c/rit. su redd. assimil. lav. dip. 900
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
26/07/10 54/002 oneri sociali 890,67 15/006 INPS 890,67
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 30/07/10 15/009 collaboratori c/compensi 3654,67
54/003 dipend. c/arrotondamenti 0,33 20/001/1 banca mediolanum c/c 3655
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 16/08/10 15/006 INPS 1336
15/007 er. c/rit. su redd. di lav. dip. 900 20/001/1 banca mediolanum c/c 2236
7. Quiz sul capitolo III
1) La contabilizzazione delle retribuzioni dei dipendenti e dei compensi dei collaboratori a progetto
a) presenta enormi differenze b) viene effettuata in modo identico c) è caratterizzata da minime differenze
2) Il conto “Oneri sociali” comprende:
a) i contributi previdenziali a carico dei dipendenti b) i contributi previdenziali a carico della ditta c) i costi di utilità sociale
3) Il conto “INPS” esprime:
a) in dare i crediti e in avere i debiti verso l’ente previdenziale b) i crediti verso l’ente previdenziale c) i debiti verso l’ente previdenziale
4) Liquidazione delle retribuzioni significa:
a) pagamento degli stipendi b) determinazione dell’ammontare degli stipendi da pagare c) nessuna delle due

47
5) Il ricevimento di una fattura generalmente implica: a) IVA a debito b) IVA a credito c) nessuna delle due
6) “Erario c/ritenute su redditi di lavoro autonomo” è:
a) un debito verso un professionista soggetto a ritenuta d’acconto b) un credito verso un professionista soggetto a ritenuta d’acconto c) un debito verso l’erario per il versamento di una ritenuta inerente un
professionista soggetto a ritenuta d’acconto
7) La ritenuta d’acconto: a) riguarda i lavoratori autonomi che non siano beneficiari di regimi fiscali
agevolati con applicazione di imposta sostitutiva b) tutti i lavoratori autonomi c) tutte le aziende
8) I “documenti aziendali”:
a) vanno sempre contabilizzati b) vanno contabilizzati solo se generano una variazione numeraria c) vanno soltanto esaminati e compresi
9) Una scrittura contabile che comprenda “dipendenti c/retribuzioni” in Dare e “banca
mediolanum c/c” in Avere significa: a) che è sorto un debito nei confronti dei dipendenti b) che i dipendenti hanno richiesto un acconto sulle retribuzioni c) che è diminuito il debito verso i dipendenti poiché gli stipendi sono stati
pagati
10) “Collaboratori c/compensi”: a) è un conto economico b) è un conto numerario c) è un conto di costo

48
Capitolo IV – Un caso completo di esercitazione svolta: dalla situazione contabile al bilancio d’esercizio 1. Situazione contabile di partenza
situazione contabile elenco conti saldo Dare saldo Avere Fabbricati 140000 Attrezzature comm.li 27000 Arredamento 16000 Fondo amm.to fabbricati 49000 Fondo amm.to attrezz. comm.li 20500 Fondo amm.to arredamento 14000 Crediti vs clienti 22980 Cambiali attive 1500 Cambiali all'incasso 1250 Fondo rischi su crediti 235 Iva a credito 5800 C/c postale 2150 Denaro in cassa 11800 Patrimonio netto 155000 Debiti per TFR 17500 Debiti vs fornitori 30600 Cambiali passive 1650 Iva a debito 3300 Debiti per ritenute da versare 300 Erario c/IVA 6800 Debiti per imposte 5450 Istituti previdenziali 2180 Unicredit Banca c/c 12700 Merci c/vendite 425315,5 Resi su vendite 950 Fitti attivi 1150 Merci c/acquisti 401600 Resi su acquisti 2850 Variazione rimanenze merci 76500 Costi di trasporto 9050 Consulenze 2675 Costi postali 462,5 Assicurazioni 850 Provvigioni passive 1450 Canoni di leasing 2050 Salari e stipendi 17650 Oneri sociali 6530,5 Interessi attivi vs clienti 1375 Interessi passivi bancari 1657,5 Macchinari Debiti vs fornitori esteri Commissioni bancarie Unicredit Banca c/ cambiali all'incasso TOTALI 749905,5 749905,5

49
2. Scritture contabili d’esercizio
1) 05/02/2010: Pagamento – tramite bonifico bancario – di un anticipo (fatturato) ad un fornitore italiano per un importo di 7000 euro + IVA 20%.
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 05/02/10 20/001/2 Unicredit Banca c/c 8400
10/003 anticipi a fornitori 7000 10/001 IVA a credito 1400
2) 12/02/2010: Ricevimento della fattura per l’acquisto di merci di cui al punto
precedente per un valore di 20000 euro + IVA 20%.
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
12/02/10 14/001 debiti verso fornitori 22600 51/001 merci c/acquisti 20000 10/001 IVA a credito 2600
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 12/02/10 14/001 debiti verso fornitori 7000
10/003 anticipi a fornitori 7000
3) 08/03/2010: Ricevimento di una fattura per l’acquisto di un macchinario per un importo di 150000 euro + IVA 20%.
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 08/03/10 14/001 debiti verso fornitori 180000
40/001 macchinari 150000 10/001 IVA a credito 30000
4) 15/03/2010: Ricevimento della fattura per l’installazione e il collaudo del
macchinario di al punto precedente, per 2000 euro + IVA 20%.
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
15/03/10 14/001 debiti verso fornitori 2400 40/001 macchinari 2000 10/001 IVA a credito 400
5) 12/04/2010: Ricevimento di una fattura per acquisto merci da un fornitore
statunitense per 25000 dollari (cambio: 1,25 euro per un dollaro. Quindi: 25000 x 1,25 = 31250 euro).

50
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
12/04/10 14/003 debiti vs fornitori esteri 31250 51/001 merci c/acquisti 31250
6) 03/05/2010: Emissione di una fattura per vendita merci al Comune di Torino per un
importo di 2000 euro + IVA 20%.
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE 03/05/10 45/001/1 crediti vs Comune di Torino 2400
49/004 merci c/vendite 2000 15/011 IVA a deb. ad esigibilità differita 400
7) 07/06/2010: Incasso – tramite bonifico bancario – della fattura di cui sopra.
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 07/06/10 45/001/1 crediti vs Comune di Torino 2400
20/001/2 Unicredit Banca c/c 2400
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE 07/06/10 15/001 IVA a debito 400
15/011 IVA a deb. ad esigibilità differita 400
8) 17/09/2010: Al fine di regolare una posizione creditoria di 12000 euro viene emessa una cambiale tratta a 6 mesi. La cambiale viene presentata all’incasso con la clausola s.b.f. (Salvo Buon Fine). La banca comunica l’effettuazione dell’operazione ed addebita spese pari a 50 euro.
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 17/09/10 45/001 crediti verso clienti 12000
45/005 cambiali attive 12000
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE 17/09/10 20/001/2 Unicredit Banca c/c 11950
52/014 commissioni bancarie 50 15/012 Unicredit Banca c/cambiali all'incasso 12000

51
9) 29/10/2010: Liquidazione e pagamento di retribuzioni (e ritenute previdenziali e fiscali in data 16/11/2007) così strutturate (le cifre fra parentesi tonde sono da sottrarre): Retribuzioni 150000,00 Assegni familiari 10000,00 Ritenute previdenziali (15000,00) Ritenute IRPEF (30000,00) Totale da pagare 115000,00
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
29/10/10 54/001 salari e stipendi 150000 15/005 dipendenti c/retribuzioni 150000
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 29/10/10 15/005 dipendenti c/retribuzioni 10000
15/006 INPS 10000
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
29/10/10 15/005 dipendenti c/retribuzioni 15000 15/006 INPS 15000
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 29/10/10 15/005 dipendenti c/retribuzioni 30000
15/007 er. c/rit. su redd. di lav. dip. 30000
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
29/10/10 15/005 dipendenti c/retribuzioni 115000 20/001/2 Unicredit Banca c/c 115000
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 16/11/10 15/006 INPS 5000
15/007 er. c/rit. su redd. di lav. dip. 30000 20/001/2 Unicredit Banca c/c 35000

52
3. Mastrini originati dalle scritture contabili d’esercizio
Unicredit Banca c/c Anticipi a fornitori IVA a credito Merci c/acquisti 2400 8400 7000 7000 1400 20000 11950 115000 2600 31250
35000 7000 7000 30000 400 51250
14350 158400 34400
Debiti vs fornitori Macchinari Deb. vs fornit. esteri Cred. vs Com. di TO7000 22600 150000 31250 2400 2400
180000 2000 2400 31250 2400 2400 152000
7000 205000
Merci c/vendite Iva a deb. a esig. diff. IVA a debito Crediti vs clienti 2000 400 400 400 12000 2000 400 400 400 12000
Cambiali attive Commiss. bancarie Unicredit c/camb. Inc. Salari e stipendi 12000 50 12000 150000
12000 50 12000 150000
Dipend. C/retrib. INPS Er. c/rit. redd. lav. dip. 30000 150000 10000 15000 30000 30000 15000 10000 5000
115000 30000 30000 15000 15000
160000 160000
Saldi dei conti: Unicredit Banca c/c Avere 144050 Anticipi a fornitori 0 IVA a credito Dare 34400 Merci c/acquisti Dare 51250 Debiti vs fornitori Avere 198000 Macchinari Dare 152000 Debiti vs fornitori esteri Avere 31250 Crediti vs Comune di Torino 0 Merci c/vendite Avere 2000 IVA a debito ad esigibilità differita 0 IVA a debito Avere 400 Crediti vs clienti Avere 12000 Cambiali attive Dare 12000 Commissioni bancarie Dare 50 Unicredit Banca c/cambiali all’incasso Avere 12000

53
Salari e stipendi Dare 150000 Dipendenti c/retribuzioni 0 INPS 0 Erario c/ritenute su redditi di lavoro dip. 0 4. Primo bilancio di verifica situazione contabile scritture d'esercizio 1^ bilancio di verifica elenco conti saldo Dare saldo Avere Dare Avere saldo Dare saldo AvereFabbricati 140000 140000 Attrezzature comm.li 27000 27000 Arredamento 16000 16000 Fondo amm.to fabbricati 49000 49000 Fondo amm.to attrezz. comm.li 20500 20500 Fondo amm.to arredamento 14000 14000 Crediti vs clienti 22980 12000 10980 Cambiali attive 1500 12000 13500 Cambiali all'incasso 1250 1250 Fondo rischi su crediti 235 235 Iva a credito 5800 34400 40200 C/c postale 2150 2150 Denaro in cassa 11800 11800 Patrimonio netto 155000 155000 Debiti per TFR 17500 17500 Debiti vs fornitori 30600 198000 228600 Cambiali passive 1650 1650 Iva a debito 3300 400 3700 Debiti per ritenute da versare 300 300 Erario c/IVA 6800 6800 Debiti per imposte 5450 5450 Istituti previdenziali 2180 2180 Unicredit Banca c/c 12700 144050 156750 Merci c/vendite 425315,5 2000 427315,5 Resi su vendite 950 950 Fitti attivi 1150 1150 Merci c/acquisti 401600 51250 452850 Resi su acquisti 2850 2850 Variazione rimanenze merci 76500 76500 Costi di trasporto 9050 9050 Consulenze 2675 2675 Costi postali 462,5 462,5 Assicurazioni 850 850 Provvigioni passive 1450 1450 Canoni di leasing 2050 2050 Salari e stipendi 17650 150000 167650 Oneri sociali 6530,5 6530,5 Interessi attivi vs clienti 1375 1375 Interessi passivi bancari 1657,5 1657,5 Macchinari 152000 152000 Debiti vs fornitori esteri 31250 31250 Commissioni bancarie 50 50 Unicredit Banca c/ camb. all'inc. 12000 12000 TOTALI 749905,5 749905,5 399700 399700 1137605,5 1137605,5

54
5. Scritture di assestamento al 31/12
1) Gli interessi passivi bancari stimati ammontano a 500 euro.
data codici conti cifre sezione cifre sezione DARE AVERE
31/12/10 60/001 interessi passivi bancari 500 15/013 Unicredit c/inter. pass. da liquidare 500
2) L’accantonamento per TFR ammonta a 42500 euro.
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 31/12/10 57/001 accantonamento TFR 42500
12/001 (Debiti per) TFR 42500
3) Il conto “Assicurazioni”, pari a 850 euro, si riferisce unicamente all’assicurazione annuale del fabbricato aziendale, versata anticipatamente in data 01/08/2010 [850 : 12 = 70,84 assicurazione mensile; 70,84 x 7 = 495,88 costo assicurazione da stornare; I 7 mesi vanno dal 31/12/2010 all’1/8/2011].
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 31/12/10 52/002 assicurazioni 495,88
21/001 risconti attivi 495,88
4) Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni sono i seguenti: - fabbricati: 10000 euro; - macchinari: 7600 euro; - attrezzature commerciali: 5400 euro; - arredamento: 3000 euro.
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 31/12/10 55/002 ammortamento fabbricati 10000
55/001 ammortamento macchinari 7600 55/003 amm.to attrezzature comm.li 5400 55/004 amm.to arredamento 3000 40/003 fondo amm.to fabbricati 10000 40/002 fondo ammortamento macchinari 7600 40/004 fondo amm.to attrezz. comm.li 5400 40/005 fondo amm.to arredamento 3000
5) I crediti verso clienti vengono svalutati per 1200 euro.
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 31/12/10 56/001 svalutazione crediti 1200
45/006 fondo rischi su crediti 1200

55
6) Si stimano fatture da emettere per vendita di merci per un importo di 15000 euro.
data codici conti cifre sezione cifre sezione
DARE AVERE 31/12/10 49/004 merci c/vendite 15000
45/007 fatture da emettere 15000 6. Secondo bilancio di verifica 1^ bilancio di verifica scritture al 31/12 2^ bilancio di verifica elenco conti saldo Dare saldo Avere Dare Avere saldo Dare saldo AvereFabbricati 140000 140000 Attrezzature comm.li 27000 27000 Arredamento 16000 16000 Fondo amm.to fabbricati 49000 10000 59000 Fondo amm.to attrezz. comm.li 20500 5400 25900 Fondo amm.to arredamento 14000 3000 17000 Crediti vs clienti 10980 10980 Cambiali attive 13500 13500 Cambiali all'incasso 1250 1250 Fondo rischi su crediti 235 1200 1435 Iva a credito 40200 40200 C/c postale 2150 2150 Denaro in cassa 11800 11800 Patrimonio netto 155000 155000 Debiti per TFR 17500 42500 60000 Debiti vs fornitori 228600 228600 Cambiali passive 1650 1650 Iva a debito 3700 3700 Debiti per ritenute da versare 300 300 Erario c/IVA 6800 6800 Debiti per imposte 5450 5450 Istituti previdenziali 2180 2180 Unicredit Banca c/c 156750 156750 Merci c/vendite 427315,5 15000 442315,5 Resi su vendite 950 950 Fitti attivi 1150 1150 Merci c/acquisti 452850 452850 Resi su acquisti 2850 2850 Variazione rimanenze merci 76500 76500 Costi di trasporto 9050 9050 Consulenze 2675 2675 Costi postali 462,5 462,5 Assicurazioni 850 495,88 354,12 Provvigioni passive 1450 1450 Canoni di leasing 2050 2050 Salari e stipendi 167650 167650 Oneri sociali 6530,5 6530,5 Interessi attivi vs clienti 1375 1375 Interessi passivi bancari 1657,5 500 2157,5 Macchinari 152000 152000

56
Debiti vs fornitori esteri 31250 31250 Commissioni bancarie 50 50 Unicredit Banca c/ camb. all'inc. 12000 12000 Unicredit c/int. pass. da liquid. 500 500 Acc.to TFR 42500 42500 Risconti attivi 495,88 495,88 Fondo amm.to macchinari 7600 7600 Svalutazione crediti 1200 1200 Fatture da emettere 15000 15000 Amm.to arredamento 3000 3000 Amm.to attrezz. comm.li 5400 5400 Amm.to macchinari 7600 7600 Amm.to fabbricati 10000 10000 TOTALI 1137605,5 1137605,5 85695,88 85695,88 1222805,5 1222805,5 7. Bozza di Conto Economico al 31/12/2010
COSTI Euro RICAVI Euro Resi su vendite 950 Merci c/vendite 442315,5 Merci c/acquisti 452850 Fitti attivi 1150 Variazione rimanenze merci 76500 Resi su acquisti 2850 Costi di trasporto 9050 Interessi attivi vs clienti 1375 Consulenze 2675 Costi postali 462,5 Assicurazioni 354,12 TOTALE RICAVI 447690,5 Provvigioni passive 1450 Canoni di leasing 2050 Salari e stipendi 167650 Oneri sociali 6530,5 Interessi passivi bancari 2157,5 Commissioni bancarie 50 PERDITA D'ESERCIZIO 344739,12 Acc.to TFR 42500 Svalutazione crediti 1200 Amm.to arredamento 3000 Amm.to attrezz. comm.li 5400 Amm.to macchinari 7600 Amm.to fabbricati 10000 TOTALE COSTI 792429,62 TOTALE A PAREGGIO 792429,62

57
8. Bozza di Stato Patrimoniale al 31/12/2010
ATTIVITA' Euro PASSIVITA' Euro Fabbricati 140000 Fondo amm.to fabbricati 59000 Attrezzature comm.li 27000 Fondo amm.to attrezz. comm.li 25900 Arredamento 16000 Fondo amm.to arredamento 17000 Crediti vs clienti 10980 Fondo rischi su crediti 1435 Cambiali attive 13500 Patrimonio netto 155000 Cambiali all'incasso 1250 Debiti per TFR 60000 Iva a credito 40200 Debiti vs fornitori 228600 C/c postale 2150 Cambiali passive 1650 Denaro in cassa 11800 Iva a debito 3700 Macchinari 152000 Debiti per ritenute da versare 300 Risconti attivi 495,88 Erario c/IVA 6800 Fatture da emettere 15000 Debiti per imposte 5450 Istituti previdenziali 2180 TOTALE ATTIVITA' 430375,88 Unicredit Banca c/c 156750 Debiti vs fornitori esteri 31250 Unicredit Banca c/ camb. all'inc. 12000 PERDITA D'ESERCIZIO 344739,12 Unicredit c/int. pass. da liquid. 500 Fondo amm.to macchinari 7600 TOTALE A PAREGGIO 775115 TOTALE PASSIVITA' 775115
9. Conto Economico al 31/12/2010 (per agevolare la lettura le voci sono state “sintetizzate”) CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010 cifre parziali cifre totali A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 441365,5 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione 2525 dei contributi in conto esercizio. Totale valore della produzione 443890,5 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 450000 7) Per servizi 12591,62 8) Per godimento di beni di terzi 2050 9) Per il personale a) Salari e stipendi 167650 b) Oneri sociali 6530,5 c) Trattamento di fine rapporto 42500 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 1450 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. b) Ammortamento delle immobilizzazioni 26000 materiali.

58
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazione dei crediti compresi 1200 nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 76500 sussidiarie, di consumo e merci. 12) Accantonamenti per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione Totale costi di produzione 786472,12Differenza fra valore e costi della produzione (A - B) -342581,62C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni 16) Altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti 17) Interessi e altri oneri finanziari 2157,5 17-bis) Utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + o - 17-bis) -2157,5D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni. 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposta relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0Risultato prima delle imposte (A - B + o - C + o - D + o - E) -344739,12 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 0 e anticipate. 23) Utile (perdita) dell'esercizio -344739,12

59
10. Stato Patrimoniale al 31/12/2010 (per agevolare la lettura le voci sono state “sintetizzate”)
cifre
parziali cifre totali STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - 31/12/2010 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria. I - Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili. 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre Totale 0 II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati meno fondi 81000 di ammortamento. 2) Impianti e macchinario meno fondi 144400 di ammortamento. 3) Attrezzature industriali e commerciali 100 meno fondi di ammortamento. 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale 225500 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese meno fondo svalutazione partecipazioni 2) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri 3) Altri titoli 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale 0 Totale immobilizzazioni (B) 225500 C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati.

60
3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti Totale 0 II - Crediti 1) Verso clienti meno fondo 39295 svalutazione crediti 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 4-bis) crediti tributari 40200 4-ter) imposte anticipate 5) Verso altri Totale 79495 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. 6) Altri titoli Totale 0 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2150 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa 11800 Totale 13950 Totale Attivo circolante D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Ratei attivi Risconti attivi 495,88 Totale Attivo 319440,88 N.B.: A causa di un errore nelle ipotesi al 31/12, risulta che il fondo amm.to arredamento, pari a 17000, sia superiore al valore degli arredamenti, pari a 16000, il che non è possibile. Il problema è stato "risolto" inserendo -1000 (=16000-17000) nelle immobilizzazioni materiali, fra gli altri beni.

61
cifre parziali cifre totali STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - 31/12/2010 A) Patrimonio netto I. Capitale 155000 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserve di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserva per azioni proprie in portafoglio VI. Riserve statutarie VII. Altre riserve VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) d'esercizio -344739,12 Totale -189739,12B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili. 2) Fondi per imposte, anche differite 3) Altri Totale 0C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 60000 D) Debiti 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 169250 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori 259850 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 1650 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 16250 13) Debiti verso istituti di previdenza e 2180 di sicurezza sociale. 14) Altri debiti Totale 449180E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Ratei passivi 0 Risconti passivi 0Totale passivo e netto 319440,88

62
11. Quiz sul capitolo IV
1) Il secondo bilancio di verifica: a) comprende le scritture di assestamento b) non comprende le scritture di assestamento c) non comprende le scritture contabili
2) La situazione contabile:
a) è un sinonimo di bilancio di verifica b) è un elenco di conti, ciascuno con il proprio saldo c) è una parte del bilancio d’esercizio
3) Il fondo ammortamento macchinari:
a) esprime il valore di mercato di un macchinario b) esprime il valore aggiornato di un macchinario, al netto di usura e
obsolescenza c) esprime il valore totale che un macchinario ha perso, per usura ed
obsolescenza, fino ad una certa data
4) La categoria di bilancio “debiti rappresentati da titoli di credito” comprende: a) gli assegni bancari b) le cambiali passive c) le cambiali attive e le cambiali passive
5) La perdita d’esercizio:
a) riduce il patrimonio netto b) incrementa il patrimonio netto c) non è compresa nel patrimonio netto
6) La categoria di bilancio “assegni” comprende:
a) gli assegni emessi b) gli assegni ricevuti c) gli assegni che si trovano temporaneamente in cassa
7) La categoria di bilancio “interessi e altri oneri finanziari” comprende:
a) gli interessi passivi bancari b) gli interessi attivi su conto corrente c) qualunque tipo di interessi
8) I “costi d’impianto” sono immobilizzazioni:
a) materiali b) finanziarie c) immateriali

63
9) La categoria di bilancio “costi della produzione per godimento beni di terzi” comprende:
a) costi di affitto, noleggio, leasing b) costi di assicurazione c) costi di trasporto
10) Il conto “fatture da emettere”:
a) sorge in seguito all’emissione di una fattura b) sorge esclusivamente il 31/12 in sede di scritture di assestamento c) fa riferimento alle prossime fatture da emettere ai clienti

64
Capitolo V – CD-ROM: contenuto e istruzioni Il CD-ROM allegato al testo contiene un file denominato bilancio d’esercizio.xls. Si tratta di una simulazione excel, che illustra la procedura per ottenere il bilancio d’esercizio a partire da una situazione contabile. Il caso esaminato, che ha ad oggetto l’azienda Metodologica S.p.a., è composto da tre parti:
1) situazione contabile 2) bozza di bilancio 3) bilancio d’esercizio
1. Situazione contabile Metodologica S.p.a. La prima colonna, denominata “Scelta utente codifica conto C.R.A.P.”, richiede all’utente di effettuare una scelta, vale a dire di collocare ciascuno dei conti (compresi nella colonna “elenco conti”) nella giusta categoria: Costo o Ricavo o Attività o Passività (da qui è nato l’acronimo C.R.A.P.). Tale scelta può basarsi sul saldo del conto, se esso è Dare si tratterà di un costo o di un’attività, se invece il saldo è Avere dovrà trattarsi di un ricavo oppure di una passività. La seconda colonna, denominata “Esito scelta C.R.A.P.”, contiene funzioni che identificano la correttezza della risposta. Ad esempio, se si inserisce “C” (sia maiuscola che minuscola) nella prima colonna, in corrispondenza del conto “Acc.to TFR”, si otterrà “scelta corretta” (in quanto l’accantonamento TFR è un costo); se si inserirà invece una qualunque lettera diversa da “C” oppure se non si inserirà alcuna lettera si otterrà comunque “scelta errata”. La terza colonna, denominata “Risultato automatico: scelta corretta = 1; scelta errata = vuoto”, contiene funzioni che assegnano il valore “1” alle risposte corrette, mentre non assegnano nulla (di conseguenza la cella resta vuota) alle risposte errate. Tale colonna è stata costruita al fine di consentire il calcolo automatico della percentuale di risposte errate (visibile al fondo della seconda colonna). Qui di seguito (si veda la pagina successiva) viene riportata la sezione della situazione contabile dell’azienda Metodologica S.p.a. che richiede all’utente di effettuare la prima scelta.

65
1) SITUAZIONE CONTABILE "METODOLOGICA S.P.A." Scelta ut.
cod. conto C.R.A.P.
Esito scelta C.R.A.P.
Risultato: scelta corretta=1;
errata = vuoto elenco conti saldo DARE
saldo AVERE
C scelta corretta 1 Acc.to TFR 5000 P scelta corretta 1 Acconti da clienti per prodotti finiti 1000 C scelta corretta 1 Acquisti di materie prime 331800 C scelta corretta 1 Amm.to attrezzature ind.li 900 C scelta corretta 1 Amm.to automezzi 880 C scelta corretta 1 Amm.to impianti e macchinari 18700
A scelta corretta 1 Crediti finanziari vs imprese controllate 4400
A scelta corretta 1 Attrezzature ind.li 7500 A scelta corretta 1 Automezzi 9400 A scelta corretta 1 Immobilizzazioni materiali in corso 10000 P scelta corretta 1 Banca "Y" c/c passivo 5000 C scelta corretta 1 Canoni passivi di leasing 1160 P scelta corretta 1 Capitale sociale 60000A scelta corretta 1 Clienti 37300 C scelta corretta 1 Costi per servizi 30300 P scelta corretta 1 Fondo amm.to attrezzature ind.li 900 P scelta corretta 1 Fondo amm.to automezzi 1600 P scelta corretta 1 Fondo amm.to impianti e macchinari 32000P scelta corretta 1 Fondo rischi di garanzia 350 P scelta corretta 1 Fondo svalutazione crediti 200 P scelta corretta 1 Fornitori 52100A scelta corretta 1 Impianti e macchinari 135000
C scelta corretta 1 Imposte indirette e tasse dell'esercizio 60
C scelta corretta 1 Imposte sul reddito d'esercizio 15600
R scelta corretta 1 Incremento immob. per costruzioni interne 10000
C scelta corretta 1 Interessi passivi su c/c bancario 1100 C scelta corretta 1 Interessi passivi su mutuo 500 P scelta corretta 1 Mutuo passivo 7000 C scelta corretta 1 Oneri sociali 24000 A scelta corretta 1 Partecipazioni in altre imprese 1900
R scelta corretta 1 Proventi da partecipaz. in altre imprese 200
P scelta corretta 1 Ratei passivi su mutui 100 C scelta corretta 1 Retribuzioni 67100 R scelta corretta 1 Ricavi per vendite 510000A scelta corretta 1 Rimanenze di materie prime 9800 A scelta corretta 1 Rimanenze di prodotti finiti 300 P scelta corretta 1 Riserva legale 10500P scelta corretta 1 Riserva statutaria 9000 C scelta corretta 1 Sopravvenienze passive 1500 P scelta corretta 1 Trattamento di fine rapporto 16000A scelta corretta 1 Valori bollati 150 C scelta corretta 1 Variazione rimanenze materie prime 1500 C scelta corretta 1 Variazione rimanenze prodotti finiti 100
Verifica tot. Dare = tot.
Avere OK TOTALI 715950 715950Risp. errate 0,00%

66
Nella tabella di cui sopra tutte le scelte sono corrette, di conseguenza la percentuale di risposte errate è zero. Inoltre viene visualizzata una cella, denominata “Esito verifica uguaglianza totali Dare e Avere”, il cui fine è effettuare automaticamente la verifica della quadratura, comunicando all’utente “OK” in caso di uguaglianza (che è il caso sopra riportato, nel quale i totali Dare e Avere coincidono per 715950 euro) oppure “KO” in caso di disuguaglianza. Se ad esempio l’utente dovesse sbagliare 4 risposte, la percentuale di risposte errate sarebbe del 9,30% (4 errate / 43 totali = 0,0930 x 100 = 9,30%). A destra dei saldi Dare e Avere dei conti sono presenti nel file ulteriori colonne. La prima subito dopo i saldi, denominata “Scelta utente collocazione in bilancio CE.SP.”, richiede all’utente una seconda scelta: indicare per ciascun conto la corretta collocazione all’interno del bilancio d’esercizio, vale a dire Conto Economico (CE) oppure Stato Patrimoniale (SP). Se il lettore ha già compilato la prima colonna di scelta, può ragionare in questo modo: i costi e i ricavi vanno collocati in conto economico, mentre le attività e le passività vanno inserite in stato patrimoniale. Se invece non ha ancora compilato la prima colonna di scelta, il lettore può ragionare sulla natura del conto: se economico va in conto economico, se patrimoniale va in stato patrimoniale. Analogamente alla prima scelta (C.R.A.P.), accanto alla scelta CE.SP. sono presenti due colonne: una per comunicare all’utente l’esito della scelta e l’altra per consentire il calcolo della percentuale delle risposte errate. Qui di seguito si riporta la tabella che illustra la procedura relativa alla scelta CE.SP.
elenco conti saldo DARE
saldo AVERE
Scelta utente collocazione in bilancio
CE.SP. Esito scelta
CE.SP.
Risultato automatico:
scelta corretta=1;
scelta errata= vuoto
Acc.to TFR 5000 CE scelta corretta 1 Acconti da clienti per prodotti finiti 1000 SP scelta corretta 1 Acquisti di materie prime 331800 CE scelta corretta 1 Amm.to attrezzature ind.li 900 CE scelta corretta 1 Amm.to automezzi 880 CE scelta corretta 1 Amm.to impianti e macchinari 18700 CE scelta corretta 1 Crediti finanziari vs imprese controllate 4400 SP scelta corretta 1 Attrezzature ind.li 7500 SP scelta corretta 1 Automezzi 9400 SP scelta corretta 1 Immobilizzazioni materiali in corso 10000 SP scelta corretta 1 Banca "Y" c/c passivo 5000 SP scelta corretta 1 Canoni passivi di leasing 1160 CE scelta corretta 1 Capitale sociale 60000 SP scelta corretta 1 Clienti 37300 SP scelta corretta 1 Costi per servizi 30300 CE scelta corretta 1 Fondo amm.to attrezzature ind.li 900 SP scelta corretta 1 Fondo amm.to automezzi 1600 SP scelta corretta 1 Fondo amm.to impianti e macchinari 32000 SP scelta corretta 1 Fondo rischi di garanzia 350 SP scelta corretta 1 Fondo svalutazione crediti 200 SP scelta corretta 1 Fornitori 52100 SP scelta corretta 1

67
Impianti e macchinari 135000 SP scelta corretta 1 Imposte indirette e tasse dell'esercizio 60 CE scelta corretta 1 Imposte sul reddito d'esercizio 15600 CE scelta corretta 1 Incremento immob. per costruzioni interne 10000 CE scelta corretta 1 Interessi passivi su c/c bancario 1100 CE scelta corretta 1 Interessi passivi su mutuo 500 CE scelta corretta 1 Mutuo passivo 7000 SP scelta corretta 1 Oneri sociali 24000 CE scelta corretta 1 Partecipazioni in altre imprese 1900 SP scelta corretta 1 Proventi da partecipaz. in altre imprese 200 CE scelta corretta 1 Ratei passivi su mutui 100 SP scelta corretta 1 Retribuzioni 67100 CE scelta corretta 1 Ricavi per vendite 510000 CE scelta corretta 1 Rimanenze di materie prime 9800 SP scelta corretta 1 Rimanenze di prodotti finiti 300 SP scelta corretta 1 Riserva legale 10500 SP scelta corretta 1 Riserva statutaria 9000 SP scelta corretta 1 Sopravvenienze passive 1500 CE scelta corretta 1 Trattamento di fine rapporto 16000 SP scelta corretta 1 Valori bollati 150 SP scelta corretta 1 Variazione rimanenze materie prime 1500 CE scelta corretta 1 Variazione rimanenze prodotti finiti 100 CE scelta corretta 1 TOTALI 715950 715950
Risposte
errate 0,00% 2. Bozza di bilancio Metodologica S.p.a. In questa parte della simulazione non vengono richieste scelte all’utente. Tuttavia viene delineato un utile percorso affinché il lettore possa facilmente comprendere la procedura di bilancio. Infatti il passaggio tramite la bozza di bilancio serve sostanzialmente a semplificare la redazione del bilancio d’esercizio. Nella bozza di bilancio le codifiche C.R.A.P. vengono automaticamente copiate dalla situazione contabile: ciò significa che se sono stati commessi degli errori in precedenza, essi vengono replicati nella bozza di bilancio. In particolare, dopo le colonne contenenti la “copia scelta utente codifica conto C.R.A.P.” e l’elenco conti, sono collocate 4 colonne:
- costi; - ricavi; - attività; - passività.
Per ciascun conto, nelle quattro colonne, è presente una funzione che riporta automaticamente il valore del saldo del conto nella colonna corretta (se la scelta a monte è stata corretta). Ad esempio, se il conto “Acc.to TFR” è stato correttamente codificato come costo nella situazione contabile, allora nella bozza di bilancio la collocazione di costo verrà automaticamente copiata e il saldo di 5000 euro del conto “Acc.to TFR” verrà correttamente copiato nella colonna dei costi. Per meglio illustrare tale meccanismo si riporta qui di seguito parte della bozza di bilancio di Metodologica S.p.a., che comprende i primi quattro conti, fra i quali è possibile notare la corretta collocazione di “Acc.to TFR”.

68
2) BOZZA DI BILANCIO METODOLOGICA S.P.A.
Copia scelta utente codifica conto C.R.A.P. elenco conti COSTI RICAVI ATTIVITA' PASSIVITA'
C Acc.to TFR 5000 P Acconti da clienti per prodotti finiti 1000C Acquisti di materie prime 331800 C Amm.to attrezzature ind.li 900
In merito alla codifica del conto “Acc.to TFR” (si è scelto il primo conto a titolo esemplificativo, ma il meccanismo è identico per tutti i conti), l’utente può commettere diversi tipi di errore. Innanzitutto, nella situazione contabile, l’utente potrebbe aver inserito una qualunque lettera diversa da C, R, A, P. Ad esempio D. Il risultato è illustrato nella tabella seguente, nella quale si può notare che il conto “Acc.to TFR” è rimasto privo di saldo. Ciò naturalmente porterà ad una squadratura della bozza di bilancio e – di conseguenza – anche del bilancio d’esercizio.
Copia scelta utente codifica conto C.R.A.P. elenco conti COSTI RICAVI ATTIVITA' PASSIVITA'
D Acc.to TFR P Acconti da clienti per prodotti finiti 1000C Acquisti di materie prime 331800 C Amm.to attrezzature ind.li 900
Un secondo tipo di errore è quello di codificare “Acc.to TFR” come attività (d’altronde, dalla situazione contabile, si vede che tale conto ha saldo Dare, dunque o è un costo oppure è un’attività). In questo caso il risultato – visibile nella tabella seguente – è che il saldo di 5000 euro del conto “Acc.to TFR” viene proprio collocato nella sezione richiesta dall’utente, cioè fra le attività. Ciò naturalmente è errato e – come nella situazione precedente – porterà ad una squadratura sia della bozza di bilancio che del bilancio d’esercizio.
Copia scelta utente codifica conto C.R.A.P. elenco conti COSTI RICAVI ATTIVITA' PASSIVITA'
A Acc.to TFR 5000 P Acconti da clienti per prodotti finiti 1000C Acquisti di materie prime 331800 C Amm.to attrezzature ind.li 900
Un terzo tipo di errore è quello di codificare “Acc.to TFR” come ricavo oppure come passività. Ciò è privo di senso in quanto un conto con saldo Dare non può essere né un ricavo né una passività: tale messaggio viene comunicato all’utente tramite la collocazione di un saldo pari a zero fra i ricavi (se egli ha codificato il conto come ricavo) oppure fra i costi (se la scelta dell’utente è caduta sul costo). A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito il caso di scelta del ricavo.

69
Copia scelta utente codifica conto C.R.A.P. elenco conti COSTI RICAVI ATTIVITA' PASSIVITA'
R Acc.to TFR 0 P Acconti da clienti per prodotti finiti 1000C Acquisti di materie prime 331800 C Amm.to attrezzature ind.li 900
Se tutte le codifiche sono corrette il lettore otterrà una corretta bozza di bilancio, composta essenzialmente da un elenco di conti e dalle quattro colonne di costi, ricavi, attività e passività (costi e ricavi compongono la bozza di conto economico, mentre attività e passività formano la bozza di stato patrimoniale) ciascuna delle quali possiede il proprio totale. Nelle righe successive viene calcolata in automatico la differenza fra il totale dei ricavi e quello dei costi: il risultato viene identificato come utile d’esercizio se i ricavi sono maggiori dei costi, oppure come perdita d’esercizio se i ricavi sono minori dei costi. In maniera analoga viene calcolata la differenza fra attività e passività: il risultato viene identificato come utile d’esercizio se le attività sono maggiori delle passività, oppure come perdita d’esercizio se le attività sono minori delle passività. Infine una funzione verifica automaticamente se esiste uguaglianza fra l’utile della bozza di conto economico (ottenuto come differenza fra ricavi e costi) e l’utile della bozza di stato patrimoniale (ottenuto come differenza fra attività e passività). Se l’uguaglianza esiste, l’utente potrà leggere “OK”, altrimenti risulterà “KO”. Qui di seguito si riporta l’intera bozza di bilancio. 2) BOZZA DI BILANCIO METODOLOGICA S.P.A.
Copia scelta utente codifica conto C.R.A.P. elenco conti COSTI RICAVI ATTIVITA' PASSIVITA'
C Acc.to TFR 5000 P Acconti da clienti per prodotti finiti 1000C Acquisti di materie prime 331800 C Amm.to attrezzature ind.li 900 C Amm.to automezzi 880 C Amm.to impianti e macchinari 18700 A Crediti finanziari vs imprese controllate 4400 A Attrezzature ind.li 7500 A Automezzi 9400 A Immobilizzazioni materiali in corso 10000 P Banca "Y" c/c passivo 5000C Canoni passivi di leasing 1160 P Capitale sociale 60000A Clienti 37300 C Costi per servizi 30300 P Fondo amm.to attrezzature ind.li 900P Fondo amm.to automezzi 1600P Fondo amm.to impianti e macchinari 32000P Fondo rischi di garanzia 350

70
P Fondo svalutazione crediti 200P Fornitori 52100A Impianti e macchinari 135000 C Imposte indirette e tasse dell'esercizio 60 C Imposte sul reddito d'esercizio 15600 R Incremento immob. per costruzioni interne 10000 C Interessi passivi su c/c bancario 1100 C Interessi passivi su mutuo 500 P Mutuo passivo 7000C Oneri sociali 24000 A Partecipazioni in altre imprese 1900 R Proventi da partecipaz. in altre imprese 200 P Ratei passivi su mutui 100C Retribuzioni 67100 R Ricavi per vendite 510000 A Rimanenze di materie prime 9800 A Rimanenze di prodotti finiti 300 P Riserva legale 10500P Riserva statutaria 9000C Sopravvenienze passive 1500 P Trattamento di fine rapporto 16000A Valori bollati 150 C Variazione rimanenze materie prime 1500 C Variazione rimanenze prodotti finiti 100
TOTALI 500200 520200 215750 195750 TOTALE RICAVI 520200 meno TOTALE COSTI 500200 UTILE D'ESERCIZIO 20000 TOTALE ATTIVITA' 215750 meno TOTALE PASSIVITA' 195750 UTILE D'ESERCIZIO 20000
Esito verifica uguaglianza fra utile d'esercizio da CE e SP OK
3. Bilancio d’esercizio Metodologica S.p.a. La terza ed ultima parte della simulazione consiste essenzialmente nella redazione automatica del bilancio d’esercizio (conto economico e stato patrimoniale), a partire dai valori contenuti nella bozza di bilancio. Questa operazione è caratterizzata da una serie di peculiarità, già dettagliatamente descritte nel paragrafo 5.2 del secondo capitolo del testo. Qui di seguito (si veda la pagina successiva) si riporta il bilancio d’esercizio completo.

71
3) BILANCIO D'ESERCIZIO METODOLOGICA S.P.A. (per agevolare la lettura le voci sono state “sintetizzate”)
cifre
parziali cifre totali
CONTO ECONOMICO METODOLOGICA S.P.A. A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 510000 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti -100 in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 10000 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale valore della produzione 519900 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 331800 7) Per servizi 30300 8) Per godimento di beni di terzi 1160 9) Per il personale a) Salari e stipendi 67100 b) Oneri sociali 24000 c) Trattamento di fine rapporto 5000 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. b) Ammortamento delle immobilizzazioni 20480 materiali. c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 1500 sussidiarie, di consumo e merci. 12) Accantonamenti per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 60 Totale costi di produzione 481400Differenza fra valore e costi della produzione (A - B) 38500C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni 200 16) Altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti 17) Interessi e altri oneri finanziari 1600 17-bis) Utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + o - 17-bis) -1400D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie

72
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni. 21) Oneri, con separata indicazione delle 1500 minusvalenze da alienazioni e delle imposta relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -1500Risultato prima delle imposte (A - B + o - C + o - D + o - E) 35600 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 15600 e anticipate. 23) Utile (perdita) dell'esercizio 20000
cifre
parziali cifre totali
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - METODOLOGICA S.P.A. A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria. I - Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili. 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre Totale 0 II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati meno fondi di ammortamento. 2) Impianti e macchinario meno fondi 103000 di ammortamento. 3) Attrezzature industriali e commerciali 6600 meno fondi di ammortamento. 4) Altri beni 7800 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 10000 Totale 127400 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 1900 meno fondo svalutazione partecipazioni

73
2) Crediti: a) verso imprese controllate 4400 b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri 3) Altri titoli 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale 6300Totale immobilizzazioni (B) 133700C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 9800 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati. 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 300 5) Acconti Totale 10100 II - Crediti 1) Verso clienti meno fondo 37100 svalutazione crediti 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti 4-bis) crediti tributari 4-ter) imposte anticipate 5) Verso altri Totale 37100 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. 6) Altri titoli Totale 0 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa 150 Totale 150Totale Attivo circolante 47350D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Ratei attivi Risconti attivi Totale Attivo 181050

74
cifre
parzialicifre totali
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - METODOLOGICA S.P.A. A) Patrimonio netto I. Capitale 60000 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserve di rivalutazione IV. Riserva legale 10500 V. Riserve statutarie 9000
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) d'esercizio 20000 Totale 99500B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili. 2) Fondi per imposte, anche differite 3) Altri 350 Totale 350C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16000 D) Debiti 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 12000 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 1000 7) Debiti verso fornitori 52100 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale. 14) Altri debiti Totale 65100E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Ratei passivi 100 Risconti passivi Totale passivo e netto 181050

75
Capitolo VI – Esercizi da svolgere 1. Analisi S.r.l. Registrare sulla prima nota di cassa e banca le seguenti operazioni, relative alla società Analisi S.r.l.. Compilare la prima annotazione delle scritture contabili, cioè la Prima Nota, equivale semplicemente a compilare una serie di righe. Ogni riga rappresenta un’operazione. Per ogni operazione va indicata la data, la descrizione, l’importo, se si tratta di entrata o di uscita, e se è una movimentazione di cassa oppure di banca.
1) 1/6/2010: Ottenuto, dalla Banca Cantor S.p.a., mutuo di 100.000 euro con accredito
su c/c
2) 2/6/2010: Pagata in contanti (250 euro) fattura Gross-One S.r.l. n. 100 del 3 maggio
2010
3) 3/6/2010: Conferita, dal nuovo socio Ettore Rampini, quota di 50.000 euro nel
capitale di Analisi S.r.l., tramite bonifico bancario
4) 4/6/2010: Incassata in contanti (150 euro) fattura Analisi S.r.l. n. 110 del 5 maggio
2010, emessa al cliente Insiemi Numerici S.r.l.
5) 7/6/2010: Pagata, tramite bonifico bancario, la somma di 1.200 euro a saldo fattura
Gross-One S.r.l. n. 120 del 5 aprile 2010
6) 8/6/2010: Prelevata, tramite bancomat, la somma di 250 euro da riporre in cassa al
fine di fronteggiare futuri pagamenti in contanti
7) 9/6/2010: Effettuato conteggio della cassa e confronto saldo con relative rilevazioni
in Partita Doppia. Mancano 50 euro
8) 10/6/2010: Acquistate dal tabaccaio (e pagate in contanti) 5 marche da bollo,
ciascuna di importo pari a 1,81 euro
9) 11/6/2010: Incassata, tramite bonifico bancario (2.400 euro), fattura Analisi S.r.l.
emessa al cliente Serie di Potenze S.r.l.
10) 14/6/2010: Acquistata dal giornalaio (e pagata in contanti, 10 euro) rivista di
aggiornamento fiscale
11) 15/6/2010: Pagata rata del mutuo (450 euro), tramite addebito su c/c
12) 16/6/2010: Pagata – tramite modello F24 - IVA, ritenute e contributi relativi a
maggio 2010, per un totale di 45.000 euro con addebito su c/c

76
2. Congettura S.r.l. Registrare sulla prima nota di cassa e di banca le seguenti operazioni, relative alla società Congettura S.r.l.. E poi effettuare le rilevazioni delle stesse operazioni in Partita Doppia.
1) 1/7/2010: pagata rata del mutuo, tramite addebito su c/c, per un ammontare di
850 euro, di cui 700 euro di quota capitale e 150 euro di interessi;
2) 2/7/2010: Incassata in contanti (120 euro) fattura n. 345 del 3/6/2010 per
acquisto merci;
3) 5/7/2010: Pagata, tramite bonifico bancario, quota di capitale al socio uscente
Gesta Maurizio, per 30000 euro;
4) 6/7/2010: Prelevata, tramite bancomat, la somma di 200 euro da riporre in
cassa per future esigenze;
5) 7/7/2010: Conferita, dal nuovo socio Sorbi Gennaro, quota di 45000 euro nel
capitale di Congettura S.r.l., tramite bonifico bancario;
6) 8/7/2010: Comprate (in contanti) 10 marche da bollo da 1,81 euro ciascuna;
7) 9/7/2010: Pagata, tramite bonifico bancario, la somma di 1350 euro, a saldo
fattura Cesp S.r.l. n. 130 del 9/6/2010 (per acquisto merci), pari a 1354 euro
(con un abbuono quindi di 4 euro);
8) 12/7/2010: Rilevato furto in cassa, per un ammontare di 350 euro;
9) 13/7/2010: Prelevati, per ragioni di sicurezza, 750 euro dalla cassa per versarli
sul c/c
10) 14/7/2010: Pagata prestazione occasionale ad un collaboratore esterno, per
3000 euro lordi, al netto della ritenuta IRPEF d’acconto del 20%;
11) 15/7/2010: Pagata in contanti fattura n. 234 del 15/7/2010 della CopySpeed
S.a.s. per fotocopie. L’ammontare è 50 euro + IVA 20%;
12) 16/7/2010: Pagata, tramite modello F24, IVA, ritenute e contributi relativi a
giugno 2010, per un totale di 41000 euro con addebito su c/c.

77
3. L’ultimo Teorema di Fermat S.p.a. Registrare sulla prima nota di cassa e di banca le seguenti operazioni, relative alla società L’ultimo Teorema di Fermat S.p.a.. E poi effettuare le rilevazioni delle stesse operazioni in Partita Doppia.
1) 1/9/2010: Pagata in contanti (240 euro) fattura n. 567 del 4/8/2010 per acquisto
merci;
2) 3/9/2010: Ottenuto, dalla banca AstroDenaro S.p.a., mutuo di 50000 euro con
accredito su c/c;
3) 8/9/2010: Acquistata dal giornalaio (e pagati in contanti, 6 euro) rivista di
aggiornamento fiscale;
4) 10/10/2010: Incassata, tramite bonifico bancario (3600 euro), fattura emessa ad un
cliente;
5) 13/9/2010: Prelevata, tramite bancomat, la somma di 250 euro da riporre in cassa al
fine di fronteggiare futuri pagamenti in contanti;
6) 14/9/2010: Pagata con bonifico bancario prestazione occasionale ad un collaboratore
esterno, per 4000 euro lordi, al netto della ritenuta IRPEF d’acconto del 20%;
7) 16/10/2010: Versata, tramite bonifico bancario, ritenuta di cui al punto precedente.
4. Big Bang S.r.l. Rilevare in Partita Doppia i seguenti documenti contabili 1) Pagamento di un bollettino postale relativo a spese condominiali
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento - Banco Posta sul C/C n. 63985777 di Euro 239,00 intestato a: CONDOMINIO Galaxy Via Raggi Cosmici n. 33 10100 TORINO eseguito da: BIG BANG S.R.L. Via dell'Universo, 27 10131 TORINO causale: Spese condominiali 12/05/2010 Rata n. 1 euro 239,00 Scadenza: 14/5/2010 euro 1,10 Il bollettino è stato pagato il (vedi timbro postale) Bollo dell'uff. postale Poste

78
2) Ricezione e pagamento di parcella notarile con ritenuta d’acconto
STUDIO NOTARILE Geronimo Gas - Gioacchino Plasma - Notai associati P.IVA 09035240016 Via Perseidi n. 5 10189 TORINO Tel.: 011.5615181 - 011.5349110 Spett.le BIG BANG S.r.l. Via dell' Universo, 27 10131 TORINO P.IVA 08024250016 Fattura n. 630 del 9 giugno 2010 Oggetto: consulenza statuto societario Onorari, compensi ed altre spese soggette ad IVA euro 500,00I.V.A. 20% su onorari euro 100,00Totale fattura 600,00Detratta ritenuta d'acconto euro 100,00Totale a Vostro debito euro 500,00
3) Emissione ed incasso fattura di vendita con IVA ad esigibilità differita
BIG BANG S.R.L. Via dell’Universo, 27
10131 TORINO P.IVA 08024250016
Spett.le GIGANTE ROSSA S.R.L.
Via Lattea, 42 10155 TORINO
Fattura n. 48 del 16 giugno 2010 Art. 01 – Laser ad uso astronomico – Quantità 1 Imponibile 150 euro IVA 20% 30 euro TOTALE FATTURA 180 euro Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009

79
GLOSSARIO ESSENZIALE Abitazione principale = detta anche prima casa, è l’abitazione che beneficia di varie agevolazioni quali l’esclusione dall’IRPEF, in caso di acquisto l’imposta di registro in misura ridotta e la detrazione degli interessi del mutuo. Ai fini dell’IRPEF la prima casa è quella posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale, abitata abitualmente dal contribuente e/o dai suoi familiari. Accertamento tributario = complesso di procedure mediante le quali l’Amministrazione finanziaria determina il reddito imponibile del contribuente e l’ammontare della relativa imposta in base alla legislazione vigente. Se l’Amministrazione accerta che il contribuente non ha versato, in tutto o in parte, l’imposta dovuta, fa pervenire all’interessato un avviso di accertamento, contro il quale è possibile presentare ricorso. Secondo le modalità in cui avviene, l’accertamento può essere analitico, induttivo, sintetico. L’accertamento analitico determina l’imponibile secondo i criteri previsti dalla legge. Per i soggetti obbligati alla tenuta dei libri contabili, comporta un esame della contabilità. L’accertamento induttivo si basa su dati e notizie certi e concordanti, atti a determinare il reddito di impresa o professionale. L’accertamento sintetico si basa su indici di capacità contributiva. L’accertamento con adesione è una procedura rapida per la definizione, in contraddittorio, del debito tributario. Accise = sono le imposte di fabbricazione su alcuni prodotti di origine minerale (ad es. benzina) o alcolica (birra, liquori) e le imposte di consumo che gravano su energia elettrica e gas metano. Acconti = si tratta di somme versate prima che si effettui l’acquisto o la vendita di beni o servizi. Gli acconti ricevuti da clienti rappresentano debiti; gli acconti versati a fornitori sono invece crediti. Sono previsti acconti anche per le imposte dirette: tali acconti si compensano con le imposte dovute. Ogni acconto – in generale – ha una sua specifica collocazione in bilancio. Ammortamento = termine che, letteralmente, indica l’azione di estinguere. Assume un significato diverso a seconda che riguardi l’estinzione di un mutuo (ammortamento di un prestito), lo smarrimento o la distruzione di un libretto di risparmio (ammortamento dei titoli di credito) o la ripartizione su più periodi amministrativi di un costo pluriennale (ammortamento economico). L’ammortamento economico è un procedimento tecnico-contabile con cui si ripartiscono su più esercizi i costi pluriennali sostenuti per acquisire le immobilizzazioni materiali e immateriali. In base all’art. 2426 cod. civ. il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente imputato per quote ad ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Ciò significa che l’ammortamento deve essere operato in conformità ad un piano prestabilito per ciascun bene o gruppo omogeneo di beni e non deve essere accelerato o rallentato a seconda delle politiche di bilancio; deve essere inoltre effettuato anche se un esercizio è in perdita. L’ammortamento ha inizio nell’esercizio in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso e la redazione del piano richiede la conoscenza del valore da ammortizzare (= differenza fra costo sostenuto e presumibile valore netto di realizzo al termine del periodo di vita utile del bene), della durata della vita utile (che tenga

80
conto dell’usura e dell’obsolescenza) e del criterio di ripartizione (il più diffuso è a quote costanti, che si applica dividendo il valore da ammortizzare per gli anni di durata della vita utile del bene). Assegni per il nucleo familiare = prestazione economica previdenziale (erogata dall’INPS, ma anticipata dal datore di lavoro), integrativa della retribuzione, cui hanno diritto i prestatori di lavoro per il proprio nucleo familiare. Detta prestazione compete a tutti i dipendenti e pensionati in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare. In generale spetta ai dipendenti con basso reddito, ma il cui nucleo familiare è numeroso. Assegno bancario = documento (rappresentato da un apposito modulo) in cui è contenuto l’ordine incondizionato che un soggetto (chiamato traente) impartisce ad una determinata banca (denominata trattaria), di pagare a vista una certa somma a favore del beneficiario indicato nel titolo stesso. La facoltà di emettere assegni bancari presuppone l’esistenza di fondi dell’emittente depositati presso la banca, oppure che questi possa beneficiare di una linea di credito aperta a suo favore: la banca provvederà ad eseguire gli ordini di pagamento impartiti dal traente, attingendo il necessario dai suddetti fondi. Assegno circolare = è uno strumento di pagamento che viene emesso soltanto a seguito di richiesta del cliente e previa corresponsione da parte di questi di un importo pari a quello del titolo. In sostanza, l’assegno circolare equivale al denaro contante, in quanto la banca lo emette solo se il suo cliente ha versato la somma corrispondente. Invece l’assegno bancario potrebbe anche risultare “scoperto” se il denaro disponibile sul c/c del traente fosse insufficiente a coprirne l’ammontare. Attività = qualsiasi bene o diritto appartenente ad un soggetto economico. A seconda della loro durata, le attività possono essere distinte in attività correnti (se si trasformeranno in denaro entro 12 mesi) e attività immobilizzate (se impiegheranno più di 12 mesi a trasformarsi in denaro). Le attività sono indicate generalmente a valori netti, cioè diminuiti delle cosiddette poste rettificative dell’attivo (fondo ammortamento, fondo svalutazione crediti, ecc.). In questo modo viene considerato il valore effettivo delle attività. Autofinanziamento = accrescimento dei mezzi finanziari aziendali per effetto della gestione, e non per effetto di apporti esterni. L’autofinanziamento è legato, soprattutto, alla redditività aziendale: una buona redditività consente di ottenere dalla gestione i mezzi finanziari per effettuare gli investimenti. Autotutela = è la possibilità dell’Amministrazione Finanziaria di correggere propri atti errati o illegittimi, su richiesta del contribuente o anche d’ufficio. Avviamento = contabilmente, l’avviamento corrisponde al maggior costo sostenuto nell’acquisizione di un’azienda in funzionamento, rispetto ai valori correnti dei singoli beni. Il maggior costo può essere iscritto in bilancio, nell’attivo dello stato patrimoniale, se l’acquisizione è avvenuta a titolo oneroso. Nel caso delle società per azioni l’iscrizione nelle attività (fra le immobilizzazioni immateriali) è subordinata all’approvazione del collegio

81
sindacale. L’ammortamento dell’avviamento deve essere effettuato, civilisticamente (salvo deroghe motivate), in un massimo di 5 esercizi (art. 2426 n. 6) cod. civ.). Baratto = scambio di beni con altri beni senza l’intervento della moneta. Il baratto è possibile solo a condizione che le due parti siano animate da una duplice coincidenza dei bisogni: il desiderio del bene dell’altro e la disponibilità ad offrire in cambio il proprio. Forma primitiva di commercio, il baratto ritorna in uso quando il denaro cessa di essere un mezzo di pagamento universalmente accettato (ad es. in tempo di guerra o in condizioni di prigionia). Beni ammortizzabili = beni strumentali (o cespiti), che servono a realizzare la produzione aziendale e che forniscono all’azienda un’utilità protratta nel tempo (comunque maggiore di 12 mesi). Bilancio consolidato = documento che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, così come il bilancio d’esercizio rappresenta tale situazione per una singola impresa. Il bilancio consolidato considera l’insieme di imprese appartenenti al gruppo come un’unica entità, e di conseguenza riflette solo le operazioni che le imprese hanno realizzato con soggetti esterni al gruppo (vengono in sostanza, “neutralizzate” le operazioni infragruppo). Bilancio d’esercizio = documento contabile redatto al termine del periodo amministrativo di riferimento, allo scopo di evidenziare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nonché il risultato economico d’esercizio. Il bilancio d’esercizio è composto dallo stato patrimoniale (art. 2424 cod. civ.), dal conto economico (art. 2425 cod. civ.) e dalla nota integrativa (art. 2427 cod. civ.). Bonifico bancario = atto con il quale il titolare di un conto corrente bancario ordina alla propria banca di effettuare l’accredito o il pagamento di una data somma a favore di un beneficiario, nonché il corrispondente addebito sul proprio conto. Cambiale = è un titolo di credito (cioè un documento che, oltre a provare l’esistenza di un diritto, assicura la possibilità di farlo valere) all’ordine (vale a dire trasferibile mediante girata), formale ed esecutivo, dal quale risulta l’obbligazione incondizionata assunta da un certo soggetto (= debitore) di pagare (pagherò cambiario) o di far pagare (cambiale tratta) una determinata somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore del legittimo possessore (= creditore). Se il cliente dell’azienda sottoscrive una cambiale, l’importo della stessa viene contabilizzato sotto la specifica voce “cambiali attive”, invece che come generico credito commerciale. Similmente se invece è l’azienda a sottoscrivere una cambiale (ad es. per l’acquisto presso un fornitore), essa va contabilizzata sotto “cambiali passive”, invece che come generico debito verso fornitori. Capitale sociale = corrisponde al valore nominale delle azioni nel caso di una società per azioni, o alle quote di partecipazione sottoscritte dai soci nel caso di società a responsabilità limitata o società di persone.

82
Certificazione di bilancio = è il parere professionale sulla correttezza del bilancio, espresso da una società di revisione. La certificazione è obbligatoria per le società con titoli quotati in mercato regolamentati o per enti e società per i quali è prevista da norme ad hoc. Codice Pin = è il codice che serve per accedere ai servizi telematici personali dell’Agenzia delle Entrate. Si ottiene presso gli uffici o tramite il sito internet dell’Agenzia. Contabilità di magazzino = sistema di scritture ausiliarie che rileva sistematicamente le operazioni che danno luogo a variazioni di quantità e valore delle scorte di materie prime, materiali di consumo, prodotti finiti, semilavorati, per ciascuna categoria omogenea di beni. La rilevazione avviene sulla base di documenti che comprovano la movimentazione del magazzino, originata da operazioni interne o esterne. I movimenti in entrata possono essere determinati da acquisti, resi da clienti o scarico da altro magazzino. I movimenti in uscita consistono in vendite, resi a fornitori, prelievi per passaggio ad altro magazzino o utilizzo nella produzione. La consistenza delle scorte in un dato istante indica le rimanenze finali, ed è data dalle giacenze presenti all’inizio della rilevazione (rimanenze iniziali) cui vengono sommate le entrate di materiali e prodotti e sottratte le uscite. Conti d’ordine = annotazioni per memoria indicate in calce allo stato patrimoniale per evidenziare beni di terzi esistenti presso l’azienda e/o dell’azienda presso terzi, beni in leasing, impegni derivanti da contratti già conclusi ma ad esecuzione differita, rischi assunti, garanzie prestate. Conto = è lo strumento principale per le rilevazioni contabili. IL conto, altre volte chiamato “mastrino” e che poi nella prassi contabile si concretizza con la “scheda contabile” (prodotta dai software di contabilità), è l’elenco delle operazioni effettuate, divise per oggetto, valorizzate in moneta. Conto economico = prospetto contabile in forma scalare che evidenzia la composizione dei costi e dei ricavi d’esercizio e il risultato economico (utile d’esercizio). Costi = elementi che concorrono a decrementare il reddito di impresa (per tale motivo vengono definiti anche componenti negativi di reddito). Il costo è una spesa monetaria sostenuta per l’acquisizione dei fattori della produzione, rappresentati da beni e servizi, necessari per il perseguimento delle finalità proprie di ciascuna impresa. Nel linguaggio contabile il costo può essere caratterizzato da un esborso di denaro (= costo monetario. Ad es. l’acquisto di materie prime da un fornitore) oppure no (costo non monetario. Ad es. il costo, derivante da una stima e non da un documento giustificativo, relativo alla perdita presunta su crediti verso clienti. Tale perdita, non essendosi ancora verificata, non causa un’uscita di denaro). Costi d’esercizio = si tratta di costi che forniscono un’utilità che ha una durata limitata a 12 mesi (cioè ad un esercizio) (ad es. se l’azienda compra 10 penne, questo fatto genera contabilmente il sorgere di un costo d’esercizio , in quanto le penne dureranno probabilmente meno di un mese). Tali costi, in bilancio, confluiscono nel prospetto di conto economico. Essi devono essere distinti dai costi pluriennali, che sono costi che forniscono un’utilità che dura più di 12 mesi (si tratta dei costi sostenuti per l’acquisto di beni strumentali. Ad es. se l’azienda compra da Ikea delle scaffalature di ferro per il magazzino materie prime, questo fatto genera contabilmente il sorgere di un costo

83
pluriennale, in quanto molto probabilmente gli scaffali dureranno più di un anno). I costi pluriennali, in bilancio, confluiscono nel prospetto di stato patrimoniale, fra le attività immobilizzate. Debiti commerciali = debiti originati da una transazione commerciale, tipicamente un acquisto di beni presso un fornitore con regolamento dilazionato. Tali debiti vengono anche definiti debiti di funzionamento, perché derivano dall’ordinaria gestione aziendale. Essi si distinguono dai cosiddetti debiti di finanziamento, originati da un’operazione di finanziamento (nel momento in cui l’azienda richiede ed ottiene un prestito bancario, dal punto di vista contabile sorge un debito di finanziamento in quanto l’imprenditore è tenuto a restituire la somma ricevuta a titolo di prestito). Dichiarazione dei redditi = dichiarazione annuale, diretta all’Amministrazione Finanziaria, che deve obbligatoriamente essere redatta da ogni contribuente, agli effetti dell’ IRPEF, dell’IRES, dell’IVA, dell’IRAP, con l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione della base imponibile. Elementi patrimoniali = elementi che costituiscono il patrimonio, cioè attività e passività. Elementi reddituali = elementi che costituiscono i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) del reddito di esercizio. Fair value (valore equo) = è il valore potenziale di un bene in una transazione fra parti indipendenti, consapevoli e disponibili. È un criterio di valutazione di un bene. Familiari a carico = in base al T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sono considerati familiari a carico il coniuge, i figli, i discendenti dei figli (nipoti), genitori e nonni, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, se hanno redditi propri non superiori a 2840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili ed esclusi i redditi esenti. Fattura = documento emesso, dal cedente di beni o dal prestatore di servizi, nel quale sono specificate caratteristiche qualitative e quantitative dell’oggetto dell’operazione, costi accessori, imposte gravanti sulla compravendita, modalità di pagamento. Firma digitale = firma elettronica qualificata, basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche. E’ un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla firma autografa su carta. Si basa sull’uso di un certificato digitale memorizzato su un dispositivo hardware. Fondo imposte = si tratta di una passività per accertamenti di imposte da parte degli uffici competenti (debito non certo) e per le imposte differite su componenti di reddito (ad esempio plusvalenze), per i quali l’azienda chiede che siano sottoposti a tassazione nei successivi esercizi e comunque entro il quarto. Fondo rischi = si tratta di passività potenziali che si riferiscono a costi di competenza dell’esercizio, non esattamente quantificabili, ma che si manifesteranno in un esercizio successivo (ad esempio costi per cause in corso o costi per interventi di garanzia).

84
Fondo spese future = sono passività per oneri a carico dell’esercizio, che si verificheranno in futuro, ma le cui esatte entità o date dell’esborso non sono note. Si tratta di costi che hanno un’elevata probabilità di sussistere; se la probabilità è bassa, essi ricadono nel fondo rischi. Fondo svalutazione crediti = posta rettificativi dell’attivo, iscritta a bilancio per tener conto del rischio di mancato incasso di crediti, addossando all’esercizio corrente perdite che possono verificarsi nel futuro. Il fondo svalutazione crediti deve essere portato in diminuzione diretta dell’importo dei crediti. IAS (International Accounting Standards) = sono i principi contabili internazionali che, per decisione dell’Unione Europea, sostituiranno i principi contabili nazionali. Sono emanati dall’apposito “board” (IASB) e devono essere ratificati dagli organismi europei. Hanno cambiato nome in IFRS (International Financial Reporting Standards). IASB (International Accounting Standards Board) = organo che emana gli IFRS (in precedenza IAS). IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation) = fondazione dalla quale dipende lo IASB. Immobilizzazioni immateriali = si tratta di beni che forniscono un’utilità protratta nel tempo (oltre 12 mesi) e sono intangibili, cioè non si possono toccare (es. marchi, brevetti). Immobilizzazioni materiali = si tratta di beni che forniscono un’utilità protratta nel tempo (oltre 12 mesi) e sono tangibili, cioè si possono toccare (es. impianti, macchinari, attrezzature). Imposta di bollo = sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 (ad es. atti notarili, scritture private, note di trascrizione, cambiali). L’imposta è dovuta fin dall’origine per alcuni atti (ad es. atti notarili), e solo in caso d’uso per altri (ad es. titoli di credito provenienti dall’estero). Imposta sostitutiva = imposta che sostituisce l’imposta sul reddito, per cui i proventi ad essa assoggettati non rientrano più nell’imponibile IRPEF e non figurano quindi nella dichiarazione dei redditi. Imposte dirette = imposte che colpiscono una manifestazione diretta ed immediata della capacità contributiva (= reddito e patrimonio). Imprenditore commerciale = è colui che esercita un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, un’attività bancaria o assicurativa, oppure altre attività ausiliarie delle precedenti (art. 2195 cod. civ.).

85
Impresa familiare = impresa gestita da parenti entro il terzo grado o affini (= parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge, es.: suoceri, generi, nuore, cognati) entro il secondo grado. I familiari sono collaboratori ed hanno diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili in rapporto al lavoro prestato. INAIL = acronimo di Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro: ente di diritto pubblico sorto nel 1933 per fornire ai lavoratori dipendenti l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il finanziamento dell’INAIL è a carico delle imprese e dello Stato. INPS = acronimo di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: è il più importante fra gli enti previdenziali, per numero di soggetti assistiti, per entità delle prestazioni, per varietà di eventi protetti e di casse e fondi amministrati. Ente di diritto pubblico, con propria personalità giuridica e attività esclusiva, svolge la sua azione, in forza di provvedimenti di legge, su tutto il territorio nazionale. Sono assicurati obbligatoriamente presso l’INPS tutti i lavoratori dipendenti privati che abbiano compiuto il 14^ anno di età e che non siano soggetti, per espressa previsione legislativa, ad altra forma assicurativa obbligatoria. L’Istituto trae il proprio finanziamento dal prelievo obbligatorio di contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (i contributi previdenziali che il datore di lavoro trattiene al lavoratore, per versarli all’INPS, si chiamano trattenute previdenziali) e, in parte, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Interpello = è la possibilità per il contribuente di chiedere all’Amministrazione Finanziaria come risolvere un caso personale quando è incerta l’interpretazione della normativa. IRPEF = Imposta sul reddito delle persone fisiche. Ha carattere personale (in quanto tiene conto delle differenti condizioni familiari in cui possono trovarsi le persone fisiche) e progressivo (in quanto, tassando in maniera più incisiva i redditi più alti, è un’imposta più che proporzionale). Colpisce il possesso di redditi in denaro o in natura, continuativi o occasionali, provenienti da qualsiasi fonte. I soggetti passivi, cioè i soggetti sui quali ricade l’obbligo di pagare l’imposta, sono le persone fisiche e i soci di società di persone (il cui utile viene imputato a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili stessi). L’IRPEF che il datore di lavoro – in qualità di sostituto di imposta - trattiene al lavoratore, per versarla allo Stato, prende il nome di trattenuta fiscale. IVA = acronimo di Imposta sul Valore aggiunto: imposta indiretta che colpisce, con carattere di generalità, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e le importazioni da chiunque effettuate. L’imposta sul valore aggiunto si applica sul prezzo del bene o sul corrispettivo del servizio. Aliquota IVA = per aliquota si intende tasso fisso o variabile, espresso solitamente da una misura percentuale, applicabile all’imponibile per la determinazione del tributo. Le aliquote IVA attualmente in vigore sono: 4% per i beni e i servizi indicati nella tabella A, parte seconda, riportata in appendice al D.P.R. n. 633/72 (ad es. latte, burro, frutta, ma anche libri e periodici e case di abitazione non di lusso); 10% per i beni e i servizi contenuti nella tabella A, parte terza, riportata in appendice al D.P.R. n. 633/72 (ad es. carne, uova, riso); aliquota ordinaria del 20% per i beni e i servizi non indicati nelle precedenti tabelle. Liquidazione periodica IVA = determinazione dell’IVA da versare all’erario o del credito

86
IVA nei confronti dell’erario, tramite differenza fra IVA a debito (Iva che ogni impresa riceve dal consumatore finale all’atto della vendita. È definita anche Iva sulle vendite) e IVA a credito (Iva che ogni impresa paga al momento dell’acquisto di un bene o servizio. Viene definita anche Iva sugli acquisti). La differenza positiva fra Iva a debito e Iva a credito deve essere versata dal contribuente con cadenza mensile o trimestrale. Possono optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA quei contribuenti che, nell’esercizio precedente, hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 309874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi, oppure inferiore a 516456,90 euro se effettuano cessioni di beni. Dichiarazione annuale IVA = dichiarazione annuale riepilogativa dei dati IVA, presentata obbligatoriamente dai soggetti passivi IVA. Dichiarazione di inizio attività ai fini IVA = quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all’Amministrazione finanziaria presentando un’apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società. Per effettuare tale dichiarazione si utilizza un modello diverso a seconda che si tratti di attività in forma di ditta individuale oppure in forma societaria. In entrambi i modelli è previsto un apposito quadro nel quale occorre indicare i dati relativi al soggetto depositario delle scritture contabili. All’atto della dichiarazione l’ufficio attribuisce la partita IVA. Acquisti ai fini IVA: imponibili, non imponibili, esenti, esclusi, estranei al campo di applicazione IVA = un’operazione imponibile ai fini IVA è un’operazione soggetta all’IVA: si tratta di un’operazione che realizza il presupposto di applicazione dell’IVA (vale a dire: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o arti e professioni e importazioni da chiunque effettuate). Le operazioni non imponibili sono operazioni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato: cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o connessi con l’esportazione. Le operazioni esenti riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi non assoggettate al pagamento dell’IVA per ragioni di carattere economico o sociale, oppure per esigenze di adeguamento alle normative comunitarie. Del lungo elenco di operazioni esenti (contenuto nell’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni) ci limitiamo ad indicare, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti: operazioni di credito e finanziamento, di assicurazione, di riscossione dei tributi, di trasporto pubblico di persone mediante vetture di piazza. Altre operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta per espressa previsione della legge, che intende agevolarle. E così, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n. 633/1972, non sono considerate cessioni di beni varie operazioni fra cui: cessioni di denaro o di crediti in denaro, cessioni e conferimenti di aziende, cessioni di terreni agricoli, cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari. Vi sono infine operazioni che non sono effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni, quindi sono estranee al campo di applicazione IVA. Fra le altre ricordiamo: cessioni di beni fra privati non imprenditori, cessioni di beni da privati ad imprenditori, cessioni di beni effettuate da imprenditori, quando non si tratti di beni inerenti all’impresa, prestazioni di servizi effettuate da persone che non sono esercenti abituali di arti o professioni. Lavoro autonomo = contratto di scambio a titolo oneroso con cui una persona (lavoratore autonomo) si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 del codice civile).

87
Leasing = contratto con il quale un’azienda cede in locazione ad un’altra azienda, per un periodo di tempo predeterminato e dietro il pagamento di un certo canone periodico, uno o più beni mobili o immobili. Il contratto può prevedere la possibilità che , alla scadenza del periodo di locazione fissato, il locatario (è colui che prende in locazione, mentre il locatore è colui che cede in locazione) riscatti il bene versando una somma ulteriore. Si distingue in genere tra leasing operativo, che ha per oggetto la locazione di beni strumentali per un periodo inferiore alla loro vita economica, e leasing finanziario, che è invece un’operazione di finanziamento attuata da un intermediario finanziario il quale acquista, sulla base delle indicazioni del cliente che lo utilizzerà, un bene che concede poi in utilizzo al cliente stesso, dietro versamento di un canone e con possibilità di riscatto finale. Magazzino = è rappresentato dagli investimenti non durevoli accumulabili in scorta, esistenti in un determinato istante. Prende anche il nome di “rimanenze” o “scorte”. Mercato regolamentato = mercato di strumenti finanziari, caratterizzati da un funzionamento regolare e disciplinati da un regolamento. Fra i più conosciuti mercati regolamentati, troviamo la Borsa e il mercato ristretto. Nota integrativa = è il terzo documento del bilancio. Essa si differenzia dallo stato patrimoniale e dal conto economico perché non è redatta in forma contabile, bensì discorsiva. La sua funzione è quella di facilitare la lettura delle altre due parti del bilancio. O.I.C. = Organismo Italiano di Contabilità, costituito, in veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001. Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre l’O.I.C., coordinando i propri lavori con le attività degli analoghi organismi europei, nel rispetto delle norme vigenti, fornisce il supporto tecnico per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. Partita doppia = metodo di rilevazione quantitativa degli aspetti finanziari e reddituali della gestione di impresa. In particolare, consiste nella registrazione simultanea del medesimo fatto, rispettivamente nella sezione Dare e nella sezione Avere di due conti. La partita doppia consente l’elaborazione di sistemi di scritture contabili, finalizzate a rilevare l’intero processo gestionale dell’azienda, mettendone in risalto gli aspetti più rilevanti, quali la formazione del reddito e le variazioni nella consistenza del patrimonio. Passività = insieme dei debiti liquidi (ad es. conti correnti bancari passivi), dei debiti in corso di formazione (ad es. debiti verso i fornitori) e dei valori attribuiti alle aspettative negative che gravano sulle attività (ad es. il fondo svalutazione crediti). A seconda della natura delle fonti di finanziamento, le passività possono essere distinte in capitale proprio (apporti dei soci, autofinanziamento derivante da utili accantonati a riserva e non distribuiti, utile di periodo) e in capitale di terzi (debiti verso terzi per i loro apporti). A seconda del tempo di rimborso, le passività possono essere distinte in passività correnti (debiti rimborsabili entro 12 mesi) e passività consolidate (debiti rimborsabili oltre 12 mesi).

88
Patrimonio netto (o mezzi propri o capitale proprio o equity) = è rappresentato dalla differenza fra le attività in essere in un determinato momento e le passività in senso stretto. È costituito da: capitale versato; riserve di utili (cioè ammontare di utili generati dalla gestione, ma non distribuiti ai soci); utili o perdite. Piccoli imprenditori = sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 cod. civ.). Plusvalenze e minusvalenze = sono i valori monetari ricavati in più (plus) o in meno (minus) rispetto ai valori netti contabili, dalla vendita o dall’estromissione dal processo produttivo di immobilizzazioni. Plusvalenze e minusvalenze da alienazione possono apparire, nel conto economico, sia tra i componenti ordinari che tra quelli straordinari. Posta elettronica certificata (P.E.C.) = strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. La P.E.C. aggiunge inoltre la certificazione circa il contenuto del messaggio. Principi contabili = sono regole per la realizzazione del bilancio, suggerite dalla dottrina ed elaborate dagli ordini professionali. Sono subordinate alle norme di legge, delle quali, spesso, rappresentano applicazioni o spiegazioni. Principio di competenza = principio di redazione del bilancio, indicato nell’art. 2423-bis cod. civ., il cui rispetto è necessario per una corretta e veritiera rappresentazione contabile della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Secondo tale principio, nella determinazione del risultato economico, si deve tener conto degli effetti delle operazioni gestionali che competono economicamente a ciascun esercizio, indipendentemente dal momento in cui di manifestano i relativi incassi e pagamenti. Ratei e risconti attivi = conti che traggono origine dallo sfasamento temporale tra eventi gestionali (acquisti, vendite, consumo di risorse) ed eventi finanziari (pagamenti, incassi, uscite). Essi devono rispettare il principio di competenza economica. I ratei attivi sono proventi la cui competenza economica si è sviluppata durante l’esercizio oggetto del bilancio, ma la cui esigibilità è rinviata ad esercizi successivi. I risconti attivi sono, invece, costi sostenuti nel corso dell’esercizio, ma di competenza operativa di esercizi successivi. Ratei e risconti passivi = anch’essi traggono origine dallo sfasamento temporale tra eventi gestionali (acquisti, vendite, consumo di risorse) ed eventi finanziari (pagamenti, incassi, uscite), ma sono assimilati a debiti in corso di liquidazione. I ratei passivi sono costi di competenza dell’esercizio, ma sono pagabili in esercizi successivi. I risconti passivi sono proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Reddito = differenza fra ricavi e costi (= risultato economico).

89
Registro delle imprese = registro previsto dagli artt. 2188 – 2194 cod. civ. nel quale devono essere iscritti gli imprenditori che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, o un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, o un’attività di trasporto, bancaria, assicurativa, o anche un’attività ausiliaria delle precedenti. Nel registro devono essere iscritte anche le società (anche cooperative) anche se non esercitano un’attività commerciale, nonché gli enti pubblici che hanno oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale. In una sezione speciale del registro devono essere iscritti anche gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici e gli artigiani. Lo scopo dell’iscrizione è di rendere noti ai terzi i dati essenziali relativi alle imprese. L’ufficio del registro delle imprese è istituito presso la camera di commercio. Registro di prima nota = la prima nota è una scrittura elementare cronologica che, traendo i dati dai documenti originari, elenca in ordine di tempo e senza particolari regole le operazioni aziendali man mano che vengono compiute. Retribuzione = oggetto fondamentale dell’obbligazione del datore di lavoro in conseguenza dell’espletamento, da parte del dipendente, di prestazioni lavorative aventi carattere subordinato. Ricavi = elementi che concorrono ad incrementare il reddito di impresa (per tale motivo vengono anche definiti componenti positivi di reddito). Sono principalmente i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Ricevuta fiscale = documento riguardante operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, che può essere emesso dagli stessi soggetti obbligati all’emissione dello scontrino. Tali soggetti, quindi, possono liberamente scegliere il modo in cui documentare i corrispettivi percepiti nell’esercizio della propria attività: tramite scontrino o ricevuta. Riserva di rivalutazione monetaria = contropartita della rivalutazione delle immobilizzazioni, autorizzata o imposta da norme di legge per adeguare i valori di bilancio al mutato valore economico della moneta. Riserva sovrapprezzo azioni = somme fatte pagare ai soci in occasione degli aumenti di capitale sociale, rispetto al valore nominale delle quote o delle azioni che vengono emesse in relazione agli aumenti stessi. Riserve di utili = accolgono quote di utili che non vengono distribuite ai soci o per disposizione di legge (riserva legale) o per disposizione statutaria (riserva statutaria o ordinaria), oppure per libera decisione dei soci (riserva facoltativa o straordinaria). Si tratta di fonti di finanziamento interne, destinate, di norma, a rimanere durevolmente a disposizione della società. Rientrano nel concetto di autofinanziamento.

90
Scheda carburante = la scheda carburante, relativamente all’acquisto di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela di carburante e lubrificante, gas metano e Gpl) effettuato presso impianti stradali di distribuzione da soggetti titolari di partita IVA, è un documento sostitutivo della fattura, in quanto quest’ultima, salvo rare eccezioni, non può essere emessa dagli impianti stradali di distribuzione. Scontrino fiscale = documento che può essere emesso, esclusivamente tramite apparecchio misuratore fiscale a norma di legge, in sostituzione della fattura, da soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (commercianti al minuto) o che prestano servizi in locali aperti al pubblico (es.: alberghi, ristoranti, bar, parrucchieri) o che, più in generale, si pongono in rapporto immediato e diretto con il privato consumatore. Scritture contabili = determinazioni quantitative di fenomeni economico-aziendali. Scritture di assestamento = scritture contabili redatte a fine esercizio, allo scopo di apportare alla contabilità le rettifiche derivanti dall’applicazione del principio di competenza nella registrazione contabile di costi e ricavi. Sezione DARE e sezione AVERE = le parole “dare” ed “avere” non hanno alcun significato preciso. Quindi non significano assolutamente “dare qualcosa” o “avere qualcosa”. Tali termini sono il risultato di una tradizione storica e rappresentano delle convenzioni che semplicemente significano “a sinistra” (dare) oppure “a destra” (avere) di un determinato conto. Quest’ultimo è quindi suddiviso in due sezioni. Occorre considerare il dare e l’avere in termini “quasi matematici”. Sistema informativo aziendale = insieme di uomini, macchine e procedure per il trattamento delle informazioni rilevanti per l’attività decisoria in specifiche aree dell’azienda. Ne fanno parte tutte le fasi di acquisizione, elaborazione, circolazione, archiviazione, reperimento dei dati. I dati possono provenire da fonti esterne oppure interne. Essi inizialmente passano attraverso rilevazioni elementari e statistiche (sistema informativo elementare). Successivamente, ad un secondo livello (sistema informativo contabile), vengono effettuate le rilevazioni contabili, che hanno come output la contabilità generale e il bilancio. Infine, ad un terzo livello (si tratta del sistema informativo integrato) vengono effettuate le rilevazioni di contabilità direzionale e d analitica, che servono come input per il sistema dei budget, il quale – a sua volta – è una componente del più ampio sistema di programmazione e controllo. Società di capitali = società per azioni (S.p.a.), società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), società a responsabilità limitata (S.r.l.). In tali società sono collocati in primo piano il capitale sociale, il patrimonio e il consiglio di amministrazione. I soci non sono mai responsabili dei debiti della società, dei quali risponde solo quest’ultima, con il suo patrimonio. La partecipazione alla società è rappresentata da azioni o quote liberamente commerciabili.

91
Società di persone = società semplice (S.s.), società in nome collettivo (S.n.c.), società in accomandita semplice (S.a.s.). In tali società il gruppo dei soci è costantemente in primo piano: i soci amministrano la società e rispondono personalmente e in maniera solidale e illimitata delle obbligazioni assunte dalla società. Sostituti di imposta = sono coloro che, per conto del contribuente, trattengono – dalle somme che devono corrispondergli – le imposte da lui dovute e le versano al fisco (es.: il datore di lavoro e l’ente pensionistico, che trattengono le tasse da stipendi e pensioni). Stato patrimoniale = prospetto contabile nel quale viene rappresentato, in un dato istante, il valore dell’insieme dei mezzi che l’impresa ha a disposizione e che impiega per lo svolgimento dell’attività aziendale. Lo stato patrimoniale è uno schema a due sezioni contrapposte: attività e passività. Statuto del contribuente = è la legge n. 212 del 27 luglio 2000. Studi di settore = studi relativi ai vari settori economici. Gli studi di settore si pongono l’obiettivo di individuare le condizioni effettive di operatività delle imprese, e di determinare i ricavi e i compensi che, con ragionevole probabilità, possono essere attribuiti ai contribuenti. Ciò viene realizzato attraverso la rilevazione di caratteristiche strutturali di ogni specifica attività economica, realizzata mediante la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale e di elementi che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui la medesima si svolge.

92
QUIZ DI VERIFICA FINALE
1) Un’entrata di cassa va collocata nella sezione: a) Dare b) Avere c) Non è una variazione numeraria
2) Uno storno di costi va collocato nella sezione: a) Dare b) Avere c) Non si tratta di una variazione economica
3) Una diminuzione di capitale netto è: a) una variazione numeraria attiva b) una variazione economica negativa c) una variazione economica passiva di capitale
4) I macchinari sono costi pluriennali, dunque vanno collocati: a) fra i costi del conto economico b) fra le attività dello stato patrimoniale c) non hanno collocazione in bilancio
5) L’utile d’esercizio va collocato: a) sia nel conto economico che nello stato patrimoniale b) soltanto nel conto economico c) soltanto nello stato patrimoniale
6) Debiti verso Fornitori nella sezione Avere significa: a) che abbiamo pagato un debito b) che abbiamo firmato un contratto con il fornitore c) che abbiamo ricevuto una fattura da un fornitore
7) L’IVA indetraibile: a) è un costo che si aggiunge al costo sostenuto per l’acquisto di un bene b) non va contabilizzata c) va contabilizzata con il conto “IVA indetraibile”
8) La ritenuta d’acconto: a) riguarda tutti i contribuenti b) riguarda i lavoratori autonomi c) riguarda i lavoratori dipendenti
9) “Cassa” nella sezione Dare e “Crediti verso clienti” nella sezione Avere significa: a) che l’azienda ha incassato in contanti un credito verso clienti b) che l’azienda ha pagato in contanti un credito verso clienti c) che l’azienda ha emesso una fattura al cliente
10) “Banca X c/c” nella sezione Dare e “Mutui passivi” nella sezione Avere significa: a) che l’azienda ha pagato un mutuo passivo tramite c/c bancario b) che la banca ha incassato dall’azienda un mutuo passivo c) che l’azienda ha ottenuto dalla banca un mutuo passivo.

93
SOLUZIONI
Quiz di verifica Capitolo I
1) C 2) A 3) B 4) C 5) B 6) A 7) C 8) B 9) C 10) B
Quiz di verifica Capitolo II
1) A 2) B 3) C 4) B 5) A 6) C 7) B 8) C 9) A 10) C
Quiz di verifica Capitolo III
1) C 2) B 3) A 4) B 5) B 6) C 7) A 8) B 9) C 10) B

94
Quiz di verifica Capitolo IV 1) A 2) B 3) C
4) B 5) A 6) C 7) A 8) C 9) A 10) B
Quiz di verifica finale
1) A 2) B 3) C 4) B 5) A 6) C 7) A 8) B 9) A 10) C

95
BIBLIOGRAFIA AA.VV. – “Enciclopedia dell’Economia” – Garzanti Libri, Torino 2001 AA.VV. – “Ipercompendio di economia aziendale” – Edizioni Simone, Gruppo Editoriale Esselibri Simone, Napoli 2005 AA.VV. – “L’albo unico di dottori commercialisti ed esperti contabili” – Guida giuridico normativa di Italia Oggi – Italia Oggi, Milano 2005 AA.VV. – “Le aree funzionali dell’impresa” – G. Giappichelli Editore, Torino 1980 AA.VV. – “L’Enciclopedia dell’Economia” – Istituto Geografico De Agostini, Novara 1998 Alberti Luciano – “ABC della partita doppia” – Edizioni Fag, Milano 2004 Antonelli Valerio, D’Alessio Raffaele (a cura di) – “Summa contabile 2009” – Edizioni Il Sole 24 ore, Milano 2009 Anthony Robert N., Breitner Leslie K., Macrì Diego M. – “Il bilancio: strumento di analisi per la gestione“ – McGraw-Hill, Milano 2004 Balestri Gianfranco (a cura di) – “Manuale di economia e gestione aziendale” – Editore Ulrico Hoepli, Milano 2005 Balducci Daniele – “Tenere la contabilità” – Edizioni Fag, Milano 2010 Bauer Riccardo – “Codice civile – Norme tributarie – Principi contabili” – Novecento Media editrice, Milano 2010 Campra Maura, Cantino Valter – “Contabilità e bilancio d’esercizio – casi ed esercizi” – G. Giappichelli Editore, Torino 2000 Caputo Walter – “Appunti per un corso base di contabilità e bilancio” – lavoro realizzato per Euroscuole e non pubblicato – Torino 2005 Caputo Walter – “Casi svolti di contabilità e bilancio” – Finanze & Lavoro, Gruppo Editoriale Esselibri Simone, Napoli 2007 Caputo Walter – “Casi svolti di paghe e contributi – 3° edizione 2008”- Finanze & Lavoro, Gruppo Editoriale Esselibri Simone, Napoli 2008 Caputo Walter – “Corso base Controllo di gestione – 2° edizione 2009”- Finanze & Lavoro, Gruppo Editoriale Esselibri Simone, Napoli 2009 Caputo Walter – “Corso base di contabilità e bilancio – 5^ edizione 2010”- Finanze & Lavoro, Gruppo Editoriale Esselibri Simone, Napoli 2010

96
Caputo Walter – “L’analisi per flussi e il rendiconto finanziario” – Finanze & Lavoro, Gruppo Editoriale Esselibri Simone, Napoli 2009 Caputo Walter – “Paghe e contributi – 5^ edizione 2009”- Finanze & Lavoro, Gruppo Editoriale Esselibri Simone, Napoli 2009 Caputo Walter – “TFR 2007 – Cosa cambia e cosa fare”- Finanze & Lavoro, Gruppo Editoriale Esselibri Simone, Napoli 2007 Caridi Antonino – “Il sistema aziendale: obiettivi e strategie” – Libreria editrice universitaria Levrotto & Bella, Torino 1989 Caruso Eugenio – “Come preparare e leggere un bilancio” – Tecniche Nuove Editrice, Milano 2007 Diaz Salvatore – “Professione skipper – Imprenditori & Imprenditivi” – Somedia, Milano 1993 Marchi Luciano (a cura di) – “Introduzione all’economia aziendale – Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale” – G. Giappichelli editore, Torino 2001 O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) – “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS / IFRS) / Ottobre 2005 – allegato a “Il Sole 24 ore Guida ai principi contabili internazionali” anno II, n. 10 – Il Sole 24 ore, Milano 2005 Pisoni Piero, Bava Fabrizio, Busso Donatella – “Il bilancio d’esercizio – dopo la riforma societaria e fiscale, verso gli IAS/IFRS e Basilea 2” – Euroconference Editore, Verona 2004 Roncher Armando, Merighi Igor, Roat Enrico – “Documenti di rilevazione contabile” – Seac editore, Trento 2009 Rossetto Sergio – “Manuale di economia e organizzazione d’impresa – Teorie e tecniche” – Edizioni UTET, Torino 2001 Savioli Giuseppe – “I principi contabili internazionali” – Giuffré editore, Milano 2008 Singh Simon – “L’ultimo Teorema di Fermat” – Bur Rizzoli editore – 16° edizione – Milano, febbraio 2009 Zambon Paola, Rotondaro Walter – “Manuale pratico del bilancio IAS / IFRS – Con casi aziendali risolti” – Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2007

97