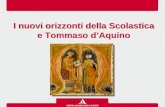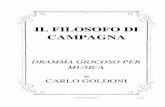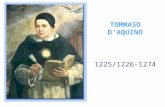Coccia -- Canonizzare Il Filosofo San Tommaso d’Aquino
-
Upload
umberto-martini -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
Transcript of Coccia -- Canonizzare Il Filosofo San Tommaso d’Aquino
-
8/18/2019 Coccia -- Canonizzare Il Filosofo San Tommaso d’Aquino
1/7
Secondo la procedura canonica, la mattina di giovedì14 luglio 1323 fu convocato nel palazzo papale di Avi-gnone un pubblico concistoro, in cui accorsero il papa
nel costume concistoriale, ovvero con un mantello o un pi-viale rosso, e la mitria aurifrigiata con perle, e tutti i car-dinali ed i prelati in veste comune, ovvero con le cappe dilane.
A prendere per primo la parola fu Giovanni XXII,
uno dei più geniali, colti e contestati pontefici della sto-ria del cristianesimo. Egli aprì il suo sermone, pronun-ciato «tenendo in capo la mitria, come vuole il costu-me», con una citazione del secondo Libro dei re: oggi è
giorno di buone notizie, e noi tacciamo. Si apriva così lacerimonia di canonizzazione di Tommaso d’Aquino.
Nato attorno alla metà degli anni venti del xiii se-colo presso Roccasecca – nel regno delle Due Sicilie, maal confine tra la zona di influenza del papa e quella del-l’imperatore –, nel 1244 questi era entrato, contro il pa-rere dei genitori, nell’ordine dei frati predicatori. Dopo
avere iniziato gli studi a Napoli e avere passato proba-bilmente qualche anno a Parigi, aveva raggiunto a Co-lonia Alberto Magno, il primo e il più originale degli ari-stotelici scolastici, divenendone l’allievo prediletto. FuAlberto a suggerire il suo nome a Giovanni Teutonico,ministro generale dell’ordine, che cercava un baccalau-reato a cui affidare l’insegnamento di teologia a Parigi.A partire da quel momento la vita di Tommaso si sareb-be confusa gradualmente con la storia della teologia e del-l’aristotelismo parigino. La sua fama di filosofo e teolo-go si era velocemente diffusa ovunque in Europa, e ave-
va resistito alla sua morte, avvenuta sulla via per il con-cilio di Lione nel 1274.«Questo glorioso erudito professore ha illuminato la
chiesa più di chiunque altri, dopo gli apostoli e i dotto-ri», avrebbe detto Giovanni XXII, stando a uno deglianonimi testimoni della celebrazione. Fra le otto auto-rità che presero la parola il giorno della canonizzazione– racconta un altro testimone oculare, il frate domeni-cano Bencio – vi fu anche il re di Napoli Roberto d’An-giò, arrivato appositamente ad Avignone assieme alla
sua consorte per partecipare alla cerimonia. Bencio rac-conta come alla fine dell’intervento Roberto si fosse ad-dirittura inginocchiato per supplicare che venisse iscrit-to nel catalogo dei santi un così grande erudito, nutritodi tanta santità e rivestito, soprattutto, di una tale fa-ma. Nella procedura di canonizzazione (che proprio Gio-vanni XXII contribuì a definire e a rendere meno flui-da) il ruolo della fama e della gloria del candidato era ineffetti estremamente importante. Secondo la definizio-
ne canonica che ne darà Enrico di Ostia si diceva infat-ti santo «colui che va venerato non solo da qualcuno mada tutti, non solo in una chiesa ma in tutte e in modouniversale».
La canonizzazione era un giudizio solenne – espres-so ufficialmente dalla massima autorità religiosa, il pon-tefice – avente per oggetto la legittimità e l’universalitàdella fama di un uomo, e dunque la venerazione che glisi doveva. Del resto, se la santità di una vita trovava lasua prova più evidente nel miracolo, il miracolo di undefunto poteva essere provato solo per via indiretta e
per testimonianza. Nel diritto di allora la fama era ap-punto uno dei gradi della prova nel diritto processuale.Fama, scriveva ad esempio Tommaso da Piperita, è
quello che gli uomini di una qualche città o di un castelloo di un vicinato o di una contrada pensano in modo co-mune e sentono e pensano affermando qualcosa senza po-terla ritenere certa, vera ed evidente.
Per questo l’inchiesta preliminare (la cosiddetta in- formatio in partibus) che precedeva il giudizio dovevamettere alla prova la veridicità della reputazione del mor-
to, la fondatezza della sua celebrità: il valore della suafama. E perciò i testimoni venivano spesso interrogatisu cosa intendessero per «fama pubblica», per «voce co-mune», per «opinione della gente». Iscrivere Tommasod’Aquino nel registro dei santi significava dunque con-fermare la sua fama o, più maliziosamente, appoggiarlae alimentarla ufficialmente.
Ma in quel luglio del 1323 stava accadendo qualco-sa di ancora più importante: di là dall’eventuale giudi-zio sulla figura di Tommaso e sulla fortuna della sua ope-
Avignone, 14 luglio 1323Canonizzare il filosofo: san Tommaso d’Aquino
papa giovanni xxii celebra la canonizzazione di tommaso d’aquino. lasantità per meriti di studio del maestro tommaso. odio e invidia: fran-cesco petrarca e l’accademia. aristotele, il filosofo dei nuovi poeti.la peculiarità italiana: accademici e scrittori. il divorzio di petrar-ca dalla filosofia, o la letteratura ai letterati. diventare la pro-pria fama
23_Coccia.qxp 29-07-2010 17:28 Pagina 162
-
8/18/2019 Coccia -- Canonizzare Il Filosofo San Tommaso d’Aquino
2/7
ra, quei giorni costruivano un evento destinato a muta-re gli equilibri millenari tra sapere e vita. L’esistenza diTommaso non era certo stata quella di un vescovo o diuna persona comune, «di una qualsiasi pia vecchietta,di un pescatore, di un devoto pastore o di un contadi-no». Colui che era stato eletto a esempio, a norma del-la massima gloria cui ogni uomo può aspirare, era un in-tellettuale, e la sua eccellenza risiedeva innanzitutto nelsapere e non in opere, azioni. O meglio, scrivere di teo-logia sembrava ora quasi coincidere coll’operare mira-coli. «Sono stati registrati non meno di trecento miraco-
li, – sembra abbia detto Giovanni XXII a proposito diTommaso, – e il numero dei suoi miracoli è pari agli ar-ticoli che ha scritto».
Secondo le parole di un testimone lontano come Gio-vanni Villani, santo era diventato allora un «maestro indivinità e in filosofia, e uomo eccellentissimo di tutte lescienze, e che più dichiarò le sacre Scritture che uomoche fosse da santo Agostino in qua». Tommaso era il pri-mo professore parigino, il primo vero dotto, a raggiun-gere questo titolo, come si direbbe oggi, per soli meritidi studio. Tommaso di Cantelupe, vescovo di Hereford,
e docente per qualche anno all’Università di Oxford, erastato canonizzato qualche anno prima, ma non certo perla sua fama di studioso. Giovanni XXII aveva espressa-mente sottolineato questo aspetto nel suo sermone ini-ziale, e lo avrebbe ribadito nella bolla di canonizzazio-ne, emessa il 18 luglio. Quali siano state le complesse ra-gioni politiche e strategiche che portarono il ponteficedapprima a proporre all’ordine dei predicatori di cano-nizzare uno dei suoi membri, poi a concentrare la suascelta su Tommaso, le conseguenze e la portata di que-sto gesto sono difficilmente sottovalutabili. Santo, os-
sia legittimamente famoso, degno di essere universal-mente venerato, era ora un teologo, e un aristotelico, an-zi colui che in modo più acceso si era battuto per libe-rare Aristotele dalle sovrainterpretazioni arabe e neo-platoniche: e questo poco più di un secolo dopo le bol-le con le quali Gregorio IX aveva proibito lo studio deilibri naturales dello stesso Aristotele.
Alla vera e propria cerimonia di canonizzazione, ce-lebrata lunedì 18 luglio, mancava uno dei più importantiseguaci di Tommaso: il maestro di teologia Erveo di Né-dellec, ministro generale dell’ordine, il quale dopo aver
presieduto il capitolo generale a Barcellona nel mese dimaggio, si era dovuto arrestare sulla via del ritorno ver-so Avignone, a Narbonne, a causa di una malattia che loavrebbe portato alla morte qualche settimana dopo. Inquei giorni di luglio era assente da Avignone anche co-lui che diverrà uno dei più celebri abitanti della città,«famoso per il suo stile di vita e la sua erudizione, af-fermatosi con enorme fama in tutto il mondo». France-sco Petrarca era infatti rientrato a Bologna nell’autun-no del 1322, assieme al fratello Gerardo, per seguire le-
zioni di diritto, interrotte a causa dei disordini dell’an-no precedente. Ad Avignone, Petrarca era arrivato giàdurante l’adolescenza (ab ipsa pueritia), ci informa Boc-caccio. A Bologna, invece, egli si trattenne fino all’in-verno del 1324, quando fu richiamato in Provenza.
Sono celebri le parole acrimoniose che Petrarca ri-serva alla felsinea città dei suoi studi, e che sono conte-nute in una lettera a Giovanni d’Andrea (il più grandecanonista del tempo, che Petrarca stesso riconosce co-me «famosissimo» e definisce in tono adulatorio: «uni-co, senza pari nei nostri tempi, principe delle lettere, a
cui è dedito»). Tali parole non riflettono tuttavia l’in-tera verità dell’esperienza universitaria di Petrarca e,come tutte le sue affermazioni autobiografiche, sono ilfrutto di una sapiente opera di mistificazione. In unalettera scritta in vecchiaia all’amico Guido Settimo, eglisi sarebbe compiaciuto di rievocare «con la memoria itempi andati», ricordando come – passato da Montpel-lier a Bologna – non potesse impedirsi di considerarequest’ultima «il luogo più bello e più libero che si po-tesse trovare nel mondo intero». A colpire la sua im-maginazione era stata, oltre all’affluenza degli studenti
e all’ordine delle lezioni, «la maestà dei professori, chea vederli parevano gli antichi giureconsulti». Eppure,all’accusa che Giovanni d’Andrea gli aveva rivolto diavere abbandonato sul più bello i suoi studi di giuri-sprudenza, come un disertore lascia cadere il suo vessil-lo, Petrarca ribatteva in maniera stizzita.
O non ho fatto davvero nulla di coscienzioso in vitamia (il che è più probabile) o se ho fatto qualcosa non miarrischio a dire, di saggio, ma almeno di felice in vita miaè proprio il fatto di aver visto Bologna ma di non essercirestato.
Con ogni probabilità, se anche si fosse trovato adAvignone nel luglio del 1323, Petrarca avrebbe comun-que evitato la cerimonia di canonizzazione. Il suo at-teggiamento nei confronti dell’università e della classeaccademica fu sempre ambiguo: marcato da odio e in-vidia, per certi versi, e da un curioso spirito di concor-renza, per molti altri. Una volta «dato il bando ai libridi giurisprudenza» e ritornato «agli studi prediletti», glieventi veramente importanti nella vita avignonese di-vennero ai suoi occhi, apparentemente, altri. Scriverà
molti anni dopo al fratello, rievocando il periodo avi-gnonese:Ti ricordi tutta la nostra folle ansietà per la smodata
eleganza del vestire (del resto non mi ha ancora abbando-nato)? […] E ricordi tutto il nostro affaccendarsi nel cam-biarci da mattino a sera, e quante paure per un capelloscomposto in testa, quale angoscia che un lieve soffio divento potesse scompigliare l’acconciatura faticosamenteottenuta? E ti ricordi con quale attenzione evitavamo ognianimale che potesse sorprenderci in modo da evitare che
Canonizzare il filosofo: san Tommaso d’Aquino 163
23_Coccia.qxp 29-07-2010 17:28 Pagina 163
-
8/18/2019 Coccia -- Canonizzare Il Filosofo San Tommaso d’Aquino
3/7
un qualche schizzo di fango potesse sporcare il nitore del-le nostre vesti o che l’urto di un’altra persona potessesgualcirne le pieghe profumate?
A fronte di parole come queste di Petrarca, riescedifficile pensare una figura e una sensibilità più distan-ti dalla sobria e misurata serietà di cui narrano le bio-grafie romanzate di Tommaso d’Aquino. A separare i dueuomini era anzitutto una differente relazione al sapere.Da una parte c’è un uomo, Tommaso, che ha passato lasua vita a insegnare; che, si racconta, riusciva a inter-rompere lo studio e la scrittura soltanto per dormire, ce-lebrare messa e mangiare, o che si bruciava su una can-dela perché distratto dai propri sillogismi sulla Trinità,o svegliava di notte i suoi segretari per poter dettare infretta e furia qualche pensiero appena concepito. Dall’al-tra parte c’è un uomo, Petrarca, che ha frequentato l’u-niversità senza grande successo; e che si lamenta, in unalettera a Luca della Penna, di avere «non dico spesi, maal tutto sprecati sette anni» nello studio del diritto ci-vile e a «imparare quanto dispongono le leggi a propo-sito di comodato mutuo, e testamento, e tutti i codicil-li a proposito di predi rustici e urbani». Da una parte,uno dei campioni riconosciuti dell’aristotelismo univer-sitario; dall’altra, chi non smetterà mai di esprimere congusto il proprio disprezzo per «gli accademici», che
filosofano nelle cattedre, ma impazziscono nelle azioni,comandano agli altri, ma sono i primi a contravvenire aipropri comandi, i primi a derogare le leggi che hanno ema-nato.
È importante sottolineare come il dileggio petrar-chesco si sia concentrato insistentemente proprio sul-la figura di Aristotele. «Ho letto tutte le opere moralidi Aristotele, ne ho persino sentito spiegare qualcuna»,scrive Petrarca nel De sui ipsius et multorum ignorantia, ma
oso affermare […] che ne sapeva così poco della vera feli-cità che una qualsiasi pia vecchietta o un pescatore o undevoto pastore o un contadino potrebbero essere non di-co più sottili nell’analizzarne il concetto, ma più capaci ditradurlo in pratica.
L’errore di Aristotele («grand’uomo e molto sapien-te, ma pur tuttavia un uomo appunto che dunque ben
poteva ignorare varie cose se non addirittura molte») eraquello di non avere mai «tenuto la promessa che metteall’inizio del primo capitolo dell’Etica, secondo cui sideve apprendere questa parte della filosofia non per di-venire più sapienti, ma per diventare migliori».
Nel disprezzo che Petrarca nutre per Aristotele, «an-dato completamente fuori strada, come si dice, anche inargomenti della massima importanza che toccano il pro-blema della nostra salvezza eterna», non si esprime sol-tanto la distanza da Tommaso. La sua crociata antiari-
stotelica risentiva anche del clima proprio dell’Universi-tà di Parigi, dove pure si era soliti esprimere giudizi piùmisurati nei confronti del filosofo greco. Le parole ec-cessivamente elogiative dei commenti di Averroè su Ari-stotele, per cui «nessuno di coloro che lo hanno seguitofino ad oggi ha aggiunto qualcosa, né si trova nelle sue pa-role un errore di qualsiasi grandezza», erano controbi-lanciate da critiche di eguale intensità, e sostenute pro-prio dal genere di argomenti di cui si avvaleva Petrarca.In quegli stessi anni Francesco di Meyronnes, teologofrancescano vicino a Duns Scoto, avrebbe definito Ari-
stotele come un pessimo metafisico: attraverso Bona-ventura ed Egidio Romano, Gilberto di Tournay e Ni-cola d’Autrecourt, la critica agli errori di Aristotele eradivenuta e avrebbe continuato a essere un vero e pro-prio luogo comune della scolastica medievale.
D’altronde, l’ammirazione per le opere aristotelichenon era un fenomeno esclusivamente parigino, né era li-mitato ai «fumosi sofisti» che popolavano le università:così come il titolo di «aristotelico» non spettava solo amedici o a filosofi, né era l’esclusivo appannaggio degliaccademici di vicolo degli Strami, nel quartiere della
Sorbona. Aristotelici, nel senso tecnico della parola, era-no sicuramente i “poeti” Dante e Cavalcanti (che Boc-caccio definirà innanzitutto «ottimo loico e buon filo-sofo»). Profondamente influenzati dalla filosofia natu-rale aristotelica erano Pietro Torregiano, medico pro-veniente dalla scuola bolognese di Taddeo Alderotti, dicui si conservano dotti sonetti sulla malattia d’amore,così come Cecco d’Ascoli, professore a Perugia e autoredi uno splendido poema sulla natura del mondo (l’ Acer-ba), che la critica moderna ha definito una «anti-Com-media». Aristotele era autore – ovvero «degno di fede e
d’obedienza», secondo le parole che Dante riprende daUguccione – per la quasi totalità dei letterati di tutto ilxiii e dell’inizio del xiv secolo. Lo stesso Dante non esi-tava a definire Aristotele «maestro e duca de la ragioneumana in quanto intende a la sua finale operazione».
La letteratura italiana delle origini, molto prima e inmodo più naturale di quanto i letterati rinascimentali ri-vendicheranno come propria marca, non ha mai distin-to filosofia e letteratura: proprio come non si è curata didistillare la poesia dalla scienza, e ha sempre fuso in unmedesimo sapere l’uso retorico della parola, la cura del-
lo stile e la prassi politica. Per questo la canonizzazionedel teologo Tommaso d’Aquino, nell’Avignone del 1323,rappresenta per la storia della letteratura italiana unevento altrettanto decisivo di quanto sia stato il gestodegli scribi anonimi che hanno vergato, nel manoscrit-to oggi conosciuto come Vaticano latino 3793, la piùstraordinaria antologia della poesia volgare italiana delxiii secolo. Sarebbe ingenuo parlare semplicemente del-l’assenza di una netta separazione disciplinare. Si trat-ta di un’articolazione di saperi, stili e pratiche lettera-
164 Avignone, 14 luglio 1323
23_Coccia.qxp 29-07-2010 17:28 Pagina 164
-
8/18/2019 Coccia -- Canonizzare Il Filosofo San Tommaso d’Aquino
4/7
rie del tutto inedita, sconosciuta alle culture coeve. Sipotrebbe dire che – con la sola eccezione di FrancescoPetrarca – fino al xv secolo la figura del poeta italianosia stata inseparabile da ogni altra figura del sapere e delpotere, e che non sia mai esistita in forma separata.
Si dimentica troppo spesso che i primi “monumen-ti” della letteratura italiana, prodotti nel circolo illumi-nato della corte duecentesca di Federico II, erano il frut-to di funzionari addetti alla redazione di privilegi o didiplomi, o preposti a più generici compiti di amministra-zione. Giacomo da Lentini, salutato dalla critica moder-
na come l’inventore del sonetto, e come la figura più emi-nente della “scuola siciliana”, era protonotarius. Pier del-la Vigna fu dapprima notaio, poi «magne imperialis cu-rie iudex», poi logoteta e infine «imperialis aule proto-notarius». Dette un contributo notevole alla redazionedelle Costituzioni di Melfi e lasciò nel suo epistolario lati-no uno degli esempi più alti dell’ars dictandi medievale.Né si tratta di esempi isolati. Prima dell’invenzione del-l’idea di un letterato puro, inviso a qualsiasi altro gene-re di sapere e di scrittura che non sia la celebrazione disé o della propria esperienza psicologica, la cura delle
lettere italiane non aveva mai avuto problemi di limiti.Anche Guido Guinizzelli era stato iudex a Bologna.Sempre a Bologna, dal 1322, Cecco d’Ascoli fu let-
tore di astrologia, mentre Cino da Pistoia – il poeta piùvicino a Dante, che ha fortemente influenzato lo stessoPetrarca – vi studiò diritto con Dino del Mugello; eglistudiò forse anche a Orléans e divenne dopo il 1313 unodei più celebri professori di diritto della penisola, con-teso tra le università di Bologna, Siena e Perugia. La fu-sione di saperi, di competenze e di ambiti apparente-mente separati rendeva ovvio non soltanto il fatto che
il letterato coincidesse “soggettivamente” con lo scien-ziato o il giurista, ma anche l’uso per il quale il diritto ola scienza medica potessero impegnarsi a spiegare e com-mentare opere “letterarie”. Tra il 1342 e il 1355 Barto-lo da Sassoferrato, che dal 1328 al 1333 aveva ascoltatole lezioni di diritto di Cino a Perugia, compose un com-mento ai versi danteschi Le dolci rime d’amor ch’io solea,a discussione del titolo De dignitatibus del Codex di Giu-stiniano. E Dino del Garbo, medico allievo di Taddeo Al-derotti e amico di Albertino Mussato, aveva compostoanni prima un commento alla canzone Donna me prega
(ne conserviamo ancora la copia vergata dalla mano diBoccaccio) in cui si prefiggeva di spiegare «ciò che il poe-ma dice in modo scientifico e verifico, tratto dai co-mandamenti della scienza naturale e morale».
Per ragioni storiche, legate innanzitutto alla diversasituazione politica, ma anche alla differente articolazio-ne accademica dei saperi rispetto alla Francia, la cultu-ra italiana del xiii e del xiv secolo si era prodotta a par-tire da una composizione dei saperi e delle pratiche discrittura assolutamente originale: giuristi e letterati, me-
dici e poeti, capaci non solo di scrivere trattati nell’unae nell’altra disciplina ma anche di farle dialogare. Il dia-logo di letteratura e saperi, la profondità del legame trascienza e poesia coincideva con la fittissima rete di re-lazioni che ognuno di questi giuristi, medici, notai e fi-losofi intratteneva con gli altri. La critica più recentenon ha mancato di notare che «una parte considerevo-le della poesia italiana del Medioevo è poesia di corri-spondenza». Sulla traccia di un celebre saggio di LuigiValli, si è sempre immaginata la letteratura italiana «del-le origini» come un «gruppo molto serrato di persone in
rapporto tra loro», poeti decadenti e «gelosi», cheparlano continuamente, loquacemente tra loro, comuni-candosi di continuo impressioni e sentimenti e soprattut-to visioni con formule e parole che hanno, guardando al-la superficie, un’impressionante monotonia.
La facile trasformazione della poesia in versi desti-nati a un destinatario non definisce però una licenza poe-tica, né articola una retorica dell’esoterismo: essa è ilcorrelato stilistico della comune esperienza di uno scam-bio intellettuale che supera i limiti di discipline, gram-
matiche, stili e ambiti di ricerca. L’idea stessa di unanetta separazione tra il sapere e la letteratura, tra scien-za e narrazione, tra poesia e filosofia, era a quell’epocauna macchinosa astrazione. Le ordinarie competenze“letterarie” erano di per sé aperte ad altre forme di co-noscenza. Il giudice e banchiere padovano Antonio daTempo, autore del più importante trattato di metricavolgare (la Summa artis rithimici vulgaris dictaminis), so-steneva che senza una buona conoscenza delle arti e del-le scienze non si può essere un buon poeta. LeonardoBruni ripeterà più tardi che grande poeta è colui che è
capace di riunire in sé una grande tecnica immaginativa(ars imaginandi), l’eleganza nell’espressione (oris elegan-tia) e una erudizione sicura in diverse discipline (multa-rum scientia).
Se i saperi che, altrove, erano riservati ai soli culto-ri accademici, costituivano in Italia il comune patrimo-nio di un qualunque letterato (cioè di chiunque sapessescrivere), anche la fruizione della poesia non era limita-ta alla fantomatica classe dei “poeti d’amore”. Per con-vincersene basta sfogliare documenti così lontani dallapoesia quanto lo possono essere i Libri memorialium bo-
lognesi: i registri che dal 1265 raccoglievano, per di-sposizione statutaria, tutti i contratti stipulati in città eredatti nel contado. Negli spazi bianchi i notai eranosoliti vergare rime di Guinizzelli, Guittone, Dante, Ca-valcanti, Cecco Angiolieri e Cino da Pistoia… Si contache, tra il 1279 e il 1333, sia stato copiato parzialmentesulle carte o sulle coperte pergamenacee oltre un centi-naio di componimenti poetici in volgare. La poesia con-viveva accanto ad atti pubblici nel medesimo specchiodi scrittura, con la stessa pacifica ovvietà con cui la re-
Canonizzare il filosofo: san Tommaso d’Aquino 165
23_Coccia.qxp 29-07-2010 17:28 Pagina 165
23 Coccia qxp 29 07 2010 17 28 Pagina 166
-
8/18/2019 Coccia -- Canonizzare Il Filosofo San Tommaso d’Aquino
5/7
166 Avignone, 14 luglio 1323
torica, nella bocca di Brunetto Latini, rivendicava di es-sere la scienza del governo per eccellenza. «Come l’orosupera ogni altro metallo, così la scienza del ben parla-re e del governare il popolo è più nobile di tutte le artidel mondo», aveva scritto Brunetto nel suo Tresor .
Ora, è proprio questa congiunzione tra la reggenzadegli uomini e il governo delle parole che Petrarca cer-cherà di disattivare, di convertire a un uso privato e pu-ramente celebrativo. Rivendicando la retorica alla sola“poesia”, Petrarca la sottrae all’uso pubblico, la priva diogni valore politico. Attaccando il professore di diritto
Giovanni d’Andrea, Petrarca attacca dunque la formapiù tipica dell’uomo di lettere. A Giovanni, Petrarcarimprovera una falsa erudizione («fan plauso i discepo-li, e storditi dai nomi d’innumerabili autori te procla-mano un’arca di tutte le scienze quasi che tanti letti neavessi di quanti conosci i frontespizi»), e inoltre la pre-tesa di conoscere ed eccellere in più di una disciplina:«ad un uomo di genio basta la gloria di un solo studio»,scrive risentito.
Chi si vanta di essere grande in molte arti, se non èdivino, è un temerario o un folle. Ti ricordi per caso di
un greco o di un latino che l’abbia fatto? Si tratta in real-tà di un costume moderno, di una sfrontatezza tutta mo-derna.
Ma la lista immaginaria di questi «superbi millanta-tori», specialisti in campi diversi del sapere, che «pro-mettono tutto e non fanno nulla», dovrebbe compren-dere – in realtà – tutte le più grandi figure della lette-ratura italiana delle origini (con la sola eccezione, ap-punto, di Petrarca stesso): Cino da Pistoia, Guinizzelli,Pier della Vigna, Pietro Torregiano, Brunetto Latini.Del resto, è probabile che, in Giovanni d’Andrea, Pe-trarca proietti e attacchi anche l’esempio più illustre del-l’intellettuale che rifiuta ogni specializzazione, DanteAlighieri.
Il disagio e il disprezzo di Petrarca per l’accademiae «gli uomini di più di una gloria» risultano, peraltro,sin troppo affettati: sembrano tradire il risentimento dichi non era riuscito nemmeno a portare a termine i pro-pri studi o non ne aveva saputo trarre alcuna utilità. C’èuna vena di inautenticità anche nelle accuse petrarche-sche verso chi si macchia della colpa di trasformare l’in-telletto in fonte di lucro: è difficile trovare qualcosa dimoralmente riprovevole nel tentativo di vivere del pro-prio sapere senza più appoggiarsi alle prebende eccle-siastiche a cui lo stesso Petrarca faceva ampio ricorso.Cosa si cela allora dietro i suoi strali contro «la litigiosaParigi e il petulante vicolo degli strami»? Cosa muovela sua guerra contro «la filosofia delle università», con-dotta attraverso i più triti luoghi comuni di quella tra-dizione teologica universitaria? Insomma, cosa rappre-sentava Parigi, che cosa era l’università medievale?
A partire da poco più di un secolo prima (correval’anno 1231), in una bolla che si è soliti considerare unodei momenti fondativi dell’università medievale, Parigiera stata santificata dalla legge canonica come «madredelle scienze, città delle lettere» che «splende di chiaraluce», «fucina di sapienza» dove
uomini prudenti lavorano collane d’oro intarsiate d’ar-gento e fabbricano monili ornati di pietre preziose di ine-stimabile valore, destinati a dare ornamento e onore allasposa di Cristo.
La bolla di Gregorio IX aveva definito esplicita-mente il progetto sotteso all’università: quello di coniu-gare sapere e fede, di produrre
il ferro con il quale si munisce di fortezza la terrena fra-gilità, si preparano la corazza della fede, la spada dello spi-rito, tutta l’armatura della milizia cristiana, a difesa dallepotenze ultraterrene.
Un progetto – a ben guardare – difficilmente distin-guibile da quello petrarchesco di uno studio delle lette-re «che ecciti l’amore per la verità e tolga il timore del-la morte».
Nella lotta contro i francesi «qui modice literatisunt» (che conoscono così poco le lettere), Petrarca “in-venta” dunque l’opposizione tra filosofia e letteratura.
A cosa serve conoscere la natura delle belve e degli uc-celli e dei pesci e dei serpenti e ignorare e trascurare la no-stra natura di uomini e lo scopo per il quale siamo nati edove siamo diretti?
Ma questa separazione era tutt’altro che ovvia. L’i-
dea stessa di una letteratura «scritta solo per lettera-ti», che occuperà così frequentemente le preoccupa-zioni apologetiche e “risorgimentali” della modernastoria della letteratura, ha probabilmente le sue radicilontane nell’abile messa in scena petrarchesca. Il com-pito del De ignorantia è proprio quello di definire unanuova forma di letteratura – typus litterarum, scrive Pe-trarca – capace di «infiammare», l’animo, «di parlar-gli», di trasformare chi la legge e la pratica. Essa nondeve mai insegnare (docere), ma commuovere (movere),e proprio per questo il suo principe non è Aristotele,ma Cicerone.
Da Petrarca in poi, la nuova letteratura deve so-prattutto essere fruibile «absque ulla scientia», senzaaver bisogno di alcun’altra conoscenza: non deve pre-supporre alcun sapere reale diverso da quello che il sog-getto ha di sé. Per questo anche i personaggi che la po-polano sono irreali, fantasmi del passato o proiezionispeculari di chi scrive. Boccaccio lo suggerisce, nella suapropria lettura di Petrarca: «ritengo che quella Lauret-ta vada intesa in senso allegorico per la corona di alloro
23_Coccia.qxp 29-07-2010 17:28 Pagina 166
23 Coccia qxp 29-07-2010 17:28 Pagina 167
-
8/18/2019 Coccia -- Canonizzare Il Filosofo San Tommaso d’Aquino
6/7
Canonizzare il filosofo: san Tommaso d’Aquino 167
che poi lui ha conseguito»; «Laura» non è una donna,ma un semplice nome. Difficile sottovalutare il peso diquesto gesto: l’oggetto d’amore del nuovo typus littera-rum non è più una donna, né il mondo, né Dio, o un an-gelo. Ridotta a pura gloria di sé, essa stessa fama di sé,la letteratura coinciderà con il fatto che si parli di lei,proprio come Laura coincide con il nome, e con la poe-sia che la celebra. È ancora la fama a definire, in Pe-trarca, le forme e l’intensità della concorrenza della vir-tus illiterata contro il sapere dei «fumosi sofisti» delleuniversità: «Il desiderio di gloria è proprio non solo agli
uomini comuni, ma soprattutto ai sapienti e agli uomi-ni eccellenti». Disprezzarla è impossibile, perché anchechi ne scrive contro, «appone il suo nome in testa ai suoilibri».
Stando alla cronologia eroica con cui ha articolato ex post la propria vita, due anni prima di scrivere le accusea Giovanni d’Andrea Petrarca avrebbe ricevuto la pro-posta congiunta dell’Università di Parigi (il cui cancel-liere era allora un suo amico, Roberto de’ Bardi) e dellacittà di Roma di un’incoronazione poetica. Dopo quan-to abbiamo detto, il rifiuto dell’offerta parigina non ha
certo bisogno di spiegazioni. Ma le ragioni e gli scopidell’offerta di Roma restano poco comprensibili. In ef-fetti, «quando nell’aprile del 1341 Petrarca venne in-coronato poeta in Campidoglio, non aveva ancora com-posto un libro che fosse giunto a compimento», ha no-tato maliziosamente un interprete. Una possibile ragio-ne del rifiuto era stata da lui messa in versi nell’ Africa:«non si ottiene gratuitamente un nome famoso, né lo siconserva gratuitamente: la custodia della fama è un gran-de sforzo». Questo sforzo coincide con la pratica lette-raria, e di tale faticosa conquista Petrarca non smetterà
mai di parlare.
La fama è una cosa laboriosa, specie quella letteraria:contro di essa stanno tutti all’erta e in armi e anche quel-li che non hanno speranze d’averla, cercano di strapparlaa chi ce l’ha.
Dire in cosa davvero consista questa gloria riesce pe-rò molto arduo. Interrogato da Agostino, Petrarca for-nisce nel suo Secretum la risposta che avrebbe dato unqualunque testimone dell’informatio in partibus nellaprocedura di canonizzazione di Tommaso: «la fama nonè che il discorso su qualcosa propagato e diffuso nellebocche di molti uomini».
«Santo si è solo per gli altri e perché tale ti diconogli altri»: la fama di Tommaso ha seguito la sua morte,e ha toccato soltanto accidentalmente il suo soggetto.Nella prima lettera delle Familiari, indirizzata al suo ami-co Tommaso Caloiro da Messina, che si era lamentatodi non avere raggiunto la fama, Petrarca difende inve-ce un amore diretto per la gloria, quella «donna più bel-la assai ch’el sole» a cui avrebbe dedicato una delle piùstruggenti composizioni del Canzoniere. E Petrarca nonesita a dare all’amico un curioso consiglio:
Vuoi che i tuoi versi siano lodati? Muori. Dalla mor-
te dell’uomo inizia a vivere il favore degli uomini e la fi-ne della vita è il principio della gloria.
Se, nel luglio avignonese del 1323, per la prima vol-ta la scrittura era stata considerata come un miracolo, ela sapienza aveva coinciso per un attimo con la fama disantità, nella dichiarazione d’amore per quella «famosabeltade» questa coincidenza non appare più accidenta-le. Da ora in poi, intellettuale non sarà che colui checoincide con la propria fama. Di nuovo Boccaccio lo sug-gerisce per primo: «egli è pur lo stesso che pennuta fa-ma per bocca dei suoi portatori divulga».
Sulla canonizzazione di Tommaso d’Aquino si vedano soprat-tutto i due saggi di a. m. walz, Historia canonizationis sanctiThomae de Aquino, a cura di S. Szabó, Xenia Thomistica, vol.III, Tractatus historico-criticos continens, Roma 1925, pp. 105-172; id., Papst Johannes XXII. und Thomas von Aquin, zur Ge- schichte der Heiligsprechung des Aquinaten, in a. a. maurer(a cura di), St Thomas Aquinas 1274-1974: CommemorativeStudies, tomo I, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, To-
ronto 1974, pp. 29-47. Resta valido anche l. v. gerulaitis,The Canonization of Saint Thomas Aquinas, in «Vivarium», n.5(1967), pp. 25-46. Importante per definire la genesi del pri-mo tomismo il volume di a. a. robiglio, La sopravvivenza e la gloria. Appunti sulla formazione della prima scuola tomista (sec.xiv ), Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2008. Sulla vitadi Tommaso d’Aquino j.-p. torrell, Amico della verità. Vitae opere di Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano,Bologna 2006. Sui processi di canonizzazione nel Medioevocfr. il capolavoro di a. vauchez, La sainteté en Occident aux
derniers siècles du Moyen Âge (1198-1431), Recherches sur les men-talités religieuses médiévales, École française de Rome, Roma1988; k. gábor, Procès de canonisation au Moyen Âge. Aspects juridiques et religieux - Medieval Canonization Processes. Legal and Religious Aspects, École Française de Rome, Roma 2004;t. wetzstein, Heilige vor Gericht. Das Kanonisationsverfahrenim europäischen Spätmittelalter , Böhlau, Köln 2004.Su Petrarca, oltre alle classiche biografie di U. Dotti (citato
nel saggio a proposito dell’incoronazione del poeta) e E. H.Wilkins, cfr. ora k. stierle, La vita e i tempi di Petrarca. Alleorigini della moderna coscienza europea (2003), Marsilio, Ve-nezia 2007. Del suo epistolario latino è in corso una nuovaedizione presso la casa editrice Les Belles Lettres di Parigi.Per la Collatio laureationis cfr. c. godi, La collatio laureationisdel Petrarca nelle due redazioni, in «Studi Petrarcheschi», n.s.,V (1988), pp. 1-58. Il Privilegium laureationis è stato edito dad. mertens, Petrarcas “Privilegium laureationis”, in m. bor-golte e h. spilling (a cura di), Litterae Medii Aevi. Festschrift
emanuele coccia
23_Coccia.qxp 29 07 2010 17:28 Pagina 167
-
8/18/2019 Coccia -- Canonizzare Il Filosofo San Tommaso d’Aquino
7/7