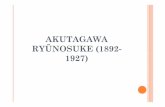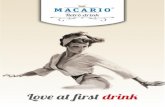Classicità e contesto
description
Transcript of Classicità e contesto
La classicit e le sue radiciIntroduzione alla nascita della classicit greca
Dispensa per uso didattico a cura di Vincenzo CavallaroSettembre 2013
Nella prima met del I millennio A.C., nella Grecia arcaica si posero le fondamenta della civilt europea. La societ ellenica, distrutta in gran parte con l'invasione dorica degli anni intorno al 1200 A.C. si ricostitu grazie alla comunanza sostanziale della lingua, della religione, delle tradizioni e lo sbocco di questo processo fu la Polis, la citt-stato, elemento di unificazione del mondo greco. La Polis era un'entit autonoma e indipendente ma non impermeabile, anzi, la sua apertura sotto il profilo culturale era notevole. Vale a dire che i suoi abitanti erano disposti a recepire senza chiusure o ostacoli le novit che arrivavano dai territori circostanti, in ogni campo. Per esempio nella filosofia, riguardo alle istituzioni che davano forma allo stato, all'arte o alle tecnologie, ai mille aspetti dell'esistenza quotidiana. Nel Periodo di formazione le citt greche infatti non persero mai i rapporti con la campagna circostante e i suoi villaggi: il flusso della gente dalla citt alla campagna e viceversa seguiva puntualmente il ritmo delle stagioni. Fu dunque l'organizzazione del villaggio a determinare l'evoluzione della citt. Le tradizioni rurali, senza troppe barriere tra le classi e le professioni, comprendevano l'usanza di mettere in comune le decisioni pi importanti. Si potrebbe dire che la principale ragione alla base della fusione dei villaggi in citt fosse di coinvolgere nelle scelte e nelle decisioni riguardanti la comunit una cerchia pi vasta di persone. In sostanza, il termine Polis, pi che indicare che lo stato era costituito da una citt, sottolinea il fatto che in un centro urbano unico, o pi importanti di altri, si concentravano potere, culto religioso, cultura, attivit amministrativa.La Polis era un mondo aperto, in cui le idee circolavano, i contatti erano stretti e continui, la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva era effettiva. Il sapere della Polis nasceva proprio all'interno del clima di libera circolazione e di confronto tra citt e individui. Esso tendeva a misurarsi con il reale, in quanto legato a esigenze particolari. Come l'arte, anche la democrazia ateniese non si era conformata a modelli precostituiti: essa nacque dalle esigenze quotidiane richieste da una comunit di questo tipo, come descritta pi sopra. Via via che quei comportamenti si sperimentavano e apparivano buoni, essi si consolidavano come paradigma, esempio, cio degni di essere ripetuti e imitati, diventando cos dei modelli. Con il tempo si stabil un modo simile nel regolare i processi di decisione che riguardavano la polis greca (ad es. la difesa militare, le forme di approvigionamento della citt, le regole da usare nei dibattiti pubblici, ecc) e i processi di decisione di altri ambiti, per esempio in campo artistico. Per esempio non c'era molta differenza fra un artigiano che sceglieva le soluzioni migliori per realizzare un mobile o un artista che doveva scegliere le possibilit pi diverse per realizzare la forma pi bella per una statua e il cittadino che, attraverso l'osservazione quotidiana di problematiche e comportamenti traeva le idee e proposte da portare in assemblea per dare il propio contributo per la risoluzione di talune problematiche che interessavano la citt, creando cos un criterio organizzativo della societ di tipo razionale e di grande efficacia. Per questa via quindi i greci riuscirono a creare una fusione fra i diversi campi del sapere (arte, filosofia, politica), tutte governate dalle coordinate di razionalit e verificabilit del modo con il quale le decisioni venivano assunte.Il processo di elaborazione dell'arte che chiamiamo "classica" affonda le sue radici in un complesso intreccio fra produzione artistica ed elaborazione teorica. Infatti molti degli artisti di quel tempo, non soltanto costruivano, scolpivano o dipingevano ma scrivevano anche riguardo alla loro arte. E i loro trattati non consistevano unicamente in informazioni tecniche e in principi derivati dall'esperienza pratica ma anche in discussioni generali intorno alle leggi (per esempio di simmetria, proporzioni numeriche), alle regole e contenevano principi estetici che facevano da guida agli artisti successivi, secondo un uso presente anche nei generi letterari e che consentivano di distinguere la tragedia dalla poesia, la lirica dall'epigramma. Non poteva quindi mancare, come per le altre discipline, una regola anche per l'arte che nasceva dalla "tchne", dall'esperienza e dall'abilit, proponendosi come punto di riferimento. Knon era la regola, la forma cui l'artista guardava, anche se in modo elastico, senza rigidit. Se infatti in alcuni periodi il canone proposto era seguito e rispettato, perch vissuto come garanzia di perfezione, in altri periodi o contemporaneamente, da altri autori fu rifiutato come una pericolosa limitazione della propria libert. La duttilit del canone era dunque dovuta da una continua ricerca, sempre in atto che, quindi, comportava uno continuo cambiamento delle caratteristiche del canone, sempre soggetto a revisione e correzione.Un altro aspetto estremamente importante per chiarire in cosa consistesse la sensibilit e l'esperienza artistica definita "classica" dato dal passaggio da forme schematiche a forme naturalistiche. Fu questo un mutamento di importanza straordinaria per la storia dell'arte. L'arte greca, infatti, pass con incredibile rapidit dalle forme schematiche, stilizzate e geometriche usate nell'arte arcaica a quelle reali, organiche e verosimiglianti della natura, allontanandosi cos dalla tradizione orientale. In altri termini questo signific passare dalle forme inventate a quelle osservate, da quelle che richiamavano l'attenzione per il loro valore simbolico a quelle attraenti per la loro verit.Ma anche su questo "naturalismo" occorre fare chiarezza. E' vero che gli artisti classici cercavano di rappresentare le forme autentiche del corpo umano che l'oggetto primario, se non unico, della rappresentazione artistica greca, ma altrettanto vero che essi cercavano nello stesso tempo di scoprirne, e riprodurne, le proporzioni costanti. E' qui il tratto pi caratteristico delle loro opere, poich i corpi riprodotti pur essendo assolutamente naturalistici e veri in tutte le parti anatomiche non si riferivano mai ad un individuo preciso, con nome e cognome e quindi individuabile e riconoscibile con la sua identit ma invece si voleva rappresentare l'uomo in generale, cio l'idea dell'uomo che gli artisti di quell'epoca avevano: era quindi la rappresentazione dell'idealizzata dell'uomo, fedeli alla sentenza del filosofo Protagora che, nel V secolo A.C., afferm: "l'uomo la misura di tutte le cose". Perci in architettura come in scultura, il canone stabiliva le proporzioni che dovevano essere mantenute fra le varie parti dell'insieme affinch l'opera risultasse perfetta. Se al corpo veniva data una lunghezza sette volte quella del viso, e al viso una lunghezza tre volte quella del naso, perch questi rapporti numerici racchiudevano la sintesi perfetta delle proporzioni umane.
Si toccava cos un difficile punto d'equilibrio tra naturalismo e astrazione: si rappresentava la realt riconoscibile, cercando per di individuarne le forme e le proporzioni ideali, perfette.