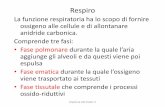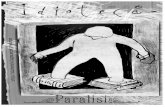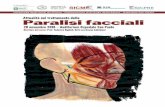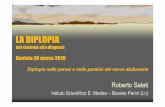1 CEREBROLESIONI, CEREBROPATIE E PARALISI CEREBRALI INFANTILI.
Cinesiterapia delle paralisi facciali
Transcript of Cinesiterapia delle paralisi facciali

� I – 26-463-B-10
Cinesiterapia delle paralisi facciali
C. Bernard
La sfera otorinolaringoiatrica(ORL) è spesso stata trascurata dal mondo della massofisioterapia. La para-lisi facciale fa parte di queste patologie spesso abbandonate o che si ritengono secondarie, forse perchésono in minoranza o perché richiedono delle competenze specifiche oppure, forse, anche perché noi letrattiamo più raramente e presentano, quindi, un carattere sconosciuto che ci lascia esitanti. Tuttavia,questa paralisi non deve essere trascurata, in quanto angoscia fortemente i nostri pazienti, soprattuttoper il pregiudizio funzionale ed estetico che essa provoca. Alcune conoscenze nella neurofisiopatologiadel voto permettono al fisioterapista di fornire le prime cure e, soprattutto, di non trascurare una partedel corpo che è forse la più importante. Le mani del fisioterapista faranno il resto, sostenute, ovviamente,dalle conoscenze e dalle competenze del paziente stesso, che noi dobbiamo educare e, soprattutto,rassicurare.© 2013 Elsevier Masson SAS. Tutti i diritti riservati.
Parole chiave: Volto; Disturbo funzionale; Pregiudizio estetico; Integrità affettiva; Disabilità; Rieducazione;Educazione
Struttura dell’articolo
■ Introduzione 1■ Alcuni richiami 2
Muscoli del volto 2Muscoli delle palpebre e delle sopracciglia 2Muscoli del padiglione auricolare 2Muscoli del naso 2Muscoli delle labbra 3Muscoli costrittori 3
■ Linee del volto 3■ Eziologie e semeiologia 3
Paralisi facciale a frigore o idiopatica (Charles Bell) 3Paralisi facciali virali 3Paralisi facciali otitiche 4Paralisi facciali tumorali 4Paralisi facciali da cause generali 4Paralisi facciale del neonato e del bambino 4Paralisi facciale traumatica 4
■ Conseguenze funzionali 5■ Sequele e complicanze 5
Sequele psicologiche 5Contrattura omolaterale e controlaterale 5Sincinesie 5Conseguenze distali sulla relazione nervo/muscolo 5Spasmo emifacciale 5
■ Terapie mediche 5■ Trattamenti chirurgici 6■ Trattamenti massofisioterapici 6
Paralisi facciale centrale 6Paralisi facciale periferica 6
■ Conclusioni 10
� IntroduzioneSir Charles Bell descrisse la paralisi facciale nel 1829 e realizzò,
qualche tempo più tardi, uno Studio sull’anatomia e sull’espressionenella pittura. La paralisi facciale ha una storia nell’arte, come testi-moniano le statuette ellenistiche di Smirne [1], e non vi è alcundubbio sul fatto che l’identità di un individuo risieda prima ditutto nell’espressione del suo viso. È la sua impronta facciale chesegna i tratti della sua personalità, e i solchi che il tempo tracciaprogressivamente sono come le linee della mano; il viso umanooffre una lettura precisa dei suoi atteggiamenti espressivi. Unacaricatura delle espressioni è rappresentata dalle maschere del tea-tro nô giapponese; queste maschere evocano il rapporto tra ilvolto e il carattere [2]. Oltre al pregiudizio estetico evidente cheessa provoca, in un’epoca dove l’estetica ha assunto una dimen-sione considerevole, la paralisi facciale altera l’immagine che lapersona ha di sé, riflettendo la deformazione del suo «io» pro-fondo. La persona si ritrova mascherata o smascherata e, spesso,
EMC - Medicina Riabilitativa 1Volume 20 > n◦4 > dicembre 2013http://dx.doi.org/10.1016/S1283-078X(13)66029-0

I – 26-463-B-10 � Cinesiterapia delle paralisi facciali
questa lesione prende il sopravvento sul resto; in effetti, non èraro che un paziente emiplegico attribuisca molta più importanzaal proprio viso che al proprio emisoma, sottintendendo anche ilpregiudizio funzionale che si aggiunge al pregiudizio estetico. Lacinesiterapia del volto è tanto più importante delle altre poichéessa deve permettere prima di tutto all’individuo di ritrovare lapropria integrità affettiva con o senza postumi.
� Alcuni richiamiIl nervo faciale è un nervo misto che include il VII motorio e il
VII sensitivo, o nervo intermedio, che presenta sul suo decorso ilganglio genicolato [3].
Il nervo faciale ha la sua origine nella protuberanza inferiorecon un nucleo, schematicamente suddiviso in due nuclei, unoper il faciale superiore e uno per il faciale inferiore. Questo nucleoè collegato al centro corticale controlaterale. In seguito, il nervofaciale emerge dalla fossetta laterale del bulbo, raggiunge il nervococleare per formare il fascio acusticofacciale, attraversa l’angolopontocerebellare, penetra nel condotto uditivo interno e rien-tra nell’acquedotto di Falloppio. Nel suo tragitto più periferico,esso si divide in due rami all’interno della ghiandola parotide, unramo temporofacciale (i suoi rami sono minacciati al momentodell’intervento per l’eliminazione delle rughe o per il lisciaggiodel volto, il lifting), per la parte superiore del volto, e un ramocervicofacciale per la parte inferiore del volto.
Il nervo faciale è un nervo motorio per i muscoli pellicciai delvolto e il muscolo stapedio (la paralisi facciale può provocareun’ipoacusia) ed è un nervo sensitivo che innerva la zona di Ram-say Hunt (nervo intermedio); esso è anche sensoriale per i dueterzi anteriori della lingua e la sensibilità tattile discriminativa e,infine, vegetativo per la secrezione delle ghiandole lacrimali, nasalie salivari (riduzione della secrezione in caso di paralisi facciale).
La zona di Ramsay Hunt comprende il timpano, la parete poste-riore del condotto uditivo esterno e una parte del padiglioneauricolare: la conca (è nella conca che compare l’eruzione dellozoster genicolato) e i due terzi anteriori dell’emilingua (la para-lisi facciale può provocare una perdita del gusto). L’innervazionesensitiva del volto è assicurata dal nervo trigemino.
La paralisi facciale periferica di Bell è dovuta a una lesionenucleare o tronculare, che si traduce nella paralisi facciale flaccidadei muscoli della mimica dell’emivolto omolaterale. La palpebrainferiore è rilasciata, ma non la palpebra superiore, innervata dalnervo oculomotore (III) [3]. La commissura delle labbra è abbassatacon perdita della saliva.
La paralisi facciale centrale è dovuta a una lesione sopranu-cleare, che induce una paralisi dell’emivolto controlaterale conun’asimmetria del quadrante inferiore; l’innervazione del qua-drante superiore è assicurata da fibre corticonucleari dirette [3].
Muscoli del volto (Fig. 1)
Si tratta di piccoli muscoli poco potenti, ma numerosi, che sonoraggruppati intorno agli orifizi del volto e che presentano tuttiun’inserzione ossea fissa e un’inserzione cutanea mobile. Essi assi-curano la chiusura, l’apertura o la deformazione di questi orifizi [2].Ad ogni muscolo corrisponde un’espressione ed ogni contrazioneinduce delle rughe e delle pliche.
Si possono suddividere i muscoli pellicciai della testa e del colloin quattro gruppi [4]:• muscoli delle palpebre e delle sopracciglia;• muscoli del padiglione auricolare;• muscoli del naso;• muscoli delle labbra che si possono assimilare al pellicciaio del
collo.
Muscoli delle palpebre e delle sopraccigliaIl muscolo epicranico od occipitofrontale assicura l’elevazione del
sopracciglio. La fronte si corruga creando delle rughe orizzontali.È il muscolo dello stupore [5].
1
2
3
4
56
7
89
10
111213
14
15
16
17
18
19
202122
23
24
25
26
27
28
Figura 1. Punti motori e reperi morfologici. 1. Frontale; 2. corrugatoredel sopracciglio; 3. procerus; 4. orbicolare dell’occhio; 5. nasale porzionetrasversa; 6. elevatore del naso e del labbro superiore; 7. zigomatici;8. orbicolare superiore della bocca; 9. orbicolare della bocca;10. buccinatore; 11. depressore dell’angolo della bocca; 12. orbicolareinferiore della bocca; 13. depressore del labbro inferiore; 14. mentoniero;15. platisma; 16. glabella; 17. testa del sopracciglio; 18. coda del soprac-ciglio; 19. angolo nasale dell’occhio; 20. angolo temporale dell’occhio;21. caruncola lacrimale; 22. zigomo; 23. solco nasogenieno; 24. plicamediana nasolabiale; 25. plica nasogiugale; 26. commissura labiale;27. plica mentoniera; 28. fossetta mentoniera.
Il muscolo piramidale o muscolo procerus abbassa la testa delsopracciglio e la avvicina alla linea mediana. Esso partecipa allaprotezione dell’occhio contro l’abbagliamento.
L’orbicolare delle palpebre assicura l’occlusione palpebrale. Nellasua contrazione forzata, esso genera delle rughe nella porzioneesterna dell’occhio (zampe di gallina) e fa scomparire quasi latotalità delle ciglia.
Il muscolo sopracciliare o corrugatore solleva ed eleva la testa delsopracciglio e richiama in basso e all’interno i due terzi esterni. È ilmuscolo dell’attenzione, della riflessione e della disapprovazione.
Muscoli del padiglione auricolareI muscoli auricolari anteriore, superiore e posteriore sono molto
rudimentali nell’uomo. Sono dei dilatatori del condotto uditivoesterno e degli orientatori del padiglione. La loro contrazione ènotevole nel cane e nel gatto, quando, all’ascolto di un rumore,l’orecchio compie dei movimenti circolari senza il movimentodella testa.
Muscoli del nasoIl trasverso del naso o muscolo nasale attira l’ala del naso in alto
e in avanti e dilata la narice. Esso esprime il disgusto in collabo-razione con il procerus.
Il dilatatore delle narici porta l’ala del naso all’esterno e aumentail diametro trasversale delle narici.
Il mirtiforme abbassa l’ala del naso e restringe trasversalmentel’orifizio delle narici.
2 EMC - Medicina Riabilitativa

Cinesiterapia delle paralisi facciali � I – 26-463-B-10
Muscoli delle labbraI muscoli delle labbra sono suddivisi in due gruppi:
• I dilatatori profondi:◦ il canino, che innalza l’angolo della bocca e il labbro superiore
a livello del canino. È il muscolo del disdegno e del sogghigno◦ il buccinatore, il muscolo più profondo, che traziona
all’indietro la commissura e che permette di comprimere laguancia quando la cavità orale è piena di aria, di acqua odi cibo. Riunisce gli alimenti sotto i molari in vista dellamasticazione. È il muscolo del trombettista
◦ il quadrato del mento, che richiama in basso il labbro infe-riore, lo fa risalire e lo arriccia. È il muscolo del broncio
◦ il fiocco del mento, che innalza il mento in alto e in avanti eil labbro inferiore;
• i dilatatori superficiali:◦ l’elevatore superficiale dell’ala del naso e del labbro superiore, che
richiama in alto l’ala del naso e il labbro superiore, scoprendoi denti del mascellare superiore
◦ l’elevatore profondo, che ha un’azione identica◦ il piccolo zigomatico, che richiama in alto e in fuori il labbro
superiore. È il muscolo del pianto◦ il grande zigomatico, che porta in alto e in fuori la commissura
labiale. È il muscolo del sorriso◦ il risorius, che attira in fuori e indietro la commissura delle
labbra, assottiglia le labbra e partecipa al sorriso enigmatico,«sorriso della Gioconda»
◦ il triangolare delle labbra, che richiama la commissura in bassoe in fuori. È il muscolo del dubbio o, ancora, della tristezza.
Muscoli costrittoriQuesti muscoli sono rappresentati dall’orbicolare delle labbra e
dal compressore delle labbra, che comprime le labbra dall’avantiall’indietro. Quest’ultimo è particolarmente sviluppato nel neo-nato e assume una parte importante nell’azione della suzione. Èanche il muscolo della riserva.
Il muscolo platisma o muscolo pellicciaio del collo, che richiamain basso la cute del mento, abbassa la commissura labiale e puòanche tenderla e pieghettare la cute del collo attirandola versol’alto. Esso abbrevia l’altezza del collo aumentandone il diametroorizzontale (Fig. 1).
� Linee del volto [6]
Su un volto a riposo e indenne da ogni paralisi, si possonoevidenziare il lato dominante e il lato dominato (Fig. 2). La domi-nante facciale si reperisce con delle linee di convergenza chesi costruiscono sui reperi morfologici. A partire da una foto diidentità di fronte, l’esaminatore traccia una linea passante per lecommissure labiali; la seconda linea passa per il bordo inferioredel limbo inferiore dell’occhio, mentre la terza linea passa per ilbordo superiore del limbo superiore dell’occhio. Noi possiamo,allora, determinare la dominante facciale (in particolare l’occhiopiù piccolo) e avere, così, un’idea più precisa della facilità di recu-pero (il lato dominante ha più facilità di recupero), ma ancheprevenire meglio i rischi di ipertonie e di sincinesie su questo latodominante, più forte e, dunque, più labile.
� Eziologie e semeiologiaLa paralisi facciale centrale interessa, il più delle volte, l’area pira-
midale dei centri motori corticali. La lesione può situarsi anche adiversi livelli della via corticonucleare. Le cause principali sono [7]
gli accidenti vascolari cerebrali (AVC), i traumi cranici e i tumoricerebrali. La paralisi facciale centrale interessa spesso la parte infe-riore del volto con lesione del canino, del piccolo e del grandezigomatico, dell’orbicolare inferiore e superiore delle labbra, deltriangolare delle labbra, del fiocco e del quadrato del mento e delplatisma. La paresi è localizzata sul lato opposto alla lesione. Esi-
Droite Gauche
1
2
Figura 2. Linee del volto. 1. Dominante superiore destra; 2. dominanteinferiore sinistra.
stono dei disturbi dei movimenti volontari. Talvolta, si riscontrauna dissociazione automaticovolontaria paragonabile all’aprassiaorofacciale [7].
La paralisi facciale periferica interessa la totalità dell’emivolto,a volte in forma frustra (lesione lieve) o incompleta (lesione diuna parte del territorio). La lesione è, quindi, di gravità variabileandando da:• neuroaprassia = demielinizzazione senza interruzione assopla-
smica;• assonotmesi = interruzione della guaina di mielina + assone;• neurotmesi = interruzione istologica completa (assone +
tubulo).
Paralisi facciale a frigore o idiopatica (CharlesBell)
I segni clinici sono i seguenti:• insorgenza brutale strettamente monolaterale senza eziologie
riscontrate;• causa più frequente;• causa virale: herpes simplex virus 1 (HSV1);• fattori predisponenti: compromissione dello stato generale,
stress, esposizione al freddo, shock vasomotorio;• prognosi:
◦ 70% di recupero completo in 4-6 settimane senza postumidopo il trattamento
◦ 16% di sequele motorie: deficit motorio residuo, spasmi, sin-cinesie.
Paralisi facciali viraliSono delle paralisi facciali zosteriane (zoster del ganglio genico-
lato) con:• eruzione nella zona di Ramsay Hunt, dolori;• lesioni possibili del ganglio di Corti (sordità), ganglio di Scarpa
(vertigini);
EMC - Medicina Riabilitativa 3

I – 26-463-B-10 � Cinesiterapia delle paralisi facciali
1
2
345
6
8
9
7
13
V1
V2
V314
15
161917
18
20
21
22
23
24
2625
2728
30
29 IX10
1112
Figura 3. Sistematizzazione del nervo faciale. 1. Ghiandola lacrimale; 2. nervo zigomaticotemporale; 3. II; 4. ganglio pterigopalatino; 5. ghiandole nasali;6. nervo grande palatino; 7. nervo linguale; 8. palato duro; 9. palato molle; 10. lingua; 11. ganglio e ghiandole sublinguali; 12. ganglio e ghiandolesottomandibolari; 13. ganglio trigeminale; 14. ganglio genicolato; 15. nervo grande petroso; 16. nervo petroso profondo; 17. plesso timpanico; 18. plessocarotideo interno; 19. ganglio otico; 20. nervo piccolo petroso; 21. nervo timpanico; 22. corda del timpano; 23. ghiandola parotide; 24. nucleo del nervoabducente; 25. nucleo motore del nervo faciale; 26. nucleo salivare superiore; 27. nucleo salivare inferiore; 28. nucleo del tratto solitario; 29. foramestilomastoideo; 30. nervo auricolare posteriore.
• reazione meningea possibile.Il trattamento deve essere urgente e prolungato (antivirale).
Paralisi facciali otiticheQuesto tipo di paralisi richiede un’otoscopia minuziosa per
distinguere l’otite media acuta dall’otite cronica.
Paralisi facciali tumoraliUna paralisi progressiva e/o uno spasmo emifacciale sono molto
evocatori di questa diagnosi. Si distinguono:• i tumori della rocca: paraganglioma, meningioma della rocca;• i tumori dell’angolo pontocerebellare: neurinoma, metastasi,
aneurisma, ecc.;• i tumori della parotide.
Paralisi facciali da cause generaliLe cause delle paralisi facciali possono essere:
• diabete, tetano, tifoide, difterite;• malattia di Lyme: contesto: zecche, sierologia;• periarterite nodosa, sarcoma reticolare, intossicazione.
Paralisi facciale del neonato e del bambinoSi distinguono:
• la paralisi del neonato: traumatica, malformativa;• la paralisi del bambino: otogena (bacillo di Koch, BK), a fri-
gore, ematologica, ipercalcemia idiopatica e intossicazione davitamina D.
Paralisi facciale traumaticaSi distinguono i traumi:
• accidentali: frattura della rocca petrosa, ferita della parotide;• postoperatori: chirurgia otologica, neurinoma dell’acustico,
parotidectomia, ecc.).Tra i vari nervi cranici, il nervo faciale è quello più frequen-
temente colpito isolatamente. La paralisi può essere, a volte,bilaterale, come nella malattia di Guillain-Barré. In funzione dellatopografia delle lesioni, la paralisi facciale periferica può essereassociata ad altri deficit come:• deficit cocleare e vestibolare, in particolare dopo l’exeresi di un
neurinoma dell’acustico;• deficit della sensibilità tipo ipoestesia nel territorio del V;• riduzione del riflesso corneale;• lesione dell’oculomotricità esterna;• ipoacusia o iperacusia per lesione del nervo del muscolo stape-
dio;• riduzione della secrezione lacrimale e salivare;• anosmia (disturbo dell’olfatto);• ageusia (mancanza del senso del gusto).
L’osservazione di uno schema della sistematizzazione delnervo faciale [3] permette di dedurre i segni clinici relativi allalesione del nervo faciale secondo la topografia delle lesioni(Fig. 3).
Nella forma completa della paralisi facciale periferica, si osser-vano:• un’ipotonia dell’emivolto;• un volto asimmetrico, con i movimenti che aumentano questa
asimmetria (Fig. 4);• l’eliminazione delle rughe frontali;• una fessura palpebrale allargata;
4 EMC - Medicina Riabilitativa

Cinesiterapia delle paralisi facciali � I – 26-463-B-10
Figura 4. Faccia asimmetrica.
• il segno di Charles Bell (fisiologicamente, al momentodella chiusura degli occhi, il bulbo oculare è attirato inalto e all’esterno; quando la chiusura dell’occhio colpitoè impossibile, l’esaminatore vede, quindi, il bianco dell’occhio);
• il segno delle ciglia di Souques (al momento della chiusura for-zata degli occhi, si vedono comparire maggiormente le cigliadal lato paralitico);
• l’abolizione del solco nasogenieno;• l’abolizione della plica centrale nasolabiale o philtrum;• la caduta della commissura labiale;• la guancia pendente;• il segno di Babinski (segno evidenziato da Babinski, che si carat-
terizza per la contrazione, più importante dal lato sano chedal lato paralitico, del muscolo pellicciaio del collo o plati-sma, quando si richiede al paziente di realizzare un sorrisocontratto).
� Conseguenze funzionaliUna paralisi facciale centrale provoca dei disturbi della parola
dovuti a una deviazione della lingua e alla lesione del piano infe-riore.
Lo sbavamento è frequente e i disturbi masticatori sono nume-rosi. Si osservano dei disturbi della deglutizione. La paralisi delterritorio inferiore del viso può essere associata, a volte, a un defi-cit dell’emifaringe e del velo del palato, del collo, dell’emilaringee della sensibilità emifacciale. Si osservano queste manifestazioniprincipalmente in caso di lesioni corticali diffuse. La lesione sitrova dal lato opposto alle manifestazioni cliniche, salvo nelcaso della sindrome alterna. La sindrome di Millard-Gubler è unasindrome alternata, che associa una paralisi di un emisoma con-trolaterale alla lesione e che rispetta il volto a una paralisi del VIabducente e/o del VII di tipo periferico omolaterale alla lesione.Si tratta di una lesione del tronco cerebrale situata nella regionepontina inferiore.
Una paralisi facciale periferica provoca la perturbazione dellemimiche espressive, la mancata occlusione palpebrale con ilrischio di lesione della cornea, dei disturbi dell’articolazione,dell’alimentazione, del gusto e dell’udito e, soprattutto, deidisturbi psicologici. Questi disturbi psicologici sono sempre for-temente descritti nel caso di lesione periferica e sono pocoo per nulla descritti nel caso di lesione centrale. Peraltro, ipazienti emiplegici sono, a volte, più disturbati dall’alterazioneestetica e funzionale del loro viso che dalla disabilità degliarti.
� Sequele e complicanze [4]
Sequele psicologicheLa ripercussione psicologica è quasi immediata e perfetta-
mente reversibile, se il recupero sembra adeguarsi alla prognosidi partenza, ma può divenire cronica dopo qualche mese dilentezza o di assenza di recupero. Questi disturbi psicologicivanno dalla sindrome depressiva cronica all’isolamento modu-lato dall’aggressività nei confronti delle persone vicine e del corposanitario. È l’assenza di movimento il disturbo più difficile da sop-portare, in quanto anche delle contrazioni muscolari inadatte tiposincinesie e spasmi possono essere sopportate meglio psicologica-mente dopo qualche mese, offrendo al paziente una speranza dimovimento espressivo.
Contrattura omolaterale e controlateraleLa contrattura controlaterale è una pseudocontrattura collegata
a un tentativo di correzione forzata. Il lato sano si contrae inmaniera eccessiva per tentare di ottenere una contrazione del latoparalitico. Il risultato è un peggioramento dell’asimmetria assolu-tamente antiestetico. È il principio dei muscoli forti che hannoil sopravvento sui muscoli deboli e di cui il fisioterapista dovràtenere conto fin dall’inizio della rieducazione.
La contrattura omolaterale può consistere nella forma tonicadello spasmo emifacciale; essa è ritardata ma progressiva; mentresi constatano i progressi del recupero, si vede instaurarsi progres-sivamente un recupero eccessivo che finisce, anch’esso, per avereripercussioni sul lato opposto.
SincinesieLe sincinesie sono delle contrazioni involontarie associate ai
movimenti volontari, particolarmente a livello dell’occhio e dellabocca. Queste sincinesie corrono molto spesso dall’alto versoil basso e, per esempio, l’ammiccamento palpebrale provocauna contrazione del risorio e degli zigomatici. Queste sincine-sie sono dovute a un errore di indirizzamento delle fibre dirigenerazione.
Conseguenze distali sulla relazionenervo/muscolo
La scomparsa degli assoni motori in un territorio ha, come con-seguenza, quella di portare molto rapidamente a una sofferenzamuscolare che, se non è compensata da una neurotizzazione disupplenza, condurrà progressivamente alla rarefazione degli effet-tori muscolari.
Spasmo emifaccialeLo spasmo emifacciale è di comparsa molto tardiva; si tratta
di sequele che realizzano delle contratture in gradi diversi.È la complicanza più grave, l’asimmetria è invertita e vi èun’ipercontrazione a riposo. Tale emispasmo può essere leggeroe interessare solo l’orbicolare delle palpebre, ma può assumerela forma di una smorfia intensa di tutto il lato paralitico. I con-flitti neurovascolari arteriosi costituiscono di gran lunga la causapiù frequente di questa patologia. Può trattarsi di vasi suscettibilidi entrare in conflitto con il fascio acusticofacciale. Una paralisifacciale periferica progressiva con emispasmo deve far sospettareun’origine tumorale. Il bilancio di diagnostica per immagini conTC e RM apporta degli argomenti essenziali.
� Terapie medicheLe terapie sono a base di corticosteroidi (salvo nei casi di zoster,
di herpes e di diabete), di vasodilatatori e di infiltrazioni. Que-sti trattamenti sono somministrati soprattutto nei casi di paralisi
EMC - Medicina Riabilitativa 5

I – 26-463-B-10 � Cinesiterapia delle paralisi facciali
facciali periferiche. Parallelamente, possono essere prescritti dellevitamine B6-B12, delle lacrime artificiali, dei colliri e, soprattutto,una protezione dell’occhio durante la notte con Steristrip® per evi-tare l’essiccamento della cornea. Nei casi di spasmo emifacciale,si può, talvolta, praticare un’iniezione di tossina botulinica neglizigomatici [7].
� Trattamenti chirurgiciEsistono due gruppi principali di tecniche chirurgiche.Il primo gruppo comporta diversi tipi di anastomosi nervose
(anastomosi VII-XII); esse consistono nel dirottare un nervo per-ché esso «sostituisca» il nervo faciale leso, allo scopo di rianimarei muscoli facciali prima che questi siano completamente atro-fici. Questo tipo di intervento è realizzato fino a 18-24 mesi dopol’inizio della paralisi (per esempio, dopo l’exeresi di un neurinomadell’acustico). I primi segni di recupero funzionale sono visibili unmese dopo l’intervento, il recupero è lungo, spesso incompleto, ele sincinesie possono essere numerose.
Il secondo gruppo si basa su trasposizioni di muscoli e su inci-sioni di indebolimento dei muscoli del lato sano con l’obiettivodi migliorare la simmetria del volto, nonché su diverse tecnichedestinate a ottenere la chiusura dell’occhio (molle, innesti carti-laginei, tarsorrafia).
Tuttavia, non bisogna dimenticare che un nervo periferico puòrichiedere fino a tre anni per rigenerarsi.
� Trattamenti massofisioterapiciParalisi facciale centraleValutazione
La valutazione del volto nelle paralisi centrali presenta le stessecaratteristiche di valutazione dei casi di neurologia centrale, cioèl’ispezione del volto, la valutazione del tono a riposo e la valu-tazione della forza muscolare che non è un test muscolare,poiché questo è riservato alla neurologia periferica (non vi èuna lesione del nervo faciale o del suo nucleo nella PF centrale,ma si tratta di un disturbo del comando volontario e i riflessirimangono conservati). La scala di Catherine Bergego concernentel’eminegligenza [8] possiede una voce relativa alla dimenticanza diun lato della bocca: «Le accade di dimenticare di asciugare il latodestro (sinistro) della bocca dopo il pasto?» (punteggio da 0, mai,a 3, quasi sempre). Generalmente, si osservano delle differenzetra le paralisi destre (lesione dell’emisfero dominante) e le paralisisinistre (lesione dell’emisfero minore). Queste ultime sono spessoassociate a un’eminegligenza, che può essere responsabile di unadeviazione del sorriso più marcata e di uno sbavamento impor-tante. La Scala di Orgogozo [8] prevede una voce di valutazione deimovimenti del volto, che ricevono un punteggio di 5 se sono nor-mali o se vi è un’asimmetria minima e di 0 per una paralisi o unaparesi marcate.
È assolutamente possibile utilizzare delle scale specifiche per gliAVC, come il punteggio di Held e Pierrot-Desseilligny, molto piùadatto alle PF centrali rispetto al test muscolare. È evidente che lenozioni di pesantezza e di resistenza sono da escludere oppure, inogni caso, da adattare al contesto del volto e, più particolarmente,della parte inferiore del volto. La nozione di «spostamento disegmento» in questa valutazione può essere avvicinata al sistemadi Nottingham [9], che misura le distanze a riposo e allo sforzotra due punti di repere sul viso; esistono tre punti di riferimentofacciale, occhio, naso, bocca:• 0: assenza di contrazione;• 1: contrazione percepibile senza spostamento del segmento;• 2: contrazione che induce uno spostamento, qualunque sia
l’angolo percorso;• 3: lo spostamento può avvenire contro una lieve resistenza;• 4: lo spostamento avviene contro una resistenza più impor-
tante;• 5: il movimento ha una forza identica al lato sano.
RieducazioneLa rieducazione mira a ristabilire il comando volontario. Essa
inizia con la presa di coscienza dei deficit facciali inferiori conl’ausilio di uno specchio. Il paziente prende coscienza del suosorriso deviato, della sua mancanza di prensione labiale, dellacaduta della commissura, dell’eccessivo sbavamento e della dis-simmetria del platisma. Questo lavoro di presa di coscienza deveessere eseguito anche al momento dei pasti, per permettere alpaziente di gestire meglio la perdita degli alimenti liquidi esemiliquidi per il difetto di chiusura labiale [7]. I disturbi dellasensibilità dovuti all’emiplegia (per le cause di PF post-AVC) nonpermettono al paziente di avvertire i liquidi che colano lungo lacommissura.
L’aspetto posturale ha un’estrema importanza e, in particolare,è importante il lavoro del portamento della testa, in quanto, ineffetti, il difetto di portamento della testa altera il buon funziona-mento visivo, vestibolare, temporomandibolare, uditivo, olfattivoe gustativo. I disturbi dell’equilibrio da seduti e in piedi sonopotenziati da un portamento della testa difettoso. Qualsiasi formadi comunicazione che deriva dalla testa e dal volto è compromessada una postura cervicale inadeguata. La fisioterapia permette,quindi, di recuperare anche i muscoli del volto indirizzandosial rachide cervicale e al tronco. Il controllo dell’orbicolare dellelabbra è assoggettato a un buon equilibrio posturale, almeno inposizione seduta, e a un buon portamento della testa. Il fisiotera-pista deve, quindi, valutare i dolori fisici e psicologici, le carenzevertebrali, tipo ipotonia, ipertonia e/o ipoestensibilità e i deficitpropriocettivi e prevedere un trattamento dapprima isolato delrachide nella sua globalità e, quindi, associato a degli esercizifacciali.
Infine, devono essere forniti al paziente e a coloro che lo aiu-tano dei consigli di igiene di vita, tipo non esagerare i movimenti,controllare l’articolazione e la masticazione, tenersi bene eretto,in particolare al momento dei pasti, e prevedere dei fazzolettidi carta per asciugare regolarmente la commissura labiale, senzadimenticare di adattare il vocabolario e la scelta degli eserciziin funzione dell’età del paziente, della sua patologia e, soprat-tutto, dei disturbi associati, che sono frequenti in neurologiacentrale.
Paralisi facciale perifericaTotalmente diversa dalla PF centrale, la PF periferica è dovuta alla
lesione del nervo faciale in un qualsiasi punto del suo tragitto.Come ogni paralisi periferica, essa è flaccida all’inizio e inte-ressa un emivolto (facciale superiore e facciale inferiore), quandoè interessato un solo nervo faciale; essa può essere bilaterale(Guillain-Barré).
Diagnosi massofisioterapicaLa diagnosi massofisioterapica permette di personalizzare la
rieducazione e di fornire il miglior trattamento possibile in fun-zione del progetto del paziente e dei suoi deficit. Essa inizia conun’anamesi scrupolosa, che, spesso, è il mezzo più sicuro per indi-viduare la lesione, poiché, al di fuori della causa traumatica epostchirurgica dove si conosce la sede esatta della lesione, è spessodifficile precisare la sede delle altre lesioni, particolarmente neltragitto intrapetroso del nervo faciale [4].
Per esempio, l’esistenza di disturbi del gusto indica una lesionesituata a monte della corda del timpano. Un’ipoacusia dolorosa èa favore di una lesione del muscolo stapedio. Delle vertigini e degliacufeni, con sordità associata, fanno sospettare una lesione evo-lutiva dell’angolo pontocerebellare oppure una lesione infettivao infiammatoria, che richiede la realizzazione di esami comple-mentari. La lesione associata di altri nervi cranici può far pensarea un accidente vascolare del tronco. Le prove acumetriche e audio-metriche possono oggettivare una sordità di trasmissione o dipercezione e l’esame vestibolare può evidenziare una vertigine connistagmo.
Test di localizzazione classiciQuesti test riguardano:
6 EMC - Medicina Riabilitativa

Cinesiterapia delle paralisi facciali � I – 26-463-B-10
• il riflesso stapedio, che deve essere ricercato per entrambe leorecchie;
• lo studio della secrezione lacrimale, o test di Schirmer, cheesplora con carta filtro graduata la secrezione lacrimale dopouna stimolazione mediante inalazione di vapori di ammoniaca;
• lo studio della secrezione salivare, o test di Blatt, consistenell’eccitare la secrezione salivare con del succo di limone appli-cato sul dorso della lingua; una differenza del 25% del flusso trai due lati è significativa e corrisponde a una lesione grave delnervo faciale;
• la gustometria chimica permette di predire che la lesione delnervo è situata al di sopra della nascita della corda del timpanoe che è realizzata con soluzioni sapide applicate sulla lingua adiverse concentrazioni;
• l’elettrogustometria è basata sulla misurazione delle sogliedella sensazione soggettiva del gusto prodotto mediantel’applicazione sulla lingua di correnti anodiche continue; unadifferenza del 30% è patologica [4].La conoscenza dei risultati di questi test permetterà essen-
zialmente al fisioterapista di dare dei consigli di igiene di vitaperché la vita quotidiana del paziente sia più confortevole [6] e,soprattutto, per anticipare i rischi corneali. I postumi sensorialisono la sindrome delle «lacrime di coccodrillo», che compareverso la 5a settimana e il 10o mese. Si tratta di una lacrima-zione monolaterale che compare durante i pasti in occasionedella stimolazione gustativa e dovuta a una ricrescita anomaladelle fibre a destinazione salivare che si dirigono alla ghiandolalacrimale. La sindrome di Frei fa spesso seguito a degli interventisulla ghiandola parotide ed è dovuta all’innervazione delle ghian-dole sudoripare da parte di fibre secretorie destinate alla parotide.Essa si manifesta con una sudorazione a volte abbondante, cheinsorge durante i pasti, facendo spesso credere a una fistolasalivare.
ValutazioniL’interrogatorio prosegue con una valutazione del tono musco-
lare in fase flaccida e il punteggio va da 0, normale, a -1, parzialee a -2, totale. Sono valutati [5]:• l’abolizione delle rughe frontali;• l’abbassamento della punta del sopracciglio;• il naso deviato a virgola verso il lato sano;• l’abolizione del solco nasogenieno;• l’abolizione del philtrum;• la deviazione e l’abbassamento della commissura labiale;• il labbro superiore inghiottito;• il labbro inferiore inghiottito;• la guancia «affossata» pendente come un sacco.
Nel quadro delle paralisi facciali con sequele di ipertonia il pun-teggio va da +3 a +1 e riguarda:• elevazione anomala della punta del sopracciglio;• esagerazione della fossetta sopracciliare;• esagerazione del solco nasogenieno;• attrazione della commissura labiale in alto e in fuori;• appuntimento del mento;• ipertono del muscolo platisma, fibre anteriori;• ipertono del muscolo platisma, fibre posteriori e inferiori;• lacrimazione prandiale monolaterale.
Nel quadro delle sincinesie essenziali, il punteggio va da +3 a +1e riguarda:• le sincinesie bocca/occhio;• le sincinesie occhio/bocca;• le sincinesie emozionali.
Il bilancio più importante in una paralisi periferica è il testmuscolare che non è analitico, ma che si vuole analitico. I muscolisono valutati da 0 a 4, sapendo che le nozioni di gravità e diresistenza sono minime sui muscoli pellicciai:• 0: nessuna mobilità della grana della cute osservabile a occhio
nudo o alla luce radente alla terminazione cutanea profondadel muscolo;
• 1: mobilità della grana della cute al momento del comando delmovimento;
• 2: il soggetto è in grado di ripetere il movimento cinque voltein un’ampiezza incompleta e in modo asincrono rispetto al latosano;
• 3: il soggetto è in grado di ripetere il movimento otto-dieci voltein un’ampiezza completa, ma in modo asincrono rispetto al latosano;
• 4: il soggetto è in grado di realizzare il movimento in modo sin-crono e simmetrico; esso è integrato nella mimica volontaria [5];La classificazione di Georges Freyss richiede anche la coopera-
zione del paziente, ma valuta i muscoli soprattutto secondo gruppidi funzionalità. Il punteggio va sempre da 0 a 3, 0 per nessuna con-trazione, 1 per contrazione minima, 2 per contrazioni ampie, macon difficoltà e senza forza e 3 per movimenti volontari completieseguiti con forza. Sono testati dieci muscoli:• il frontale con le sopracciglia per produrre le rughe;• l’orbicolare delle palpebre per chiudere gli occhi;• il sopracciliare (aggrottare le sopracciglia) e il piramidale (pie-
ghettare la radice del naso);• l’elevatore del naso e del labbro superiore (sollevare i bordi
laterali delle narici);• l’orbicolare delle labbra (fischiare);• lo zigomatico e l’elevatore delle labbra (eseguire un risata sar-
donica);• il buccinatore (soffiare);• il quadrato del mento (fare il broncio).
Si stabilisce un punteggio da 0 a 30:• tra 20 e 30: paralisi facciale leggera;• tra 10 e 20: paralisi facciale media;• tra 0 e 10: paralisi facciale grave;• punteggio uguale a 0: paralisi totale.
La classificazione di House-Brackmann valuta la funzionalità fac-ciale e le sequele a distanza; si presenta sotto forma di sei gradi:• grado I: funzione facciale normale in tutte le aree;• grado II: lesione moderata, a riposo; tono e simmetria nor-
mali, alla fronte; da alcuni movimenti a movimenti normali,all’occhio; chiusura normale allo sforzo minimo e mas-simo, disturbi secondari: sincinesie molto leggere e incostanti.Assenza di contratture;
• grado III: lesione moderata, a riposo: tono e simmetria normali,alla fronte; movimenti lievi o assenti, all’occhio; chiusura allosforzo massimo con asimmetria evidente, disturbi secondari:sincinesie e/o contratture notevoli ma non gravi;
• grado IV: lesione mediamente grave, a riposo: tono e simmetrianormali, alla fronte; nessun movimento, all’occhio; chiusuraincompleta allo sforzo massimo, alla bocca; movimenti asim-metrici allo sforzo massimo, disturbi secondari: sincinesie e/ocontratture gravi;
• grado V: lesione grave, a riposo; asimmetria facciale, alla fronte;nessun movimento, all’occhio; discreto movimento allo sforzomassimo, disturbi secondari: sincinesie, contrattura di solitoassente;
• grado VI: paralisi totale, a riposo: perdita totale del tono, allafronte; nessun movimento, all’occhio; nessun movimento, allabocca; nessun movimento, disturbi secondari: assenti.La valutazione della sensibilità si esegue nella zona di Ramsay
Hunt per il nervo faciale (VII) e nelle altre aree del viso la cui sen-sibilità è attribuita al nervo trigemino (V), in particolare, la zonasopraoculare innervata dal nervo oftalmico, la zona interoculo-orale innervata dal nervo mascellare e la zona infraorale innervatadal nervo mandibolare [3].
Il bilancio dell’eloquio è indispensabile e si esegue in collabora-zione con il logopedista.
Il bilancio della coordinazione ricerca le sincinesie. Le sincinesiesono dei movimenti irregolari involontari che si creano durantemovimenti volontari. Per esempio, quando il paziente chiude gliocchi, si vede l’innalzamento della commissura labiale.
Occorre notare che ogni paralisi facciale che non recupera nei25 giorni che seguono la lesione causa inevitabilmente delle ano-malie di recupero [6]. Il nervo faciale è il solo nervo periferico che dàdelle spasticità al momento del suo recupero, ma occorre notare che èanche il solo nervo che recupera più a lungo nel tempo, fino a 4 anni.
I diversi elementi del bilancio sono registrati su una scheda dibilancio specifica o, meglio, all’interno della cartella informatiz-zata tipo «EMED».
EMC - Medicina Riabilitativa 7

I – 26-463-B-10 � Cinesiterapia delle paralisi facciali
Obiettivi della massofisioterapiaGli obiettivi sono i seguenti:
• mantenimento trofico;• lavoro della qualità muscolare;• mantenimento dello schema motorio;• guidare e aiutare il recupero mediante il lavoro analitico e, poi,
reintegrare funzionalmente il lato interessato rispetto al latosano;
• lottare contro le sincinesie;• integrare la mimica volontaria e, con la ripetizione, renderla
automatica;• sostenere psicologicamente;• fornire dei consigli di igiene di vita.
Principi della massofisioterapiaI principi della massofisioterapia sono:
• lavorare in un luogo calmo;• non affaticarsi;• effettuare delle sedute brevi e pluriquotidiane;• spiegare e dimostrare chiaramente, in quanto la mimica è
innata;• controllare il lato sano per evitare l’aspirazione del lato inte-
ressato e la comparsa di una contrattura controlaterale e/odomolaterale;
• sostenere e incoraggiare durante tutta la rieducazione, inquanto è lesa l’integrità affettiva;
• rieducare in modo analitico i muscoli costrittori per primi, inquanto i dilatatori sono sempre più forti.
Mezzi e tecniche di rieducazioneFisioterapia
Caldo umido e secco. Il riscaldamento aumenta la condu-zione nervosa e l’ipervascolarizzazione ritarda l’effetto di fibrosi,vale a dire l’aspetto trofico. Si possono utilizzare delle compressecalde e umide secondo la tradizione giapponese (per le manidopo il pasto). Questi piccoli tovaglioli sono facili da prepa-rare e molto interessanti per il riscaldamento del volto senzarischi. In effetti, per ogni applicazione di calore, occorre testarela sensibilità del volto. È vietato apporre del caldo sull’occhio,sulla tempia e sul collo per ragioni vascolari [6]. Gli altri mezzi diriscaldamento (IR) sono da escludere per il loro rischio di essicca-mento della cornea o di ustione, poiché la cute del volto è moltofragile.
Drenaggio linfatico manuale. Riguarda soprattutto le para-lisi facciali traumatiche o postoperatorie. Il fisioterapista insistesulle manovre di riassorbimento.
Massaggi. Si utilizzano i massaggi tipo sfioramento, stimola-zione tattile e stiramenti per il loro effetto trofico e il loro aiutoal rilassamento e alla distensione. Questi massaggi devono essereanche endorali ed endonasali. Essi sono eseguiti su un paziente indecubito dorsale (se lo sopporta), e il massaggiatore-fisioterapistasi pone alla testa del paziente. La palpazione del muscolo buc-cinatore (Fig. 5) si esegue infraoralmente ed è, d’altra parte,interessante dissociarlo dal muscolo massetere e dal muscolo pte-rigoideo. La palpazione e il massaggio del dilatatore delle narici(Fig. 6) si eseguono endonasalmente.
Tecnica della maschera. Con un ritardo di recupero, il volto piùforte può attirare il volto più debole e sono soprattutto i muscolidilatatori che hanno il sopravvento, in particolare a livello dellabocca. Il naso si posiziona progressivamente «a virgola» e la com-missura labiale è attirata in alto e all’esterno verso l’emivolto sano.È la contrattura controlaterale, da non confondere con la contrat-tura omolaterale o con lo spasmo emifacciale, che, dal canto suo,interessa l’emivolto paralitico. La tecnica della maschera riguardala profilassi e la lotta contro la «deviazione dal lato sano». Sitratta di immaginare di indossare una maschera di traverso. Latecnica consiste nel «rimettere a posto la maschera» praticandoun massaggio di stiramento. Si deve stirare l’emivolto paraliticoall’esterno e l’emivolto attivo all’interno, aggiungendo al gestouna componente rotatoria, per rispettare l’orientamento dellefibre (Fig. 7). La tecnica acquista tutto il suo interesse quando siesegue in collaborazione con il paziente, che pone le proprie mani
Figura 5. Palpazione del buccinatore (con la cortese collaborazionedegli studenti dell’Institut de formation en massokinésithérapie [IFMK]di Nizza).
Figura 6. Palpazione e massaggio del dilatatore delle narici (con lacortese collaborazione degli studenti dell’Institut de formation en mas-sokinésithérapie [IFMK] di Nizza).
Figura 7. Tecnica della maschera (con la cortese collaborazione deglistudenti dell’Institut de formation en massokinésithérapie [IFMK] diNizza).
8 EMC - Medicina Riabilitativa

Cinesiterapia delle paralisi facciali � I – 26-463-B-10
Figura 8. Tecnica della maschera con la collaborazione del paziente(con la cortese collaborazione degli studenti dell’Institut de formation enmassokinésithérapie [IFMK] di Nizza).
sulle mani del fisioterapista durante la mobilizzazione (Fig. 8),potendo, così, ricreare la stessa tecnica a domicilio. Questa tecnicasi esegue anche davanti a uno specchio.
Rilassamento. È una tecnica molto importante per il voltoe il corpo intero, in quanto tutte le nostre emozioni pas-sano per il viso. Il rilassamento è particolarmente indicato incaso di spasmo emifacciale, dove i massaggi sono controin-dicati, in quanto possono, attraverso il tatto, aumentare glispasmi.
Rieducazione motoria. La rieducazione motoria inizia conuna cinesiterapia analitica in decubito dorsale per facilitare il rilas-samento, ma con uno specchio a maniglia per utilizzare un ausiliovisivo in partenza e ottenere una contrazione volontaria. L’utilizzodi fotografie di identità permette di valutare, come abbiamo vistoinizialmente, il lato dominante, ma anche di conoscere meglio lemimiche del paziente nel corso delle sue emozioni precedenti. Sirichiede, quindi, al paziente o a coloro che lo aiutano di fornirenumerose sue fotografie. Ogni muscolo è sollecitato manual-mente, all’inizio in maniera passiva, poiché i muscoli sono a 0(in caso di PF flaccida), quindi lavoreremo progressivamente versol’attivo assistito, l’attivo libero e l’attivo contro leggera resistenza(spesso meccanica), nel migliore dei casi. Tuttavia, il paziente puòesserci affidato a un qualsiasi stadio della paralisi. La cinesitera-pia passiva del volto deve rispettare i punti motori e il senso dellefibre muscolari. La cinesiterapia attiva assistita utilizza degli sti-moli di stiramento rapido nel senso delle fibre. Il lavoro in attivolibero deve essere controllato regolarmente, a livello della suaampiezza, della sua velocità di esecuzione, delle sincinesie, dellasimmetria e/o dell’asimmetria di alcune mimiche. La nozione diresistenza è ben specifica per il volto e non si tratta in nessuncaso di utilizzare delle resistenze manuali, ma piuttosto delle resi-stenze meccaniche come abbassalingua, palloncini, acqua, aria,matite e rondelle di diversi calibri per il lavoro dell’orbicolare dellelabbra.
All’inizio del trattamento, si consiglia di lavorare i muscoliin posizione supina per una distensione perfetta della personatrattata. Il fisioterapista richiede la contrazione più selettiva possi-bile di ogni muscolo e ricrea simmetricamente e passivamente lamimica dal lato paralitico (Figg. 9-12). Con il progredire del recu-pero, sarà preferita la posizione seduta per facilitare gli scambi dicomunicazione propri del volto. Diviene particolarmente difficilebilanciare e lavorare analiticamente i muscoli periorali inferioricome triangolare, quadrato del mento e ciuffo, che si contrag-gono contemporaneamente nella mimica della parte inferiore delvolto.
A partire da queste nozioni di facilitazione, tutti gli esercizi conpallone sono molto interessanti da realizzare. L’aspetto tondo, leg-
Figura 9. Lavoro del frontale (con la cortese collaborazione degli stu-denti dell’Institut de formation en massokinésithérapie [IFMK] di Nizza).
Figura 10. Lavoro del dilatatore delle narici (con la cortese collabo-razione degli studenti dell’Institut de formation en massokinésithérapie[IFMK] di Nizza).
gero e ludico del pallone è del tutto adeguato agli esercizi del voltoe della testa. In posizione supina, degli esercizi di elevazione con ilpallone di Klein, seguiti dallo sguardo, aiutano i movimenti versol’alto e, in particolare, il lavoro del muscolo epicranico (Fig. 13).Analogamente, un lavoro di flessione del tronco e della testa conl’aiuto dello stesso pallone seguito dallo sguardo rinforza i movi-menti verso il basso del viso e, in particolare, facilita il lavorodell’orbicolare delle labbra (Fig. 14).
Questi esercizi non sono solo degli esercizi di facilitazioneneuromuscolare, ma permettono anche di reintegrare il voltonell’unità corporea. Questi metodi più globali di facilitazione tro-vano il loro posto all’inizio del trattamento e in fase flaccida, pertentare di scatenare un abbozzo di contrazione, vale a dire quandoi muscoli hanno un punteggio di 0 nel test muscolare. In seguito,il lavoro analitico diventa fondamentale. Quindi, al termine deltrattamento, con o senza postumi, il viso deve ritrovare il suoposto all’interno del corpo. Questa riabilitazione funzionale glo-bale è indispensabile per aiutare il paziente nella ricostruzionedel suo «io» e, certamente, per tentare di ridurre al minimo lafissazione che alcuni pazienti hanno sul proprio viso, quando,purtroppo, non recuperano.
EMC - Medicina Riabilitativa 9

I – 26-463-B-10 � Cinesiterapia delle paralisi facciali
A
B
Figura 11. Lavoro del sopracciliare (A, B) (con la cortese collaborazionedegli studenti dell’Institut de formation en massokinésithérapie [IFMK] diNizza).
Figura 12. Lavoro piramidale del naso (con la cortese collaborazionedegli studenti dell’Institut de formation en massokinésithérapie [IFMK] diNizza).
� ConclusioniLa massofisioterapia è essenziale nella gestione delle paralisi
facciali. Non esiste una sola paralisi facciale, bensì esistono delle
“ Punto importante
Alcune nozioni da sapere per facilitare la rieduca-zione motoria• I movimenti sono bilaterali e simmetrici in caso di emo-zioni intense (p. es., collera).• I movimenti sono bilaterali e asimmetrici in occasione didi attività rigorose (p. es., durante uno sforzo intenso).• I movimenti sono totalmente asimmetrici per controllovolontario (p. es., ammiccare con l’occhio).• Una forte contrazione dei muscoli circolari della boccae degli occhi richiede una reazione in allungamento deglialtri muscoli e del cuoio capelluto.• Una forte contrazione dei muscoli nasali esige la fortecooperazione dei muscoli degli occhi e della bocca.• L’estensione della testa e del collo rinforza tutti i movi-menti verso l’alto.• La flessione rinforza tutti i movimenti verso il basso.• La rotazione del collo rinforza i movimenti del volto dallato dove si guarda.
Figura 13. Facilitazione neuromuscolare verso l’alto.
Figura 14. Facilitazione neuromuscolare verso il basso.
paralisi facciali che differiscono per la loro lesione iniziale, l’età deipazienti, la loro motivazione, la loro comprensione, il loro gradodi lesione e il loro tormento psicologico. Questa rieducazioneè ancora troppo poco affrontata negli istituti di massofisiotera-pia, ma è vero che si tratta, in questo caso, di una rieducazione
10 EMC - Medicina Riabilitativa

Cinesiterapia delle paralisi facciali � I – 26-463-B-10
“ Punto importante
Consulenza di igiene di vita• Soprattutto prevedere l’occlusione degli occhi di notteper evitare l’essiccamento della cornea e prevenire i rischidi congiuntivite e di cheratite• Spiegare bene il rischio di sbavamento, soprattutto nellePF centrali, e insegnare al paziente a controllare la boccacon le mani• Parlare controllando l’ampiezza dei movimenti dellabocca• Fare attenzione al freddo, all’umidità e alle correntid’aria e coprire il collo e le orecchie• Indossare dei occhiali da sole per proteggere gli occhidalla luminosità, dalle aggressioni esterne e dalle polveri,in quanto, in effetti, il paziente ha perso l’ammiccamentoriflesso dell’occhio che serve a lubrificare e a proteggere• Lavorare a casa due o tre volte al giorno di fronte auno specchio dopo cinque minuti di applicazione di unasciugamano caldo e umido• Massaggiarsi il volto secondo i consigli del fisioterapistae, in particolare, ripetere la tecnica della maschera
molto specifica, che richiede certamente delle conoscenze e dellecompetenze supplementari in anatomia clinica. Tuttavia, i centriospedalieri, le cliniche e i centri di rieducazione ricevono spessodei pazienti che soffrono di paralisi facciale che dobbiamo trat-tare rapidamente, offrendo loro una qualità di gestione raffinata epersonalizzata. Nei pazienti emiplegici, il volto è troppo spessotrascurato a vantaggio degli arti e del tronco e, tuttavia, que-
sti pazienti attribuiscono un’importanza notevole al loro visoe si sentono sminuiti da questo difetto di comunicazione evi-dente e dal pregiudizio estetico. Esiste, senza dubbio, una lesionedell’integrità affettiva e il disturbo funzionale associato è moltoinvalidante. Oltre a questa lesione motoria, la lesione dell’occhioe il disagio alla fonazione e alla masticazione fanno sì che questalesione presenti diversi deficit, tutti importanti allo stesso modo.L’educazione del paziente rappresenta, senza dubbio, l’elementoessenziale di questa gestione. Il fisioterapista deve, quindi, aiutareil paziente a comprendere ciò che gli accade e deve accompa-gnarlo verso la guarigione o verso la gestione della sua disabilitàpsicomotoria.
� Riferimenti bibliografici[1] Charlier P. Histoire des sciences médicales, tomeXL1; 200749–57.[2] Dufour M, Pillu M. Biomécanique fonctionnelle. Paris: Masson; 2006.[3] Kamina P. Anatomie clinique (tome 5. Neuroanatomie). Paris: Maloine;
2008.[4] Charachon R, Bebear JP, Sterkers O, Magnan J, Soudant J. La
paralysie faciale, le spasme hémifacial. Société Francaise d’oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale; 1997.
[5] Lacôte M, Chevalier AM, Miranda A, Bleton JP. Évaluation cliniquede la fonction musculaire. Paris: Maloine; 2008.
[6] Chevalier AM. Rééducation des paralysies centraleset périphériques. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris),Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-463-B-10,2003 : 15p.
[7] Couture G, Eyoum I, Martin F. Les fonctions de la face : évaluation etrééducation. Paris: Ortho édition; 1997.
[8] HAS. Référentiel d’auto-évaluation des pratiques professionnellesen masso-kinésithérapie. Évaluation fonctionnelle de l’AVC; Janvier2006.
[9] Murty GE, Diver JP, Kelly PJ, O’Donoghue GH, Bradley PJ. TheNottingham system: objective of facial nerve function in the clinic.Otolaryngol Head Neck Surg 1993;110:156–61.
C. Bernard, Cadre de santé kinésithérapeute, coordonnatrice éducation thérapeutique, enseignante ([email protected]).Institut Polyclinique de Cannes, 33, boulevard Oxford, 06400 Cannes, France.Institut de formation en massokinésithérapie, CHU Archet 2, 15,1 route de Saint-Antoine de Ginestière, 06202 Nice Cedex 3, France.
Ogni riferimento a questo articolo deve portare la menzione: Bernard C. Cinesiterapia delle paralisi facciali. EMC - Medicina Riabilitativa 2013;20(4):1-11[Articolo I – 26-463-B-10].
Disponibile su www.em-consulte.com/it
Algoritmi Iconografia Video- Documenti Informazioni Informazioni Autovalutazione Casodecisionali supplementare animazioni legali per il paziente supplementari clinico
EMC - Medicina Riabilitativa 11