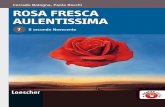Cielo d'Alcamo - Rosa Fresca Aulentissima (Ed. Langella)
-
Upload
arthemis696 -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Cielo d'Alcamo - Rosa Fresca Aulentissima (Ed. Langella)
-
8/17/2019 Cielo d'Alcamo - Rosa Fresca Aulentissima (Ed. Langella)
1/7
Metro: contrastoOpera: Rosa fresca aulentissima
1G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.letteratura it
VOLUME 1
Le origini e il Duecento
Lezione profilo 6 • La lirica delle origini: dalla Francia all’Italia
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima
Questo componimento ci è stato tramandato inmaniera anonima, ma viene attribuito a Cielod’Alcamo da alcune postille dei codici del filologocinquecentesco Angelo Colucci. Il componimentoappartiene al genere del contrasto, già sperimentatoin ambito trobadorico: nelle strofe si alternano in-
fatti la voce di un giullare e quella di una donna,
secondo alcuni studiosi una contadina, secondo al-tri una più generica figura femminile. Il giullarepropone il proprio amore alla donna in maniera
sempre più pressante; dal canto suo, l’amata conti-nua a respingerlo con convinzione via via minore fi-no a cedere, lasciando supporre che fin dall’inizio
fosse intenzionata ad accettare il poeta. È importan-te ricordare che l’amore in gioco è quello prettamen-te fisico, cosa che configura il dialogo come qualco-
sa di molto diverso dalla richiesta di essere presi a
servizio mossa da molti trovatori e dagli stessi poeti siciliani: anzi, il linguaggio del componimento defi-nisce una parodia piuttosto accesa in questo senso.
Cielo d’Alcamo
Rosa fresca aulentissima
Punti chiave: Affinità con le pastorelle provenzaliRegistro basso, popolareRitmo vivace, serrato
Schema metrico: strofe di cinque versi, dicui tre alessandrini e una coppia di endeca-sillabi, con rima AAABB. Sono inclusive le ri-me ai vv. 11, 12 e 13 (morto: diporto: orto), 24e 25 (Deo: eo), 71, 72 e 73 (bale : scale : ale ),91, 92 e 93 (ài : assai:prai ) e 126, 127 e 128(Matteo: giudeo: eo); sono numerosissimele rime siciliane ai vv. 21, 22 e 23 (fare:ago-stari: Bari ), 36, 37 e 38 (aucisa: ripresa: di-
stesa ), 89 e 90 (dire:abere ), 111, 112 e 113(parenti: jente: mente ), 121, 122 e 123 (fina:marina: rena ), 129 e 130 (‘ntutto: disdotto),151, 152 e 153 (seno: patrino: meno) e 159e 160 (ora: ventura ). La rima ai vv. 81 e 83(strutto: frutto) è ricca, mentre fare: fare aivv. 131 e 133 è una rima identica; è infineequivoca la rima amo:amoai vv. 134 e 135.1-2. Rosa... maritate: fresca rosa profuma-tissima, che compari verso l’estate, (tutte)le donne ti desiderano, fanciulle e sposate.La rosa citata nell’incipit è metafora del-l’amore, della bellezza e della donna: perquesto il fiore è desiderato da tutte, ma inparticolare dal poeta, come meglio si evin-ce dal v. 13. La metafora della rosa è piut-
tosto diffusa nella letteratura medievalenon solo italiana, come testimonia il Romande la Rose (XIII sec.). Il v. 2 è una traduzio-ne pressoché letterale del Cantico dei Can-tici I 2: adulescentulae dilexerunt te , dovel’oggetto del desiderio è la sposa. Disianosignifica “desiderano”. La prima strofa è re-citata dal giullare.3. tràgemi... bolontate: toglimi da questifuochi, se questa è la tua volontà. La frase,citata anche da Dante nel De vulgari elo-quentia I, XII 6, è colma di meridionalismi:per esempio, l’uso di b- per v- in bolonta-te (“volontà”); este inteso nel primo casocome “queste” e nel secondo caso come“è”; focora , termine neutro plurale che in-dica i fuochi. I suddetti fuochi sono chiara-
mente quelli dell’arsura d’amore, qui inte-sa prettamente come desiderio fisico. L’im-magine dell’amore come fuoco che consu-ma trova già attestazione nella letteratura
latina, ma è particolarmente diffusa nellapoesia dei trovatori.4-5. per te... madonna mia: a causa tuanon ho riposo di notte né di giorno, mentrecontinuo a pensare a voi, mia signora.Abento significa “requie”, “pace”, “ripo-so”, mentre aio è la forma siciliana per“ho”. Notte e dia è un sintagma piuttostodiffuso con i significati di “sempre” oppure,come in questo caso, di “mai”. Il giullare sirivolge alla donna passando dal tu al voi eusando il linguaggio tipico delle poesie di lo-de già dei trovatori e della scuola siciliana.In questo contesto le formule della linguacortese hanno una funzione parodistica.6. Se di meve... fare: se soffri per me, è lafollia che te lo fa fare. Meve è pronome
meridionale, coniato su teve , dal latino ti-bi . Il secondo emistichio mantiene l’ordineantico dei pronomi.7-10. Lo mar... m’aritonno: potresti arare
il mare, prima di averlo seminato, accumu-lare tutte le ricchezze di questa terra: manon puoi avere me in questo mondo; piut-tosto mi taglierei (m’aritonno) i capelli. È danotare il duplice adynaton, figura retoricache consiste nel presentare situazioni im-possibili: il giullare potrebbe riuscire acompiere entrambe queste azioni che ladonna propone, ma lei, piuttosto di cedere,si ritirerebbe in convento. L’allusione al ta-glio dei capelli, infatti, è quasi sempre, nel-la letteratura medievale, immagine dellamonacazione. Monno e aritonno sono for-me meridionali con assimilazione del nes-so -nd- in -nn-.11-12. Se li cavelli... diporto: se ti tagli i ca-pelli, preferirei essere ucciso, donna, per-
«Rosa fresca aulentissima ch’apari inver’ la state,le donne ti disiano, pulzell’ e maritate:tràgemi d’este fòcora, se t’èste a bolontate;
per te non aio abento notte e dia,5 penzando pur di voi, madonna mia.»
«Se di meve trabàgliti, follia lo ti fa fare.
Lo mar potresti arompere, avanti asemenare,l’abere d’esto secolo tuto quanto asembrare:
avere me non pòteri a esto monno;10 avanti li cavelli m’aritonno.»
«Se li cavelli artóniti, avanti foss’io morto,donna, ch’aisì mi pèrdera lo solaccio e ’l diporto.
-
8/17/2019 Cielo d'Alcamo - Rosa Fresca Aulentissima (Ed. Langella)
2/7
2G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.letteratura it
VOLUME 1
Le origini e il Duecento
Lezione profilo 6 • La lirica delle origini: dalla Francia all’Italia
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima
L’AUTOREDi questo autore vissuto nel XIII secolo sappiamo molto poco.“Cielo” sarebbe la forma toscana del siciliano “Celo”, da “Mi-celi”, cioè “Michele”, e la città di Alcamo si trova, effettivamen-
te, in Sicilia. Secondo alcuni studiosi, Cielo sarebbe stato ungiullare attivo presso la scuola siciliana e il suo celebre con-trasto Rosa fresca aulentissima – unica attestazione della suaattività poetica – andrebbe datato tra il 1231 e il 1250.
ché con essi perderei la mia gioia e il miopiacere (lo solaccio e ’l diporto). Il verbo mo-rire con il significato di “essere ucciso” è ungallicismo, come la dittologia sinonimicasolaccio e diporto, che si trova spesso nel-la lirica provenzale. Pèrdera è condizio-nale siciliano.13-15: Quando... amore: quando passo diqui e ti vedo, fresca rosa del giardino, mi do-ni sempre un gentile conforto: decidiamo dicongiungere il nostro amore. Il terminerosa è, qui, immagine della donna; véioti eaiunga sono forme meridionali.16-18. Che ‘l nostro... corenti: che il nostroamore si congiunga non voglio che mi piac-
cia: se mio padre con gli altri miei parenti titrova qui, stai attento che non ti raggiunga-no, questi che corrono veloci. Si tratta del-l’allusione a una vendetta da parte dei pa-renti della donna. M’atalentiè un gallicismoe significa “mi piaccia”, “mi faccia piacere”.In pàremo (“mio padre”), pare è un gallici-smo, mentre l’uso del pronome possessivoenclitico (-mo) è tipicamente siciliano.19-20. Como... partuta: come ti è piaciutala venuta, ti consiglio di fare attenzione al-la partenza.21-23. Se i tuoi... Bari: se anche i tuoi pa-renti mi trovano, che mi possono fare? Im-pongo loro una multa di duemila augusta-li: tuo padre non mi toccherebbe per tutte
le ricchezze di Bari. La difensa venne isti-tuita da Federico II con le Costituzioni diMelfi del 1231: si trattava della possibilitàda parte della persona che veniva aggredi-ta, di invocare la difesa imperiale e unamulta, il cui ammontare era stabilito dallavittima; gli augustali erano invece moneted’oro coniate nello stesso anno. Da questacitazione possiamo dedurre che il contra-sto sia stato composto dopo il 1231, ma pri-ma del 1250, anno della morte di FedericoII. Di fatto, il giullare minaccia, in caso di ag-gressione, di imporre al padre della giova-ne una multa altissima, a causa della qua-le avrebbe dovuto rinunciare alla vendetta.Il modo di dire quanto avere ha ’n Bari è do-
vuto al fatto che Bari era a quel tempo unadelle città più ricche.24-25. Viva... dico eo?: viva l’imperatore,grazie a Dio! Capisci, bella, quello che ti stodicendo?26. né sera né maitino: mai. La donna la-menta l’insistenza del giullare. Maitino è ungallicismo.27. Donna... massamotino: sono padronadi monete d’oro e oro massamotino (cioè,“sono una donna ricca”). I pèrperi sonomonete d’oro bizantine; l’oro massamoti-no era ritenuto particolarmente pregiato edeve il suo nome ai califfi Amoadi, che re-gnavano nell’Africa settentrionale.28-30. se tanto... mano: se tu mi donassitante ricchezze quante ne ha il Saladino, e
in aggiunta quelle che ha il sultano, non po-tresti nemmeno toccarmi sulla mano. Sa-ladino è il famoso sovrano di Siria ed Egit-to, citato anche da Dante nella Commedia.31-33. Molte... podesta: sono molte ledonne che hanno la testa dura, e l’uomo ledomina (adimina ) e ammonisce (amonesta )con le parole: la incalza (procazzala ) tantoda tutte le parti finché l’ha in suo potere (po-testa ). Amonesta e procàzzala sono galli-cismi, mentre potesta è un latinismo. Iltermine femine ha forse qui e al verso suc-cessivo il valore di “donne di basso rango”,o anche di facili costumi. Si trova infatti, peresempio, nella lirica provenzale, l’opposi-zione della femna alla domna , cioè la “si-
gnora”. Si noti il passaggio dal plurale alsingolare.34-35. Femina... ripentere: una donnanon può fare a meno dell’uomo: attenta,bella di non pentirtene. Ripentere è galli-cismo.36-37. Ch’eo... ripresa: che io debba pen-tirmene? Preferirei essere uccisa piuttostoche qualche buona donna fosse rimprove-rata per colpa mia (cioè, piuttosto di getta-re, attraverso il mio cattivo esempio, discre-dito su tutte le altre donne oneste).38-40. Aersera... gueri: tempo fa passastidi qui, correndo a più non posso. Prendi ri-poso, cantastorie: le tue parole non mi piac-ciono per niente. Aersera è un gallicismo.
Quando ci passo e véioti, rosa fresca de l’orto,bono conforto donimi tutore,
15 poniamo che s’aiunga il nostro amore.»
«Che ’l nostro amore aiùngasi, non boglio m’atalenti:se ci ti trova pàremo cogli altri miei parenti,guarda non t’arigòlgano questi forti corenti.
Como ti seppe bona la venuta,20 consiglio che ti guardi a la partuta.»
«Se i tuoi parenti trovami, e che mi pozon fare?
Una difensa mètoci di du mili’agostari:non mi tocara pàdreto per quanto avere à ’n Bari.
Viva lo ’mperadore, grazi’a Deo!25 Intendi, bella, quel che ti dico eo?»
«Tu me no lasci vivere né sera né maitino.Donna mi so’ de pèrperi, d’auro massamotino;se tanto aver donàssemi, quanto à lo Saladino,
e per aiunta quant’à lo Soldano,30 tocare me non poteri a la mano.»
«Molte sono le femine ch’ànno dura la testa,e l’omo con parabole l’adimina e amonesta;tanto intorno procazzala fin che·ll’à in sua podesta.
Femina d’omo non si può tenere:35 guàrdati, bella, pur de ripentere.»
«Ch’eo ne pur ripentésseme? Davanti foss’io aucisaca nulla bona femina per me fosse ripresa! Aersera passàstici, corenno a la distesa.
Aquìstati riposa, canzoneri:40 le tue parole a me non piacion gueri.»
-
8/17/2019 Cielo d'Alcamo - Rosa Fresca Aulentissima (Ed. Langella)
3/7
3G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.letteratura it
VOLUME 1
Le origini e il Duecento
Lezione profilo 6 • La lirica delle origini: dalla Francia all’Italia
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima
41-42. Quante sono... fore!: quante sono lepene (schiàntora ) che mi hai inflitto al cuo-re, anche soltanto riflettendo tra me, digiorno, quando esco! Schiantoraè un neu-tro plurale; purpenzànnome è un gallici-smo.43. secolo: è un latinismo e significa “mon-
do”.44. teve: te.46-47. Se distinata... bellezze: se fossidestinata a te, cadrei in basso, perché nel-le tue mani le mie bellezze sarebbero malriposte. Caderia e fora sono forme di con-dizionale siciliano e teve è forma meridio-nale derivante dal latino tibi .48-50. Se tuto... persone: se mi capitassetutto questo, mi taglierei le trecce e mi fa-rei monaca in un monastero, piuttosto chetu possa toccare la mia persona. Tagliàra-mi è condizionale siciliano. La donna riba-disce la “minaccia” già attuata al v. 10.51-53. Se tu consore... volontieri: se tu tifai suora, donna dal viso luminoso, vengoanch’io al monastero e mi faccio frate: pervincerti attraverso una prova tanto grande,lo farei volentieri. Cleri, mostero e confle-ri sono francesismi.54-55. Conteco... dimino: starò con te mat-tino e sera: è necessario che io ti abbia inmio possesso. L’espressione la sera e lomaitino significa “sempre”, “senza sosta”.56. Boimè... distinato!: Ahimé, povera in-felice!, che crudele destino (distinato) ho!57-58. Gieso Cristo... blestiemato: l’Altissi-mo Gesù Cristo è del tutto arrabbiato conme: mi hai concepito affinché mi imbat-tessi in un uomo empio. Si noti l’apostrofe aCristo, dopo averne parlato in terza perso-na. Il giullare è definito empio (blestiemato)a causa del suo proposito sacrilego di farsi
frate per ottenere le grazie della donna.59-60. Cerca... troverai: percorri, cercan-do, la terra, che è tanto grande: troverai unadonna più bella di me. Il verbo cercare haqui il significato di “percorrere/vagare men-tre si cerca”. Chiù (“più”) è forma tipica-mente meridionale.61-65. Cercat’aio... prese: ho percorsoCalabria, Toscana e Lombardia, Puglia,Costantinopoli, Genova, Pisa e Siria, Ger-mania e Babilonia e tutta l’Africa del nord:non vi ho trovato una donna nobile come voi,per questo vi ho presa come mia signora.66-70. Poi tanto... comannamente: poi-ché hai tanto sofferto, ti faccio una richie-sta: che tu vada a domandarmi a mia ma-
dre e a mio padre. Se si degnano di darmia te, portami al monastero e sposami pub-blicamente, poi farò quello che desideri.Davanti da la iente significa “davanti a tut-ti” e menami significa “portami”. La propo-sta di matrimonio da parte della giovane èun primo segnale di cedimento nei confron-ti del cantastorie.71-72. Di ciò che tu dici... scale: quelloche dici, vita mia, non ti giova a niente,perché delle tue parole non ne parlo nem-meno più. Il giullare rifiuta di rispondere al-la richiesta di matrimonio della ragazza.L’espressionefatto n’ò ponti e scale sareb-be, secondo Gianfranco Contini, un modo didire siciliano.73-75. penne... villana: “pensavi di mette-
re le penne e ti sono cadute le ali; io ti ho da-to il colpo di grazia (la bolta sotana ). Dun-que, se puoi, difenditi, villana”. Con questeparole il giullare accusa la giovane di esse-re poco sincera e di aver fatto un’offerta dimatrimonio interessata, che lui ha rifiuta-to. Il tema delle false penne che cadono po-trebbe derivare dalla leggenda di Icaro op-
pure dalla favola di Fedro, Graculus super-bus et pavo.76-78. En paura... zitello: non mi mettipaura di nessun manganiello: me ne sto alsicuro tra le mura di questo forte castello;stimo le tue parole meno di quelle di unbambino. La metafora dell’assalto è provo-cata dalla bolta sottana della strofa prece-
«Quante sono le schiàntora che m’à’ mise a lo core,e solo purpenzànnome la dia quanno vo fore!Femina d’esto secolo tanto no amai ancore
quant’amo teve, rosa invidïata:45 ben credo che mi fosti distinata.»
«Se distinata fósseti, caderia de l’altezze,ché male messe fòrano in teve mie bellezze.Se tuto adivenìssemi, tagliàrami le trezze,
e consore m’arenno a una magione50 avanti che m’artochi ’n la persone.»
«Se tu consore arènneti, donna col viso cleri,a lo mostero vènoci e rènnomi confleri:per tanta prova vencerti fàralo volontieri.
Conteco stao la sera e lo maitino:55 besogn’è ch’io ti tenga al meo dimino.»
«Boimè tapina misera!, com’ao reo distinato!Gieso Cristo l’altissimo del tuto m’è airato:concepìstimi a abàttare in omo blestiemato.
Cerca la terra ch’èste grane assai,60 chiù bella donna di me troverai.»
«Cercat’aio Calabria, Toscana e Lombardia,Puglia, Costantinopoli, Genoa, Pisa e Soria,Lamagna e Babilonia, e tuta Barberia:
donna non ci trovai tanto cortese,
65 per che sovrana di meve te prese.»
«Poi tanto trabagliàstiti, facioti meo pregheri,che tu vadi adomànimi a mia mare e a mon peri.Se dare mi ti degnano, menami a lo mosteri,
e sposami davanti da la iente;70 e poi farò le tuo comannamente.»
«Di ciò che dici, vìtama, neiente non ti bale,ca de le tuo parabole fatto n’ò ponti e scale:penne penzasti mettere, sonti cadute l’ale;
e dato t’aio la bolta sotana.
75 Dunque, se poti, tèniti, villana.»
«En paura non metermi di nullo manganiello:istòmi ’n esta groria d’esto forte castiello;prezo le tuo’ parabole meno che d’un zitello.
-
8/17/2019 Cielo d'Alcamo - Rosa Fresca Aulentissima (Ed. Langella)
4/7
4G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.letteratura it
VOLUME 1
Le origini e il Duecento
Lezione profilo 6 • La lirica delle origini: dalla Francia all’Italia
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima
dente. Il manganiello è una sorta di cata-pulta, utilizzata spesso negli assedi. Proba-bilmente è da ravvisare, in questa strofa,una certa ambiguità di linguaggio. Prezoviene dal provenzale prezar e vuol dire “sti-mare”. Lo zitello è il ragazzino.79-80. Se tu... chiaci: se non ti levi e non te
ne vai di qua, mi piacerebbe che tu vi fossiucciso. Morto con il significato di “ucciso”è un gallicismo, mentre chiaci è la forma si-ciliana per “piace”, qui con il valore di con-dizionale.82-85. Se morto... matino: se anche doves-si essere ucciso o completamente sfre-giato, non mi muoverei di qui (di quaci nonmi mòsera ) senza ottenere il frutto chesta nel tuo giardino: lo desidero mattino esera. Mòsera è condizionale siciliano. Ilfrutto contenuto nel giardino della donna èuna chiara allusione alle grazie della ragaz-za stessa; la metafora della donna comegiardino è piuttosto ricorrente nella lette-ratura medievale.86-88. Di quel frutto... feri: non hannoavuto quel frutto né conti né cavalieri; lo de-siderarono molto marchesi e giudici re-gionali, ma non riuscirono ad averlo: perquesto se ne andarono fortemente adirati.La ragazza si vanta di aver rifiutato le prof-ferte amorose di pretendenti ben più degnidi un giullare. Nell’elenco figurano ancheiustizieri , cioè i giudici a cui Federico II af-fidava una certa porzione di territorio affin-ché facessero rispettare le leggi; si tratta-va quindi di una carica di una certaimportanza. Pòttero sta per “poterono”;feri ha qui il significato di “adirati”.90. Men’èste... abere: quello che possiedivale meno di mille once. L’oncia era unamoneta in uso in vari Stati italiani durante
il Medioevo.91-92. Molti... m’assai: sono molti i chio-di di garofano, ma non così tanti che tupossa formare una salma: bella, non di-sprezzarmi, se prima non mi provi. La sal-ma è un’unità di misura diffusa soprattut-to in Sicilia ed equivalente all’incirca a treettolitri; i chiodi di garofano sono una spe-zia che viene dall’Oriente, e dunque nelMedioevo era merce abbastanza rara epreziosa. Alcuni studiosi stabiliscono unrapporto metaforico tra i garofani e i corteg-giatori ricchi della donna; seguendo que-st’ultima ipotesi, il giullare direbbe alladonna che in realtà i suoi estimatori non sa-rebbero tanti come si era lasciato intende-
re nella strofa precedente: ma si tratta diun’interpretazione piuttosto improbabile.Un’altra interpretazione ancora vede i ga-rofani come le qualità della donna: essa nonne sarebbe così piena quanto crede. Assai è un gallicismo e significa “provi”.93-95. Se vento... dole: se il vento cambiaed è in proda e ti raggiungo sulla spiaggia,ti ricorderò queste parole, che quest’ani-mella, dentro di me, soffre assai. Il giulla-re torna sul tema del dolore e della soffe-renza, benché l’uso del termine animella sembri abbassare il tono del discorso. Lametafora sottintesa è, in questo caso, quel-la della navigazione, piuttosto diffusa inambito amoroso per indicare il compiersidel desiderio.
96-100. Macara... Soldano: Volesse il cie-lo che tu soffrissi al punto da cadere mor-to tra i tormenti: la gente accorrerebbe datutte le parti e tutti mi direbbero: “Soccor-ri questo poveretto!” Non mi degnerei di
porgerti la mano per tutti gli averi del pa-pa e del sultano.Il tema della sofferenza è ripreso dalladonna, che arriva a dichiarare che nonsoccorrerebbe il giullare per tutto l’oro delmondo, quando questo cadesse svenutoper amore suo. Angosciato significa “privodi sensi”; degnara è condizionale siciliano.La locuzione da traverso e da·llato signifi-ca “da ogni direzione”; da·llato presenta ilraddoppiamento fonosintattico.101-102. Deo... pantasa: lo volesse Dio, vi-ta mia, che fossi ucciso in casa tua! L’ani-ma se ne andrebbe consolata, perché gior-no e notte delira a causa tua.Morto è di nuovo impiegato come gallici-smo, con il significato di “ucciso’”; arma è
l’anima, mentre cònsola è participio forte evuol dire “consolata”. Pantasa significa“delira”.103-105. La iente... la vita: la gente ti direb-be: “Ohi, malvagia spergiura, che hai ucci-
so l’uomo in casa tua, traditrice!”. Mi toglila vita senza nemmeno colpirmi.Il giullare riprende l’immagine della follache giungerebbe in suo soccorso, rivol-gendola a proprio favore. La gente biasime-rebbe la donna per aver lasciato morire ilcantastorie. Chiamàrano è condizionalesiciliano; traìta significa “traditrice”. Laforma càsata presenta il pronome pos-sessivo enclitico in fine di parola, comenell’uso meridionale. L’espressione san-z’onni colpo significa “senza colpire”: ladonna infatti ucciderebbe l’uomo senza al-zare una sola mano su di lui, ma continuan-do a resistergli e a fargli proposte assurde.106-110. Se tu... aitare: se non ti alzi e nonte ne vai con la mia maledizione, i miei
Se tu no levi e va’tine di quaci,80 se tu ci fosse morto, ben mi chiaci.»
«Dunque voresti, vìtama, ca per te fosse strutto?Se morto essere déboci od intagliato tuto,
di quaci non mi mòsera se non ai’ de lo fruttolo quale stäo ne lo tuo iardino:85 disïolo la sera e lo matino.»
«Di quel frutto non àbero conti né cabalieri,molto lo disïarono marchesi e iustizieri,avere no ’nde pòttero: gìro ’nde molto feri.
Intendi bene ciò che bole dire?90 Men’èste di mill’onze lo tuo abere.»
«Molti so’ li garofani, ma non che salma ’nd’ài;bella, non dispregiàremi s’avanti non m’assai.
Se vento è in proda e gìrasi e giungioti a le prai,a rimembrare t’äo ’ste parole,
95 ca dentr’a ’sta animella assai mi dole.»
«Macara se doléseti che cadesse angosciato,la gente ci coresoro da traverso e da·llato;tut’a meve dicessono: “Acori esto malnato!”,
non ti degnara porgere la mano100 per quanto avere à ’l Papa e lo Soldano.»
«Deo lo volesse, vìtama, te fosse morto in casa!
L’arma n’anderia cònsola, ca dì e notte pantasa.La iente ti chiamaràno: “Oi periura malvasa,ch’à’ morto l’omo in càsata, traìta!”
105 Sanz’onni colpo lèvimi la vita.»
«Se tu no levi e va’tine co la maladizione,li frati miei ti trovano dentro chissa magione.
-
8/17/2019 Cielo d'Alcamo - Rosa Fresca Aulentissima (Ed. Langella)
5/7
5G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.letteratura it
VOLUME 1
Le origini e il Duecento
Lezione profilo 6 • La lirica delle origini: dalla Francia all’Italia
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima
fratelli ti troveranno in questa casa. [...]certo lo sopporterei, che tu qui perda la vi-ta, perché sei venuto a importunarmi con leparole; nessun parente né amico di potràaiutare. La donna minaccia il giullare del-l’arrivo e della ritorsione dei suoi fratelli, selo trovassero in casa a importunarla con
questi discorsi. Il tono tuttavia suona un po’debole, quasi un avvertimento più che unaminaccia. La prima parte del vv. 108 è an-data perduta. La persone indica il corpo vi-vo e, quindi, la vita. Sormonare significa let-teralmente “parlare”, “fare discorsi”.111-112. A meve... iente: non mi sonod’aiuto amici né parenti: sono straniero, miacara, in mezzo a questa buona gente.113. Or fa... mente: ora è un anno, vitamia, che mi sei entrata nella mente (è pas-sato un anno da quando mi sono innamo-rato di te).114-115. Di canno... feruto: da quando haivestito il maiuto, bella, da quel giorno so-no ferito (dall’amore). Il maiuto è un pannogrezzo, usato per gli abiti delle fanciulle dibassa estrazione sociale o dalle donne diservizio. La frase si presta a molteplici in-terpretazioni, soprattutto per quanto ri-guarda il maiuto: in ogni caso, il giullare di-chiara di essersi innamorato della donnadal primo momento in cui l’ha vista.116-117. Ai!... sciamito?: ah ti sei innamo-rato tanto, tu, Giuda traditore, come se (ilmaiuto) fosse porpora, scarlatto o sciami-to? Porpora, scarlatto e sciamito sono tes-suti preziosi.118-120. S’a le Vangele... perfonno: seanche mi giurassi sul Vangelo che sarai miomarito, non potresti avermi in questo mon-do: piuttosto mi butto nel profondo del ma-re. La donna asserisce che preferirebbe
gettarsi in mare piuttosto che cedere algiullare. Il tema del giuramento sui Vange-li tornerà nelle strofe finali del componi-mento.121-125. Se tu... pecare: se ti getti in ma-re, donna cortese e nobile, ti seguirò pertutta la marina e, quando sarai affogata, titroverò sulla spiaggia solo per raggiunge-re questo scopo: voglio congiungermi apeccare con te. Misera, anegàseti e trobà-rati sono condizionali siciliani; cortese e fi-na è una dittologia sinonimica tipica dellalirica trobadorica. A questo punto il giulla-re tocca con mano la necrofilia: arriva infat-ti a dire alla donna che, anche se si lascias-se affogare in mare, lui ne seguirebbe il
corpo per potervisi congiungere.126-128. Segnomi... anch’eo!: mi segnonel nome del Padre, del Figlio e di sanMatteo: so che non sei eretico o figlio di giu-deo, ma non ho mai sentito dire parole co-me queste. La donna, sentendo le paroleblasfeme del giullare, fa il segno della cro-ce. La citazione di san Matteo non è chia-ra: probabilmente si tratta dell’autore delprimo Vangelo, forse patrono della locali-tà in cui è ambientata la vicenda. Retico si-gnifica “eretico”; la congiunzione e delv.128 ha valore avversativo.129-130. Morta... disdotto: se la donna èmorta, si perdono il piacere e il diletto. Sa-boro e disdotto è un’altra coppia sinonimi-ca tipica della lirica provenzale.
132. Se quisso... cantare: se non fai que-sto per me, smetto di cantare. Arcòmplimi significa letteralmente “compi per me, amio favore”.133. plàzati: ti piaccia.134-135. Ancora tu... a l’amo: tu non miami ancora, io ti amo molto, così mi hai pre-so come un pesce all’amo. In pratica, se-condo il giullare, la donna l’avrebbe fatto in-namorare di sé illudendolo, con tuttoquesto gioco di profferte e di rifiuti, così co-me illusoria è l’esca usata dal pescatore.136. «Sazo che m’ami... paladino»: lo so
che mi ami e io ti amo di amore sincero. Pa-ladino qui significa “sincero”, “nobile”, co-me i paladini di Carlo Magno.137-140. Levati suso... in tua baglia: alza-ti e vattene, torna domani mattina. Se fai perme ciò che ti dico, ti amerò con cuore nobi-le e buono. Ti prometto questo, senza ingan-no: credi alla mia buona fede, perché mi haiin tua balìa. Sanza faglia è un modo di diredella lirica cortese e significa “senza fallo”,“senza inganno”. Faglia è gallicismo.141-142. Per zo che dici... cortello novo:proprio per quello che mi dici, cara mia, non
[...] be·llo mi sofero pèrdici la persone,ch’a meve sè venuto a sormonare;
110 parente né amico non t’àve aitare.»
«A meve non aìtano amici né parenti:
istrani’ mi so’, càrama, enfra esta bona iente.Or fa un anno, vìtama, ch’entrata mi sè ‘n mente.Di canno ti vististi lo maiuto,
115 bella, da quello iorno so’ feruto.»
«Ai!, tanto ‘namoràstiti, tu Iuda lo traìto,como se fosse porpore, iscarlato o sciamito?S’a le Vangele iùrimi che mi sia a marito,
avere me non pòter’a esto monno:120 avanti in mare gìtomi al perfonno.»
«Se tu nel mare gìtiti, donna cortese e fina,
dereto mi ti mìsera, per tuta la marina,e da poi c’anegàseti, trobàrati a la rena,solo per questa cosa adimpretare:
125 conteco m’aio agiungere a pecare.»
«Segnomi in Patre e ’n Filio ed i·santo Mateo:so ca non sè tu retico o figlio di giudeo,e cotale parabole non udi’ dire anch’eo!
Morta sì è la femina a lo ’ntutto,130 pèrdeci lo saboro e lo disdotto.»
«Bene lo saccio, càrama: altro non pozo fare.
Se quisso nonn-arcòmplimi, làssone lo cantare.Fallo, mia donna, plàzati, ché bene lo puoi fare.
Ancora tu no m’ami, molto t’amo,135 sì m’ài preso como lo pesce a l’amo.»
«Sazo che m’ami, àmoti di core paladino.Levati suso e vàtene, tornaci a lo matino.Se ciò che dico facemi, di bon cor t’amo e fino.
Quisso t’adimprometto sanza faglia:140 te’ la mia fede, che m’ài in tua baglia.»
«Per zo che dici, càrama, neiente non mi movo.Inanti prenni e scànnami: to’ esto cortello novo.
-
8/17/2019 Cielo d'Alcamo - Rosa Fresca Aulentissima (Ed. Langella)
6/7
6G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.letteratura it
VOLUME 1
Le origini e il Duecento
Lezione profilo 6 • La lirica delle origini: dalla Francia all’Italia
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima
mi muovo affatto. Piuttosto prendi e scan-nami: tieni questo nuovo coltello. Il giulla-re rifiuta di andarsene proprio perché ladonna ha dichiarato di amarlo. L’urgenzadel desiderio è tale da chiederle di scannar-lo piuttosto che rimandare.143. Esto fatto... un uovo: quest’azione si
può compiere più facilmente di quando siscalfisca un uovo. Cioè: impiegheresti me-no tempo a cedere ai miei desideri che arompere un guscio d’uovo.144-145. Arcompli... mi s’infella: adempiil mio desiderio, amica bella, perché l’ani-ma si rattrista con il mio cuore.Talento e in-fella sono gallicismi; «amica bella» è inve-ce un sintagma tipico della lingua amorosa,piuttosto diffuso nella lirica provenzale.146. Ben sazo... arsura: so bene che la tuaanima soffre come chi prova arsura (amo-rosa). Omo è forma impersonale.147-150. Esto fatto... la testa: quest’azio-ne non può compiersi in nessun altro mo-do: se non hai i Vangeli, affinché possadirti “giura!”, non puoi avermi in tuo pote-re; piuttosto prendi e tagliami la testa. Po-desta è un latinismo. La donna è, in realtà,pronta a cedere: il giuramento sui Vange-li, da lei proposto, è reso blasfemo dall’at-to che verrebbe a legittimare.151-152. Le Vuangelïe, càrama... patrino:i Vangeli, cara mia? Io li porto in seno: li hopresi al monastero, non c’era il confessore.Il giullare dichiara, in pratica, di aver ruba-to i Vangeli; Ferroni avanza l’ipotesi che ilcantastorie in realtà finga semplicementedi averli con sé. Il patrino qui citato è il pa-dre confessore.153-155. Sovr’esto libro... sutilitate: tigiuro su questo libro di non venirti maimeno. Compi il mio desiderio, per carità,
perché la mia anima si va consumando.Non ti vegno meno significa “non ti lasce-rò mai”. Il giuramento è ovviamente fasul-lo e finalizzato al raggiungimento del solopiacere fisico. “Stare in sutilitate” significa“consumarsi”; caritate e sutilitate sonodue latinismi.
156-158. Meo sire... difenno: mio signore,poiché me l’hai giurato, mi accendo tuttaquanta. Sono davanti a voi, da voi non mi di-
fendo più. Se ti ho disprezzato, pietà, mi ar-rendo a voi.La prontezza della donna dopo il giura-mento è la conferma che in effetti la sua ri-luttanza era solo parte di una schermagliaamorosa. Le parole della fanciulla, l’imma-gine dell’incendio, la resa e la richiesta di
pietà sono stilemi trobadorici, solitamen-te legati alla figura maschile. Minespreso(“disprezzato”) e merzé (“pietà”, “perdono”)
sono gallicismi.159-160. A lo letto... ventura: andiamoce-ne a letto di buon’ora, perché questo ci èstato dato in sorte. Il distico finale suggel-la la caduta di ogni resistenza da parte del-la donna e il compimento del desiderio.
Esto fatto far pòtesi inanti scalfi un uovo. Arcompli mi’ talento, ’mica bella,
145 ché l’arma co lo core mi s’infella.»
«Ben sazo, l’arma dòleti, com’omo ch’ave arsura.
Esto fatto non pòtesi, per null’altra misura:se non à’ le Vangelie, che mo’ ti dico: iura,avere me non puoi in tua podesta:
150 inanti prenni e tagliami la testa.»
«Le Vuangelïe, càrama? Ch’ïo le porto in seno;a lo mostero présile, non ci era lo patrino.Sovr’esto libro iùroti mai non ti vegno meno.
Arcompli mi’talento in caritate,155 che l’arma me ne sta in sutilitate.»
«Meo sire, poi iuràstimi, eo tuta quanta incenno;
sono a la tua presenzia, da voi non mi difenno.S’eo minespreso àioti, merzé, a voi m’arenno.
A lo letto ne gimo a la bon’ora,160 ché chissa cosa n’è data in ventura.»
a cura di M. Spampinato Beretta, in I poeti della scuola siciliana, vol II,Poeti alla corte di Federico II , dir. C. Di Girolamo,
Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2008, vol. II.
Affinità con la pastorella provenzale Il celebre contrastodi Cielo d’Alcamo si configura come la schermaglia amoro-
sa tra due personaggi che gli studiosi non hanno identifica-to con sicurezza: se la voce maschile sembra essere quella diun giullare (al v. 39 viene chiamato canzoneri ), non è certo sequella femminile appartenga a una contadina o a un perso-naggio di rango superiore. Quello che è sicuro è invece il de-siderio dell’amore della donna provato dal cantastorie, che,in maniera sempre più pressante e blasfema, cerca di convin-cerla ad amarlo. La situazione presentata non è nuova, e so-no evidenti alcune affinità con il genere della pastorella pro-venzale e francese: sul piano stilistico-compositivo, per lapresenza del dialogo diretto; sul piano tematico, per la sfron-tatezza delle richieste del giovane. Tuttavia, la pastorellad’Oltralpe mette in scena normalmente un cavaliere, o un tro-vatore, e una contadina, e dunque il divario sociale tra i per-
sonaggi è notevole, ed è a vantaggio dell’uomo. Qui, al con-trario, l’uomo è quasi sicuramente un giullare, mentre per
quanto riguarda la donna non se ne conosce il rango. Tuttosommato questo contrasto sembra essere più vicino alla ten-zone Domna, tant vos ai preiada, scritta dal trovatoreRaimbaut de Vaqueiras, dove un giullare cerca di sedurre unapopolana genovese. Anche il personaggio maschile di Rosa fre- sca aulentissima condivide questo scopo, mentre la donna rea-gisce con vigore, ora ritraendosi, ora rispondendo apertamen-te al giullare, senza mai celare completamente la possibilità diaccettare il pretendente.La fanciulla inizialmente oppone infatti un rifiuto deciso (si ve-da, per esempio, la seconda strofa), per poi proporre al canta-storie di sposarla, se proprio la vuole avere (vv. 66-70), e quin-di concludere chiedendo all’uomo di giurarle sui Vangeliamore eterno e cedendo infine alle sue richieste.
ANALISI DEL TESTO I temi e le scelte stilistiche
IN PRIMO PIANO
-
8/17/2019 Cielo d'Alcamo - Rosa Fresca Aulentissima (Ed. Langella)
7/7
7G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.letteratura it
VOLUME 1
Le origini e il Duecento
Lezione profilo 6 • La lirica delle origini: dalla Francia all’Italia
Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima
Comprensione e analisi1. Riassumi il contenuto del testo facendo attenzione ai mutamenti nell’atteggiamento della fanciulla nei confron-
ti del giullare: in quante fasi è divisibile il componimento?2. La donna minaccia più volte di farsi monaca. Con quali parole esprime questa intenzione? Come reagisce il giul-
lare?
3. Gli studiosi hanno discusso a lungo riguardo all’identità della ragazza, per capire se si tratti di una nobile o di unapopolana: raccogli i dati che vengono forniti su di lei nel componimento e tracciane una descrizione.
4. Cerca nel testo tutte le parole con cui il pretendente si rivolge alla fanciulla: a quale registro stilistico apparten-gono?
5. Nella seconda strofa vengono elencate alcune azioni che il giullare dovrebbe fare per provare a conquistare la ra-gazza: quale figura retorica viene usata? In che cosa consiste? Quale effetto ne risulta?
Approfondimenti6. Nella quinta strofa sono presenti chiari riferimenti al tempo in cui la poesia è stata scritta: delinea la figura del-
l’imperatore di cui si parla e dei letterati che facevano parte della sua corte. (15-20 righe)
Per tornare al testo SPAZIOCOMPETENZE
Gli aspetti linguistici Lo scambio di battute avviene a ritmiserrati, in un’alternanza regolare delle voci da una strofa al-l’altra. La forma dialogica è sottolineata dall’impiego diffusodi coblas capfinidas e di riprese più o meno estese tra un in-tervento e l’altro. La lingua del giullare non differisce in alcunmodo da quella della donna, come invece avviene nel contra-
sto bilingue di Raimbaut de Vaqueiras, cui già si è accennato.Entrambi infatti parlano un volgare siciliano diverso dal lin-guaggio poetico di Giacomo da Lentini e dagli altri poeti del-
la corte di Federico II: si tratta di un linguaggio di registro piùumile, popolare, che alterna, tuttavia, l’uso di gallicismi,espressioni marcatamente cortesi e auliche, addirittura ci-tazioni illustri a un lessico basso, dialettismi, modi di dire edoppi sensi; il linguaggio cortese è inoltre impiegato in sen-so parodistico e ironico. Tutto questo concorre a rendere più
divertente e beffarda questa contesa, in cui l’amore richie-sto alla donna non è più quello, quasi mistico, tra un trovato-re e una dama, ma si limita al mero atto sessuale.